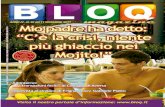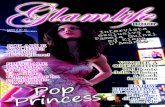InMeteo Magazine 11
-
Upload
giancarlo-modugno -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of InMeteo Magazine 11
Anno IV – Nr 11 Settembre – Ottobre 2010
PERICOLO ALLUVIONI
Foto dell'alluvione del 4 Ottobre 2010 in Liguria
Dall'alto, foto di Andrea Perasso e di Fabio Mazzarello
© ASSOCIAZIONE CULTURALE INMETEO
AMBIENTE
CLIMA
AMBIENTE
L'estinzione: scivolare verso il nulla
Ivonne Carpinelli a pag 3
Cambia il clima o il mondo?
Michele Cotugno De Palma a pag 5
Impronta dei gas serra: Italia ed Europa ancora fuori norma
Giancarlo Modugno a pag 8
2 InMeteo Magazine Settembre – Ottobre 2010 – Nr 11
EDITORIALE
IL FALSO DECLINO DELLA CULTURA METEOROLOGICA NELL'ERA
DEL GLOBAL WARMING
di Giancarlo Modugno
Molti siti, blog e forum che hanno dedicato il loro “hosting” al servizio della divulgazione scientifca nel settore meteo – climatico rivendicano il fatto che questa branca della fsica venga in generale sottovalutata e a volte ridicolizzata dal pubblico popolare. Il tipico e più banale esempio è quello dell'accostamento delle previsioni del tempo alle (false) previsioni dell'oroscopo, a partire dai giornali per terminare alle trasmissioni tv. L'esempio più grave, però, riguarda i numerosi tentativi di inabissare la cultura scientifca tagliando i fondi qua e là. L'ultimo scempio riguarda la volontà di chiudere l'Osservatorio del Collegio Romano, uno dei più importanti luoghi scientifci della storia della meteorologia; l'Associazione InMeteo ha deciso di aderire alla petizione on line intrapresa dall'associazione Bernacca di Roma.
Perché mai la meteorologia e la fsica dell'atmosfera vengono umiliate nelle più svariate forme mentre altri settori della fsica non ricevono lo stesso trattamento? Eppure queste materie si presentano altamente complicate e diffcili da studiare e vanno perfettamente alla pari con astrofsica e fsica nucleare.Sarà perché parlare del tempo è l'atteggiamento più banale per poter iniziare una conversazione con chicchessia? O forse perché i fenomeni meteorologici interessano tutti noi in maniera diretta tutti i giorni? Non a caso sono state citate altri due settori della fsica: è molto più facile che chiunque oggi, grazie a internet, si improvvisi meteorologo dell'ultimo minuto che piuttosto fsico nucleare.
Bisogna a ogni modo guardare in faccia la realtà: non è piangendosi addosso che si migliorerà la situazione. Anzi. Vi sono bellissimi siti in circolazione che in maniera seria e rigorosa cercano di divulgare al meglio le conoscenze meteorologiche, come climalteranti.it o realclimate.org. Anche InMeteo, ormai da 5 anni, cerca di dare il suo contributo e così anche altri siti di altre associazioni. E' per questo motivo che è
sbagliato parlare di “declino” come si legge in qualche sito e molto spesso in qualche discussione nei forum: sebbene in tv si stia spettacolarizzando sempre più, l'angolo scientifco – meteorologico sta diventando sempre più ampio e potenzialmente sarebbe possibile studiare la materia in maniera estremamente approfondita. Aumentano i siti meteo, si moltiplicano i cosiddetti meteofli, si diffondono previsioni e articoli scientifci di alto calibro ogni giorno. Questo mi pare un successo, senza nulla togliere alla capacità dei nostri nonni e bisnonni di “capire” il tempo senza né usare internet né manuali di alcun tipo.Se esiste un declino questo è da ricercare parallelamente nella cultura intrinseca dell'uomo come essere individuale e collettivo: individualmente l'uomo da solo può usufruire delle migliori conoscenze sulla materia messe a disposizione ma non lo fa; collettivamente accetta che gli si proponga qualcosa di passabile. Forse il vero declino va ricercato nella coscienza.
Servirebbe proprio un bell'esame di coscienza: mentre inesorabilmente limitiamo le risorse per le generazioni a venire stiamo sterminando nettamente intere specie di animali e vegetali: il mondo si sta trasformando in un enorme lager e noi ne siamo i dittatori. Anche nell'articolo a pagina tre viene utilizzato il termine “declino”, ma questa volta in senso più drammatico: l'annientamento totale.Così, ogni anno si ripetono inutili discussioni sulla presunta [nda: evidente] colpa dell'uomo in tutto ciò mentre l'inevitabile è sotto i nostri occhi: il termine “Global Warming” ha 35 anni, come ricordato nel sito di Climalteranti, e le previsioni di decenni fa si sono avverate. Invece di reagire ci si continua a cullare nel vano tentativo di credere che forse ci stiamo sbagliando. Intanto il tempo passa e i danni si contano ogni anno.
Il clima cambia, sia chiaro, per defnizione: se con esso individuiamo le caratteristiche meteorologiche di un certo periodo per quale motivo dovremmo pensare che il
periodo successivo debba essere simile o meglio uguale? Non avrebbe senso sebbene le intenzioni dei “primi climatologi” erano proprio quelle: studiare le caratteristiche meteorologiche per poter distinguere geografcamente le varie zone del pianeta. Ma la materia oggi si è evoluta e sappiamo che il clima in quanto ente astratto fsico tende a cambiare e se gli vengono somministrate “spinte” non naturali degenera inesorabilmente. Basti leggere gli studi sullo spazio delle fasi delle variabili climatiche che spiegano quanto la confgurazione attuale esca totalmente dal dominio naturale.
Domandiamoci allora che cosa signifchi veramente “declino”: vogliamo limitarci alla mera e pura illusione della vita televisiva o vogliamo allargare la nostra visuale all'intero mondo su cui dovremmo vivere e lasciar vivere gli altri?
InMeteo Magazine Settembre – Ottobre 2010 – Nr 11 3AMBIENTE
ESTINZIONE: SCIVOLARE VERSO IL NULLA. di Ivonne Carpinelli
In un mondo in cui è l'uomo a fare da padrone, sembra non esserci più spazio per specie alcuna. I maggiori interessi, riguardanti il denaro e l'accumulo del medesimo, calpestano e annullano i diritti e la sopravvivenza stessa degli abitanti della terra.
In un quadro così brutale non sorprende la progressiva scomparsa di specie animali dovuta all'accelerazione del tasso naturale di estinzione rispetto all'aumento della biodiversità globale; la crescita demografca, i cambiamenti climatici, lo sfruttamento delle terre, l'inquinamento e l'introduzione delle specie invasive stanno progressivamente minacciando la ricchezza della biodiversità sul pianeta. In altre parole, l'azione dell'uomo sta alterando - e in parte l'ha già fatto - il giusto equilibrio naturale determinando il mutamento obbligato e la distruzione dell'eterogeneità ambientale in ogni angolo del pianeta.
Nell'anno internazionale della biodiversità proclamato dalle Nazioni Unite, numerosi enti, tra cui il comitato IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), si stanno muovendo ai fni di promuovere azioni utili alla salvaguardia di specie, ecosistemi e ricchezze naturali a livello globale. Possiamo citare il recente Countdown 10 (“Conto alla rovescia 10”) secondo cui tutti i governi Europei, coinvolgendo esperti di ogni settore, dovranno adottare ogni misura necessaria per fermare la perdita della biodiversità entro il 2010. Una scommessa dunque, ma anche un grande impegno, perché non si tutela solo la biodiversità ma anche la sopravvivenza dell'umanità stessa. Come auspicare al sostentamento di comunità pacifcate, alla crescita economica equilibrata, alla riduzione della povertà e allo sviluppo sostenibile senza gestire al meglio le risorse naturali? Come pensare di sopravvivere, di vivere, di camminare in un mondo fatto solo di denaro e cemento?
Dalla IUCN Red List (la Lista rossa IUCN, la più autorevole fonte di classifcazione delle specie in via d'estinzione) è emerso che, rispetto ai 2 milioni stimati di varietà animali esistenti sul nostro pianeta, sono a
rischio il 35% degli invertebrati, il 28% dei rettili, il 22% di tutti i mammiferi e il 12% degli uccelli; un quadro inquietante se si pensa che, una volta estinta, la specie in questione scomparirà per sempre. Su alcune di queste specie, defnite dal WWF “Specie bandiera”, viene focalizzata l'attenzione per sensibilizzare le persone e coinvolgerle nella lotta contro la distruzione della biodiversità; di fatto chi non simpatizza per il panda gigante, la tigre, l'orso polare, il gorilla, l'elefante, la foca monaca, le balene, i campidogli, il leopardo delle nevi e lo scimpanzé (per citarne alcuni)?
Concentriamoci sul panda gigante, per il quale le maggiori minacce sono la distruzione del suo habitat naturale (all'incirca del 50% negli ultimi 15 anni), il bracconaggio per esportarne la pelle e la foritura del bambù (ovviamente in fuenzata dall'espansione delle popolazioni umane e dai cambiamenti climatici). Pensiamo alla tigre, la cui sopravvivenza è minata dalla perdita del suo habitat e dalla mancanza di prede, causata anche qui dalla mano dell'uomo e del clima. Soffermiamoci sullo scimpanzé e sul gorilla minacciati dalla distruzione delle foreste per ricavare legnami e terreni coltivabili.
Rifettiamo sul pericolo che corre l'orso polare. D'inverno l'Ursus marittimus - questo il nome scientifco - si rifugia sulle banchise per riuscire a
catturare un maggior numero di prede; queste stesse banchise, a causa del riscaldamento globale, impiegano sempre più tempo per formarsi impedendo agli orsi di procacciarsi il cibo. A causa della crescente concentrazione dei gas nell'atmosfera, il ben conosciuto fenomeno
dell'effetto serra determina l'aumento delle temperature in tutto il globo causando il prematuro scioglimento delle banchise dell'Artico e costituendo un grave pericolo per la sopravvivenza di questi mammiferi. Secondo l'ultimo rapporto IUCN-PBSG (2006) esistono 19 popolazioni di orsi polari intorno all'Artico: 5 in declino, 5 stabili e 9 di cui non vi sono dati a suffcienza per stilare un pronostico. Nei prossimi 10 anni, 5 popolazioni di orsi polari avranno un rischio di declino da alto a molto alto, 6 avranno un rischio compreso tra scarso e molto scarso e non vi è alcuna valutazione sulle restanti 8.
Di fronte ad un quadro così disastroso, non è certo possibile rimanere impassibili e indifferenti. L'unica soluzione è quella di collaborare per salvare quanto di bello esiste su un pianeta così ricco e vario e di insegnare a non infuenzare ulteriormente, con le proprie azioni, l'instabilità climatica oggi esistente. Impossibile per contro instillare il rispetto nell'animo umano; quello, purtroppo, non si insegna.
Fonti: www.wwf.it; www.iucn.itFoto:www.wwf.it
4 InMeteo Magazine Settembre – Ottobre 2010 – Nr 11
CLIMA
UN BILANCIO POSITIVO PER L'ESTATE 2010 (?)
di Roberta Marinelli
Il bilancio dell'estate 2010 non è eccessivamente negativo in termini di incendi e caldo insopportabile, che sono i principali problemi climatici di quella che defniamo “bella stagione”. D'estate, in presenza di alte temperatura unite ad un tasso elevato di umidità, si è soliti parlare anche di condizioni di afa e caldo torrido che comportano gravi ripercussioni nei territori boscosi e nelle campagne; un esempio comune è quello dell’autocombustione. Ma questa è ormai una stagione che abbiamo lasciato alle spalle: infatti in meteorologia le stagioni si dividono per trimestri e iniziano il primo giorno di settembre (l'autunno), dicembre (l'inverno), marzo (la primavera) e giugno (l'estate). Quindi l’autunno meteorologico è già iniziato mentre per quello astronomico bisogna attendere il 21 settembre, giorno dell'equinozio. Resta da chiedersi, allora, come mai parlare dei problemi climatici di una stagione ormai passata. La risposta è semplice: tutte le stagioni hanno ripercussioni l’una sull’altra e l’andamento dell’una può gravemente infuenzare il decorso dell’altra. Quest’anno abbiamo assistito ad una diminuzione degli incendi del 30% rispetto agli anni precedenti, specie nei mesi di giugno e luglio, grazie alle temperature - mai eccessivamente elevate - e alle grandi piogge delle settimane precedenti, che hanno garantito un verde lussureggiante della vegetazione, meno soggetta al divampare delle famme. Ma la mancanza di precipitazioni, soprattutto nel mese di agosto, ha portato e porterà al fenomeno inverso. Anche nel sud Italia l'autunno è arrivato e, con esso, anche le grandi piogge che ogni anno, tra settembre, ottobre, novembre e dicembre, provocano fenomeni di dissesto del territorio.Sopratutto nelle ultime stagioni, nei mesi autunnali abbiamo assistito a un'escalation di fenomeni meteo estremi con gravi ripercussioni sui territori, anche a livello tragico: ultimo esempio ne è l'alluvione del messinese jonico del 1° ottobre 2009. Anche in questo caso ad un’estate torrida ha fatto seguito un autunno particolarmente piovoso che ha provocato frane e alluvioni.
I recenti eventi sismici che hanno colpito la nostra penisola in maniera grave e le continue frane sono un monito di madre natura che avverte rispetto a ciò che potrebbe accadere su gran parte del territorio Italiano nel prossimo autunno alle prime piogge consistenti. La causa di ciò sono le così dette “Estati di fuoco”, causate dal sempre più grave effetto serra. Oltre, infatti, ai fenomeni di autocombustione, inaridimento del terreno e frane c’è da aggiungere l’aumento delle malattie cutanee e dei tumori della pelle dovuto ad un sole sempre più malato e dannoso, privo del naturale schermo protettivo che circonda la terra e che fltra i raggi ultravioletti, che si va sempre più assottigliandosi. Inoltre il caldo umido o calore afoso è in grado di determinare stati di notevole disagio alle popolazioni, segnatamente quelle residenti nei grandi centri urbani (le città esaltano le temperature massime diurne comportandosi come isole di calore a causa dell’elevata cementifcazione) ma anche lungo le zone costiere (trasporto di aria molto umida dal mare nelle ore pomeridiane e serali tramite le brezze). La sensazione di caldo umido o calore afoso è avvertita dal corpo umano ogni qualvolta i valori di temperatura ed umidità relativa superano determinate soglie critiche, oltre le quali i naturali processi di termoregolazione corporea subiscono signifcativi disturbi, variabili a seconda dell’età e dello stato di salute del soggetto.A modifcare la sensazione di caldo umido può intervenire una terza grandezza meteorologica: il vento, che generalmente ha effetti positivi: in primo luogo dà origine od aumenta il rimescolamento dell’aria ai livelli troposferici medio-bassi (quelli che poi interagiscono col nostro corpo) ostacolando l’accumulo di vapore acqueo nei primissimi strati adiacenti il suolo; in secondo luogo favorisce il raffreddamento cutaneo incrementando i processi di evaporazione.Il prof. Franco Ortolani, ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianifcazione e Scienza del Territorio dell'Università di Federico II di Napoli, è intervenuto sul tema dei problemi
meteorologici della stagione estiva. “E’ necessario che le regioni si preoccupino maggiormente della cura del territorio – commenta Ortolani – i danni dell’estate si vedranno presto. Se adesso sotto l'ombrellone viviamo spensierati il divertimento della bella stagione, l'incubo di frane e smottamenti su strade e centri abitati potrebbe presto tornare a materializzarsi nel corso dell'autunno 2010. E’ ora che gli italiani comincino a rendersi conto che la "bella stagione" cominciava a rivelarsi per molti versi la più cattiva, la più pericolosa e perversa: una situazione di rischio ecologico, economico e sociale”.
InMeteo Magazine Settembre – Ottobre 2010 – Nr 11 5
CLIMA
INONDAZIONI, CALDO ESTREMO E INVERNI RIGIDI: ECCO
L'ESTATE 2010
di Michele Cotugno De Palma
Non solo calure e temperature bollenti a livello politico, in Italia come in Europa. L'estate 2010 verrà ricordata, dai più attenti osservatori e dai più acuti e continui lettori di giornali e quotidiani, come l'estate dei più strampalati ed incredibili fenomeni meteorologici.Chi lo avrebbe mai detto, infatti, che la Russia, paese rigido (in tutti i sensi) per eccellenza, sarebbe stata colpita nel mese di agosto da una incredibile ondata di caldo, che ha devastato ettari di foreste e che ha negativamente mostrato a tutto il globo l'arretratezza del sistema sanitario russo?Chi lo avrebbe mai immaginato che il Pakistan sarebbe stato devastato da una violentissima serie di inondazioni, causando migliaia di vittime e milioni di sfollati?Chi avrebbe scommesso che In America del sud, invece, questo sarebbe stato l’inverno più freddo degli ultimi due secoli con nevicate nella foresta Amazzonica, gelo in Brasile, Argentina, Cile, Perù, Bolivia, Uruguay e Paraguay?Nessuno. Ma gli esperti assicurano che il clima non sta affatto cambiando, ma che quello che è successo in Russia ed in Asia e nel resto del mondo sono dei fenomeni da analizzare per quello che sono.Ma partiamo con ordine, concentrandoci su quello che è successo nel nostro stivale. A dispetto delle solite previsioni catastrofche, possiamo dire senza ombra di dubbio che in Italia non ha fatto per nulla caldo, anzi, l'estate si conclude perfettamente in linea con la media delle temperature del periodo 1961-1990 e ben al di sotto rispetto alle medie del più recente periodo 1981-2009.Inoltre è stata un'estate piovosissima su tutta l'Italia centro/settentrionale.Ma questa estate ha fatto parlare di se soprattutto, ripetiamo, per quello che è successo oltre le Alpi ed oltre le Dolomiti, a migliaia di chilometri di distanza da noi, facendo rivivere la paura dei terribili cambiamenti climatici di cui tanto ma tanto si sente parlare.Ma gli esperti, per una volta concordi tra di loro, mettono a tacere le paure, le fobie e spiegano compatti che il clima non sta
cambiando, o meglio non si sta evolvendo diversamente da quello che ormai è ampiamente risaputo e che i più incredibili fenomeni estivi sono frutto di precise congiunture meteorologiche.Guido Visconti, docente di fsica dell'atmosfera presso l'Università degli Studi dell'Aquila, ribadisce con forza il fatto che “l'unico dato scientifco rilevante di questa estate è che la temperatura della terra è aumentata nell'ultimo secolo di qualche decimo di grado. Ma non è quello che spiega un'estate così estrema. Così come non è l'effetto serra la causa diretta delle alluvioni in Pakistan e in Cina, che ci sono già state anche nel 2002, e gli incendi in Siberia, verifcatisi pure nel 2004. Questi fenomeni in alcune zone del pianeta si verifcano con una certa regolarità. La gente è impressionata perchè stavolta il fuoco è arrivato a Mosca invece di fermarsi, come sempre è accaduto, nelle steppe desertiche».“Quello che è successo quest'estate è già accaduto, non è un fenomeno climatico fuori dalla norma- continua Visconti- e non è certo questa la prima estate in cui si verifcano forti acquazzoni a metà agosto anche in Europa o nel nord Italia. Non ci sono evidenze scientifche che possano dire che siamo di fronte a cambiamenti climatici epocali. Piuttosto la gente, e soprattutto la politica, dovrebbero preoccuparsi di quanto siano più gravi oggi, e più pesanti per la collettività, le conseguenze di un temporale rispetto a 50 anni fa. In Europa centrale - ad esempio - avrebbero dovuto mettere mano ad un sistema di protezione dei bacini per evitare catastrof idrogeologiche, non l'hanno fatto uscendo dalla lunga dittatura e il risultato sono le terribili conseguenze di fenomeni meteorologici anche normali. Per cui, secondo il professore, “Non è il clima che è cambiato rispetto a 20-30 anni fa, è cambiato il mondo».Sulla stessa lunghezza d'onda anche Peter Stott, capo climatologo del Met Offce britannico, la più importante autorità meteorologica del mondo.Secondo Stott, “il fatto che in India e anche in Cina le piogge nel periodo dei monsoni siano diventate più intense è del tutto coerente con le nostre nozioni di fsica dell'atmosfera, in cui masse d'aria più calde trattengono più umidità e quindi il
riscaldamento globale sta aumentando in alcune regioni la probabilità di precipitazioni torrenziali”. Scott poi entra più nel dettaglio, affermando che “il fusso nell'alta troposfera sopra India, Himalaya e Pakistan è dominato dall'anticiclone monsonico, che fa da barriera alla penetrazione verso Sud delle condizioni meteo delle medie latitudini. Quest'anno invece sistemi meteo particolarmente attivi si sono diffusi verso il Pakistan, e combinandosi con i monsoni, hanno generato piogge da record. Il caldo intenso e gli incendi di foreste e coltivazioni in Russia così come le piogge torrenziali in Cina sono sempre conseguenze di questa anomala confgurazione”.Ma questi fatti anomali potrebbero ripetersi? Non è detto, ma potrebbe succedere, perchè, ci spiega sempre Stott “ciò che è avvenuto questa estate è certamente un'evenienza rara, si diceva, ma non troppo; tanto da far supporre ai ricercatori che questi e altri disordini climatici possano diventare la norma verso metà secolo. Altri fenomeni meteorologici estremi invece potrebbero diminuire di frequenza grazie al cambiamento climatico e per questa motivazione è urgente saper distinguere fra gli uni e gli altri per imparare a rispondere alle sfde del cambiamento climatico in corso.Anche Kevin Trenberth, responsabile delle analisi climatiche presso il National Centre for Atmospheric Research, vede dei collegamenti tra i fatti pakistani ed i fatti russi.Trenberth, infatti, spiega che "le due cose sono collegate su una scala molto grande, attraverso ciò che chiamiamo un'inversione della circolazione monsonica". "L'attività straordinaria dei monsoni- spiega ancora il responsabile- viene alimentata dalla temperature decisamente più elevate rispetto alla media di questo secolo che si sono verifcate nell'Oceano Indiano, e che hanno generato violenti nubifragi sopra il Pakistan. A ogni due gradi (Farenheit) di aumento della temperatura del mare corrisponde un aumento dell'8 per cento dell'umidità dell'aria. L'aria calda e umida sale verso l'alto per poi scendere a Nord, come è avvenuto appunto in Russia”.
6 InMeteo Magazine Settembre – Ottobre 2010 – Nr 11
ENERGIA
LE FONTI RINNOVABILI (2à PARTE)
di Chiara Antonucci
Non dimentichiamo il ruolo del Sole, che è la fonte primaria di energia per eccellenza. La quantità di energia solare che arriva sulla Terra è in media, considerando sfericità e rotazione, di 200 W/m2, ovvero 10.000 volte superiore a tutta l’energia usata dall’umanità nel suo complesso.L'energia termica derivante dall' irraggiamento solare può essere "catturata" in molti modi e utilizzata per le varie necessità energetiche: come semplice energia termica utile alla produzione di acqua calda per usi sanitari e per riscaldamento ma anche per ottenere energia frigorifera, energia elettrica o energia meccanica. A permetterci di ottenere energia elettrica dal Sole è l’effetto fotovoltaico, che è basato sulle proprietà di alcuni materiali semiconduttori, e non necessita di parti meccaniche in movimento ne dell'uso di alcun combustibile. L'elemento base nella costruzione di un modulo fotovoltaico è detto cella fotovoltaica, e si tratta di una lamina di materiale semiconduttore (generalmente silicio). La cella fotovoltaica è sostanzialmente un diodo cioè una giunzione PN tra due semiconduttori, uno drogato P ed uno drogato N. Si tratta tuttavia di un diodo particolare, in cui il semiconduttore drogato P ha uno spessore sottile, così da permettere alla luce di penetrare nella regione prossima alla superfcie della giunzione: qui le coppie elettrone-lacuna, create per effetto fotoelettrico interno , migrano nel campo elettrico della giunzione e generano in un circuito esterno una corrente fotovoltaica.Esistono due tipi di sistemi fotovoltaici: gli impianti senza accumulo e collegati alla rete elettrica (grid connected) e quelli con accumulo (stand alone). Questi ultimi sono provvisti di accumulatori per rendere disponibile durante la notte e in condizioni climatiche non favorevoli l’energia prodotta durante il giorno e specialmente nelle ore di sole. L'energia viene conservata in batterie (normalmente piombo-acido) ed un regolatore di carica impedisce che la tensione di carica superi un certo valore per salvaguardare l'integrità degli accumulatori. Gli impianti senza accumulo sono
normalmente utilizzati per fornire energia a una rete elettrica già alimentata da generatori convenzionali e servono ad immettervi altra energia.La quantità di energia prodotta da un impianto fotovoltaico varia nel corso dell’anno e dipende da una serie di fattori, quali l’ubicazione del sito e le condizioni meteorologiche. Ovviamente prima di realizzare un impianto energetico vengono installate stazioni meteo tramite cui monitorare le zone migliori per trarre vantaggio dalle risorse rinnovabili.L’Italia è favorita dalle condizioni climatiche per quello che riguarda la produzione di energia tramite impianti fotovoltaici. Infatti questi impianti producono in un anno circa 1.100-1300 kWh nel Nord Italia, 1.100-1.500 kWh nel Centro Italia e 1.300-1.800 kWh nel Sud Italia. Considerando che un circuito solare di 1.200 Wp (Watt picco: potenza teorica massima producibile da un generatore elettrico) può produrre energia suffciente per coprire un'abitazione con un consumo annuale di circa 2.000 kWh (3-4 persone con attenti consumi elettrici), si tratta di una fonte da non sottovalutare.Per incentivare l’installazione e l’utilizzo di impianti domestici è nato nel 2003 il “Conto Energia”, che però è stato modifcato negli anni. Oggi, a differenza del passato in cui l'incentivazione all'utilizzo delle fonti rinnovabili avveniva mediante assegnazioni di somme a fondo perduto grazie alle quali il privato poteva limitare il capitale investito, il meccanismo del conto energia è assimilabile ad un fnanziamento in conto esercizio, in quanto non prevede alcuna facilitazione particolare da parte dello Stato per la messa in servizio dell'impianto.
Il privato proprietario dell'impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, con cadenza tipicamente mensile, per i primi 20 anni di vita dell'impianto. Condizione indispensabile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso alla rete (grid connected). La dimensione nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere
superiore a 1 kWp. Non sono incentivati dal Conto energia quegli impianti fotovoltaici destinati ad utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica.Un’altra fonte energetica è costituita dal calore della Terra negli strati più profondi della crosta. Tale calore, seppure presente in quantità enormi (si valuta che il fusso totale di calore verso la superfcie della terra sia di 16 TW) e praticamente inesauribile ,risulta essere poco concentrato e diffcilmente raggiungibile, eccetto che in condizioni particolari. Esistono nella crosta terrestre delle zone privilegiate in cui il gradiente geotermico è nettamente superiore a quello medio (30 °C ogni km) il che è dovuto alla presenza a circa 5 o 10 km di profondità di masse magmatiche fuide o parzialmente solidifcate. L’energia geotermica qui presente viene resa disponibile a profondità accessibili dall’esistenza di serbatoi costituiti da cavità di rocce impermeabili che contengono acqua meteorica in forma liquida o gassosa. L’utilizzazione principale di tale energia è la generazione di energia elettrica dal vapore naturale, oltre a usi diretti del calore geotermico nel riscaldamento di edifci, serre o in processi industriali.L'Italia sfrutta il calore della Terra per produrre energia elettrica dall’inizio del Novecento, tramite la realizzazione di centrali elettriche geotermiche capaci di sfruttare la forza del vapore. Questo è stato possibile prevalentemente in Toscana, dove i giacimenti naturali di vapore producono ogni anno oltre 4 miliardi di kWh di elettricità nelle sole centrali di Larderello (Pisa) e di Montieri (Grosseto).A livello mondiale il Paese che maggiormente impiega la geotermia è l'Islanda, dove l'85% delle case è riscaldato con questa fonte energetica. La grande isola del Nord Atlantico basa l'intera sua esistenza sul naturale equilibrio tra la presenza di acqua calda in profondità e l'atmosfera esterna sotto zero. In California a The Geysers c’è il più grande impianto del mondo, con un potenziale di 1400 MW, suffciente a soddisfare le richieste energetiche dell'area metropolitana di San Francisco. Anche il Kenya e l'Etiopia hanno costruito degli impianti per l'energia
Fonti: www.wikipedia.it
InMeteo Magazine Settembre – Ottobre 2010 – Nr 11 7
ENERGIA
geotermica. Tra le energie pulite annoveriamo poi quella idroelettrica. Lungo il corso di fumi e di laghi si può sfruttarel' energia cinetica delle masse d’acqua nel superamento di un dislivello o della naturale corrente, che grazie ad un alternatore accoppiato ad una turbina, si può trasformare in energia elettrica. Si tratta di una risorsa rinnovabile, disponibile ovunque esista un suffciente fusso d'acqua costante.Gli impianti possono essere di diversi tipi, ovvero ad acqua fuente (quando sono posizionati sul corso d'acqua), a bacino (quando l'acqua è raccolta in un bacino grazie a un'opera di sbarramento o diga), oppure ad accumulo (nel caso in cui l'acqua viene portata in quota per mezzo di pompe). Nell'ultimo decennio si stanno sviluppando anche sistemi da installare in un contesto marino, utilizzando il potenziale delle onde, delle maree, delle correnti marine o del gradiente di temperatura tra fondo e superfcie degli oceani.Attualmente nel mondo sono installati 740.000 MW di impianti idroelettrici, con una produzione di 3.200 TWh che rappresentano circa il 20% dell'attuale consumo di energia elettrica. Gli scienziati concordano sulla possibilità di accrescere la produzione totale di energia idroelettrica fno a 5 volte quella attuale: in pratica l'energia idroelettrica può soddisfare l'attuale richiesta di energia elettrica. Secondo il rapporto annuale della BP (Statistical review of world energy 2003), riconosciuto globalmente come tecnicamente affdabile, solo il 10% del potenziale idroelettrico è utilizzato. Questo signifca che, se concretamente utilizzate, le risorse idroelettriche potrebbero fornire 2 volte l'attuale richiesta di energia elettrica.Per lo sfruttamento delle risorse idriche i costi di produzione possono essere considerati imputabili ai soli impianti di produzione, dato che quelli relativi alle materie prime sono marginali. Questo fa si che il costo del KWh così ottenuto risulta competitivo nei confronti delle fonti esauribili. In generale il tempo di ammortamento degli impianti idroelettrici è valutabile in 8-10 anni, mentre il tempo di funzionamento è in media superiore ai 30 anni (non sono rari gli impianti operativi da un centinaio d'anni).In ultimo citiamo come fonte di energia rinnovabile la biomassa, intesa come sostanza di matrice organica destinata a fni
energetici o utilizzabile in questo senso, e che in realtà rappresenta una sofsticata forma di accumulo dell’energia solare. Le biomasse che sono considerate fonti rinnovabili sono quelle per cui il tempo dello sfruttamento è paragonabile a quello di generazione e che vengono generate tramite pratiche ad impatto ambientale trascurabile o addirittura nullo (come ad esempio le operazioni di manutenzione boschiva). Materie plastiche e combustibili fossili ovviamente non rientrano in questa categoria. Sono invece classifcabili come biomasse tutti i residui di coltivazioni agricole e forestazioni, gli scarti dei prodotti agro-alimentari, i residui non trattati chimicamente dell’industria della lavorazione della carta del legno, i prodotti organici derivanti dall’attività biologica dell’uomo e degli animali.A seconda del tipo di biomassa di cui si dispone se ne fa un diverso utilizzo. La si può lavorare tramite processi termochimici (come la combustione) o biochimici (come la metabolizzazione ad opera di batteri), ottenendo calore, biocarburanti, biocombustibili per la produzione di energia elettrica, biogas.La disponibilità di biomassa non è continua ma stagionale, sono dunque necessarie grandi zone per lo stoccaggio del materiale. Inoltre la sua produzione necessita dell’impiego di vaste aree, infatti basti pensare che per alimentare a biomassa un impianto costituito da quattro gruppi da 660 MW sarebbe necessario dedicare alla sua coltura una superfcie di circa 6.400 km2 . Comunque la combustione di biomassa di tipo legnoso ha un minore impatto nell’emissione di anidride carbonica rispetto a quella delle risorse fossili, e tramite una opportuna riforestazione si può compensare tale emissione.Quando l’alimentazione di un impianto a biomassa avviene tramite prodotti di scarto delle zone circostanti si realizza la condizione ideale di utilizzo della fonte rinnovabile. Il sistema energetico a biomassa è di taglia medio piccola (produzione inferiore a 20 MW), quindi può sostenere la richiesta di zone limitate, indicativamente nel raggio di circa 70 km.Si legge in un articolo della FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da fonti Rinnovabili) che in Italia si potrebbero realizzare, soprattutto in zone alpine, prealpine ed appenniniche, non ancora raggiunte dalla metanizzazione, ma
anche nelle isole, ed in Comuni con popolazione di circa 4.000 abitanti, 400 impianti di teleriscaldamento con potenza compresa fra i 5 ed i 10 MW termici ed eventuale ulteriore produzione elettrica compresa da 1 a 2 MW elettrici per impianto ottenendo quindi una potenza termica media di circa 3.000 MW ed elettrica di circa 400 MW. L’investimento per la realizzazione di queste opere può essere preventivato in circa 7.000 Milioni di Euro. La quantità di biomassa (legnosa) richiesta sarebbe dell’ordine di almeno 4 milioni di tonnellate all’anno, in parte sostitutiva degli attuali impieghi a bassa effcienza in parte raccolta come sottoprodotti, in maggior parte da produrre dal rilancio della coltura e manutenzione dei boschi e da colture dedicate (Short Rotation Forestry), sostituendo così l’utilizzazione di circa 1 milione di tonnellate di fonti fossili (gasolio) e mancate emissioni di circa 3 milioni di tonnellate di CO2.Fonte: http://www.fper.it/fleadmin/user_upload/cosa_facciamo/Position_Paper_Fiper.pdf
Considerando ciò che è stato fn qui detto ci sembra evidente la possibilità di ottenere tutta l’energia elettrica e termica necessaria all’uomo da fonti rinnovabili. Basterebbe realizzare altri impianti ecocompatibili che sfruttino al meglio le condizioni meteorologiche e geomorfologiche di ciascun sito e che immettano l’energia prodotta sul circuito globale. Si tratta di una soluzione tecnicamente ed economicamente attuabile: le fonti rinnovabili sono il nostro futuro.
Fonti: www.wikipedia.it
InMeteo Magazine Settembre – Ottobre 2010 – Nr 11 8
AMBIENTE
IMPRONTA DEI GAS
SERRA: ITALIA ED
EUROPA ANCORA
SOTTO NORMA
di Giancarlo Modugno
Uno studio dell'università di Trondheim e del Centro di Ricerca Internazionale sul Clima e Ambiente di Oslo, in Norvegia, ha portato alla luce “l'impronta” della CO2 di 73 nazioni in tutto il mondo, ovvero un indice che spiega quanto incide la produzione di questo questo gas serra. I processi che causano le emissioni di gas serra producono dei benefci che si traducono in possibilità di avere a disposizione cibi e servizi. Questi benefci, insieme alla responsabilità per le emissioni, variano a seconda dello scopo o della categoria di consumo e sono distribuiti uniformemente. Sono stati analizzati i contributi di otto categorie: costruzioni, riparazioni, cibo, abbigliamento, mobilità, prodotti manifatturieri, servizi e commercio. La media pro capite dell'impronta varia da una 1 tonnellata di CO2 all'anno nelle nazioni africane a circa 30 tonnellate in Lussemburgo e negli Stati Uniti. A livello globale il 72% delle emissioni di gas serra sono relative ai consumi familiari, il 10% ai consumi governativi e il 18% agli investimenti. Il cibo è responsabile per il 20% delle emissioni, costruzioni e manutenzione delle abitazioni per il 19% e la mobilità per il 17%.Il cibo e i servizi sono molto importanti per i Paesi in via di sviluppo, mentre la mobilità e i prodotti manifatturieri dominano nei Paesi ricchi.
Nello studio dei ricercatori e anche sul sito http://www.carbonfootprintofnations.com è possibile visualizzare quanto e per cosa ogni nazione studiata produce CO2. Abbiamo creato una classifca europea, nonché analizzato quanto avviene in Italia (grafco riassuntivo nell'immagine in alto).
L'indicatore di riferimento è l'impronta di diossido di carbonio pro capite, misurata in tonnellate di CO2 equivalenti. Nella classifca Europea delle nazioni più
inquinanti spuntano sul podio Svizzera(18,4), Finlandia (18) e Olanda (16,7). L'Italia (11,7) si posiziona all'undicesimo posto, subito dopo la Francia e prima della Spagna ma la legenda (vedasi immagine in basso) indica che siamo ancora molto lontani dal valore medio mondiale, nonché dai valori defniti sostenibili. Le uniche nazioni che non rientrano nella zona “rossa” sono Romania (5,2), Turchia (4,6) e infne Albania (2,5).
L'analisi generale indica che quasi tutta l'Europa è ben lontana dal livello di emissioni di anidride carbonica sostenibile e l'Italia non è esclusa.
Il termine “Carbon Footprint” include le emissioni dei gas serra relative all'utilizzo di carburante e energia utilizzata nelle abitazioni (impronte defnite “dirette”) e allo stesso tempo le emissioni prodotte nell'intero ciclo di produzione che riguarda la produzione di beni (impronte defnite “indirette”). Un automobile inquina non solo perché è sede di processi di combustione ma anche a causa del processo di lavorazione; anche l'insalata imbustata che troviamo al supermercato ha bisogno di energia, precisamente quando la si lava, quando la si trasporta da un continente all'altro e quando si produce la busta che la conterrà.
L'Italia produce circa 700 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, che divise per il numero di abitanti restituisce proprio il valore 11,7 (immagine a lato). Se consideriamo questo dato totale, non contando il numero di abitanti di ogni nazione, notiamo che la classifca cambia notevolmente: ora sul podio troviamo Russia (1500), Germania (1200) e Regno Unito (900). L'Italia sale di due posizione arrivando al quinto posto, preceduta dalla
Francia (800) e seguita ancora una volta dalla Spagna (430). Svizzera (130), Finlandia (90) e Olanda (250) si posizionano questa volta nella seconda metà della classifca. Si nota che si può dividere la classifca in due parti: le over 400 e le under 400. Nella prima, la quale contiene le nazioni più inquinanti, vi è un numero limitato di “partecipanti” e a loro si attribuisce solitamente la denominazione di “super potenze europee”.
Fonti: http://www.carbonfootprintofnations.com http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es803496aImmagini tratte dal sito http://www.carbonfootprintofnations.com