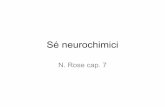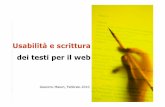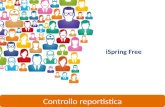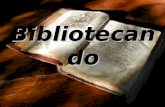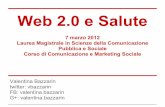BibliotecAscuola
-
Upload
lucrezia-avitto -
Category
Education
-
view
138 -
download
0
Transcript of BibliotecAscuola

ITE “Vitale Giordano” - BitontoD.S. prof. Arcangelo Fornelli
Progetto “BibliotecAscuola”
presso la
Biblioteca Comunale “Eustachio Rogadeo” - Bitonto
in convenzione con l’Istituto “Luigi Sturzo” di Roma
Classe IB AFM a.s. 2015/2016

Il progetto “BibliotecAscuola”, promosso dall’Istituto “Luigi Sturzo” di Roma all’interno delle attività del SAC Nord Barese, ha come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi in età scolare alla Biblioteca, intesa come centro non solo di conservazione libraria e di studio, ma anche come luogo di aggregazione sociale, confronto, scambio e crescita culturale.
Gli argomenti trattati sono stati scelti come approfondimento alle U.D.A. programmate dalla docente di lettere per l’a.s. 2015/2016.
Il progetto ha visto il pieno coinvolgimento della classe IB AFM dell’ ITE “ V. Giordano” di Bitonto in una serie di attività legate alla conoscenza del territorio bitontino, all’approfondimento di tematiche storico-letterarie e alla produzione di elaborati personali e originali legati a un percorso di scrittura creativa.


Il tutto è stato reso possibile grazie al progetto SAC Nord Barese, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Sistemi Ambientali e Culturali, una modalità di gestione integrata del patrimonio ambientale e culturale. Si tratta di un’iniziativa mirata a trasformare il sistema culturale e ambientale del territorio in un volano di sviluppo locale. Un’attenzione particolare nel progetto è riservata all’integrazione dei diversi beni culturali, alla massima fruizione dei patrimoni, alla valorizzazione turistica e all’occupazione giovanile. Grazie al potenziamento dei primitivi ambienti della Biblioteca Comunale, il Salone affrescato, nel quale si sono tenuti gli incontri programmati, è stato trasformato da sala deposito in aula polifunzionale e centro di presentazioni, conferenze e dibattiti.

Facciamo un po’ di storia…
La Biblioteca Comunale “Eustachio Rogadeo” si trova su via Giandonato Rogadeo (già via Mercanti), parte integrante del duecentesco palazzo della famiglia, proveniente da Ravello. Addossata al palazzo c’è l’antica chiesetta famigliare (1204), intitolata a sant’Anna e sede, dal 1551, del Sedile dei nobili della città. L’ingresso principale della cappella, che dà su via Mercanti, si trova all’interno di un arco che riporta gli stemmi delle 18 famiglie nobili che governavano Bitonto alla metà del XVII secolo.

La Biblioteca, che conserva ancora alcune stanze con gli affreschi e gli arredi originali, fu donata al Comune di Bitonto nel 1966 dall’ultimo discendente del casato, il conte Franco VIII (1892 - 1985). Fu intitolata a Eustachio III Rogadeo (1855 - 1920), illustre paleografo e studioso di storia locale.

alcuni arredi originali della Sala Rogadeo (studio e divise da parata del conte Franco
Rogadeo)

La Biblioteca conserva materiale raro e prezioso, tra cui l’Evangelario miniato dell’XI secolo, pergamene e manoscritti antichi, incunaboli e cinquecentine.

Tra i reperti conservati in loco, ci siamo soffermati su un’antica moneta peuceta (IV-III sec. a. C.) raffigurante su una faccia il volto di profilo della dea Atena, sull’altra una spiga di grano; la moneta è oltremodo interessante perché riporta in greco antico la scritta BUTONTINWN (traducibile in “gente di Botone”), in riferimento al leggendario fondatore della città.

Perché proprio Atena a Bitonto? Basta guardarci attorno: la città è letteralmente sommersa fra gli ulivi, sin dall’antichità considerati alberi sacri alla dea, che li avrebbe creati in occasione di una mitica contesa che l’avrebbe opposta al dio Posidone per il dominio dell’Attica. Molto rappresentata da pittori e scultori con i suoi attributi tipici (come l’elmo, la lancia e lo scudo, l’egida, la Nike e la testa della gorgone), era dea molto venerata perché protettrice delle arti e dispensatrice di saggezza.

Il suo animale totem è la civetta, di cui ha assimilato alcune caratteristiche, in particolare gli occhi e la vista. La civetta compare spesso nelle antiche raffigurazioni della divinità (a volte è la stessa divinità che appare con gli elementi caratteristici dell’animale, come gli occhi, le ali e gli artigli). Atena era definita «glaucopide» (traducibile come «dallo sguardo scintillante»), un termine che ha la stessa radice del termine greco usato per indicare la civetta.

A Bitonto è attestato sin dall’antichità un culto molto forte per Atena: nell’antica zona acropolare della città, esattamente dove ora sorge la chiesa di san Pietro in Vincoli, c’era un tempio dedicato alla dea, di cui abbiamo testimonianza in alcuni reperti rinvenuti in loco: in particolare, una lastra votiva in cui è menzionata la stessa dea:
MINERVAESACRUM
C. MARIUSC NOINU(S)
(V) S.

Secondo la tradizione, san Pietro, nel suo viaggio per Roma, sarebbe giunto anche a Bitonto (intorno alla metà del I secolo d. C.) e avrebbe sradicato il culto pagano locale, nominando Apollinare primo vescovo della città e ponendo le basi per la costruzione della chiesetta in luogo del tempio della dea. Secondo un’altra leggenda, le colonne del tempio furono riutilizzate nella cripta della Cattedrale cittadina.

A ben guardare, Atena è ancora presente in città: i tanti volti grotteschi scolpiti su case e palazzi, dalla chiara funzione apotropaica, rimandano direttamente al capo mozzato di Medusa, che aveva la capacità di pietrificare i nemici della dea e che, in tempi moderni, serve a scacciare malelingue e altri influssi negativi.
La bellissima Medusa aveva osato paragonare il suo aspetto a quello di Atena, che l’aveva punita trasformandola in un mostro anguicrinito e dallo sguardo mortifero; fu uccisa dall’eroe greco Perseo, utilizzando il sua scudo come specchio per non guardare direttamente il mostro negli occhi. Fu la stessa Atena a suggerirgli il trucco. L’eroe donò poi il macabro trofeo alla dea, che lo appose sul suo scudo per terrorizzare i suoi nemici.

Alcune curiosità…
Vi ricordate la moneta da 100 lire? Su una delle sue facce era proprio raffigurata la dea Atena/Minerva, vestita di peplo e coperta dal caratteristico elmo, con la mano destra poggiata su un alberello di ulivo. Pensate poi a due grandi marchi, la Nike e Versace: il primo rimanda direttamente alla dea Nike, che accompagnava Atena nelle sue imprese, favorendone la vittoria; il secondo ha come logo proprio la testa di Medusa, di cui abbiamo parlato.

La lettura del V canto dell’Odissea, che celebra l’incontro tra Odisseo e Nausicaa (voluto proprio da Atena), ci ha offerto lo spunto per sviluppare una nostra storia originale, sfruttando i dettami della scrittura creativa. In particolare, abbiamo immaginato di essere anche noi naufraghi, sbarcati in una Bitonto antica: sulla base di alcuni termini forniti in aula (supplico, bellezza, tempeste, pietà, accordo, folle, popolo), abbiamo prodotto diversi racconti di stampo mitologico.

“Vi supplico, o mia signora di infinita bellezza, di avere pietà di me e del mio popolo
che, nonostante le varie peripezie affrontate durante folli tempeste, è giunto sulle sponde del
fiume Tiflis.Confidiamo nella vostra generosità
nel volerci ospitare in questa splendida e solare terra degli ulivi.
Siamo certi che il nostro popolo vi sarà riconoscente”
Cifarelli AriannaGiampalmo Angelica
Traetta GigiCarelli Luigi
Ricci Gianluca Spadafino Gaetano

“Bellissima creatura,sono naufragato in un paese a me sconosciuto e
ho trovato voi, gentilissima e divina, di una meravigliosa bellezza. Vi supplico, abbiate pietà di me accoglietemi nella vostra patria affinché io
possa conoscere di quale natura sia il vostro popolo.
Accompagnatemi alle rive del fiume Tiflis in modo che io possa purificarmi nelle sue limpide acque e
donatemi un ramoscello d’ulivo in modo che io possa ricordare in futuro la vostra clemenza e la
vostra benevolenza.”
Garofalo ClaudioSouii Omar
Caputo OnofrioIuliano Raffaele

Dea Atena, la vostra bellezza è fresca come una palma.
Il vostro coraggio e la vostra intelligenza mi incantano. Vi supplico di avere pietà di me, di questo naufrago che ha bisogno di aiuto dopo tutte le estenuanti tempeste vissute in questi anni, che mi hanno portato sulle sponde del fiume Tiflis. Con queste mie folli parole vi
supplico di annunciare al vostro popolo di un accordo tra la vostra maestà e questo povero uomo e di volermi ospitare nella vostra amata
città di Bitonto.
Garofalo ValentinaDe Santis Debora
Mundo Angela Allegretti Domenico
Vacca Davide

“O bella dea Atena,con questa umile preghiera
ti supplico di donarmi la tua infinita pietà. Ti chiedo di stringere un accordo fra il popolo
bitontino e la tua nobile discendenza ,tanto che sia paragonabile
all’incredibile potenza sprigionata da una folle tempesta.”
Chiapperini LorenzoSomma Michele Tutino CristianVillani Antonio
Mongiello Alessandro

Il nostro percorso è proseguito con un seminario di approfondimento su due generi letterari molto conosciuti, soprattutto da bambini e ragazzi: la favola e la fiaba. Sinonimi solo nel nome (che deriva dal verbo latino «far, faris» = «dire», «raccontare»), si differenziano per diversi aspetti. La favola è un componimento breve e dalla morale ben evidenziata, i cui protagonisti sono animali dal comportamento umano. Uno dei più grandi autori del genere fu il greco Esopo (VI sec. a. C.), le cui fiabe sono diventate talmente famose che le ritroviamo in alcuni detti moderni, come «Al lupo! Al lupo!», «fare come la cicala con la formica» e «la volpe che non arriva all’uva dice che è acerba».

Più lunga e articolata, la fiaba si distingue essenzialmente per il ricorso a personaggi fantastici (fate, orchi, gnomi, etc.), per una morale sottintesa e, soprattutto, per il ricorso all’elemento magico, totalmente assente nella favola. Si tratta di un racconto che nasce dal popolo, non prettamente per bambini: erano infatti soprattutto gli adulti a raccontarsi queste storie per vincere la fatica del lavoro e procurarsi occasioni di svago; in particolare, le donne (costrette a rimanere in casa e a curare l’educazione dei figli) diedero vita a numerosi racconti che le videro protagoniste indiscusse.

Il mondo delle fiabe è senza spazio né tempo (pensate ai «C’era una volta» di apertura, che non indicano un contesto storico preciso; oppure alle formule come «in un paese molto lontano», in cui manca qualsiasi riferimento geografico), pieno di personaggi inverosimili, che spesso nascono poveri e derelitti per poi diventare, nella classica apoteosi finale, re o principesse. Per questo motivo «romantico», diverse fiabe sono ambientate in età medievale, epoca in cui dominava la monarchia.
Il mondo delle fiabe è nettamente diviso in due e la ragione non sta mai al centro (abbiamo parlato infatti di «manicheismo morale»); i motivi sono spesso ricorrenti, così da allungare la storia, renderla più chiara, prolungare la sensazione di mistero e facilitarne il processo di memorizzazione. Il linguaggio è quello del popolo, molto semplice e a volte un po' sgrammaticato, ma ricco di modi di dire e di formule popolari.

Abbiamo preso in esame un autore romano di epoca classica, Lucio Apuleio (125 - 170 circa), scrittore, sacerdote, filosofo e mago di scuola platonica, noto per il romanzo «Le metamorfosi (o Asino d'oro)»: si tratta dell’unico romanzo in lingua latina risalente all'epoca romana pervenutoci integralmente. L’opera è diviso in 11 libri.

Ci siamo soffermati, nella fattispecie, sulla favola di Amore e Psiche, in cui una fanciulla di straordinaria bellezza suscita l'invidia di Venere, che manda suo figlio Cupido affinché la faccia innamorare dell'uomo più brutto della terra; ma il giovane, vedendola, se ne innamora e la porta con sé in un castello. Psiche non resiste al divieto che le vieta di conoscere la vera identità dell’amato e, istigata dalle sorelle invidiose, spia Amore mentre dorme: il giovane dio, svegliato da una goccia di cera della candela che Psiche teneva in mano, fugge per non far più ritorno. Psiche affronterà numerose e pericolose avventure prima di ritrovare Amore e di diventare, infine, la sua sposa.

La favola ha un significato allegorico: Cupido, dio dell'amore e del desiderio, unendosi a Psiche (che in greco significa «anima») le dona l'immortalità. Tuttavia questa, per giungervi, dovrà affrontare quattro durissime prove, tra cui quella di scendere agli Inferi per purificarsi. La storia ha un significato mistico: le prove che la donna dovrà affrontare sono simbolo delle iniziazioni religiose al culto di Iside, di cui Apuleio era sacerdote.

Sulla scorta delle informazioni ricevute, abbiamo sviluppato un racconto in cui sono confluiti in «crossover» personaggi di storie diverse, legate alla favola di Amore e Psiche e a quella del lupo e dell’agnello, con innesti ricavati dall’Odissea (il ciclope Polifemo e la dea Atena). Dopo aver abbozzato un canovaccio, decidendo ambientazione, collocazione temporale, personaggi principali, intreccio e morale, abbiamo strutturato una nostra personalissima fiaba, liberi di scegliere se dotarla di un lieto fine oppure di un finale tragico. Questi i prodotti del laboratorio:

“C’era una volta un Ciclope che era innamorato di Psiche e un giorno decise di incontrala e parlarle dei sentimenti che provava per lei. Dopo qualche giorno, ingenuamente Psiche decide di rivederlo, portando con sé un agnello che rappresentava per lei una difesa. Psiche, così, arrivò alla grotta del Ciclope e si avvicinò a lui per parlargli; il Ciclope, che in precedenza aveva preparato una trappola, si avvicinò a Psiche e lasciò cadere dall’alto una gabbia da cui lei non poteva più liberarsi.Nel frattempo dalla grotta si udirono le urla di Psiche che tentava invano di liberarsi. Così amore, sentendo le urla, con l’aiuto del lupo si incamminò su un percorso che conduceva alla grotta. Una volta lì, vide Psiche intrappolata nella gabbia e per salvarla mandò il lupo a distrarre il Ciclope; così Amore si diresse verso la gabbia, liberò Psiche e insieme fuggirono felici e contenti”.
Garofalo Claudio De Santis Debora Giampalmo AngelicaMundo Angela Vacca DavideMongiello Alessandro

“C’era una volta, in una casa in campagna, una ragazza di nome Psiche. Un giorno, mentre portava il suo agnello a bere l’acqua al fiume, si accorse che più lontano c’era un ciclope di nome Polifemo con il suo lupo. Psiche fece finta di non vederli ma poi si accorse che il lupo stava guardando l’agnello in modo aggressivo e in quel momento capì che il lupo era addestrato ad aggredire gli animali più piccoli. Psiche amava il suo agnello e quindi chiede al ciclope di allontanare il lupo; invece Polifemo, essendo un mostro senza pietà, ordinò al lupo di attaccare l’agnello e quello subito obbedì.Poi Polifemo rapì Psiche e la portò nella sua grotta, dove rimase imprigionata per sempre. La morale di questa favola è che il più forte vince sul più debole”.
Somma MicheleAllegretti DomenicoCaputo OnofrioSouii OmarVillani Antonio

“C’era una volta nell’antica città di Bitonto il Dio dell’amore Cupido, che si era perdutamente innamorato, e ricambiato, di Psiche. Un giorno Cupido tornò a casa e non trovò Psiche: disperato, si mise alla sua ricerca. Durante il cammino, un lupo mandato da Polifemo stava per colpirlo alle spalle ma interviene un piccolo agnello che, grazie ai suoi poteri, lo trasformò in una piccola pianta e se la mangiò. Dopo aver vinto contro il lupo, con astuzia Cupido e l’agnello si diressero verso Polifemo nel tentativo di recuperare Psiche. Arrivato nella grotta dove Polifemo teneva prigioniera Psiche, Cupido escogitò un piano: lui distrasse Polifemo e l’agnello portò Psiche al sicuro; così Cupido combatté contro Polifemo e, dopo tanta fatica, riuscì a sconfiggerlo. Così Psiche e Cupido vissero felici e contenti”.Garofalo ValentinaCifarelli AriannaTraetta Gigi Carelli Luigi Spadafino Gaetano Tutino Cristian

Infine abbiamo affrontato un genere letterario molto in voga nei secoli, sin dall’antichità: la novella. Si tratta di una narrazione in prosa breve e semplice, più breve di un racconto, nella quale c'è un'unica vicenda semplice e in sé conclusa, colta nei suoi momenti essenziali, i cui personaggi si possono facilmente ritrovare nella vita quotidiana. Essa nasce, non si sa con precisione dove e quando, nel contesto della letteratura orale. Tracce di novella sono presenti nelle letterature dell'antico Egitto e della Mesopotamia (Sumeri, Babilonesi). Celebre la raccolta di novella universalmente conosciuta come “Le mille e una notte”.

Alla base della struttura che la novella assumerà, troviamo l'exemplum medievale, una forma semplice di novella a metà strada tra la fiaba e la parabola, inglobato in altri generi, come la vita dei Santi, perché era usato molto spesso dai predicatori con finalità educative e morali, per ricondurre sulla giusta strada coloro che avevano commesso qualche peccato: si veda, per esempio, l’episodio legato alla vita di san Nicola, relativo alla carità fatta alle tre fanciulle povere, da cui si svilupperà l’iconografia delle tre sfere e, successivamente, la figura di Babbo Natale.
La novellistica ha, nel Duecento italiano, un esempio nel Novellino, opera in prosa composta da un autore di area toscana nella seconda metà del XIII secolo: comprende aneddoti e brevi narrazioni che avevano valore di insegnamenti ed esortazioni, e perciò erano tanto più efficaci quanto più brevi e calzanti.

Nel corso del Trecento, la novella si sviluppa in due generi distinti: il primo, d’ispirazione morale e religiosa, vede l’esempio maggiore nei “Fioretti di San Francesco”, una serie di racconti legati alla vita del santo, tra realtà e agiografia, scritti da un anonimo frate francescano.
Il secondo genere è più legato al diletto del pubblico e sviluppa una serie di racconti legati a vicende di carattere quotidiano, molto spesso carichi di contenuti tra il faceto e il licenzioso: parliamo, in particolare, della più famosa raccolta di novelle del periodo, composta e sviluppata dal grande Giovanni Boccaccio (1313 - 1375).

Il “Decameron” si compone di cento novelle che un gruppo di dieci giovani fiorentini (tre uomini e sette donne) di nobili natali si raccontano per trascorrere in allegria le giornate nelle campagne fiorentine: erano infatti fuggiti dalla città a causa dalla peste nera che l’aveva colpita nel 1348. All’interno di questa cornice, sapientemente sviluppata da Boccaccio per contestualizzare l’opera, ogni ragazzo racconta agli altri una novella al giorno per dieci giorni (da cui l’etimologia del titolo dell’opera); i temi sono decisi di volta in volta dal Re o dalla Regina della giornata, precedentemente eletti. Solo Dioneo, per la sua giovane età, è esentato dal vincolo ma sarà sempre l’ultimo a recitare.

Nel proemio all’opera, Boccaccio spiega di volere dedicare il Decamerone a tutti coloro che soffrono le pene d’amore, così che possano trovarne svago e diletto: in particolare, dedica la sua opera alle donne, in primis perché, costrette in casa a dedicarsi all’educazione della prole, non avevano la possibilità di concedersi gli stessi svaghi maschili; poi, perché avevano più tempo libero per dedicarsi alla lettura delle sue opere. In definitiva, Boccaccio si rivolge alla classe borghese fiorentina, agiata e colta, di cui lui stesso faceva parte. Nella conclusione, Boccaccio afferma che l’intento dell’opera è quello di mostrare ai fiorentini che è possibile rialzarsi da qualunque disgrazia si venga colpiti, seguendo l’esempio dei dieci giovani.

Il mondo del “Decamerone” è popolato da una serie di personaggi, dipinti con vivacità e precisione, difficili quindi da dimenticare. Che siano belli o brutti, nobili o poveri, astuti o sciocchi, tutti vivono in bilico tra due forze, una esterna e una interna: la Fortuna e la Natura.
La Fortuna è una forza esterna, piomba dall’alto e sconvolge in un attimo ogni situazione, ma l’uomo può rivolgerla a proprio favore utilizzando l’astuzia; la Natura è invece una forza interna a ogni uomo, è il richiamo dei sensi, fortissimo e invincibile, che tuttavia deve essere mediato dalla ragione.

Abbiamo analizzato due novelle del “Decamerone”: la tragica e commovente “Lisabetta da Messina”, e la divertente “Chichibio e la gru”; abbiamo inoltre accennato a una novella, la decima della nona giornata, in cui Boccaccio fa esplicito riferimento alla Fiera di San Leone, antichissima e famosa anche ai suoi tempi, che si tiene a tutt’oggi il 6 aprile.
Partendo dall’analisi della citazione bitontina nella novella («compar Pietro con uno asino, come usato era, attese a fare il suo mestiere antico, e con donno Gianni insieme n’andò alla fiera di Bitonto»), abbiamo immaginato una vicenda ambientata nella Bitonto dell’epoca, facendo riferimento alla suddetta fiera e sviluppandone contenuti originali:

“Il giorno 6 aprile compare Pietro e Don Gianni si dirigono verso la fiera di San Leone per comprare orzo, olio, vino. Arrivati alla fiera lasciano l’asinello incustodito vicino a un albero d’ulivo e intanto vanno a fare i loro acquisti, non trovando le spezie che desideravano e comprando l’indispensabile. Intanto l’asinello ha bisogno di dissetarsi e, non avendo la possibilità di allontanarsi dall’albero d’ulivo, beve da una vecchia fontana trovata lì vicino; tuttavia l’acqua è sporca e piena di germi e dopo un po’ di tempo l’asinello muore. Arrivati vicino all’albero dove avevano lasciato l’animale, i due compari lo trovano morto e, non avendo più il loro mezzo di trasporto, sono costretti a portare i loro acquisti in spalla fino alla casa situata sul fiume Tiflis”.Traetta Gigi Mundo AngelaSomma Michele Allegretti DomenicoVillani Antonio

“Pietro smise di lavorare e andò con Don Gianni e il loro asino alla famosa fiera di Bitonto chiamata “fiera di San Leone”: questa era una delle sei fiere più famose del Sud Italia e loro ogni anno, come di consueto, ci andavano. Arrivati in città, un cavallo impazzito corse verso di loro ed essi cercarono di difendersi con dei bastoni. Tutti risero e loro corsero impauriti in mezzo alla fiera cercando qualcosa per calmare il cavallo; vedendo un telo rosso pensarono di utilizzarlo sventolandolo davanti all’animale, come se fosse un toro. Il cavallo scappò e tutti applaudirono l’impresa”.
Giampalmo AngelicaGarofolo Valentina Ricci GianlucaCaputo OnofrioSouii OmarSpadafino Gaetano

“Pietro terminò il proprio mestiere e, insieme al suo ansino e a Don Gianni si recò alla fiera di Bitonto. Arrivati lì i due cercarono un posto dove lasciare l’asino, poi si trovarono nei pressi di una fontana dove incontrarono una bellissima donna che si accingeva a riempire le casse dell’acqua e aveva bisogno d’aiuto. Pietro si offrì di aiutarla e, appena lei alzò lo sguardo, se ne innamorò a prima vista. Passati dei giorni Pietro decise di confidare il suo amore alla donna, sperando che lei lo ricambiasse… ma non fu così. La donna gli disse che il suo cuore apparteneva a un’altra persona. Il giorno seguente, Don Gianni andò nella stanza dove alloggiava Pietro e lo trovò a terra senza vita, con accanto a lui una lettera in cui il giovane spiegava che la sua morte era dovuta alle sue pene d’amore. Dopo qualche giorno, Don Gianni, ancora disperato, ritornò al suo lavoro, sforzandosi di dimenticare la tragica fine del suo amico”.Cifarelli AriannaGarofalo Claudio Chiapperini LorenzoDe Santis DeboraVacca Davide

Gli alunni della IB AFM impegnata nelle attività di scrittura creativa.

Gli alunni della IB AFM impegnati nelle attività di scrittura creativa.




Progetto “BibliotecAscuola”
Alunni coinvolti: classe IB AFM – ITE “Vitale Giordano” Bitonto (BA)
Docenti coinvolti: prof.ssa Lucrezia AVITTO
prof.ssa Rosangela MAGRO
Referente SAC Nord Barese e docente dei seminari:dott. ric. Domenico SCHIRALDI