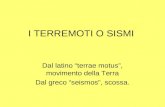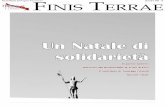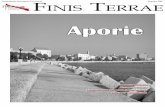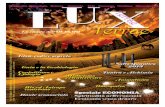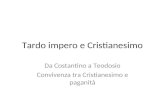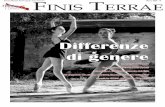PER UN'ANALISI LINGUISTICA DEL DE SITU TERRAE SANCTAE DI TEODOSIO (VI SEC. D.C.) L'USO DELLE...
-
Upload
edoardo-scarpanti -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
Transcript of PER UN'ANALISI LINGUISTICA DEL DE SITU TERRAE SANCTAE DI TEODOSIO (VI SEC. D.C.) L'USO DELLE...

PER UN'ANALISI LINGUISTICA DEL DE SITU TERRAE SANCTAE DI TEODOSIO (VI SEC. D.C.)L'USO DELLE PREPOSIZIONIAuthor(s): Edoardo ScarpantiSource: Aevum, Anno 79, Fasc. 2 (Maggio-Agosto 2005), pp. 239-248Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/20861709 .
Accessed: 15/06/2014 15:10
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Aevum.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Edoardo Scarpanti
PER UN'ANALISI LINGUISTICA DEL DE SITU TERRAE SANCTAE DI TEODOSIO (VI SEC. D.C.)
L'USO DELLE PREPOSIZIONI
II De situ Terrae Sanctae (ca. 530 d.C.) e una breve guida per il pellegrinaggio, che dal punto di vista iinguistico rappresenta un esempio molto interessante di latino volgare. Se ne inizia a studiare
qui, in particolare, l'uso delle preposizioni, che rivela spesso quelle peculiarita che ci si attende di ritrovare nella lingua dei testi tipologicamente affini, fra cui i piu noti Itinerarium Egeriae e Itin. Antonini Placentini. Proprio per il suo carattere di itinerarium, il De situ e particolarmente ricco di
espressioni formulari indicanti le tappe del percorso che viene presentato e commentato; la frequenza di preposizioni indicanti un movimento e, di conseguenza, particolarmente elevata. Si rilevano poi particolarita sintattiche tipiche del latino volgare, quali: la preferenza per i costrutti analitici, alcuni slittamenti nelle scelte dei casi, il declino di a nei confronti di de e diverse altre peculiarita.
Fra i piu interessanti esempi di itineraria ad loca sancta redatti fra il IV ed il VI secolo d.C. si colloca una breve opera nota come De situ Terrae sanctae, una
guida di viaggio per i pellegrini di lingua latina diretti a Gerusalemme, databile attorno all'anno 530 \ Tale testo rappresenta, anzi tutto, un note vole esempio di latino volgare, al pari del piu noto Itinerarium Egeriae e di altri scritti di pellegri naggio come VItinerarium Antonini Placentini, VItinerarium Burdigalense ed il Breviarium de Hierosolyma. In secondo luogo, l'opera riveste anche una grande importanza storica: insieme al successivo Itinerarium Antonini Placentini essa
rappresenta, di fatto, l'ultimo resoconto che ci possa dare un'idea della situazione della Gerusalemme bizantina prima delle conquiste arabe e delle crociate2. In questa
1 L'edizione critica qui seguita e quella curata da Geyer, piu volte adottata e ristampata pratica
mente senza variazioni in successive raccolte a partire dal 1898: Theodosii De situ Terrae Sanctae, ed. P. Geyer, in Itinera Hyerosolymitana saeculi IIII-VIII (CSEL XXXIX), Vindobonae 1898, 137
50; rist. anast: New York-London 1964; rist. con correzione di alcuni refusi in: Itineraria et alia
geographica (CCSL CLXXV), Turnholti 1965, 114-25; rist. in: PL Suppl IV, 1967, 1456-63. Si riporta la numerazione basata sulla suddivisione in 32 capitoli come compare nei volume di CCSL CLXXV
(1965). In mancanza di una traduzione italiana, si possono consultare quelle in lingua inglese, tedesca e francese: J. Wilkinson, Jerusalem pilgrims before the crusades, Warminster 20022 (19771), 103
16; H. Donner, Pilgerfahrt ins Heilige Land, Stuttgart 1979, 199-225; P. Maraval, Recits des premiers pelerins Chretiens au proche-orient: (IVe-VIIe siecle) textes choisis, presentes, traduits et
annotes par Pierre Maraval, Paris 1996, 186-201. Le concordanze e gli indici relativi al De situ Terrae Sanctae sono raccolti in CCSL CLXXVI,
547-88, 787-815; il testo e disponibile anche in formato elettronico nella raccolta CLCLT-5. Gli altri itineraria citati sono invece editi nei gia ricordato CCSL CLXXV; per YItinerarium Antonini
Placentini, si rimanda in particolare a C. Milani, Itinerarium Antonini Placentini. Un viaggio in
Terra Santa del 560-570 d.C, Milano 1977. 2 Notizie su Teodosio si possono reperire, fra gli altri, in: G. Auletta, Pellegrini e viaggiatori
in Terrasanta, Bologna 1963, 28; F. Mian, Gerusalemme cittd santa. Oriente epellegrini d'Occidente, Rimini 1988, 155-56; E. Menesto, Relazioni di viaggi e di ambasciatori, in Lo spazio letterario del medioevo. II medioevo latino, 1/2, Roma 1993, 545-46; K. Frank, Theodosius Archidiaconus, in
Lexikon des Mittelalters, VIII (1997), 646.
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

240 E. SCARPANTI
sede si vuole analizzare, in particolare, un aspetto della fades linguistica dell'o
pera, evidenziando le caratteristiche del latino di Teodosio che emergono dalFuso che l'autore fa dei costrutti preposizionali. Si sono registrate, a tale scopo, le occorrenze delle singole preposizioni in un riassunto ordinato alfabeticamente.
a / ab (8 occorrenze) La preposizione a / ab e anzi tutto regolarmente utilizzata con senso spaziale in alcune espressioni indicanti la distanza di un determinato luogo da un altro, come ad esempio in:
habens ab Hiericho milia XVIII (1, 3), e in due altri passi dello stesso tipo:
piscina Siloe a lacu, ubi missus est Hieremias... (8, 3); ab Alexandria Scabiosa usque Antiochia (32, 9).
L'uso di questa preposizione, come accade quasi sempre nel latino tardo, tende tuttavia inesorabilmente a declinare di fronte alia preferenza che viene accordata alia preposizione de: cosi, nel nostro testo se a / ab presenta solo otto occorrenze, de compare per ben novantun volte. I pochi casi in cui l'autore mostra di preferire a / ab rispetto a de non sembrano, pero, essere riconducibili ad una comune
matrice, come parrebbe invece di poter fare per il testo del Diario di Egeria, dove la scelta cade sulla preposizione a / ab quasi sempre quando ci si trova a descri vere un movimento che prende origine da un luogo sacro; cosi, ad esempio, troviamo: descendentes a monte Dei (Itin. Eg. 2, 3), e diversi altri casi simili3.
In altri passi del testo di Teodosio la preposizione e invece usata, ancora
regolarmente, per introdurre il complemento d'agente: ibi baptizatus est domnus Cornelius a domno Petro (4, 10); sanctae crucis, quando inuenta est ab Helena matre Constantini (31, 1).
Inoltre, essa si trova anche utilizzata in un modo invece decisamente particolare ed inconsueto, in un passo dove l'autore vuole spiegare come la citta di Zerapta fosse, in un tempo remoto, soggetta al piu grande centro di Sidone:
ipso tempore metropolis erat Sidona a Saraptha (23, 4), espressione nella quale sembrerebbe di poter dare alia preposizione un significato di complemento di specificazione, dove invece ci si aspetterebbe normalmente di ritrovare l'uso di un caso genitivo, del tipo: Sidona erat metropolis Saraptae. Lo stesso significato sembrerebbe nuovamente avere la preposizione nella frase:
a pinna templi subtus monasterium est de castas (11, 1). Sembra di poter intendere tale espressione come "sotto il pinnacolo del tempio si trova un monastero di monache", anche in questo caso con il significato, a quanto pare, di specificazione, sebbene il senso esatto della frase rimanga parzialmente oscuro. Questo uso della preposizione a / ab risulta comunque oltremodo partico lare e, fra le espressioni che nel latino tardo vanno sostituendo il caso genitivo, e estremamente meno frequente dell'uso, ad esempio, della preposizione de, sempre accompagnata al caso ablativo: lo si trova, invece, con una qualche maggiore frequenza, come sostituto dell'ablativo del secondo termine di paragone, anche in
questo caso pero assai meno comunemente della preposizione concorrente de\
3 Al riguardo, cfr. V. Vaananen, Le Journal-epitre d'Egerie (Itinerarium Egeriae): etude lingui
stique, Helsinki 1987, 35; altri casi analoghi nei testo egeriano sono in: 4, 1; 33, 2; 49, 3; 39, 3. 4 J.B. HoFMANN - A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, Munchen 1965 (Handbuch der
Altertumswissenschaft, II, 2), 58; V. Vaananen, Introduzione al latino volgare, Bologna 19823, 200-02;
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PER UN'ANALISI LINGUISTICA 241
Si segnala infine un'espressione in cui la preposizione in questione e utiliz zata in modo chiaramente ridondante:
ab unde Domnus baptizatus est, usque ubi... (20, 12).
absque (1 occorrenza) All'inizio della trattazione compare la preposizione absque, che generalmente ha il significato di "a parte, non considerando...", con il valore piu o meno corrispon dente al classico praeter; la frase in questione e la seguente:
Hierusalem habens portas maiores VI absque posticia (1, 1). II valore esatto della preposizione come viene utilizzata nella nostra espressione e, tuttavia, reso dubbio dalla differente interpretazione che e possibile fornire del termine posticia: se si trattasse di un ablativo singolare, la preposizione rispette rebbe l'uso classico, che richiede appunto il caso ablativo5; qualora invece volessimo intendere posticia come un accusativo plurale, cosi come ha fatto
Wilkinson6, la preposizione verrebbe a trovarsi accompagnata da un caso che normalmente le sarebbe stato del tutto estraneo.
Infine, ancora riguardo a tale preposizione, risulta forse interessante il confronto con due passi della Vulgata, entrambi dal libro della Genesi: duxit uxorem absque Us quas prius habebat (28, 9); ed ancora: domus Ioseph cum
fratribus suis absque paruulis (50, 8); sempre, dunque, con l'ablativo.
ad (40 occorrenze) Molto usata appare la preposizione ad, con quaranta occorrenze totali nel testo, diciassette delle quali anzi tutto ricorrono in una precisa espressione formulare, che indica le tappe degli itinerari che sono descritti nel De situ, come ad esempio:
de Hiericho usque ad fontem Helysaei milia II (1, 7). Tale espressione, frequentissima sin dal principio dell'opera, risulta formata dalla
preposizione de seguita dal luogo di origine in ablativo, cui seguono la formula
usque ad, la localita d'arrivo, il sostantivo milia ed infine un numero indicante la quantita delle miglia da percorrere. Lo schema ricorrente puo essere dunque riassunto con una formula sintetica di questo tipo:
de + L(l) + usque ad + L(2) + milia (o: passus) + N
Si considerino cosi alcuni esempi, tratti dalla prima parte delPitinerario: De Hiericho usque ad fontem Helysaei milia II (1, 7); de Scitopoli usque ad mare
Tyberiadis milia XXIIII (2, 8); de Magdale usque ad septem fontes... (2, 12); de
ipso loco usque ad Ascalona milia XX (3, 5), etc. La distanza fra le varie tappe
P. Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters, IV. Formenlehre, Syntax und Stilistik, Munchen 1998 (Handbuch der Altertumswissenschaft, II, 5), 281-85; C. Lee, Linguistica romanza, Roma 2000, 136-37.
5 Tuttavia l'uso della forma posticia al femminile singolare sarebbe piuttosto insolito, mentre
e testimoniato quello della forma concorrente postica; per quest'ultima, cfr. Apuleii Metamorphoses 9, 2 (ed. R. Helm, Leipzig 1955, 203); altri esempi nella Vulgata, Iud. 3, 24; Dan. 13, 26. 6
Wilkinson, Jerusalem pilgrims, 103; H. Pinkster, Lateinische Syntax und Semantik, Tubingen 1988, 101, 104; anche in questo caso e possibile citare un passo della Vulgata, dove compare posticium nel senso di "porta posteriore": egressae sunt per posticium {Dan. 13, 18).
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

242 E. SCARPANTI
e segnalata in miglia se il percorso e di una certa lunghezza e in passi nel caso di tappe piu brevi7.
L'uso di ad con il normale significato di "verso, in direzione di" compare anche in altre espressioni non formulari, come:
porta Beniamin exiens ad Iordanem (1, 2); ed analogamente in altri casi (1, 3; 7, 3. 5; 12, 1; 16, 4; 28, 9. 12). In altre espres sioni, ad presenta il consueto significato di "presso, nei pressi di" (12, 1; 13, 4; 26, 2. 5; 32, 17), in particolare pero quando la preposizione viene usata con un sostantivo indicante un luogo sacro, come un santuario o una chiesa, o comunque un luogo di interesse per i pellegrinaggi. Si considerino al riguardo le frasi:
in ciuitate Hierusalem ad sepulcrum Domini (7, 1); quae fuit in domo Caiphae, ad quam domnus Chistus flagellatus est (7, 17); septem dies in Hierusalem ibi ad sepulchrum Domni missas celebrantur (31, 3).
Particolarmente interessante e il confronto con alcuni passi dell'Itinerarium
Egeriae nei quali la preposizione e usata in maniera analoga, sempre cioe con riferimento a luoghi sacri o di particolare devozione; cosi, nel testo di Egeria abbiamo: haec operatio cotidieper dies sex ita habetur ad Crucem et adAnastasim; ed ancora: facta ergo missa in ecclesia maiore, id est ad Martyrium8.
In un brano del nostro testo si trova la preposizione ad utilizzata al posto di un dativo di attribuzione; la frase e la seguente:
Urbicius dicebatur praepositus imperil, qui ad septem imperatores praepo situs fuit (28, 1). Nel latino tardo, infatti, giunge a compimento la tendenza, gia testimoniata in autori come Plauto, Cicerone ed Orazio9, alia sovrapposizione del costrutto preposizionale sulla classica costruzione con il caso dativo; cosi, ad esempio, troviamo in Gregorio di Tours espressioni come: miserat ad eum obuiam; o ancora: ad episcopum aiebat10. II significato genitivo compare, poi, in alcune espressioni quali terra ad illo homine, e menbra ad duus fratres (sic) n. D'altra parte, l'utilizzo della preposizione adrisultava assai comodo, sul piano semplicemente pratico, quando ci si trovasse di fronte a nomi indeclinabili, come capita owiamente di frequente nella Vulgata con la trascri zione di molti nomi ebraici; tale uso poteva, probabilmente, costituire un ulteriore
stimolo, almeno per gli autori cristiani, ad utilizzare ad al posto del caso dativo. In altri casi, poi, la preposizione ad e utilizzata con normale significato di
complemento di termine, come nelle frasi: domno Clementi anchor a ad collum ligata est (12, 3); si quis uero de uexaticis ad ipsam anchor am adtingere potuerit (12, 9); sanctus Helias missus est ad uiduam illam (23, 6).
E possibile segnalare, poi, un caso in cui la preposizione ha un significato temporale:
medius ipse ager et occurrit ad pascham (18, 3). Infine si riportano due casi nei quali essa riveste, invece, un significato finale:
quando Domnus ad baptismum descendit (22, 4); quando in prouincia imperatoris ad praedandum ueniebant (29, 3).
7 Menesto, Relazioni, 546. 8 Itin. Eg. 24, 7; 30, 3; cfr. Vaananen, Le Journal-epitre d'Egerie, 39.
9 Cfr. Plauti Captivi 1019; Ciceronis Verrinae 3, 101; Horatii Saturae 2, 6, 90; Stotz, Handbuch, 275; Hofmann-Szantyr, Lateinische Syntax, 86, 220; E. Lofstedt, Syntactica. I, Lund 1942, 187-89.
10 Gregorii Turonensis Historia Francorum 10, 9.
11 Cfr. su questo: Stotz, Handbuch, 277.
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PER UN'ANALISI LINGUISTICA 243
ante (3 occorrenze) E testimoniato un caso di uso della preposizione ante con l'ablativo:
in ipso loco ante pascha dominico omnis populus congregat (23, 11-12). Nel latino volgare tale uso e gia testimoniato, ad esempio, dalla Vetus latina, che
presenta ante sole; espressione questa presente anche in Egeria12. In particolare, un'epigrafe del VI secolo sembrerebbe testimoniare lo stesso uso con l'ablativo nelPambito della medesima accezione temporale della preposizione: ante ordina tione13. Negli altri due casi in cui si ritrova nel testo, invece, ante si accompagna normalmente ad un caso accusativo (5, 6; 22, 5).
circa (1 occorrenza) Presenta una sola occorrenza nel testo, con un significato locativo e con il caso accusativo:
circa Iordanem est (22, 3).
cum (8 occorrenze) Presente nel testo del De situ per un totale di otto occorrenze, in un caso la
preposizione si accompagna ad un accusativo, nella frase: in mari memoriam eius cum corpus missus est (10, 6);
del resto, il sostantivo corpus poteva suscitare qualche difficolta data la sua anomalia morfologica. Lo stesso uso e poi testimoniato in Egeria, con l'espres sione cum epistolam (19, 17) ed ancora nell'Itinerarium Antonini Placentini (8, 22), oltre a diversi esempi nelle iscrizioni14. Inoltre, possiamo segnalare come nella frase seguente la preposizione cum sembri, di fatto, comparire dove classi camente avremmo invece avuto con ogni probability un ablativo strumentale {quo):
Inde pullus asinae, quern Domnus sedit, adductus est, cum quo intrauit de
porta Beniamin in Hierusalem (21, 5-6), La sostituzione, per fini di maggiore chiarezza, di costrutti preposizionali alle forme casuali pure e semplici e testimoniata fin dalle fasi antiche della lingua, manifestandosi pero in particolare nel latino tardo; cosi, ablativi strumentali
appaiono precisati dall'uso della preposizione cum in svariati esempi, tra i quali ricordiamo: cum pecunia sua fecit15; cum lacte conspersa16.
de (93 occorrenze) La preposizione de appare utilizzata nel testo in due modi differenti: in alcune
frasi, infatti, si accompagna normalmente al caso ablativo, mentre in altri esempi essa sembra al contrario preferire il caso accusativo. Le frasi dove la proposizione
12 Psal 71, 17: erit nomen eius benedictum in saecula, ante sole permanet nomen eius (Vetus);
sit nomen eius benedictum in saecula, ante solem permanet nomen eius (Vulgata); l'espressione e
testimoniata dal ms. Cavense 14 (1) di Cava dei Tirreni (VIII s.), cfr. La vetus Latina hispana, ed. T. Marazuela, V, Madrid 1962, 722-23; il brano egeriano e Itin. Eger. 27, 9.
13 CIL X, 1365, 8; si tratta delPepitaffio deirarciprete Adeodato, nella chiesa di san Felice a Nola; nel testo non sono presenti segni espliciti di abbreviazione: ante ordinatione ann XXX.
14 Cfr. ad esempio: cum coiugem (sic) et filios (CIL VI, 667); ed ancora: cum omnes sacratos
(VI, 730). 15 CIL III 14469. 16 Chironis Mulomedicina, ed. E. Oder, Leipzig 1901, 411.
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

244 E. SCARPANTI
si accompagna all'accusative), su di un totale nelPintero testo di 93 occorrenze di
de, sono soltanto le quattro qui di seguito riportate17: exit Iordanis de duo loca lor et Dan (2, 17); de Caluariae locum usque in Golgotha passus numero XV (7, 7-8); de montes Armeniae exeunt flumina duo (16, 1); monasterium est de cast as (11, 1).
Nei primi tre esempi citati il senso dell'espressione appare chiaramente quello di un complemento di moto da luogo, con l'accezione di un movimento dalPalto verso il basso: la scelta della preposizione de, in luogo di e/ex o di a/ab, risulta
percio corretta dal punto di vista semantico (nel latino classico la preposizione de poteva, infatti, marcare un movimento 'verticale', dunque una 'discesa'), mentre
irregolare appare, owiamente, la presenza del caso accusativo assieme alia preposi zione in questione. Un significato analogo sembrerebbe avere, nelPItinerarium
Burdigalense, Pespressione: non longe de statuas1*. Diversamente, nella frase teodosiana monasterium est de castas (11, 1) la preposizione sembra avere un chiaro significato di complemento di specificazione, dove percio nel latino classico avremmo trovato un semplice caso genitivo; ancora una volta, comunque, Pecce zionalita dell'espressione sta nella presenza del caso accusativo. Tali esempi non fanno che confermare, owiamente, Pormai evidente fenomeno di progressivo abbandono del sistema flessionale classico, con la concomitante scelta preferen ziale per Puso dell'accusativo come sostituto degli altri casi della declinazione. Al riguardo, possiamo ricordare anche due espressioni analoghe che compaiono nell'Itinerarium Egeriae, dove Puso della preposizione sembra essere molto simile a quello qui analizzato: de actus apostolorum; e: de martirium19.
In qualche caso e, comunque, difficile dimostrare in maniera incontroverti bile quale uso sia realmente testimoniato, owero se la preposizione si accompagni al caso ablativo oppure all'accusativo, trovandosi di fronte a nomi indeclinabili; si veda a questo proposito Pespressione:
secundo miliario de Hierusalem (23, 11). L'uso regolare della preposizione de, con Pablativo, compare invece nella maggior parte delle occorrenze (ben 89 su 93 totali). In tutti questi casi, il significato e
generalmente quello di moto da luogo (81 volte), assai ricorrente all'interno delle
espressioni formulari descritte in precedenza. A titolo di esempio possiamo citare: de Hiericho usque Galgala miliario uno (1, 1); de Samaria usque in Sebastea (2, 5); de Buzana usque Eleuteropoli (3, 2); e cosi via.
Si riscontrano, inoltre, quattro esempi in cui la preposizione de sembra piuttosto avere un significato strumentale; essi sono:
Dominus Ihesus Christus unum sulcum de manu sua arauit (1, 5); ubi et saturauit populum de quinque panibus et duobus piscibus (2, 14); inrigat de fonte Helisaei (18, 1); in ipsa Leuiada Moyses lapidem de uirga percussit etfluxerunt aquae (19, 2).
E interessante segnalare come espressioni simili si ritrovino anche nel testo di
Egeria, come ad esempio: episcopus sedens de manibus suis summitates de ligno
17 SuH'uso di de con il caso accusativo, cfr. ad es.: Stotz, Handbuch, 252; Hofmann -
Szantyr, Lateinische Syntax, 264.
18 Itin. Burd 22, 5. 19 Itin. Eg. 93, 31; 90, 5.
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PER UN'ANALISl LINGUISTIC A 245
sancto premet20. In tre ulteriori esempi la preposizione ha poi un significato partitivo:
quando aliqua de sanctimonialibus illuc conuerti uoluerit (11, 4); si quis uero de uexaticis ad ipsam anchoram adtingere potuerit (15, 9); dies commercia geruntur et nemo de eis aliquid requirit (32, 2).
Anche in questo caso e possibile citare un precedente dall5Itinerarium Egeriae: dicet psalmum quicumque de presbyteris (24, 9). In un ultimo brano, infine, la
particella de svolge la funzione di un complemento di origine: hoc Eudoxius diaconus dixit, qui de ipsa prouincia est (30, 6).
Abbiamo gia notato, in ultima analisi, come la preposizione de tenda, nel latino
tardo, a sostituire inesorabilmente le sue "concorrenti" dirette a / ab e e / ex: in
particolare quest'ultima non compare mai nel testo teodosiano, confermando
dunque tale tendenza. Del resto, anche nel testo dell'Itinerarium Egeriae la preposi zione e / ex era utilizzata rarissime volte, esclusivamente laddove si riportava alia lettera un brano scritturistico21.
foras / foris (2 occorrenze) L'avverbio foras, che gia in autori del periodo imperiale aveva assunto talvolta la funzione di preposizione con il caso genitivo (o con l'accusativo, come in
Girolamo: foras portas), sembra avere qui proprio tale senso di preposizione, ma con il caso ablativo:
Sanctus Stephanus foras porta Galilaeae lapidatus est (8, 1). E interessante, al riguardo, un passo dell''Itinerarium Egeriae, dove ritroviamo ancora foras con il caso accusativo: ad ecclesiam quae est foras ciuitatem (20, 3). Al contrario, l'avverbio foris, che ha pure una sola occorrenza nel testo, si trova usato con il significato preposizionale dell'avverbio foras, cioe con un senso
generale di movimento piuttosto che di quiete (significato che foris avrebbe nella
lingua classica), questa volta unito al caso accusativo e posposto al nome cui si riferisce:
eum sepulchrum foris iactauit (28, 18), La confusione fra i due termini, foras e foris, appare di fatto completa; un
fenomeno, questo, che viene comunque largamente confermato da diversi esempi nella lingua degli itineraria coevi22.
in (103 occorrenze) La preposizione in si trova utilizzata, in due frasi del De situ, insieme ad un caso
accusativo, dove invece ci aspetteremmo un ablativo, dato che sembra di poter intendere senz'altro le espressioni in questione come dei complementi di stato in
luogo piuttosto che di moto a luogo. Cosi in: nam aquam ibi in cisternas habent (11, 7); in ipsas aquas calidas leprosi curantur (19, 6).
Lo stesso uso appare testimoniato anche in diversi passi dell'Itinerarium Egeriae, fra i quali possiamo citare, ad esempio, il seguente: qui in montem Dei uel circa
20 Itin. Eg. 37, 2; ma anche: 37, 3; cfr. VAananen, Le Journal-epitre d'Egerie, 38. 21
Cfr. Itin. Eg. 5, 12; 11, 3; 24, 5; 39, 5. 22
Itin. Burd. 22, 20; 22, 12; Itin. Eg. 63, 4; 73, 12.
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

246 E. SCARPANTI
ipsum montem commorabantur23. La preposizione appare in una formula doppia con
antea, tipica del latino tardo, nella frase: nullatenus potuerunt eum in antea mouere (28, 12). Negli altri numerosi casi (la preposizione ha ben 103 occorrenze nel De situ),
l'uso e invece del tutto regolare, con l'accusativo o Pablativo a seconda che si tratti di un complemento di moto oppure di stato in luogo.
inter (1 occorrenza) Un solo esempio nel testo, regolarmente con il caso accusativo:
Inter Ascalonam et Gazam ciuitates duas (3, 6).
iuxta (6 occorrenze) II significato di iuxta e sempre quello locativo, con un totale di sei occorrenze nel testo, regolarmente accompagnate dal caso accusativo (7, 15, 8, 7; 16, 5; 20, 15; 23, 2; 27, 1).
per (8 occorrenze) La preposizione per compare otto volte, accompagnata invariabilmente dall' ac
cusativo, con un significato locativo (7, 5; 11, 7; 27, 5. 6), temporale (12, 7; 20, 6; 31, 2) e ancora finale nella frase:
ad stratas sedeant per peregrinos suscipiendos (13, 4).
post (4 occorrenze) Presente quattro volte nel testo e sempre accompagnato dall'accusativo, post presenta in tre casi un significato temporale (4, 15; 9, 2; 32, 2) ed in un caso un senso locativo, nella frase:
de ipso altare communicator, tamen post sepulchrum Domni est (28, 14).
pro (3 occorrenze) La preposizione pro presenta tre sole occorrenze nel testo, sempre con il caso
ablativo; fra queste, in un solo esempio essa ha l'usuale significato locativo:
fabricata est pro Iordane (20, 5). Nei restanti due casi, la stessa preposizione sembra invece oscillare tra il senso finale e quello causale:
aliquanti pro religiositate ibi cum uenerint (10, 5); per annum de fisco accipiunt pro uita sua transigenda (20, 7).
Espressioni simili si riscontrano, ancora una volta, nel testo del Diario di Egeria, fra le quali possiamo citare ad esempio le seguenti: monachos (...) qui tamen pro etate aut imbecillitate occurrere (...) non poterant24; nos cum grandi reuerentia attendimus locum ilium, ubiprimitus domus sancti Abrahaefuit, pro memoria illius25.
propter (3 occorrenze) II significato di propter e, in tutte le tre occorrenze in cui si presenta nel testo
(23, 3; 29, 3; 30, 5), sempre regolarmente causale.
23 Itin. Eg. 5, 12. 24 Itin. Eg. 5, 10. 25 Jtf/i. ?g. 20, 8; altri esempi in: 25, 6; 25, 12; 24, 8.
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PER UN'ANALISI LINGUISTICA 247
subtus (2 occorrenze) La particella avverbiale subtus si ritrova soltanto in due passi del De situ; in una di tali occasioni essa e trattata come una preposizione; accompagnata ad un caso
ablativo, nella frase: subtus ciuitate coniungunt (2, 19).
Al contrario, nella seconda occorrenza subtus sembra essere utilizzato regolarmente come awerbio, per specificare ulteriormente un'espressione che lo precede, anche se il senso della frase non sembra essere del tutto chiaro; il passo in questione e:
a pinna templi subtus monasterium est de castas (11, 1), che potrebbe essere inteso: "sotto il pinnacolo del tempio si trova un monastero di monache".
super (7 occorrenze) Con sette occorrenze totali nel testo, la preposizione super si trova utilizzata in
genere con il caso accusativo (7, 4; 12, 6; 17, 4; 20, 4; 21, 1; 20, 6), mentre in un esempio soltanto essa si accompagna ad un ablativo singolare (20, 11) senza, tuttavia, rimarcabili differenze di significato rispetto alPaltra costruzione.
trans (2 occorrenze) Due sono i passi nei quali si trova usata la preposizione trans, sempre regolar mente accompagnata da un caso accusativo e in entrambi i casi riferita al fiume
Giordano, con il normale significato "di la dal": trans Iordanem (19, 1; 20, 8).
usque (54 occorrenze) Usatissima (ricorre ben 54 volte, sempre con 1'accusativo), la preposizione usque contribuisce alia formazione delle espressioni formulari che segnano le tappe di tutto l'itinerario descritto da Teodosio, fra le quali possiamo soltanto citare ancora una volta un paio di esempi significativi:
de Hiericho usque Galgala miliario uno (1, 3-4); de Sebastea usque in Scitopolim milia XXX (2, 7).
L'uso di tale preposizione si presta comunque ad alcune osservazioni: anzi tutto, usque risulta utilizzata quasi esclusivamente nell'arco dei primi sette capitoli del testo e del solo capitolo trentaduesimo, laddove cioe e piu evidente anche ad una
prima lettura il carattere di itinerarium della nostra opera; in secondo luogo, inoltre, possiamo notare come la preposizione si trovi usata da sola soltanto undici
volte, in passi nei quali e sempre invariabilmente seguita da un nome di una localita geografica, come ad esempio in:
de Tyberiada usque Magdale (2, 1); de Capharnaum usque Bethsaida (2, 15).
Al contrario, la stessa preposizione si ritrova in quindici casi nelfespressione usque ad, questa volta sia con nomi di localita sia con espressioni piu generiche indicanti un qualche luogo differente da una citta, come negli esempi che seguono:
de Hiericho usque ad fontem Helysaei milia II (1, 7); de Scitopoli usque ad mare Tyberiadis (2, 8); de Magdale usque ad septem fontes (2, 12); de domo Pilati usque ad piscinam probaticam (8, 5).
Nella maggior parte dei casi, invece, si ritrova l'espressione usque in, sempre con nomi di citta; infine, troviamo in quattro frasi usque ubi (3, 1; 5, 1; 6, 2; 20, 12).
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

248 E. SCARPANTI
In conclusione, e possibile rintracciare nel testo di Teodosio, gia nella semplice analisi delPuso delle preposizioni, importanti ed evidenti tracce dei fenomeni che accompagnano lo sviluppo e la diffiisione del latino tardo. In tale prospettiva, una completa disamina della lingua del De situ Terrae Sanctae non potrebbe, dunque, che confermarne ancora una volta l'importanza come documento linguistico esemplare di un fondamentale momento di transizione nella storia della lingua latina.
This content downloaded from 91.229.248.187 on Sun, 15 Jun 2014 15:10:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions