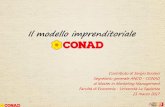2015 06 11 La Valutazione Della Formula Imprenditoriale 5392 STR
description
Transcript of 2015 06 11 La Valutazione Della Formula Imprenditoriale 5392 STR

(protocollo n° 5392) Copyright © SDA Bocconi, Milano
LA VALUTAZIONE DELLA FORMULA IMPRENDITORIALE
Vittorio Coda

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 2
Vittorio Coda
La valutazione della formula imprenditoriale
Nel governo strategico delle imprese, la valutazione della formula (o impostazione) imprenditoriale occupa una posizione centrale. Infatti, se la gestione strategica si distingue da quella operativa perché, in luogo di assumere come “data” l’impostazione imprenditoriale e di occuparsi di farla funzionare in modo più efficiente, la mette in discussione e ne cura se del caso il cambiamento, il problema da cui prende l’avvio qualsiasi attività di gestione strategica è di capire qual è l’attuale impostazione imprenditoriale, di giudicarne la validità e di individuare, almeno nelle loro linee di fondo, le eventuali necessità di rinnovamento della stessa. In questa nota, dopo aver chiarito cosa intendiamo per “formula imprenditoriale” (d’ora innanzi f.i.) e cosa contraddistingue le f.i. di successo, si affronta la problematica valutativa distinguendo fra due fondamentali “livelli” ai quali deve condursi l’analisi, quello di area strategica di affari e quello aziendale. L’approccio analitico–valutativo proposto in questa nota utilizza solo una piccola parte della ricca strumentazione analitica offerta dalla letteratura in tema di “analisi, valutazione e formulazione della strategia” e si caratterizza, rispetto ad altre impostazioni, perché si fonda esplicitamente su una rete concettuale piuttosto scarna, ma evocativa di una sia pur embrionale teoria del successo e insuccesso aziendale, e propone un ridotto numero di ipotesi-guida come strumento di indirizzo delle indagini volte ad individuare i problemi cruciali che la direzione deve fronteggiare.
1. Cos’è una formula imprenditoriale La f.i. di un’azienda è la risultante delle scelte di fondo riguardanti: a – i mercati cui è indirizzata la propria offerta e, più in generale, il sistema competitivo (o i sistemi competitivi) in cui è inserita;
b – i prodotti e/o servizi offerti con tutti gli elementi configuranti la “offerta” o “sistema di prodotto” della impresa, vale a dire: i caratteri materiali del prodotto (qualità, gamma, livello tecnologico, affidabilità, ecc.), gli elementi immateriali ad esso connessi (come prestigio, eleganza, salute, sicurezza), il servizio collegato al prodotto (velocità e puntualità di consegna, assistenza pre- e post-vendita, application engineering, ecc.), le condizioni più strettamente economiche dello scambio (prezzo, termini e modalità di pagamento, condizioni di trasporto, garanzie, assicurazioni, ecc); c – la proposta progettuale che l’impresa in modo più o meno esplicito o implicito rivolge alle forze economiche e sociali coinvolte e/o da coinvolgere o da associare nella realizzazione della proposta stessa (lavoratori, managers, azionisti, creditori, rappresentanti sindacali, esponenti del mondo finanziario e creditizio, collettività locale, ecc.), offrendo determinate prospettive e richiedendo determinati contributi o consensi; d – il sistema degli attori sociali interessati (gli stakeholder estranei al sistema competitivo), cui di fatto tale proposta si indirizza, con le loro aspettative nei riguardi dell’impresa e il loro potere di influire sulla vita della stessa;

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 3
e – la struttura che consente all’impresa di presentarsi sul mercato con quella certa offerta e agli attori sociali con quella certa proposta progettuale. Il termine “struttura” è qui usato in una accezione molto lata, sì da ricomprendervi non solo la struttura organizzativa e i meccanismi operativi (come il sistema di programmazione e controllo, i sistemi di gestione del personale, ecc.), ma anche tutte le risorse – umane e non – costituenti il patrimonio tecnologico, commerciale, direzionale ed economico-finanziario dell’impresa. Queste cinque variabili aggregate (sistema competitivo, sistema di prodotto, prospettive offerte/contributi richiesti agli attori sociali, sistema degli attori sociali, struttura) si ritrovano in qualsiasi impresa e sono avvinte da relazioni che le compongono in un’unica formula imprenditoriale articolatesi in due sottoinsiemi, esprimenti l’uno il modo di essere dell’impresa in una certa “arena” competitiva (l’impostazione con la quale essa è presente in un settore di attività economica); l’altro il modo di essere dell’impresa nel sistema di forze economiche, politiche e sociali in cui cerca le risorse e i consensi che le occorrono (Fig.1). Si può anche dire che il primo sottoinsieme rispecchia la collocazione e la strategia competitiva dell’impresa, mentre il secondo ne riflette la collocazione e la strategia “sociale”. In un’ottica analitico-interpretativa, si può asserire che la struttura determina il sistema di prodotto, il quale, a sua volta, mentre concorre a plasmare il sistema competitivo, consente all’impresa di ritagliarvi il suo spazio operativo. Dal sistema competitivo, infine, la struttura riceve continui flussi informativi che ne stimolano gli adattamenti di breve e di lungo periodo nonché i flussi di risorse rappresentanti i corrispettivi degli scambi che intrattiene col sistema stesso. Considerazioni simili possono svilupparsi a proposito dell’altro sottoinsieme: la struttura esprime la proposta progettuale attorno a cui si aggregano determinate forze sociali che le assicurano le collaborazioni vitali di cui necessita. In sostanza, la f.i. assume la configurazione di due sottoinsiemi a forma circolare , entrambi facenti perno e ruotanti intorno alla struttura, che, mentre sintetizza la storia passata dell’impresa nei suoi molteplici aspetti (di apprendimento imprenditoriale, di avviamento commerciale, economico-finanziari, ecc.) ne rappresenta la capacità propositiva nei riguardi sia del sistema competitivo sia delle altre forze sociali, cui dà i suoi contributi, ricevendone impulsi, risorse e collaborazioni. Si noti, ancora, che la figura 1 rappresenta schematicamente la f.i. dell’impresa monobusiness. Il caso dell’impresa operante in più aree di affari richiederebbe la rappresentazione di tante “formule competitive” quanto sono le aree stesse, ognuna con i suoi propri elementi di struttura, tutti unificatisi intorno ad una struttura centrale. Pur con una simile articolazione, dunque, la struttura continuerebbe ad essere il perno dell’intera f.i.

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 4
Figura 1 – Gli elementi della formula imprenditoriale
2. Cosa contraddistingue una formula imprenditoriale di successo La formula imprenditoriale delle imprese di successo ha delle connotazioni inconfondibili che vale la pena di esplicitare per ciascuno dei due sottoinsiemi dianzi accennati. La formula adottata per competere nel campo di attività economica prescelto (si supponga, per semplicità, di essere in presenza di un’impresa mono-area di affari) presenta, rispetto ai sistemi di prodotto delle imprese rivali, dei chiari “vantaggi concorrenziali”, funzionali a specifici “bisogni” o “fattori critici di successo” del mercato. Tali vantaggi, poi, a loro volta sono consentiti da una struttura che, se posta a confronto con quella delle imprese rivali, presenta delle inconfondibili “competenze distintive”. Nelle imprese di successo sia il sistema di prodotto che la struttura sono internamente coerenti; il sistema di prodotto poi si adatta bene sia alle caratteristiche della struttura (di cui sfrutta a fondo i punti di forza), sia alle caratteristiche del sistema competitivo (di cui coglie determinate opportunità); la struttura, infine, è ben dimensionata in rapporto alla dimensione del mercato controllato – o, più frequentemente, del segmento o nicchia di mercato – ed ha il grado di flessibilità/rigidità necessario per competervi validamente. In sintesi, gli elementi tutti della formula competitiva, nelle imprese di successo, presentano un elevato grado di consonanza. E ciò perché rappresentano per così dire sviluppi logici di un’idea centrale circa il modo di essere competitivi in quel certo ramo d’industria. Un’idea che è il risultato di una sintesi imprenditoriale, spesso intuitiva, tra un bisogno percepito e una possibilità intravista di soddisfarlo economicamente; un’idea concettualmente semplice, frutto di ragionamenti lineari, che nulla hanno da spartire con riflessioni contorte, e perciò capace di imporsi all’attenzione per una sua intrinseca validità; una idea, ancora, che è consonante con le linee evolutive di fondo dell’ambiente e del settore, ancorché in certi casi possa apparire “controcorrente” poiché fortemente innovativa o sintonizzata con dei valori sociali condivisi solo da minoranze.. La consonanza tra gli elementi di una formula competitiva di successo, dunque non si forma né per caso né come risultato di una rigorosa progettazione della formula stessa. E’ bensì il prodotto di un processo di apprendimento imprenditoriale, che, almeno a partire da un certo punto in poi, si focalizza
Struttura Sistema di prodotto
Prospettive offerte / contributi consensi richiesti
Sistema competitivo
Sistema degli attori sociali

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 5
intorno a una valida intuizione imprenditoriale al cui sviluppo e alla cui realizzazione è interamente rivolto. Tale intuizione è una “visione anticipatrice” o “embrione” della formula di successo. Questa coerenza degli elementi della formula competitiva intorno a un’idea centrale intrinsecamente valida è alla base del successo competitivo e del successo reddituale dell’impresa: del successo competitivo perché genera un vantaggio concorrenziale duraturo (e non già effimero) su uno o più fattori critici di successo (e non già su variabili competitive di minor rilievo) e ciò determina la dominanza dell’impresa sul mercato o su un suo segmento o nicchia; del successo reddituale, perché l’economicità scaturisce proprio dalla capacità del sistema di prodotto di soddisfare al contempo necessità del mercato e vincoli della struttura, nonché da un buon grado di sfruttamento di quest’ultima, che, a sua volta, è espressione di una consonanza tra struttura e spazio operativo conquistato dall’impresa nell’ambito del sistema competitivo. Questo per quanto riguarda quel sottoinsieme della f.i. che abbiamo più volte indicato con l’espressione di “formula competitiva”. Ma anche l’altro sottoinsieme – che costituisce in un certo senso una “f.i. sovraordinata” rispetto a quella propria di una data area di affari – presenta delle inconfondibili caratteristiche nelle imprese avviate su un sentiero di successo. Precisamente, la proposta che si rivolge agli attori sociali cui si richiedono risorse e consensi si contraddistingue per certi “vantaggi differenziali”, ossia viene percepita da coloro che vi aderiscono come capace di soddisfare le loro “aspettative di fondo” meglio di altre eventuali proposte alternative, ancorché il cammino da percorrere possa comportare sacrifici e non essere privo di incognite e rischi (ad esempio, agli azionisti potrebbe essere richiesta la rinuncia a prelevare gli utili per salvaguardare la sopravvivenza e l’autonomia aziendale; ai lavoratori un impegno particolare per mantenere il vantaggio competitivo e così via). La struttura, infine, negli aspetti che più direttamente interessano la f.i. sovraordinata, si contraddistingue tendenzialmente per una cultura aziendale forte, fatta di valori condivisi, fra i quali spiccano la continuità e l’autonomia, l’economicità e la socialità. La continuità, che induce a considerare l’impresa come un istituto che trascende la vita e gli interessi particolari dei soggetti che ne sono responsabili per un breve tratto della sua storia e deve essere conservato e trasmesso integro alle generazioni future. L’autonomia, che porta a vedere nell’impresa una tipica e fondamentale espressione dei sistemi economici a decisioni largamente decentrate. Corollario di questi due valori è l’economicità, perché la sopravvivenza senza economicità comporta inevitabilmente la perdita dell’autonomia. L’economicità poi, a sua volta, nelle “imprese eccellenti” è inseparabile dalla socialità; cui tende ad essere legata da un rapporto di reciproca funzionalità. Una cultura forte, radicata su questi valori, è una potente forza motivazionale, che induce dedizione al bene inteso interesse aziendale ed è alla base di un successo duraturo e quindi anche della capacità di attrarre le risorse e collaborazioni necessarie. Ecco che, allora, anche la “f.i. sovraordinata” si presenta come un insieme coerente di elementi, il quale genera consenso, fiducia, soddisfazione, coesione intorno al progetto strategico dell’impresa, condizioni tutte basilari per consentire all’impresa di assolvere nel migliore dei modi il suo ruolo sociale di centro produttore di ricchezza. Una sintesi schematica dei caratteri distintivi della f.i. nelle imprese di successo si ritrova nella Figura 2.

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 6
Figura 2 – Elementi della formula imprenditoriale e loro caratteri distintivi nelle imprese di successo.
3. Come si valuta una formula imprenditoriale: cenni introduttivi La valutazione della f.i. si effettua a livello di area di affari (ASA) e a livello aziendale. Al primo livello si tratta di analizzare e valutare la formula competitiva che caratterizza la presenza dell’impresa nell’ASA o nelle ASA più significative. Al secondo livello si tratta di valutare nel suo insieme la f.i. negli aspetti comuni e sovrastanti alle ASA. Fra i diversi approcci che si possono seguire per valutare la validità della f.i, sia a livello di ASA che a livello aziendale, quello che forse più di ogni altro consente di puntare diritto allo scopo valutativo prefisso consiste nel cercare risposta ai seguenti interrogativi: − come si colloca l’ASA considerata o l’impresa nel suo complesso rispetto alle tipiche “dimensioni” del
successo imprenditoriale, che sono quella competitiva e quella reddituale a livello di ASA, e quella sociale e quella economica complessiva a livello aziendale?
Sistema competitivo
Sistema degli attori sociali
Struttura Sistema di prodotto
Prospettive offerte/contributi
o consensi richiesti
Fattori critici di successo
Aspettative di fondo
Economicità
Vantaggi concorrenziali
Competenze distintive
Cultura aziendale
forte
Vantaggi differenziali
CONSONANZA
Dominanza Coesione Fiducia
Soddisfazione

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 7
− quale che sia la collocazione in parola dell’ASA o della impresa, quale spiegazione essa ha? attraverso quale “cammino” vi si è arrivati?
− posto che si tratti di una collaborazione ottimale che si spiega con l’apprendimento di una formula imprenditoriale di successo, si prospettano minacce capaci di scardinare le basi del successo e quindi fronteggiabili solo con radicali mutamenti di impostazione imprenditoriale?
− posto, invece, che si tratti di una collocazione sfavorevole almeno lungo una “dimensione” e che ciò si spieghi con certe carenze della f.i., quali necessità di innovazione imprenditoriale ne discendono?
In tesi generale una f.i. è valida se l’ASA o l’impresa è posizionata favorevolmente rispetto ad entrambe le dimensioni del successo e se non è minacciata da minacce che ne richiedano un cambiamento radicale. Una f.i. valida deve essere protetta, difesa, consolidata. In ogni altro caso, invece, la f.i. necessita di un rinnovamento più o meno profondo. Vediamo ora con maggior grado di dettaglio come si valuta la f.i. cominciando dalla formula competitiva.
Valutazione della f.i. a livello ASA Si è appena accennato che, a livello ASA, le dimensioni del successo imprenditoriale sono quella competitiva e quella reddituale. Ebbene un primo quesito cruciale è il seguente: l’impresa ha successo (in quella certa ASA, s’intende) sul piano reddituale e/o sul piano competitivo? La risposta a questa domanda deve essere ricercata raccogliendo e soppesando le manifestazioni di successo, anche solo quelle di natura indiziaria o sintomatica, avendo cura di valutare se sono segno di un successo passato o ancora attuale. Per quanto riguarda la dimensione competitiva del successo, le manifestazioni su cui maturare un giudizio sono date dalle più disparate informazioni, anche di carattere indiziario, concernenti le quote di mercato assolute e relative, il grado di copertura del mercato, il livello qualitativo della clientela presso cui si è introdotti, il grado di penetrazione presso le varie fasce di clientela. Si tratta, come si vede, di informazioni esprimenti i risultati del gioco competitivo e non già i loro fattori causanti. Questi ultimi – che possono cogliersi spostando l’indagine sui differenziali concorrenziali e sulle competenze distintive proprie di ciascun competitore – vanno presi in esame in un momento successivo, quando ci si interroga sul perché del successo o insuccesso. La loro considerazione in questo stadio iniziale del processo analitico non soltanto complicherebbe inutilmente le cose, ma richiederebbe di rendere evanescente la stessa distinzione fra i concetti di “successo competitivo” e “successo reddituale”. Così, ad esempio, se in questa sede ci si preoccupasse di confrontare la struttura dei costi dell’impresa con quella dei suoi concorrenti, si rischierebbe di confondere in un tutt’uno la valutazione del successo aziendale sul piano competitivo e su quello reddituale. E ciò per la semplice ragione che la competitività della struttura di costi è nel contempo fattore causale e della capacità competitiva e della capacità di reddito. Si tratta, in conclusione, di esprimere un giudizio sintomatico sul grado di successo competitivo, basato esclusivamente sulle manifestazioni coglibili a livello di risultati e non a livello di comportamenti o di strutture concorrenziali. Quanto alla dimensione reddituale del successo, il giudizio deve incentrarsi sulla redditività operativa dei mezzi investiti (reddito operativo su attivo totale al netto dei fondi rettificativi) e non sulla redditività netta dei mezzi propri (che è invece l’indicatore di economicità per valutare la f.i. a livello aziendale). La conoscenza della redditività dei mezzi investiti non è sempre ottenibile, vuoi perché, trattandosi di impresa multi-ASA, possono esservi ingenti costi fissi e rilevanti elementi attivi del capitale comuni alle diverse ASA, con la conseguenza di una impossibilità tecnica di misurare la redditività medesima distintamente per ogni ASA; vuoi perché potrebbero non essere disponibili bilanci attendibili. In questi casi è possibile maturare ugualmente un giudizio sul grado di successo reddituale, utilizzando altri indicatori di economicità variamente connessi alla redditività operativa, come, ad esempio, i margini di contribuzione sul

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 8
fatturato, i coefficienti di rigiro del circolante, il fatturato (o il valore aggiunto) per addetto, i margini di ricarico operati sul costo primo per formare i prezzi di vendita, la politica degli sconti attuata e così via. Una volta posizionata l’impresa – o, meglio, la singola ASA – in una matrice degli indicatori del successo imprenditoriale a livello ASA, è di estrema importanza darsene una spiegazione cercando di rispondere a interrogativi del seguente tenore: su quali basi poggia un successo che al contempo si manifesta sul piano competitivo e su quello reddituale? Com’è possibile che l’impresa guadagni e abbia quindi successo sul piano reddituale, pur non avendo un buon grado di introduzione sul mercato? O, all’opposto, com’è possibile che non guadagni pur avendo un’ottima reputazione e un’eccellente affermazione nel mercato? O perché non ha successo né sul piano concorrenziale né su quello economico? La risposta a questi interrogativi di solito va ricercata sulla scorta delle ipotesi-guida indicate nella matrice della figura 3. Precisamente, se l’impresa ha successo, in quella certa ASA, sia sul piano competitivo che su quello reddituale, ciò si spiega con ogni probabilità col funzionamento efficiente di una formula competitiva coerente nei vari elementi che la compongono intorno a un’idea centrale intrinsecamente valida. Si può anche asserire che la compresenza di successo competitivo e di successo reddituale legittima l’ipotesi che il primo sia causa del secondo e ne sia, a sua volta, alimentato. Ma questo circolo virtuoso non è casuale, bensì espressione del funzionamento di una ben studiata formula competitiva di successo, i cui pilastri verosimilmente saranno dati da certe competenze distintive, che consentono all’impresa di presentarsi sul mercato con un certo vantaggio competitivo, il quale, a sua volta, le conferisce un consistente potere quanto meno su un certo segmento (o nicchia) di mercato, rispetto al quale la struttura si presenta ben dimensionata. Diverso è il caso delle imprese che hanno un sostanziale successo reddituale senza avere una consistente affermazione sul mercato. Qui la spiegazione deve ricercarsi nell’operare di condizioni esterne favorevoli, facilitanti il compito di produrre utili, come ad esempio: un continuo e prolungato dilatarsi della domanda; l’esistenza di barriere all’entrata di nuovi concorrenti, quali dazi doganali, contingentamento delle importazioni, economie di scala, altri vantaggi di costo (legati, ad esempio, ai bassi saggi retributivi, alla qualificazione e all’impegno particolare delle maestranze, al basso costo del denaro), vantaggi di qualità, di canale distributivo o d’altro genere non accessibili ai potenziali nuovi concorrenti o troppo onerosi da colmare, ecc.; accordi efficaci di limitazione della concorrenza fra i produttori; una situazione di cronica debolezza contrattuale dei fornitori, dotati di capacità produttive fortemente eccedentarie e incapaci di accordarsi per azioni di sostegno dei prezzi e così via. La formula competitiva di queste imprese probabilmente è di tipo semplice, povera di contenuti imprenditoriali, poggiando semplicemente sull’idea di sfruttare le condizioni esterne favorevoli che spesso si assume, in modo implicito o esplicito, siano destinate a perdurare indefinitamente.

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 9
Figura 3 – Matrice per diagnosticare in prima approssimazione la situazione di un’impresa in una data “area d’affari”. ALTO SUCCESSO COMPETITIVO BASSO
ALTO BASSO SUCCESSO REDDITUALE Al contrario, nelle imprese che hanno successo sul piano competitivo, ma non su quello economico, di solito c’è una formula competitiva di tipo complesso, che consta di vari elementi collegati, la quale spiega il successo di mercato. La convalida del successo sul piano reddituale, tuttavia, è impedita da certe coerenze interne alla f.i., come possono essere, ad esempio: un differenziale positivo di qualità cui non corrisponde un congruo differenziale di prezzo; uno squilibrio strutturale tra dimensione della nicchia dominata e capacità produttiva, originante una sistematica sottoutilizzazione di quest’ultima; una struttura appesantita da una diffusa “cultura dello spreco”, non più tollerabile in presenza di intense pressioni concorrenziali; una forte capacità di innovare nei prodotti non accompagnata da un’altrettanto forte capacità di sfruttarli economicamente. E ciò per un qualche blocco che impedisce alla cultura produttiva di evolversi verso un livello industrialmente avanzato o per via di un assetto produttivo strutturalmente incoerente con le richieste che si rivolgono alla produzione in fatto di flessibilità, costo, qualità, livello di servizio e così via. Da ultimo, le imprese che non hanno successo né sul piano competitivo né sul quello reddituale devono questa loro situazione all’assenza di una “ragione d’essere” ricompensata dal sistema di mercato. Per una migliore comprensione delle ipotesi esplicative del posizionamento delle ASA nella matrice or ora presentata, giova considerare i più frequenti percorsi di successo o di crisi che portano ad una certa collocazione nell’ambito della matrice medesima. Il riquadro I rappresenta il punto di arrivo di un processo di apprendimento imprenditoriale, che tipicamente si svolge attraverso i seguenti stadi sequenziali, ancorché in parte sovrapponentisi: concepimento della visione imprenditoriale (c.d. stadio dei sensori), sviluppo della stessa, realizzazione, consolidamento. Questo processo di apprendimento – che avanza normalmente attraverso tentativi ed errori più o meno gravi – può innescarsi sin dal primo maturare della decisione di entrare in certo ramo di affari oppure può principiare in un’ASA da tempo operante; può svolgersi ininterrottamente oppure subire prolungate battute d’arresto.
FORMULA FORMULA COMPETITIVA COMPETITIVA DI SUCCESSO INTERNAMENTE INTERNAMENTE INCOERENTE COERENTE I III II IV SUCCESSO MANCANZA DI ECONOMICO UNA “RAGIONE DIPENDENTE DA D’ESSERE” CONDIZIONI RICOMPENSATA ESTERNE DI DAL SISTEMA PARTICOLARE DI MERCATO VANTAGGIO

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 10
Solo nei casi in cui il processo in parola si svolga sin dal primo maturare dell’idea di dar vita ad una iniziativa imprenditoriale e senza gravi sbandamenti o interruzioni si ha un diretto ingresso dell’ASA nel riquadro I senza passare attraverso alcuno degli altri riquadri (Fig. 4, percorso a). Nel caso, invece, molto frequente nella storia industriale del nostro Paese, di imprese sorte ad iniziativa di imprenditori un po’ improvvisati, armati di una certa competenza tecnica, di una minima dotazione di risorse finanziarie e di tanta voglia di lavorare approfittando di una favorevole situazione di mercato, l’ASA inizialmente viene a collocarsi nel riquadro II della nostra matrice e solo successivamente, man mano si apprende una formula competitiva di successo, fatta di un insieme di più elementi fra loro strettamente coerenti, si sposta verso il riquadro I (Fig. 4 percorso b). E’ questo un cammino di successo tipico delle iniziative imprenditoriali che sorgono nello stadio di rapida crescita di un’industria, quando sulle esigenze di messa a punto di una elaborata f.i. prevale la spinta a cogliere senza indugio una situazione favorevole, rimandando a un momento successivo la costruzione di durature basi di successo. Figura 4- Percorsi di successo di un”area d’affari”. ALTO (a) SUCCESSO COMPETITIVO (b) BASSO
ALTO BASSO SUCCESSO REDDITUALE E’ per contro impensabile che un cammino di tal fatta possa essere percorso da iniziative imprenditoriali poste in essere in settori maturi, contraddistinti da una stagnazione dei consumi a livello aggregato, nei quali ci si deve misurare con una domanda esigente e smaliziata e con una agguerrita concorrenza passata al vaglio di dure prove. L’ingresso in questi settori, perché sia coronato da successo, presuppone una intuizione imprenditoriale dotata di una sua originalità, da elaborare e verificare attraverso tutto un complesso di attività – di raccolta di informazioni tecniche e commerciali, di sperimentazione, di verifica di fattibilità (sul piano tecnici, commerciale e finanziario), di valutazione economica – che sono tipiche dello stadio dei sensori e dello stadio di sviluppo di una formula imprenditoriale di successo.
(d)
I III
(c)
IV II

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 11
Al di fuori di queste due ipotesi di realizzazione di una f.i. di successo – l’una tipica della fase di rapida crescita dei settori industriali, l’altra della fase di maturità – l’ingresso di un’ASA nel riquadro I della nostra matrice può soltanto essere il risultato di un processo di risanamento di una realtà in crisi più o meno grave, che si colloca nel riquadro III o IV. Gli interventi necessari per passare dal riquadro III al I (Fig. 4, percorso c) dipendono dal tipo di dissonanze o incoerenze interne alla f.i. cui bisogna porre rimedio e possono andare nel senso di razionalizzare la f.i. oppure di mutarla radicalmente. Di solito occorrono prima di tutto degli interventi di razionalizzazione, destinati a fare emergere il potenziale di miglioramento reddituale esistente. Si tratta di interventi che possono essere abbastanza semplici da attuare (come, ad esempio, un aumento dei prezzi di vendita) oppure relativamente impegnativi (come, ad esempio, quelli necessari per una efficiente gestione del circolante); tutto sommato indolori (come quelli dianzi accennati) oppure comportanti gravi sacrifici (come, ad esempio, nei casi di riduzione di organico); richiedenti o meno l’effettuazione di investimenti consistenti. Gli interventi di razionalizzazione non sempre sono risolutori. In tal caso è plausibile che la f.i. sia invalida e necessiti di un radicale riorientamento. Ecco che allora le azioni di razionalizzazione diventano censurabili se comportano l’impiego di risorse scarse ben più proficuamente allocabili in altre direzioni. Il passaggio dal riquadro IV al I (Fig. 4, percorso d) si configura come un percorso di risanamento alquanto problematico, perché si tratta di percorrere tutte le tappe del processo di sviluppo di una formula imprenditoriale muovendo da una situazione fortemente compromessa sotto ogni aspetto. Fortunatamente anche nelle situazioni più disastrate esistono delle potenzialità positive, il cui esplicarsi è peraltro impedito da tutto un insieme di forze conservatrici che ostacolano l’innesco del processo di risanamento. Questo si configura così, fin dal suo avvio, come un cammino non facile, che sembra seguire certe tappe obbligate, ognuna delle quali richiede il verificarsi di certe precise condizioni. Tuttavia il risanamento resta spesso una possibilità aperta anche in situazioni di crisi molto grave. Questo per quanto riguarda i tipici sentieri di successo, che spiegano come un’ASA può venire a trovarsi nella situazione del riquadro I della nostra matrice. Ma come si configurano i più frequenti percorsi di crisi, che possono portare un’ASA verso le situazioni sintetizzate nei riquadri III e IV? Le dinamiche suscettibili di spostare un’ASA dal riquadro I al riquadro III (Fig. 5, percorso a) sono tipicamente le seguenti: − logoramento graduale della f.i., dovuto, da un lato, all’intensificarsi delle pressioni concorrenziali
(caratteristico, ad esempio, delle fasi di maturità dei settori) e, dall’altro, all’assenza nell’azienda, adagiatasi nel suo successo, di una tensione all’economicità;
− attuazione di una strategia di sviluppo inficiata da gravi errori, tali da rompere la coerenza interna fra i diversi elementi della f.i. senza per altro dar luogo a un calo di competitività a breve termine (ad esempio, l’ampliamento della capacità produttiva fondato su errate previsioni di mercato conduce a una struttura squilibrata in rapporto alla dimensione della nicchia dominata);
− restringersi della domanda, dovuto a cause non transitorie (ad esempio a spostamenti duraturi nei consumi), e conseguente sottoutilizzazione della struttura che appare così sovradimensionata.

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 12
Figura 5 – Percorsi di crisi di un’”area d’affari”. ALTO SUCCESSO COMPETITIVO BASSO
ALTO BASSO SUCCESSO REDDITUALE Una volta posizionata nel riquadro III, un’ASA è fatalmente destinata prima o poi a perdere anche in capacità concorrenziale e quindi a spostarsi verso il riquadro IV (Fig. 5, percorso b), a meno che si intraprendano azioni efficaci rivolte a recuperare un buon successo reddituale. Infatti, la difesa delle posizioni competitive è un’impresa che richiede l’impegno continuativo di risorse ben difficilmente mobilitabili in assenza quanto meno di concrete prospettive di successo reddituale. Un’ASA di successo può anche precipitare direttamente dal riquadro I al riquadro IV (Fig. 5, percorso c). E’questo il caso di “idee imprenditoriali” minate nelle loro basi di successo dall’avvento dirompente di tecnologie e prodotti sostitutivi. Da ultimo, altri caratteristici percorsi di crisi sono quelli che si producono al venir meno di condizioni esterne favorevoli, facilitanti il compito di produrre utili. In tali situazioni, le ASA posizionate nel riquadro II inevitabilmente scivolano verso il riquadro IV (Fig. 5, percorso d1). Anche quelle collocate nel riquadro I, com’è ovvio, si spostano verso destra, almeno in un primo momento (Fig. 5, percorso d2). Tuttavia, mentre queste ultime restano pur sempre redditizie, le prime cessano di essere economicamente interessanti. Oltre che ai fattori di successo e di crisi sin qui illustrati, gli spostamenti delle ASA all’interno della nostra matrice possono essere dovuti ai tentativi non riusciti di realizzare percorsi di successo. Emblematico è, ad esempio, il caso di imprese che, mentre inseguono con successo traguardi ambiziosi di quote di mercato e/o di livello di produttività, giungono a risultati disastrosi sul piano economico-finanziario. Oppure, ancora, di imprese in crisi che, nel tentativo di sopravvivere, tagliano i rami secchi, vendono i “gioielli di famiglia”, realizzano economie a destra e manca, senza per altro riuscire a innescare o a portare innanzi con continuità un serio processo di risanamento. Il posizionamento di un’ASA nella matrice degli indicatori di successo imprenditoriale e la comprensione, anche solo approssimativa, delle cause che lo spiegano, sollevano tutta una serie di interrogativi cruciali,
(d2) (a) I III (c) (b) (d1) II IV

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 13
rispondendo ai quali, mentre si matura un giudizio consapevole sulla validità o invalidità della f.i., è possibile individuare le “direzioni” nelle quali l’impresa deve rinnovarsi. Le necessità innovative, a loro volta, suggeriscono alcuni interrogativi essenziali per valutare l’adeguatezza del management, riconducibili tutti ai seguenti: la direzione è consapevole del problema strategico di quell’ASA? sta muovendo gli opportuni passi per affrontarlo? è disponibile al cambiamento? è alla altezza dei problemi da affrontare? Alcune indicazioni circa gli interrogativi e gli indirizzi di gestione strategica che emergono dall’analisi di come si posiziona un’ASA nella nostra matrice sono contenute nella tabella 1. In breve, se l’ASA si colloca nel riquadro I, il problema interessante è di sapere (1°) se l’impresa può rimanervi, (2°) con quale tipo di strategia (di consolidamento o di cambiamento, lieve o radicale) e (3°) con quale tipo di management (corrispondente o meno a quello attualmente esistente). Se l’ASA, invece si trova nel riquadro II, il problema è di valutare, da un lato, la possibilità che le condizioni esterne favorevoli su cui poggia il successo reddituale abbiano a durare ancora a lungo; dall’altro, la disponibilità del management al superamento di una certa mentalità da “speculatore” per far posto ad una mentalità e ad una cultura da autentico “imprenditore”. Da ultimo, se l’ASA si colloca in uno degli altri riquadri (III e IV), il problema è di valutare (1°) il potenziale di miglioramento reddituale realizzabile senza sostanziali mutamenti di f.i., (2°) le opportunità/minacce strategiche implicanti radicali mutamenti di f.i., (3°) la disponibilità delle risorse direzionali e finanziarie occorrenti per il risanamento.

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 14
Tabella 1 –Interrogativi per giudicare della validità di una f.i. a livello di area d’affari
Posizionamento dell’ASA nella matrice di fig. 3
Interrogativi sulla validità della F.I.
Necessità di innovazione nella F.I.
Interrogativi
sull’adeguatezza del management
I-Alto successo competitivo/
Alto successo reddituale
● Il successo è minacciato da mutamenti in atto
o prevedibili futuri? Dove si collocano le minacce
sulla scala del tempo? Quale la loro gravità? E la
loro probabilità di manifestazione?
Sono fronteggiabili senza un profondo rinnovamento
della f.i.?
● Il successo è consolidato? In caso negativo,
è consolidabile?
La f.i. può richiedere, secondo i casi, di essere:
● riorientata
radicalmente
● ridefinita
● consolidata
La direzione è consapevole del problema
strategico e si muove di conseguenza?
Oppure investe in direzione sbagliate,
puntando al consolidamento quando dovrebbe diversificare e viceversa?
II – Basso successo
Competitivo/Alto successo reddituale
● Quanto tempo ancora possono durare le condizioni
favorevoli? Quali conseguenze può avere sull’economia
dell’impresa il loro venir meno?
● Il settore è ancora lontano dalla maturità? In caso negativo, l’impresa ha accumulato un forte ritardo, rispetto ai suoi concorrenti diretti, nella messa a punto di una valida f.i.? Nel caso opposto, quale ruolo potrà
L’impresa deve, secondo i casi:
● percorrere
rapidamente le tappe del cammino di apprendimento di una f.i. di successo
La direzione ha una lucida comprensione dello stadio evolutivo che sta vivendo il
settore? E degli scenari macroeconomici
rilevanti? Cosa fa per dominare l’incertezza strategica che caratterizza il suo ambiente? Per scoprire e realizzare la
“vocazione” aziendale?

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 15
giocare l’impresa nel settore? ● modellare la sua f.i. gradualmente, man mano si riduce l’incertezza strategica propria degli stadi iniziali del ciclo di vita del settore, puntando ad avere, negli assetti futuri del medesimo, un ruolo significativo
Insomma, per fondare il successo economico su basi meno fragili e insicure?
Posizionamento dell’ASA nella matrice di fig. 3
Interrogativi sulla validità della F.I.
Necessità di innovazione nella F.I.
Interrogativi sull’adeguatezza del management
III – Alto successo competitivo/Basso successo reddituale
● Le incoerenze interne alla f.i. sono facilmente rimediabili oppure, per porvi rimedio, è necessaria una direzione di livello qualitativo molto elevato? Sono rimediabili in tempi brevi o lunghi? Con o senza investimenti?
La f.i. deve essere, secondo i casi:
● razionalizzata e/o
● riorientata oglradicalmente
La direzione è conscia dell’anomalia di un successo competitivo non convalidato sul piano reddituale?
Come se lo spiega? Cosa fa per porvi rimedio?
IV – Basso successo competitivo/Basso successo reddituale
● Di che consistenza è il potenziale di miglioramento reddituale? Quali gli ostacoli alla sua realizzazione? Quali le potenzialità strategiche?
Senza trascurare le possibilità di miglioramento economico a breve, occorre una nuova e valida “visione imprenditiva” da sviluppare e realizzare
C’è una nuova “visione imprenditiva” meritevole d’appoggio? In caso negativo, cosa si sta facendo per generarla? Come viene affrontato il problema della sopravvivenza a breve?

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 16
Valutazione della f.i. a livello aziendale Anche la valutazione della f.i. a livello aziendale può prendere le mosse dal posizionamento in una matrice degli indicatori di successo imprenditoriale. Le “dimensioni” del successo, in questo caso, sono quella sociale e quella reddituale. la prima ha manifestazioni evidenti nei “livelli di soddisfazione” degli attori sociali legati alle sorti dell’impresa – segnatamente dei lavoratori e degli azionisti – e nella capacità che questa ha di attrarre a sé le risorse, le collaborazioni e i consensi che le sono necessari, entrando efficacemente in competizione con le altre imprese e, più in generale, con gli altri impieghi alternativi delle risorse scarse. La dimensione reddituale, invece, è significativamente espressa dalla redditività netta dei mezzi propri, la quale, com’è noto, è determinata dalle seguenti variabili: redditività dei mezzi investiti, costo dei mezzi dei terzi, grado di indebitamento (variabili tutte che con le loro grandezze definiscono l’effetto di leva finanziaria), tasso di incidenza delle imposte. Figura 6 – Matrice per diagnosticare in prima approssimazione la validità della formula imprenditoriale a livello aziendale ALTO SUCCESSO SOCIALE BASSO
ALTO BASSO SUCCESSO REDDITUALE Anche qui, una volta posizionata l’impresa nella nostra matrice, è importante cogliere le ragioni profonde di tale posizionamento, le quali di solito vanno ricercate investigando lungo le ipotesi-guida enunciate nella figura 6. Se l’impresa si posiziona nel riquadro I, è probabile che il successo si fondi sul funzionamento “virtuoso” di “anelli critici” in cui l’economicità della gestione è vitalmente legata ai livelli di soddisfazione di determinati detentori di interessi. E’ questo il caso, ad esempio, di un’azienda chimica, avente gli impianti in funzionamento ventiquattro ore su ventiquattro per tutto l’anno, in cui il personale di produzione è al centro dell’attenzione e delle cure del management; o di una compagnia aerea, in cui lo spiccato “orientamento al servizio cliente” si salda con un altrettanto forte “orientamento al benessere dei lavoratori”, nel fondato e sperimentato convincimento che “benessere del personale” e “soddisfazione dei passeggeri” sono variabili interconnesse e cruciali agli effetti del successo reddituale, il quale, a sua volta, consente di
Economicità Successo sociale della gestione ottenuto a e soddisfazione scapito del dei partecipanti ruolo si alimentano economico a vicenda dell’impresa I III II IV Successo Diseconomicità economico della gestione e ottenuto con insoddisfazione sacrificio delle dei partecipanti “attese” di una o più si alimentano categorie di partecipanti a vicenda

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 17
alimentare il successo competitivo (mantenendo alto rispetto ai concorrenti il rapporto qualità/prezzo del servizio) e il successo con i dipendenti (soddisfacendo le loro attese retributive e d’altro tipo). Nelle imprese del riquadro I, come si può comprendere anche dagli esempi appena tratteggiati, il successo reddituale è perseguito in vista di soddisfare le attese dei detentori di interessi (in particolare di quelli critici) e il benessere e la soddisfazione degli stakeholders sono perseguiti nel presupposto verificato che lavoratori, azionisti, creditori ecc. soddisfatti del loro rapporto con l’impresa consentono alla stessa di raggiungere elevati livelli di produttività, efficienza, redditività; questa è l’”idea” che con ogni verosimiglianza costituisce il “cuore” della f.i. sovraordinata delle imprese posizionate nel riquadro I. Spesso è un’idea della cui portata il management non è ben consapevole e che perciò trova applicazione solo parziale – in ambiti ben più limitati rispetto a quelli in cui potrebbe esplicarsi – e quasi per forza naturale di cose. Tuttavia in qualche misura essa è operante. Nel riquadro II, invece, si ritrovano le imprese che hanno sistematicamente sottovalutato le loro responsabilità sociali nei confronti di una o più categorie di “detentori di interessi” (lavoratori, azionisti facenti parte del c.d. capitale controllato, comunità residenti nelle zone di insediamento degli stabilimenti, ecc.), in ciò favorite da una legislazione e, più ancora, da un clima sociale (politico, economico, socio-culturale) che ha consentito o tollerato bassi livelli di soddisfazione degli interessi di cui trattarsi. Naturalmente, come il clima muta nel senso di diventare più esigente, si innescano (ad iniziativa, per esempio, di gruppi di lavoratori o di esponenti sindacali, di soci non impegnati nella conduzione aziendale, di magistrati, ecc.) fenomeni di conflittualità destinati ad avere conseguenze esiziali per l’economicità della gestione. Gli anni postsessantotto sono ricchissimi di esempi al riguardo (e non soltanto in Italia). Le imprese che si posizionano nel riquadro III, al contrario di quelle che abbiamo appena esaminato, recano l’impronta inconfondibile di leaders socialmente illuminati (sensibili alle istanze di promozione sociale ed economica dei lavoratori; aperti nei confronti dei problemi dei lavoratori; aperti nei confronti dei problemi della comunità, che li vede non di rado politicamente impegnati; rigorosi nei riguardi della proprietà, disponibile per lo più ad accontentarsi di una remunerazione esigua); incapaci tuttavia di generare una forte tensione verso obiettivi di economicità, quale invece si richiede allorché vengono meno condizioni esterne facilitanti il compito di produrre ricchezza. E’ inutile dire, infatti, che il successo sociale prima o poi si rivela di corto respiro, se non è sostenuto da un buon successo reddituale e se, a sua volta, non è canalizzato al conseguimento di quest’ultimo. Nelle imprese di cui si discorre, invece, il benessere dei lavoratori – ed eventualmente di altri detentori di interessi – è perseguito senza una altrettanto vigorosa determinazione nel ricercare alti livelli di redditività. Viene così a svilupparsi una cultura aziendale forte attorno a valori imprenditoriali molto validi, fra i quali tuttavia spicca per la sua assenza il “profitto”, quasi che esso abbia di necessità una connotazione negativa, indipendente dal modo in cui viene perseguito e dall’uso che se ne fa. La conseguenza è bensì quella di produrre una forte coesione e identificazione con l’impresa; ma con una impresa che a un certo punto si rivela sottocapitalizzata, dotata di una insufficiente capacità di autofinanziamento e quindi incapace di sostenere i livelli di successo sociale raggiunti. Da ultimo, nel riquadro IV si ritrovano imprese incamminatesi in una spirale di crisi, in cui, da un certo punto in poi, la riduzione dei livelli di redditività e l’insoddisfazione dei partecipanti, generatrice di tensioni sociali e/o dell’indebolimento della volontà di collaborare, si alimentano a vicenda. Simili situazioni, ove la spirale di crisi non venga drasticamente interrotta inserendo l’impresa in un sentiero di risanamento, sono destinate a sfociare o in una liquidazione o in una sorta di stabilizzazione della crisi stessa. In questa seconda ipotesi, le imprese sono contraddistinte dai meccanismi di alimentazione finanziaria tipici delle economie assistite, ove le tensioni sociali sono utilizzate per ottenere le risorse necessarie a sopravvivere senza economicità. Vengono così a trovarsi stabilmente inserite nel riquadro IV imprese operanti con una f.i. sovraordinata diametralmente opposta a quella delle imprese del riquadro I. Come, infatti, queste ultime si fondano su circuiti autoalimentatisi di successo, dove alti livelli di redditività si coniugano con alti livelli di soddisfazione degli stakeholders, così le prime si mantengono in vita senza economicità grazie al combinarsi di perdite e di tensioni sociali alimentanti la richiesta e l’ottenimento di sussidi, i quali, proprio perché

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 18
erogati in una logica assistenziale – e quindi, tra l’altro, tardivi e insufficienti a sostenere seri progetti di risanamento – contribuiscono al perpetuarsi della crisi. Per una migliore comprensione e un corretto utilizzo della matrice della figura 7, è utile interrogarsi sui possibili comportamenti delle imprese ivi posizionate dinanzi ad una crescita generalizzata delle attese e richieste sociali che ad esse si rivolgono o ad un forte aumento delle pressioni ambientali sui livelli di redditività indipendente da variazioni nei livelli delle attese dei partecipanti. Se crescono le domande sociali che si rivolgono alle imprese, è verosimile che le aziende del riquadro I siano nelle condizioni migliori per rispondervi validamente. Esse, infatti, diversamente dalle altre aziende del riquadro III, dispongono di una redditività tale da consentir loro di assecondare, se del caso, tali richieste senza compromettere l’equilibrio economico-finanziario della gestione e, diversamente dalle aziende del riquadro II, hanno le carte in regola per interagire con gli stakeholders sulla base di rapporti aperti e costruttivi. Inoltre, ove esse abbiano sviluppato una cultura gestionale delle sinergie positive tra redditività aziendale e soddisfazione dei partecipanti, non è inverosimile che sappiano scorgere, nelle mutate condizioni ambientali, delle opportunità di crescita sul duplice piano della socialità e della redditività. Questo per quanto riguarda i plausibili comportamenti delle aziende del riquadro I. Quanto alle aziende che siano riuscite a trovare una collocazione abbastanza stabile all’interno dei riquadri II e III, è verosimile che, per motivi inerenti ai loro diversi valori imprenditoriali, le prime siano indotte a resistere all’aumentata pressione sociale, correndo quindi l’alea di pericolose rotture dei rapporti di collaborazione che bene o male si erano sino a quel momento mantenuti; le seconde ad assecondare le richieste nei limiti dei margini di redditività e liquidità ancora disponibili aggravando così il rischio di una rottura dell’equilibrio economico-finanziario. Quanto alle imprese in crisi cronica, stabilmente posizionatesi nel riquadro IV, si possono ipotizzare delle reazioni volte a contenere il livello delle perdite entro un limite politicamente accettabile, consistenti sia in interventi limitati di risanamento sia in azioni di contenimento delle pressioni sociali. Figura 7 – Percorsi di crisi. ALTO SUCCESSO SOCIALE BASSO
ALTO BASSO SUCCESSO REDDITUALE
I III (b) (d) (c) (a) II IV

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 19
Considerazioni sostanzialmente non dissimili possono svilupparsi circa i possibili comportamenti delle imprese dei riquadri II, III e IV in presenza di un forte aumento delle pressioni ambientali sui livelli di redditività. Anche qui – se si trascura l’ipotesi di radicali cambiamenti di rotta, che implicano cambiamenti non facili da realizzare nella cultura e nei valori aziendali – è verosimile che le aziende del riquadro II cerchino di difendere i livelli di redditività chiedendo ulteriori sacrifici a certe categorie di stakeholders; le aziende del riquadro III cerchino di difendere i livelli di socialità raggiunti senza arrivare a una rottura dell’equilibrio economico-finanziario: le aziende del riquadro IV si adoperino per contenere le perdite entro limiti politicamente accettabili. Quanto alle aziende del riquadro I, invece, giova distinguere quelle la cui redditività poggia su formule competitive di successo internamente coerenti da quelle il cui successo reddituale è invece influenzato in misura decisiva da condizioni esterne favorevoli che in ipotesi vengono meno. Le prime evidentemente si trovano nelle migliori condizioni non solo per resistere alle accresciute pressioni sui livelli di redditività, ma addirittura per trarne vantaggio. Le seconde, invece, entrano in un sentiero di crisi che plausibilmente le porta nel riquadro III se la cultura aziendale è permeata di socialità mentre è scarsamente influenzata dalla dimensione economico-finanziaria e nel riquadro II nel caso opposto. Le considerazioni fin qui svolte consentono di disegnare sulla nostra matrice alcuni tipici sentieri di crisi (Fig. 7). I percorsi a e b, con la loro caratteristica forma a gomito, stanno a indicare imprese già attestatesi rispettivamente nei riquadri II e III, le quali in ipotesi hanno resistito sino al limite di rottura nella difesa del livello di redditività o di quello di socialità, per poi precipitare nella situazione del riquadro IV. I percorsi c e d, invece, sono quelli di due imprese già posizionate, nel riquadro I, che, a seguito di forti pressioni sui livelli di redditività, si portano su sentieri di crisi inizialmente orientati in senso rispettivamente verticale e orizzontale e poi in discesa obliqua verso il riquadro IV. Ciò sta a significare una iniziale tenuta o della redditività o dei livelli di soddisfazione dei partecipanti (anche grazie al ridimensionamento delle attese di alcuni di loro e segnatamente dei proprietari) e, successivamente, l’attivarsi di un circuito perverso insoddisfazione/perdite che tende a trascinare l’impresa verso il riquadro IV. Questo per quanto riguarda i percorsi di crisi. Quanto ai percorsi di successo, essi, quando riguardano imprese posizionatesi nei riquadri II, III, e IV, comportano sempre un grosso cambiamento culturale: nel caso delle imprese del riquadro II si tratta di aprirsi alla socialità; quelle del riquadro III devono introdurre capillarmente nella loro cultura manageriale e aziendale il bene inteso valore della profittabilità che è alla base di una forte capacità di incrementare i mezzi propri, a sua volta condizione necessaria per recuperare un’ampia libertà di scelta e di elasticità gestionale; quelle del riquadro IV, per riattivare i sani meccanismi di alimentazione finanziaria basati sulla fiducia, devono staccarsi dall’ancoraggio ai valori e alle logiche di funzionamento delle economie assistite. Trattasi di “giri di boa” purtroppo abbastanza rari in assenza di eventi traumatici (causanti un forte, rapido aggravarsi della crisi) e/o di un cambiamento nel gruppo di potere che controlla l’impresa. Nel caso delle imprese già posizionate nel riquadro I sono pure pensabili dei cammini di progresso che consentano il realizzarsi di un potenziale di miglioramento dell’impresa, sia sul piano sociale che su quello reddituale, probabilmente destinato a non esaurirsi mai. Si tratta di portare avanti un continuo apprendimento imprenditoriale incentrato solo su variabili economico-finanziarie e sociali in senso lato, ma anche su quelle competitive proprie delle diverse ASA in cui l’impresa è impegnata. Nelle pagine precedenti, invero, per meglio focalizzare le relazioni che nelle imprese eccellenti si stabiliscono tra successo reddituale e successo sociale, si sono sottaciute le connessioni tra successo sociale e successo competitivo. Tuttavia, gli esempi in precedenza addotti per chiarire i circuiti virtuosi tra livelli di redditività aziendale e livelli di soddisfazione dei partecipanti denotano come tali circuiti, lungi dall’essere avulsi dalla realtà di concreti sistemi competitivi, sono elementi essenziali di strategie competitive vincenti. Si può pertanto asserire che una f.i. valida è orientata a perseguire simultaneamente e congiuntamente il successo sul piano competitivo, su quello sociale e su quello reddituale e tende ad attivare dei circuiti di successo autoalimentantisi che intersecano questi diversi piani, secondo quanto indicato nella figura 8.

SDA Bocconi School of Management La valutazione della formula imprenditoriale (protocollo n° 5392)
Copyright © SDA Bocconi, Milano 20
Figura 8 – Circuiti di successo caratterizzanti il funzionamento di una formula imprenditoriale pienamente valida. Le connessioni tra successo sociale e successo competitivo appaiono particolarmente evidenti e immediate quando gli stakeholders in considerazione sono i lavoratori, mentre possono sembrare meno evidenti e dirette quando sono in gioco altri detentori di interessi come gli azionisti o le banche. E ciò specialmente nel caso di imprese multibusiness. A ben vedere, però, anche in questi casi e per questi altri tipi di stakeholders si stabiliscono rilevanti connessioni tra successo sociale e successo competitivo, le quali si annodano intorno a una certa missione aziendale condivisa, i cui contenuti, ancorché non siano verbalizzati, sono resi manifesti dal concreto operare aziendale in certe definite arene competitive e secondo certi criteri o modalità di successo.
Considerazioni conclusive In sintesi, l’approccio valutativo della f.i. proposto in questo scritto muove dalla rilevazione e dall’apprezzamento dei risultati conseguiti dall’impresa sul terreno competitivo, su quello reddituale e su quello della soddisfazione delle “attese” dei partecipanti. Quindi, dopo aver individuato le tipologie di appartenenza delle ASA e dell’impresa (con l’ausilio delle “matrici” dianzi illustrate), si tratta di risalire alle cause di successo o insuccesso mediante un’analisi da condurre sul filo di ipotesi-guida che, pur nella loro genericità, suggeriscono il tipo di spiegazione da ricercare. L’analisi, com’è ovvio, può essere spinta a vari livelli di profondità in relazione alle specifiche esigenze conoscitive dei soggetti interessati. In ogni caso, tuttavia, sulla scorta delle accennate ipotesi, essa tende a una spiegazione puntuale che evidenzia le eventuali necessità di rinnovamento della f.i.. Nella ricerca di una simile spiegazione, non si può fare a meno di ripercorrere in qualche misura la storia dell’azienda nei fattori salienti che hanno concorso a determinare il suo profilo attuale. Infatti, solo una prospettiva storica, che abbracci l’impresa e il settore, consente di ricostruire i sentieri di successo o di crisi dell’impresa e quindi di capire come e perché essa è arrivata a certe posizioni. I sentieri in parola, come si è visto, tendono ad assumere delle configurazioni tipiche, che possono essere rappresentate sulle note matrici. Ma, al di là delle possibili rappresentazioni degli stessi, è importante identificarne di volta in volta il tracciato tempificato e i passaggi che segnano svolte significative.
Successo competitivo
Successo reddituale
Successo sociale