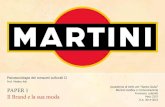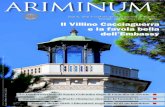Stile cognitivo tra apprendimento ed insegnamento Ornella Castellano.
Ornella Martini
-
Upload
educare-comunicare -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
description
Transcript of Ornella Martini
3. La casa, le casedi Ornella Martini
Io sono una donna (l’affermazione risuoni piana, osservativa, assolutamente esente daenfasi nervosa, aggressiva o lamentosa), per questo attrezzata a stare sul limite, il con-trasto, l’innumerevole, il caos.
In questo contributo ho scelto, ovviamente in accordo con gli altri quattro membridel gruppo di autori (maschi, come si evince dai nomi), di filare il tema indicato dal ti-tolo del volume ambientandolo sulla scena materiale, simbolica, metaforica, della casa(e, perché no, della famiglia. Di questi tempi, poi, argomento più che aggrovigliato esfuggente!).
Nella mia prospettiva, la casa rappresenta per un verso la complessità dell’esistenzafemminile in tutti i suoi controversi spazi di movimento, tra tentativi, spesso drammati-ci, di renderla libera, almeno in uno dei suoi angoli o dei suoi intervalli di vita, e eserci-zi di un potere spesso assoluto in luoghi insospettabili (ne vedremo, seppure velocemen-te, uno, il salotto); per un altro (insieme alla città e alla scuola, nell’intreccio dei loro rap-porti sintonici e conflittuali, almeno nella mappa dei territori che ci sembra interessantee utile ricostruire ed esplorare in questo Manuale) rappresenta la novità della rimedia-zione. Rimediazione dei rapporti tra le forme molteplici e diverse della comunicazione,essendo il luogo di estrema concentrazione della presenza di media vecchi e nuovi; e ri-mediazione degli usi e dei significati delle categorie impiegate per interpretare le profon-de trasformazioni realizzatesi fin qui e a questo momento.
Il mio tentativo è di tessere insieme i tanti (non tutti, ma tutti quelli che riesco a vede-re) fili che legano la specificità dell’esistenza al femminile alla specificità femminile del-l’esistenza qui e ora, dentro la trama dei tanti cambiamenti che stanno modificando, lo ri-peto, le forme e i modi dello stare al mondo, nella pluralità e ambivalenza dei generi ses-suali, in via di ri-definizione. Per cercare di comprendere le suggestioni, dunque le scelteeducative che si presentano in questo scenario mobile e scivoloso e che, forse anche pertali inquietanti implicazioni, appaiono moralmente ed eticamente attraenti. Vorrei risul-tasse immediatamente evidente che il mio interesse non è adottare la prospettiva di gene-re per riaffermare confini di appartenenza e di esclusione, come potrebbe accadere se, ma-le interpretando le mie intenzioni, lettori maschi si sentissero sollevati dall’impegno dileggere per intero il testo; il mio interesse è sollecitare una riflessione di portata generalesui cambiamenti in atto, caratterizzati, a mio avviso, da una specificità tutta femminile, dari-scoprire e mettere in evidenza, senza dimenticare i conflitti e i limiti persistenti nellecondizioni di vita delle donne, ma non per questo facendosi travolgere dall’incertezza, dal-la rabbia, dalla paura. Proprio la diffusa e profonda presenza di sensibilità, intelligenze,saperi, esperienze femminili in contesti attuali di vita, anche e soprattutto per effetto del-
LA CASA, LE CASE 87
03MAN_Abruzzese_cap03.qxd 17-11-2008 12:37 Pagina 87
l’azione dei tanti media della comunicazione e dell’interazione, multimediali e di rete,porta a considerare come fondamentale la prospettiva al femminile dell’esistenza.
3.1. Idee di casa
Ecco, allora, che la casa mi pare il luogo adatto per affrontare la complessità, l’apertura,l’indefinitezza dell’esistenza al femminile e dell’esistenza in generale: la casa, infatti, co-stituisce il luogo fisico e simbolico nel quale si concentrano tutti i conflitti emotivi, dal piùprofondo e intimo bisogno di protezione e cura, al desiderio indomabile di autonomia, so-litudine, fuga. Per chiunque le iniziali aspettative esistenziali prendono corpo tra quattromura, sognate come nido caldo e accogliente, dalla soglia del quale prima o poi, ovvero almomento giusto, si sarà pronti per spiccare il volo e iniziare così il proprio percorso. So-gno biologicamente esatto e prevedibile (salvo i tanti pericoli, sia quelli necessari da af-frontare, sia quelli selettivamente prevedibili) per quasi tutte le specie animali; sogno so-cialmente e personalmente impossibile, continuamente rimandato e fantasticato, per mol-tissimi individui appartenenti alla specie umana. La casa, metonimicamente e metaforica-mente rappresentazione della vita familiare, se non agisce nella direzione della separazio-ne e della crescita consapevole, si trasforma da nucleo avvolgente e dinamico in una terradi confino, con gradi diversi di stati di contenzione, di violenza, di atti repressi di resi-stenza e di ribellione. In tali condizioni, diventa simbolo di privatezza, dipendenza, domi-nio, e spesso luogo oscenamente individuabile di atti brutali e definitivi, la cui origine sitende a cercare fuori invece che dentro, nel tentativo insensato di salvaguardare un ordinedelle cose che, invece, si dovrebbe contribuire a rifiutare e smantellare del tutto.
La casa rappresenta, insomma, il luogo più controverso e conflittuale, proprio perquesto il più adatto per ragionare, secondo me, donna per genere e per realizzazione per-sonale, degli straordinari cambiamenti che stiamo vivendo, nella cornice dei tanti cam-biamenti avvenuti nel passato. Allo stesso tempo, è il luogo più adatto per ripensare leforme di una educazione intimamente e significativamente personale e umana, che si at-tui come laboratorio di opportunità e di scelte libere, e non come prima e ultima forma di«istituzione totale».
La casa, dunque, solo per semplificazione è uno spazio che si percepisce come stabi-le, impermeabile, intimo e privatissimo.
3.1.1 Il modello urbano
In primo luogo, dovremmo chiarire che idea di casa abbiamo come riferimento. Spostar-ci di molto, in un altro continente ad esempio, ci metterebbe subito a confronto con tipo-logie dell’abitare case tutt’altro che stabili (nonostante la paradossale, e profondamenteingiusta, convivenza di milioni di persone con eventi «naturali» frequenti e distruttivi);ma anche spostarci di poco, in villaggi rurali del nostro Paese ad esempio, ci mostrereb-be la forza irresistibile di penetrazione del controllo sociale da parte della comunità: nonc’è antico muro di pietra, siepe o boschetto che possa difendere il privato dalla chiac-
88 EDUCARE E COMUNICARE
03MAN_Abruzzese_cap03.qxd 17-11-2008 12:37 Pagina 88
chiera pubblica dentro la comunità di appartenenza; attenzione che poi la difesa dell’in-tegrità morale della comunità tutta ridiventa strenua, se minacciata pubblicamente dallanecessità di indagini, in caso di eventi tragici, delittuosi, discutibili. D’altra parte, però,è innegabile che la convivenza in piccole comunità presenta ancora, nonostante tutto,l’insistenza di reti di relazioni sociali che, oltre al controllo, svolgono una funzione di re-ciproco sostegno materiale e affettivo, rendendo così più mobile il confine tra pubblico eprivato anche in termini positivi, non soltanto negativi.
Risulta del tutto evidente che il modello di riferimento da adottare non può essere chequello urbano, perché la città è l’altra faccia, pubblica, nella quale le soglie delle case, con-fine sempre più sottile (come gli strati di cartongesso che separano gli spazi abitativi deigrandi conglomerati periferici) tra intimità e pubblicità, chiusura e apertura, separazionee integrazione, si addizionano in orizzontale e in verticale, quasi senza soluzione di conti-nuità. Così come la casa è centro nevralgico, laboratorio controverso degli affetti e dellescelte private, la città è centro nevralgico e laboratorio di ogni sperimentazione pubblica(il corsivo ai due termini segnala gradi di indefinitezza e ibridazione tutti ancora da chia-rire: lo farò più avanti, e sarà uno dei nuclei del mio ragionamento).
Nella sua complessità e varietà di soluzioni (le nostre città sembrano presentarne mol-teplici di origine spontanea, frutto di buchi di programmazione o di programmazioni per-sonalistiche a uso e consumo di varie genie di palazzinari), la città offre allo sguardo in-siemi davvero multiformi e curiosi; anche soltanto pensando ai tipi di case in cui una stes-sa persona può abitare: il villino familiare, il grande palazzo, il villino a schiera in condo-minio, la casa monofamiliare. Più da vicino, risulta di particolare interesse la comunità-condominio «totale»: lì, il primo gesto d’insediamento di un nuovo nucleo familiare con-siste solitamente nella predisposizione di un’alta siepe tutto intorno al giardino, per ripa-rare l’interno dagli sguardi – vissuti come indiscreti – dell’esterno; mentre, visto il conte-sto, ci si aspetterebbe atteggiamenti più disponibili all’intreccio di relazioni umane.
A fronte di questa difficoltà a intrecciare rapporti aperti di buon vicinato, colpisce percontrasto lo stile di vita dei Paesi scandinavi, nei quali il desiderio di essere raggiunti dal-la luce e dal calore del sole fa sì che si cerchi di esporre il più possibile l’interno di ogniabitazione allo schermo trasparente e cangiante del vetro; in questa secolare aspirazioneritrovo il significato dell’espressione «portare alla luce del sole» (sarebbe interessante ve-rificarne presenza e declinazione nelle lingue di quei Paesi). Non posso non pensare, in-fatti, che gli esperimenti di dinamica sociale, aperti all’integrazione, all’ibridazione, algioco, tradizionalmente avviati lì, non dipendano anche dall’abitudine di esporre il pri-vato in pubblico, rendendolo maggiormente condiviso, attento, disponibile all’influenzadi ciò che avviene fuori. Se è vero, come noi crediamo, che ogni forma e oggetto scelticomunicano, dunque significano.
3.1.2 Schermi e finestre
L’aspirazione alla trasparenza, alla comprensione dei comportamenti privati, magari an-che solo la curiosità un po’ ‘pelosa’ o il divertimento di cogliere qualcuno in flagranza diprivato di fronte al pubblico, negli ultimi anni hanno motivato l’interesse per esperimen-
LA CASA, LE CASE 89
03MAN_Abruzzese_cap03.qxd 17-11-2008 12:37 Pagina 89
ti spettacolari, ovviamente alimentati dalla messa in scena televisiva (vale come antici-pazione di discorsi che farò presto). Tra i vari che hanno bucato lo schermo, entrando nel-le case di milioni di persone, ricordo il periodo di vita di una giovane donna cilena in unacasa trasparente, e la serie, alla sua ottava edizione nel 2008, de Il Grande Fratello.
Nel primo caso, la televisione fungeva da cassa di risonanza di un’esperienza che po-teva anche avere una sua autonomia: lì, una giovane donna (Daniella Tobar, attrice), mo-tivata da intenti artistici sostenuti anche da quel genere di performance e dall’appoggiodi un’istituzione pubblica (il progetto era finanziato dal Ministero della Cultura), si espo-neva ed esponeva per quindici giorni la sua vita privata e intima allo sguardo – la defini-zione dei cui tratti faceva parte intrinseca, e forse costituiva la finalità del gioco – dei pas-santi e degli abitanti dell’intera città di Santiago, del Paese e del mondo intero, si direb-be, considerando l’attenzione costante con cui l’intera performance fu seguita dalle tele-visioni cilene e straniere (qualche informazione ‘storica’ sul caso – che risale all’iniziodel 2000 – sta in http://en.wikipedia.org/wiki/Daniella_Tobar).
Nel secondo, si tratta di un vero e proprio format televisivo di derivazione e circola-zione internazionale, in cui l’associazione comunicativa tra televisione e Internet, soste-nuta dai rimbalzi prodotti da riviste, giornali, radio e passaparola, sviluppa un vero e pro-prio sistema spettacolare autonomo. La «Casa», set e centro dell’azione, si fa trasparen-te attraverso l’azione multipla delle telecamere, occhi puntati sullo specchio dello scher-mo, dove in realtà gli spettatori guardano se stessi. Nonostante il richiamo orwelliano, ilgioco delle telecamere-specchio pare più coerente con l’impianto dello spettacolo, chenon con l’idea di un grande occhio del potere che controlla attraverso l’imposizione del-l’autocontrollo. Dentro quella casa abitano gli spettatori, e partecipano alla grande simu-lazione di una vita, sì in cattività, ma per certi versi esemplare. Moltissimi osservatori delfenomeno, rifiutando anche solo di considerarne un qualche possibile aspetto positivo,giudicano e condannano senza appello, sostenendo l’argomento del cattivo esempio, sen-za considerare l’ipotesi che esso possa costituire una sorta di laboratorio pubblico delcomportamento privato, intrecci sentimentali e rumori fisiologici compresi. Joshua Mey-rowitz, un autore importante per questo tema, e che più avanti chiamerò di nuovo a testi-mone, parla di «comportamenti da retroscena», per indicare i comportamenti privati chesolitamente si evitano in pubblico, e ragiona proprio sull’irrompere del privato nel pub-blico attraverso gli occhi della televisione. Il Grande Fratello mi pare un’idea interes-sante di per sé, perché mette costantemente gli spettatori nella condizione di domandar-si: cosa farei io in quella situazione, non da solo, nell’intimità della mia casa, ma in pub-blico, in una casa dove abitano altre persone, necessariamente chiamate a compiere unamolteplicità di azioni non tutte volute, non tutte condivise, non tutte ‘pulite’. Ma certo,se tutto si riducesse al conteggio dei rumori corporali dei partecipanti e delle loro be-stemmie, a conferma dell’idea che tutti, pubblico e autori, non abbiano in fondo che que-sto interesse, le potenzialità pedagogiche del format sarebbero ben poche.
Ho introdotto, non a caso, il tema della presenza della casa in televisione, mentre stoper sviluppare il tema della presenza della televisione, e di una molteplicità di altri media,nelle case; ho parlato di tipologie di abitazioni e di modi di viverle, e ho pensato all’altonumero di serie televisive che riempiono i palinsesti delle televisioni generaliste pubbli-che e private e delle pay-tv: in quante case, in quanti mondi entriamo, seguendo indagini
90 EDUCARE E COMUNICARE
03MAN_Abruzzese_cap03.qxd 17-11-2008 12:37 Pagina 90
giudiziarie, azioni poliziesche, emergenze mediche, intrecci amorosi, saghe familiari, ecosì via, delle tante fiction proposte? Interessante è, a questo proposito, la chiave con laquale Michelle Perrot assume la rappresentazione degli interni domestici nel romanzo del-l’Ottocento e del primo Novecento: «è un’immensa storia di famiglia, alimentata da intri-ghi domestici e avventure personali di cui lo spazio privato – dalla cantina al solaio, dalsalotto alla camera da letto – costituisce l’immancabile sfondo. Come è stato rappresenta-to questo spazio nel romanzo?». Nel presentare la sua proposta di indagine, ovvero assu-mere l’universo di finzione del romanzo come ambito di studio storico della vita privata,la Perrot sottolinea l’atteggiamento diffidente della comunità degli storici davanti all’ipo-tesi di considerare come fonti storiografiche dei prodotti di narrativa. «Via via che il loroapproccio alla realtà si faceva più complesso, essi hanno tuttavia accettato la nozione di‘rappresentazione’, con i suoi confini incerti, e cominciato a studiare la storia delle sensi-bilità e dell’immaginario: ritrovando così, fortunatamente, i percorsi della letteratura e deisuoi testi, indispensabili fili di Arianna nel labirinto dell’interiorità» (Perrot 2003, p. 496).
Ecco, le innumerevoli rappresentazioni letterarie, cinematografiche, televisive costi-tuiscono un repertorio fondamentale di ricerca, perché fanno parte integrante dell’iden-tità culturale di singoli e di gruppi.
LA CASA, LE CASE 91
LA PAGINA
Casa: bisogno di sicurezza, protezione e potereIl desiderio di opporre resistenza al tumultuare degli eventi esterni, ergendo tra sé e il mondouna casa, è insopprimibile, primordiale, anche laddove le condizioni materiali rendano l’obiet-tivo da raggiungere solo una lontanissima copia di un modello ideale di sicurezza e protezione.Sulla strada di questo mio lavoro ho trovato un bel romanzo di Kate Grenville, Il fiume segre-to, affresco vivido delle origini feroci di un mondo ormai altamente civilizzato, l’Australia, pa-gate con un prezzo altissimo dai nativi maori, a cui il romanzo è dedicato come una sorta di tri-buto postumo di una pena ingiusta, ormai ampiamente e irrecuperabilmente scontata.Il romanzo racconta la nascita e lo sviluppo di Sidney, e della nazione che le è sorta intorno, aopera dei forzati inglesi, spediti nelle terre inospitali di quella colonia, il Nuovo Galles del Sud,da Sua Maestà, per scontare una pena a vita, utile per ampliare a dismisura il potere economi-co dell’Impero britannico. La storia di William Thornhill si svolge nel 1806: la vita sua e dellasua famiglia s’intrecciano a quelle di innumerevoli altri testimoni di quel formicolio produtti-vo che tentava di riprodurre la Gran Bretagna in una terra completamente diversa per caratterifisici e antropici, combattendo brutalmente gli ostacoli più impervi, la vegetazione con i suoiserpenti, i suoi insetti velenosi e i suoi indigeni, considerati alla stregua di animali pericolosi,ovviamente, e per questo rifiutati, cacciati e uccisi. La costruzione della propria abitazione costituisce il primo atto per sancire la proprietà con-quistata di un pezzo di terra, nel tentativo di creare un dentro sicuro che protegga da un fuori,necessario e utile, però pericolosissimo. Nonostante il tentativo riesca soltanto in piccola par-te, il risultato è considerato fondamentale dal protagonista.
«A furia di estirpare, disboscare, costruire stava però scoprendo un nuovo William Thornill: unuomo che poteva combattere contro la natura selvaggia finché non gli avesse concesso un’abita-zione. Il cerchio di terra raschiata e battuta cresceva di giorno in giorno. L’aria era satura dei lorosuoni: alberi abbattuti, i crepitii delle fascine ammucchiate che bruciavano, il tonfo del picconenella terra. C’erano voluti giorni per ripulire il campo di granoturco, e a quel punto si erano ac-
03MAN_Abruzzese_cap03.qxd 17-11-2008 12:37 Pagina 91