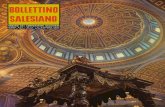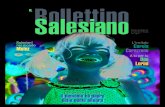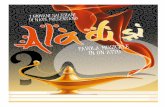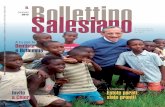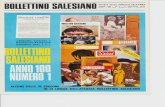Marzo 2008 - biesseonline.sdb.orgbiesseonline.sdb.org/2008/pdf/200803.pdf · Ogni persona ha...
Transcript of Marzo 2008 - biesseonline.sdb.orgbiesseonline.sdb.org/2008/pdf/200803.pdf · Ogni persona ha...
RIVISTA FONDATADA S. GIOVANNI BOSCONEL 1877
Marzo 2008Mensile - Anno CXXXII - nr. 3Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003(Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB PDSpedizione nr. 3/2008
Qual è questo origina-le sistema educativo?La prassi di Don Bo-
sco è un’arte pedagogico-pastorale, avendo egli tra-dotto l’ardente carità delsuo ministero sacerdotalein un progetto concreto dieducazione dei giovani nellafede: la pedagogia è un’arteche esige talento. Non si tratta diformule statiche o magiche, bensì diun insieme di condizioni che rendo-no la persona capace di paternità ematernità educativa. La prima diqueste condizioni è quella di cono-scere la propria epoca e di sapersiadattare a essa. In seguito vengonoalcune caratteristiche, fra le quali:
>> Creatività di artista per coniu-gare l’impulso pastorale con l’intelli-genza educativa. Si tratta di un tipodi passione apostolica che si sentechiamata in causa dall’attuale climadi secolarizzazione. In Don Bosco ilprincipio metodologico che lo spingead agire da vero artista è il suoatteggiamento di amorevolezza:costruire fiducia, familiarità e amici-zia. Il sistema preventivo ha molto dicarismatico, di “chiamata vocaziona-le” e comporta la mistica della caritàpastorale (la passione del Da mihianimas) e l’ascesi del “farsi amare”
>> Con lo sguardo fisso sull’Uo-mo nuovo. Il fine che si prefiggel’educazione salesiana è la configu-razione all’Uomo nuovo (Cristo) inogni giovane. Ciò non è preso inconsiderazione dall’educazione lai-cista. Per un educatore salesianoCristo è la migliore notizia che sipuò dare a un giovane: ci rivela Diocome Padre, e ci dice che in Cristosiamo figli di quel Padre. Non vi èdignità maggiore né miglior notiziada trasmettere. Solo Lui è la Via, laVerità e la Vita. L’evento/Cristo nonè semplicemente espressione diuna formulazione religiosa, ma unfatto obiettivo della storia umana.Ogni persona ha bisogno di Lui e aLui tende, anche se non lo sa. Laricerca malsana di efficacia e ilrelativismo religioso vanno a scapi-to della personalità dei giovani.
>> Mediante un lavoro di caratte-re preventivo. Prevenire è l’arte dieducare in positivo, proponendo ilbene in modo attraente; è l’arte difar sì che i giovani crescano dal di
(“non basta amare i giovani.Essi devono sentire chesono amati”).
>> In rapporto di solida-rietà con i giovani. Fare ilprimo passo, “andare ai
giovani” è “la prima e fon-damentale urgenza educati-
va”2. Il giovane è soggetto atti-vo nella prassi educativa e deve
sentirsi veramente coinvolto comeprotagonista nell’opera che si vuolerealizzare. Senza la sua libera colla-borazione non si costruisce nulla. Èquesta l’esperienza di Don Boscocon i ragazzi; egli non agiva conqui-standoli, ma condividendo con essile responsabilità. Una solidarietà edu-cativa oggi più necessaria che mai,visto che le varie agenzie educativenon sono sempre in sintonia con leesigenze formative del giovane.
EDUCARECON IL CUORE DI DB
IL SISTEMA PREVENTIVO“Voi avete opere, collegi, case, ma avete solo un tesoro:
la pedagogia di Don Bosco. Rischiate tutto il resto ma salvatequesta pedagogia… Il Signore vi ha affidato una pedagogia
in cui trionfa il rispetto del ragazzo… Conservatela: rinnovata,ringiovanita, arricchita di scoperte moderne, adattata
ai vostri ragazzi, che sono strapazzati in un modo come Don Bosco non ne aveva visti mai”1.
STRENNA 2008di Pascual Chávez Villanueva
Umbe
rto G
amba
2
MARZO 2008 BS
Prevenire è l’arte di educare affinché i giovani camminino con allegria correggendo deviazioni e preparandosi per l’avvenire.
3
In copertina:Sembra che meritino
le prime pagine di giornalie riviste solo notizie
tragiche e cronaca nera.Perché non cambiare
tendenza a favore di buone notizie
e cronaca bianca?Foto: Cipriano Demarie
Marzo 2008Anno CXXXII
Numero 3
RIVISTA FONDATADA S. GIOVANNI BOSCONEL 1877
Marzo 2008Mensile - Anno CXXXII - nr. 3Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003(Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB PDSpedizione nr. 3/2008
Mensile di informazionee cultura religiosa editodalla Congregazione Salesianadi San Giovanni Bosco
Direttore:GIANCARLO MANIERI
CHIESA12 Quo vadis Europa? (16) di Silvano Stracca
CASA NOSTRA14 Passeggiate e teatro di Martina Crivello
VIAGGI18 Tradizioni di un popolo... tradito di Giancarlo Manieri
EVENTI20 I talami / Chimbote di Filippo Manoni
INSERTO CULTURA23 EDB per l’Africa di Maria Antonia Chinello
FMA28 Dopo cent’anni... ci siamo di Graziella Curti
RUBRICHE2 Il Rettor Maggiore – 4 Ribalta giovani – 6 Lettere al Direttore – 8 In Italia & nel Mon-do – 11 Osservatorio – 16 Box – 17 Zoom – 22 Lettera ai giovani – 27 Bagliori – 30 Li-bri – 32 On Line – 34 Come Don Bosco – 36 Arte Sacra – 37 Laetare et benefacere… –38 Sfide etiche – 40 Dibattiti – 41 Note sulle note – 42 I nostri morti – 43 Il mese – 44 Prima pagina – 45 Relax – 46 I nostri santi – 47 In primo piano/Focus
dentro, con libertà interiore superan-do formalismi esteriori; è l’arte diguadagnarsi il cuore dei giovaniaffinché camminino con allegriafacendo il bene, correggendo devia-zioni, preparandosi per l’avvenire.
>> Unendo in un solo fascio diluce ragione, religione e amorevo-lezza che entrano in tensione “insie-me”. Non sono valori semplicementeumani, né solo religiosi e nemmenosolo di amabilità, ma tutti e tre i poliinsieme, in un clima di bontà, lavoro,allegria e sincerità. Evidentemente lapratica del sistema preventivo diven-ta per l’educatore una spiritualità esi-gente. Non si può praticare senzauna comprovata carità pastorale euna vera passione apostolica. Stia-mo parlando di santità pedagogica,attraente ma profonda, che si identi-fica con l’allegria, ottenuta a base diservizio ai giovani, sacrificio, lavoro etemperanza (coetera tolle).
>> Con un impegno creativo neiconfronti del tempo libero del gio-vane. “La vita di gruppo è un ele-mento fondamentale della tradizionepedagogica salesiana”3. A ChieriGiovannino Bosco fondò la “Societàdell’Allegria”; Domenico Savio fondòla Compagnia dell’Immacolata; Mi-chele Magone apparteneva allaCompagnia del Santissimo… Attra-verso le associazioni si arriva agliambienti e a ogni singola personaall’interno del gruppo. Naturalmenteoccorre essere sempre disposti aoffrire un competente accompagna-mento personale, specialmente aglianimatori e ai responsabili. �
È possibile leggere in anticipoil prossimo numero, collegandosi
al sito Internet:http://biesseonline.sdb.org
Redazione: Maria Antonia ChinelloNadia Ciambrignoni - Giancarlo De Nicolò - Franco LeverNatale Maffioli - Francesco Motto - Vito OrlandoSegreteria: Fabiana Di BelloCollaboratori: Severino Cagnin - R. Desiderati Graziella Curti - Enrico dal Covolo - Bruno FerreroCesare Lo Monaco - Giuseppe Morante -Vito OrlandoMarianna Pacucci - Gianni Russo - Roberto SaccarelloArnaldo Scaglioni - Silvano Stracca - Maria Antonia ChinelloFotoreporter: Santo Cicco - Cipriano DemarieChiara Fantini - Tadeo Martin - Vincenzo OdorizziGuerino PeraProgetto grafico: Laura TononiImpaginazione: Puntografica s.r.l. - Torino
Il BOLLETTINO SALESIANO si stampa nel mondo in 56 edizioni e 29 lingue diverse. Raggiunge 131 Nazioni,più di quelle in cui operano i salesiani.
Direttore Responsabile: Antonio MartinelliRegistrazione: Tribunale di Torino n. 403 del 16.2.1949Diffusione e Amministrazione: Giovanni Colombi (Roma)Stampa: Mediagraf s.p.a. - Padova
ILBO
LLET
TINO
SALESIANO
NEL
MO
ND
O
Associato allaUnione StampaPeriodica Italiana
Via della Pisana 1111 - 00163 RomaTel. 06/656.12.1 - Fax 06/656.12.643e-mail: <[email protected]>Direttore <[email protected]>Fondazione DON BOSCO NEL MONDO - ONLUSCcb 3263199 - Banca Intesa - Fil. Roma 12 CIN P - ABI 03069 - CAB 05064Ccp 36885028 - CF 97210180580e-mail: <[email protected]>web: www.fdbnm.org
BS MARZO 2008
La santità pedagogica salesiana è attraente ma profonda, si identifica con l’allegria ottenuta a base di servizio, sacrificio, lavoro e temperanza.
1 Jean Duvallet. 2 Giovanni Paolo II, “Juvenum Patris”, 14. 3 Cap. Gen. SDB 23, n. 274.
RIBALTARIBALTA
A Marco replica Pietro: “Sembra distare nella giungla!”. Pietro di anni neha 29 e guadagna 500 euro al mese. È precario in un call center. Lui non
vede un futuro con Daria 28 anni, la fidanzata. Dice che praticamentenon può formare famiglia. Davanti
allo schermo, continuando a scorrerele notizie, l’inquietudine cresce.
Bruno Santino aveva 26 anni.L’azzurro immenso del cielo è
diventato un giardino proibito. Nelbuio della stanza ci raggiunge l’eco
della televisione. C’è “Amici”, uno deiprogrammi più seguiti in tv dagli
adolescenti. È un trampolino di lancioallestito ad arte dagli adulti per noi
giovani a caccia di successo. Nel programma i ragazzi della scuola
concorrono tra loro. Le loro vicissitudini appassionano
e soprattutto alzano gli indicid’ascolto. È l’ufficio di collocamento
delle nuove generazioni. Uno su mille ce la fa.
Il costo umano degli standard diproduttività aziendali è altissimo.
Il profitto regna sovrano. Nel decreto legislativo 626/94 che
recepisce le direttive della ComunitàEuropea sulla tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori, al punto cdell’articolo 2 leggo: “Servizio di
prevenzione e protezione dai rischi”.Esaminandolo, capisco che le
normative ci sarebbero, e pure serie!Evidentemente dalle norme alla realtà
qualcosa è violato. Sembrerebbedalle testimonianze che sul luogo delrogo tre estintori non funzionassero.
“Buonanotte a tutti ragazzi”, diceMarco. Per un momento sembra un
saluto a chi se n’è andato. In realtà ètardi e andiamo a dormire, ma come
si fa a stare tranquilli? Il pensieroviaggia attraverso il respiro del
mondo; nel liquido blu del cielo.Nell’aria fredda di questo inverno lo
sguardo va oltre la finestra dovedorme un albero soave, fitto di rami.Tende le dita verso l’azzurro. Non ègiusto quanto è successo. Qualcosa
che non doveva avvenire è avvenuto.Il lavoro è un diritto, ma se anche il
lavoro brucia la nostra vita...
di Gionata Di Cicco
T
BS MARZO 2008
GIOVENTÙ BRUCIATANon abbiamo la gioia, noi giovani, di vivere tempi felici sul lavoro:
leggiamo ogni giorno una specie di bollettino di guerra…
IOVANIG
5
Tra amici, davanti a Internetdiscutiamo di lavoro. Sul web
appaiono dati da brivido. Tra il 2003 eil 2005 la media dei caduti sul lavoro
in Italia è stata di 1328 ogni anno. Nel 2007 dal 1° gennaio a oggi sicontano quasi 1000 vittime – una
media di 5 morti al giorno – più24 530 invalidi. Il 6 dicembre 2007,
alla Thyssenkrupp di Torino,un’azienda leader nel campo
dell’acciaieria e siderurgia, si parla di“torce umane”. Cerchiamo di
comprendere il senso dell’accadutoleggendo vari resoconti. Chiamiamo
strage quella nella fabbricasoprannominata la “fabbrica deiragazzi”, perché il 95% dei 180
dipendenti hanno meno di trent’anni.”Ero lì – racconta un soccorritore
presente alla tragedia – e vedevo unuomo avvolto dalle fiamme, era
Antonio Schiavone, e strillava:aiutatemi, muoio!”. E commentando
con dolore, l’impotente testimoneaggiunge: “Ho visto l’inferno, unascena tremenda”. Antonio aveva
36 anni. Lascia moglie e tre figlipiccoli. Tra gli infortunati
nell’incidente i morti sono stati 7. Ilgiorno dei funerali Benedetto XVI in
un telegramma auspica “che siatutelata con ogni mezzo la dignità e
la sicurezza dei lavoratori”.Nell’omelia l’arcivescovo di Torino
Severino Poletto lancia un monito: ”Illavoro per l’uomo, non l’uomo per illavoro. Mai più morti come queste,
mai più operai dilaniati dal fuoco”. Difronte a queste parole l’emozione
non ha voce.Carl von Clausewitz scriveva:
”La guerra è il luogo dell’incertezza, è il luogo del caso”. Mi paiono parole
appropriate per descrivere le condizioni di lavoro fotografate
da questi tragici eventi. A rompere il silenzio accanto a noi
è… un giovane come me, Marco, 28anni, dottorato senza borsa
all’università, uno dei tanti. Vorrebbeemigrare, arricchendo la schiera deitalenti nostrani all’estero. Dice: ”In
guerra, si sa, si muore, il lavoro perònon ti dovrebbe ammazzare!”.
quello del concetto di libertà ed’infinito. La vita ci offreesperienze interessanti, mera-vigliose ma anche impegnati-ve, faticose. Tutti, prima o poi,siamo chiamati a riposarci.Come quando ci è tolto un pe-so dalla spalla e ci sediamoall’ombra di un albero. Pro-viamo a chiedere a un uccellose preferisce restare in gabbiao tornare libero. Non ci sonodubbi. Basta aprire lo sportel-lo che esso sfreccia verso ilcielo azzurro”.
O SCURAMENTO.Caro direttore, [...] ho un
quadro abbastanza chiaro suirapporti omosessuali nel mon-do classico... Ma questo qua-dro si oscura con la diffusionedel cristianesimo [...]. Mi è sta-to detto che è contro natura.Ma non mi è stata data maiuna risposta soddisfacente.
Antonio@...
Caro Antonio, non so se sipossa chiamare “oscuramen-to” il quadro del cristianesimorispetto a quello del paganesi-mo (o mondo classico – comepreferisce) per quanto riguar-da i rapporti omosessuali.Ciò che posso dirle è che la fi-losofia e la teologia di matricecattolica per arrivare alle con-clusioni che lei sa non partono
dire allora? Ricordo alcuneespressioni di una mia vecchiazia – si chiamava Quinta –che faceva il catechismo inparrocchia. Diceva cosestraordinariamente vicine aquelle che qualche tempo fami ha scritto un affezionatolettore e – devo dire – ancheun sagace corrispondente, ilprof. Verdone. Quel che mi hascritto in proposito, ti trascri-vo fedelmente. “Occorre ser-virci di metafore che mettanoa fuoco concetti come quelli dipresenza, di vicinanza. Chimuore c’è ancora, anche senon può essere visto. Comequando qualcuno va avantiper la strada e rimane nasco-sto dietro una curva. Oppure,come accade la notte, quandopapà e mamma dormono inun’altra camera. Il bambinonon li vede, ma li sente vicini.Altro ambito semantico su cuiinsistere riguarda la finalitàdell’esperienza vitale. Siamosulla terra per formarci, comeil bambino nel seno materno.Quando egli è pronto per ilmondo, allora nasce. Così noi,al momento giusto per ciascu-no, passiamo ad un’altra vita.Come i frutti dell’albero che ilcontadino coglie man manoche sono maturi o come perso-ne in cammino verso casa. Chiarriva prima aspetta gli altri.Il terzo ambito da sviluppare è
fatto il nostro “eroe”, che laChiesa era già un anacroni-smo nel Medio Evo. Figurar-si! Ma un vero anacronismodel testo in questione è quellodi descrivere i monaci comeignoranti, vuoti, senza ideali,pavidi... S’è dimenticato, Fol-let – ammesso e non concessoche l’abbia mai saputo – chescuole, ospizi, ospedali, infer-merie, farmacie, ecc. ecc. so-no state invenzione dei mona-ci. Ma tant’è: Follet, per mol-ta gente, resta un super! Allafaccia!
L A NONNA MOR-TA. Caro direttore, non le
ho mai scritto, ma stavolta mifaccio coraggio e... eccomi.Perché mi è capitato addossoun grosso problema. È mortamia mamma, di tumore pur-troppo. Era anche la nonna dimia figlia [...]. si volevano ungran bene. Ora la mia bambi-na mi ha fatto un sacco di do-mande tipo: “Dov’è la non-na?”. “Lì dentro allora chic’è?”. “Quando potrò riveder-la la nonnina?” [...].
Mariella, Taranto
Domande difficili, cara signo-ra. Lo so. Difficili soprattuttoperché a quattro anni non si èin grado di fare distinzioni fi-losofico-teologiche... Che cosa
L ETTERE AL DIRETTORE
6
K EN FOLLET. Caro di-rettore, Lei ha più volte
criticato il Medio Evo come èdescritto da certi scrittori, e daparte sua lo ha magnificato co-me un’era straordinaria. Masono in tanti a non condivider-la […]. A proposito che cosane dice del Medio Evo descrit-to da Ken Follet? Lo conosce?
Vittorio, Taranto
Caro Signore, mi parla di“scrittori” che non condivi-do, o non mi condividono.Occorre specificare: si trattadi storici o di romanzieri. Daquanto mi ha scritto, sembre-rebbe riferirsi a romanzieri...E allora, le specifico subitoche il romanzo è storia comeio sono un cavallo. Mi sem-bra inutile perderci tempo.Per quanto attiene a Ken Fol-let, sì, ho letto “I pilastri del-la terra”. Pur plaudendo allabellezza del “romanzo” (diromanzo si tratta!), ho dovutoprendere atto di una certa“grossolanità” interpretativariguardo alla concezione delMedio Evo e, soprattutto, allaChiesa, per cui mi sono rifiu-tato di leggere la sua ultimafatica “Un mondo senza fi-ne”. O meglio ho letto menodi cento pagine poi ho pianta-to lì. La solfa era la stessaanzi, i difetti dei “pilastri” sisono accentuati, il Medio Evolo descrive da perfetto anti-clericale come egli è. Lui af-ferma di descrivere il MedioEvo com’era, ma per uno sto-rico sarebbe una sciocchezzapatentata scrivere, come ha
MARZO 2008 BS
�Acquisto i due volumi dicirca 750 pagine ognuno de“La vita di San Giovanni Bo-sco” – Autore G.B. Lemoyne– Casa Editrice SEI. Gian-carla Minelli, Via VassalliEandi 19, 10138 Torino.
�Sono un volontario privatoe cerco amiche di tutte le etàche abbiano bisogno di amici-zia o di parlare con una per-sona sensibile come me. DiMilano e provincia. Cerco an-che computer vecchi o usatigratis, anche rotti. Ritiro gra-tis. Tali computer saranno si-stemati e poi donati a bambinie ragazzi disabili. Contattarmi
al 389/99.19.993 – Cristia-no Monza, Via Anfiteatro14, 20121 Milano, e-mail:[email protected].
�Vorrei instaurare sinceraamicizia epistolare con ra-gazzi/e età compresa 22-32anni. Mi chiamo Daniele, ho32 anni. Scrivete a DanieleTuzzolo, Via dell’OrsaMaggiore 99, 00144 Roma.
�Desidero acquistare testiscolastici degli anni ’60-’70pubblicati dalle SEI di Tori-no. Mario Cervia, Via B.Maioni 51, 28021 Borgo-manero (NO).
�Mi chiamo Fabio, ho 37anni e cerco amiche di tuttele età per instaurare unabella e sincera amicizia.Risposta assicurata. Berto-lotti Fabio, Viale BrunoRizzieri 55, 00173 Roma.
�Sono un ragazzo di 32 an-ni, alto, snello e prossimoalla laurea. Di indole sem-plice, amo la natura e le co-se belle. Mi piacerebbe co-noscere per amicizia ragaz-zi/e della mia città o provin-cia. Grazie. Baldanzi Anto-nio, Via M. Berrino 19,10148 Torino.
Appelli
OGNI MESECONDON BOSCOA CASA TUAIl BollettinoSalesiano vieneinviato gratuitamentea chi ne fa richiesta.Dal 1877 è un donodi Don Bosco a chisegue con simpatiail lavoro salesiano trai giovani e le missioni.
Per la vostra corrispon-denza:
IL BOLLETTINOSALESIANOCasella post. 1833300163 ROMA Bravettafax 06/656.12.643E-mail: [email protected]
Diffondetelo tra iparenti e gli ami-ci. Comunicatesubito il cambiodi indirizzo.
BS MARZO 2008
7
mestiere: sarebbe un sovverti-mento delle regole del gioco.
A TEI ILLUMINATI.Caro direttore, da qual-
che tempo illustri pensatori delcalibro di Augias, Dario Fo,Odifreddi ecc., si dedicano adimpegnativi problemi storico-religiosi. Nei loro libri e nelleloro “allocuzioni”, discettanodi Chiesa e Papato con una si-curezza (e sicumera) tali da fararrossire san Tommaso d’A-quino. Tanta sapienza è ogget-to di devota attenzione nell’o-limpo televisivo, dove già han-no notevole spazio i Santoro ei Travaglio. Altri scrittori, lecui opere pregevoli e docu-mentate trattano eguali argo-menti, sono semplicementeignorati nei salotti televisivi al-la moda. Come spiegare certealchimie a noi poveri mortali?
Questa è la società in cui vi-viamo... stavo per scrivere “cimeritiamo”. Cristo è da sem-pre “segno di contraddizione”– è parola di Vangelo – e quin-di non meravigliano più di tan-to i “pro” e i “contro” Cristo.La verità è che oggi sembradiventato per alcuni talmenteingombrante questo Gesù checi si batte in tutti i modi pereliminarlo... o meglio per eli-minare la seconda parte delsuo nome, Cristo, lasciandoglila prima, Gesù, che lo qualifi-ca uomo come tutti, anzi unperdente, un predicatore unpo’ idealista e forse un po’“suonato”, un sognatore checoltiva utopie, regolarmentecancellate dal potere, un rivo-luzionario imprevidente e pernulla diplomatico. Lungo lastoria, soprattutto recente, al-cuni ci hanno provato – e altrici provano ancora – a portarea termine questa operazione disvuotamento del Cristo dellafede. Tutti sempre regolarmen-te sono stati beffati da Coluiche più lo dichiari uomo e piùsi mostra Dio, più lo seppelli-sci e più risorge.In effetti, i primi a meravi-gliarsi di questa immarcesci-bilità del maestro di Galilea
sono i suoi stessi detrattori.Per costoro si può rispolvera-re quello che il cardinale Con-salvi disse a Napoleone cheaveva fatto imprigionare PioVII: “Non siamo riusciti noipreti a distruggere la Chiesa,crede di riuscirci vostra Mae-stà?”. Basta cambiare “Chie-sa” con “Cristo”, e la frase èugualmente vera. Atei ce nesono sempre stati... Anche senon tantissimi, a dire la verità.Nell’antichità si contano sullapunta delle dita e non si pos-sono chiamare veri atei, pensoai filosofi atomisti Democritoe Leucippo. Il Medioevo prati-camente non ne conosce enemmeno l’Umanesimo e ilRinascimento. Si comincia aparlare di atei nel secolo XVII
con Voltaire, Compte, De Sa-de (il famoso marchese), Hu-me, Diderot. Nel XVIII e XIX se-colo spuntano Nietzsche, Zola,Russel, Freud (forse), Marx epochi altri. L’età moderna econtemporanea può annovera-re Sartre, Camus (forse), On-fray, Bob Dylan, Hack, Gio-rello, oltre a quelli da lei cita-ti. Questi i nomi più noti (am-messo che siano tutti atei con-vinti). Alcuni di costoro cononestà riconoscono che se èimpossibile dimostrare l’esi-stenza di Dio è altrettanto im-possibile dimostrarne la non-esistenza.Le do piena ragione riguardoalla boria supponente di certiconduttori nostrani e alla su-pina condiscendenza dei me-dia. Vede, una cosa tantogrossa fa scoop, perché si at-tenta alla fede della granmaggioranza dell’umanità. Di-scuterne è questione di prima-ria importanza per conquista-re audience, vero e unico diodei media. E forse c’è sotto an-che qualche motivo ancor me-no nobile: per sentirsi “qual-cuno” bisogna che si punti inalto, molto, molto in alto, altri-menti la normalità del quoti-diano ti risucchia nell’anoni-mato. Allora, per non affogarenel mare del nulla non restache urlare contro l’Intoccabi-le, così è assicurata, o quasi,la celebrità! Bah!
da basi strane, senza senso,avulse dalla realtà, illogiche opretestuose, ecc. Tutto il con-trario. Si parte dall’osserva-zione attenta e metodica dellarealtà e nella realtà si constatache la vita è il frutto di un in-contro tra cellule maschili ecellule femminili.Da questo fenomeno che sipresenta come “naturale”, sievince per la teologia cattoli-ca che “il sesso è per la vita”,perché la vita scaturisce sololà dove un gamete maschile euno femminile si compenetra-no. E questo, le ripeto, apparecome legge di natura. Ora,sulle conclusioni che tira laChiesa (è bene ciò che seguela natura, è anomalo ciò chenon la segue), si può non esse-re d’accordo, si può obiettareche potrebbero esserci ecce-zioni, che l’amore è più gran-de del sesso (e sono d’accor-dissimo), che un uso diversodel sesso non è poi un delitto,ecc. Ma perché tacciare laChiesa di oscurantismo?Dov’è l’oscurantismo? Qual èl’oscurantismo? La Chiesache cosa oscura in realtà? Èoscurare o non piuttosto esal-tare? In effetti, la Chiesa esal-ta talmente il sesso fino a dire:“Usatelo per gli scopi volutidal Creatore”. Per alcuni po-trà essere un’esagerazione,ma certo non è né oscuramen-to né, tanto meno, oscuranti-smo!Le ripeto: si può non essered’accordo sui principi filosofi-co-teologici (che, guarda caso,sono quelli della filosofia ari-stotelico-tomista, quindi clas-sica, anche se Tommaso è unmedioevale), ma davvero nonc’è materia per condannare laChiesa. Essa non fa che quel-lo che crede sia il suo dove-re... Si è liberi di non seguirla,ma non di condannarla. Èsempre letale condannare chifa quello che è chiamato a fareper fede, per vocazione, perconvincimento intimo o per
Non ci è stato possibile pub-
blicare tutte le lettere perve-
nute in redazione. Ce ne
scusiamo. Provvederemo a
suo tempo alla pubblicazio-
ne o alla risposta personale.
IN ITALIA NEL MONDO&
8
MARZO 2008 BS
FOGGIA, ITALIA
PICCOLIMADONNARI
L’Immacolata a Foggia, nellaparrocchia salesiana, è stataonorata anche con l’esibizionedei ragazzi dell’oratorio come“madonnari”, quegli originalipittori di strada che, armati digessetti colorati, dipingono sulselciato, sull’asfalto, sul gra-nito, sul sagrato delle chiese,soggetti sacri con una mae-stria sorprendente. Sono in ge-nere copiatori, ma così precisida sembrare fotografi, tantoè somigliante all’originale ilsoggetto riprodotto. I giova-nissimi artisti della parrocchiadel Sacro Cuore si sono ci-mentati nell’impresa con otti-mi risultati coloristici e sceno-grafici a giudizio di tutti.
PESCEANA, ROMANIA
PADRE PIO NELL’EX IMPEROROSSO
A Pesceana è sorta la primachiesa dell’ex/regime ateo de-dicata a san Pio da Pietrelci-
na. L’ha voluta padre VictorTudor, prete ortodosso con-vertitosi al cattolicesimo contutti i suoi parrocchiani dopoche il santo frate cappuccinodivenne famoso per un mira-colo verificatosi per sua in-tercessione. Nel 2002 lamamma del sacerdote, colpi-ta da un tumore al polmonesinistro, venne dichiarata ino-
perabile e perciò inguaribiledai medici. Fu trasportata aRoma presso il fratello pitto-re, nella speranza di trovareun chirurgo che volesse ope-rarla. Il figlio la portava consé in una chiesa dove stavacomponendo un mosaico. Lamamma si fermava spesso apregare davanti a una grandestatua di Padre Pio chieden-
dogli di essere guarita. Dopouna quindicina di giorni, sirecò al solito controllo: sape-va la risposta, un ulterioreaggravamento delle condi-zioni di salute... Invece, il tu-more era sparito! Nella fotodi destra: la signora LucreziaTudor con l’arcivescovo me-tropolita greco-cattolico S.B.Lucian Muresan.
9
BS MARZO 2008
PISANA, ROMA
XXVI CAPITOLOGENERALE DEI SALESIANI
È in svolgimento presso laCasa Generalizia dei salesia-ni (23 febbraio - 12 aprile) lagrande assise della congre-gazione. I 233 capitolari,provenienti dai 5 continenti,affrontano un tema che pren-de il titolo dal motto di DonBosco: “Da mihi animas,cætera tolle – Dammi le ani-me e tieniti tutto il resto”(Gn. 14,21), diviso in cinquenuclei: Ritorno a Don Bo-sco, Urgenza di evangelizza-re, Necessità di convocare,Povertà evangelica, Nuovefrontiere. Il Rettor Maggiore
redazionale
NUMISMATICAa cura diRoberto Saccarello
VATICANO SEMPRE ATTIVODopo il Battesimo e la Confermazione, il terzoanno del programma aureo della Città del Vatica-no è stato dedicato all’Eucaristia, sacramento delsacrificio e della redenzione operata da Cristo,interpretato mirabilmente dallo scultore GuidoVeroi, uno dei maggiori artisti dediti alla realizza-zione di monete e medaglie. Lavora per San Mari-no, la Repubblica italiana e lo Stato del Vaticano.
Sui 50 Euro è raffigurata l’Ultima Cena, il momen-to in cui Gesù istituisce l’Eucaristia; sulla monetada 20 Euro sono raffigurati un pesce e un cesto dipani, immagine tratta da un dipinto paleocristianodelle Catacombe di San Callisto a Roma. La tira-tura è di 3426 esemplari.
Con un pezzo d’argento da 10 Euro, disegnato ilVaticano ha inoltre celebrato l’81° Giornata Missio-naria Mondiale “Tutte le Chiese per tutto il mon-do”. La scelta di raffigurare sul rovescio la BeataMaria Teresa di Calcutta intende sottolinearecome anche oggi la Chiesa testimoni la sua pre-senza missionaria e la verità del Vangelo in tutto ilmondo. Tiratura: 13 693 esemplari.
Le serie possono essere richieste direttamenteall’Ufficio Numismatico della Città del Vaticano:tel. 06.69883414. Email: [email protected]
convocando i rappresentantidelle 96 ispettorie della con-gregazione ha scritto: “Con-templiamo Cristo con losguardo di Don Bosco eamiamo i giovani con il suocuore”.
CASTELLO DI GODEGO, ITALIA
UN POETASALESIANOCOADIUTORE
Il 10 novembre 2007 il signorGiovanni Ferraresso, salesia-no laico, ha ricevuto una con-vocazione presso il Salonedegli Affreschi del Comune,dove il presidente dell’Asso-ciazione L.I.T.A. (Libera Isti-
tuzione per la Tutela dell’An-ziano), avvocato Daria Pescee il presidente dell’istitutoMartinit e Stelline, prof. Emi-lio Trabucchi gli hanno con-ferito il terzo premio nella se-zione C-Poesia. Il signor Gio-vanni aveva partecipato allasettima edizione del concorsoletterario riservato alla terza equarta età… “Parole ritrovate– lo scrittore che c’è in te”.Qual è la notizia? che Ferra-resso, classe 1909, è un gio-vanotto di quasi 99 anni. Sa-lute a lui dal BS.
10
MARZO 2008 BS
È una notizia interessante quella chetroviamo sul BS di marzo 1908, a pagina 76,notizia che ci attesta da un lato la generosaattività di un cooperatore, dall’altral’attenzione al Bollettino Salesiano,considerato da tutti gli emigrati italiani una ventata d’aria “patria”, e letto o ascoltato con avidità. Degli emigrati italiani in Francia si parla nel trafiletto che riportiamo.
10
ROMA
GENEROSITÀ
L’Associazione LumbeLumbeOnlus che opera in Angola e inAmerica Latina in stretta sinto-nia con alcune missioni sale-siane, ha ricevuto come offertaper le opere di beneficenzaprogrammate o già in via direalizzazione, uno splendidodiamante. La giovane proprie-taria ha deciso di privarsene,dopo che un legame affettivosi era sciolto, “a beneficio deimeno fortunati”, come lei stes-sa ha precisato, devolvendoloall’Associazione fondata e so-stenuta da carabinieri e civiliche “hanno scelto di percorrerela strada della solidarietà, dedi-cando il proprio tempo liberoal sostegno di progetti di coo-
perazione internazionale”. Undono spontaneo, scrive il pre-sidente della LumbeLumbe,che sfida la logica dell’avere eil primato dei beni materiali”.Il diamante, com’era logico, èstato messo all’asta, il suo va-lore monetario ammonta a mi-gliaia di euro… “Quel dia-mante oggi è in cerca di unnuovo proprietario, ma alladonatrice ha lasciato la consa-pevolezza di aver trasformatoun’esperienza dolorosa, qualepuò essere la perdita di unamore, in uno straordinario at-to di carità che potrà ridaresperanza a chi speranza nonha”. La lista delle realizza-zioni della LumbeLumbe èormai lunga, nonostante chel’Associazione sia stata fon-data solo nel dicembre 2002.Per chi volesse saperne dipiù www.lumbelumbe.org.
BARI, ITALIA
UN VOLTO UNA STORIAdi Marco Pesola
È un libro/fotografico origi-nale e decisamente bello. In-quadra e bevissimamente com-menta con qualche riga situa-zioni particolari di vita vissu-ta in diverse parti del mondoche il sottotitolo aiuta a capi-re: “Fotografie sulle gioie e lesperanze del nostro tempo”.Rigorosamente in bianco enero, sono senza dubbio fotosplendide che parlano, rac-contano, sottintendono. Le po-che righe di commento collo-cano lo scatto in un luogo, in
un tempo precisi e in una cir-costanza particolare. È un vo-lume da leggere, anzi no, davedere. È un libro che emo-ziona, fa pensare, strappa avolte una lacrima, a volte unsorriso, a volte una nostalgia;risveglia ricordi, sollecita unapreghiera…
Da Boulogne-sur-Seine riceviamo una notizia chetornerà di grande edificazione ai lettori del Bol-lettino.Uno zelante Cooperatore salesiano di quella città,non contento di leggere il Bollettino francese,volle pure associarsi all’edizione italiana, man-dando a tal fine una generosa offerta. Da variimesi, dopo aver letto, egli si affretta di trasmet-terlo al sacerdote che dirige la cappella degli ita-liani, assai numerosi in Boulogne presso Parigi. Per l’opera di lui e della suora di S. Vincenzo de’Paoli che si occupa della Colonia italiana, si co-minciò a leggere tutte le domeniche nelle pubbli-che riunioni il nostro Bollettino con immensopiacere e profitto di tutti coloro che vi assistono.Noi ringraziamo di cuore coloro che sono statiiniziatori di questa opera buona, siamo disposti amandare un certo numero di Bollettini italiani aquei cari connazionali, e saremmo felici di enu-merare fra i nostri Cooperatori coloro che ne fa-cessero domanda.
ALICE E GLI ALTRI (10)Divagazioni (mica tanto) su... una moda in continua espansione: un cane per amico.
O SSERVATORIO Anna Rita Delle Donne
noi. Facciamo una passeggiata.Un’interruzione ci farà bene”.“Grazie Fabio, risponde mam-ma Stefania, sei molto gentile.Molto più di quella signorinache ha dimenticato da tempole promesse fatte”. “Mamma!”,esclama Alice con il viso infiamme. Poi, aggancia il guin-zaglio a Drusilla e la trascinavia. O meglio, è lei che vienetrascinata dalla cagnetta festan-te, evidentemente contenta diquesta uscita in compagniadella padroncina.
>> “Cos’è questa storia dellepromesse dimenticate?”, chie-de Fabio, mentre sono nelparco tenendo d’occhio Dru-silla che corre nell’area riser-vata ai cani. “Ma niente…Mia madre deve sempre rom-pere le scatole”, risponde Ali-ce a occhi bassi. “Uhm, credodi aver capito qualcosa. Non
è che per caso avevi promesso di occuparti di Dru-silla e adesso?…”. “No… cioè…”. Ora Alice èconfusa. “Un cane non è un giocattolo che quandoci si stufa si lascia in un angolo. Senza contare chetua madre è incinta, ed è evidente che sia piuttostostanca”. “Ma io… devo studiare, non ho tempo”,cerca di difendersi la ragazza. “Alice, anch’io houn cane. Wiskey sta con me da quando avevo treanni, gli voglio bene. Mi occupo io di lui. E ti assi-curo che non è una perdita di tempo”. IntantoDrusilla è tornata e tiene tra i denti un legnetto cheposa ai piedi di Alice. La ragazzina lo raccoglie elo lancia lontano, il cane si lancia al suo insegui-mento. “Vedi? Lei non ti ha dimenticato, ti vuolebene, si fida di te”. Alice sorride timidamente.“Sono stata una stupida, mi ero dimenticata diquanto può essere divertente”. “A volte è anchefaticoso. Ascolta, se ti va, il pomeriggio potremmovenire qui con Wiskey e Drusilla. Fare una pas-seggiata, giocare un po’ con loro, prima di ripren-dere a studiare. Che ne dici?”. “Dico che vabenissimo!”. Adesso sorride felice. �
“P apà, ti prego, tiprego… Giuro cheme ne occupo io.
Convincila tu la mamma”.Alice insiste per l’ennesimavolta. “Alice, tenere un caneè una cosa impegnativa, epoi con il bambino inarrivo…”. “Mamma, ti giu-ro, non te ne accorgerainemmeno. La mattina mialzerò mezz’ora prima perportarlo fuori; e anche ilpomeriggio e la sera. Cipenserò io”. Mamma Stefa-nia e papà Giulio si guarda-no per un momento. Poicedono. “Va bene, Alice. Loprendiamo, ma non dimen-ticare ciò che hai promes-so”. “Grazie, grazie, grazie.Vi voglio bene”. E così ilcucciolo Drusilla arriva a farparte della famiglia. I primitempi Alice si occupa dellacagnetta con affetto e dedi-zione ma, passati un po’ di mesi, Drusilla non èpiù un tenero batuffolo e cominciano ad aumenta-re le sue esigenze; così, è papà Giulio che la mat-tina si alza per portarla fuori, mentre durante ilgiorno se ne occupa mamma Stefania, nonostanteche il pancione inizi a farsi sentire.
>> Oggi, Alice è un po’ eccitata; Fabio, il compa-gno di scuola, a cui tutte le sue compagne fanno ilfilo, viene a casa sua: devono prepararsi all’interro-gazione di storia. Mentre i due ragazzi sono impe-gnatissimi nello studio, Drusilla irrompe nella stanzacon il guinzaglio in bocca e comincia a guaire, sal-tellando qua e là. “Mamma, per favore richiamaDrusilla, non riusciamo a studiare”, urla Alice. “Maè bellissima!”, esclama Fabio, e si mette subito agiocare con la cagnetta. Mamma Stefania si affacciaalla porta; sembra piuttosto affaticata. “Alice, potre-sti portarla fuori tu? Sono un po’ stanca”. “Mamma,ma non vedi che stiamo studiando? Domani abbia-mo l’interrogazione!”, risponde la figlia, infastidita.“Ma certo, signora, interviene Fabio, ci pensiamo
11
BS MARZO 2008
Fabi
ana
Di B
ello
Un anno fa, in occasionedel cinquantesimo anni-versario della firma deiTrattati di Roma del
1957, l’ex presidente della repub-blica, Carlo Azeglio Ciampi, euro-peista della prima ora, concludevaun bell’articolo sulle difficoltà del-l’Europa dei 27 con un forte appel-lo ai giovani. A loro, soprattutto,chiedeva di sostenere il difficilecammino dell’Unione con il pro-prio slancio ideale e la partecipa-zione attiva, non dimenticando diessere “i principali beneficiari del-la sicurezza di vita generata dallapur incompleta costruzione euro-pea, frutto dell’‘utopia’ vagheggia-ta dai loro antenati”. Quasi unideale passaggio del testimone del-l’europeismo dai Padri fondatori ainuovi cittadini del duemila, spe-ranza di un continente senile. Unpopolo silenzioso, i giovani, peròcon una sua consistenza strategicanell’Europa allargata del XXI seco-lo. Relativamente poco numerosaquesta “generazione E” – appena il15% della popolazione dell’Ue –
CHIESA I FIGLI
DEL DISINCANTO
Finlandia, Francia, Germania, Ita-lia, Regno Unito e Slovacchia. Ilprincipale dato emerso è il diffusodisinteresse dei giovani nei con-fronti della politica. La gran partedei ragazzi si dichiara, infatti, pocoo per nulla interessata alle proble-matiche politiche (60%). Solo unamanciata si definisce molto inte-ressata (5,9%). I più appassionatiappaiono i giovani tedeschi, quasila metà. Seguono gli italiani (il43%, di cui il 9% si dice molto in-teressato) e gli austriaci. I più di-sinteressati si trovano nel RegnoUnito (25%) e nei nuovi paesi del-l’Unione come Estonia (29%) eSlovacchia (28%). A livello di in-teresse dichiarato, stupisce soprat-tutto il fatto che paesi di lunga tra-dizione democratica, come il Re-gno Unito e la Francia, abbiano illivello più alto di indifferenza tota-
rappresenta tuttavia un segmentodi frontiera della società contem-poranea. Solo dall’impegno delleultime generazioni, infatti, ci sipuò aspettare che l’Unione diventiil nuovo sistema di appartenenza edi cittadinanza intorno a cui svi-luppare nuovi legami di solidarietàe di identificazione transnazionali.
SCETTICISMO...Ma si sentono abbastanza “euro-
pei” i ragazzi nati dopo il 1980, nelsenso che partecipano attivamenteall’edificazione della casa comu-ne? La ricerca “Euyoupart” (Politi-cal Participation of Young Peoplein Europe) ha tentato proprio diesplorare i significati della politicae le forme di partecipazione della“generazione E”. Otto gli istitutieuropei coinvolti nella grande in-dagine, finanziata dalla Commis-sione Ue e durata tre anni. Ottomilai giovani, dai 15 ai 25 anni, contat-tati in otto paesi: Austria, Estonia,
12
MARZO 2008 BS
QUO VADISEUROPA? (16)di Silvano Stracca
Scat
tolo
n
L’Europa unita...
I giovani e la politica non so-no consanguinei. Questo valenon solo per l’Italia ma ancheper il resto dell’Unione. Oc-corre indagare questa disaf-fezione.
Il logo e la moneta del 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma.
13
BS MARZO 2008
Tra le linee convergenti rintrac-ciabili nelle diverse società europee,a sorpresa va sottolineato il ruoloimportante che la famiglia conservanell’influire sugli orientamenti ideo-logici delle nuove generazioni. Unragazzo su tre ancora parla di politi-ca in casa con i genitori. Mentre ilgruppo dei coetanei contribuisce ainfluenzarne i comportamenti in re-lazione alla partecipazione. Ma perdire quanto poco entrino nella vitaquotidiana i valori della politica,ben l’82% dei giovani non ritieneimportante condividere le idee poli-tiche con i propri amici.
Altri due punti interessanti diconvergenza. Il primo è che i gio-vani, quando utilizzano normal-mente un mezzo d’informazioneche prevede una modalità di frui-zione attiva, come i giornali e In-ternet, tendono a essere più impe-gnati politicamente rispetto a colo-ro che seguono la politica passiva-mente attraverso la tv. Il secondo èche, anche tra quelli che vedono lapolitica come qualcosa di positivo,purtroppo la sua realizzazione a li-vello concreto è spesso la causadeterminante del disincanto.
(continua)
di sinistra. Solamente il 35% si ri-conosce ancora in questa dicoto-mia storica.
TOTALITARISMO DEMOCRATICO?
I ragazzi di “generazione E”paiono propendere per un impegno“fluttuante” che non mette più ingioco identità o appartenenze atempo indeterminato, bensì interes-si precisi legati alla vita sociale. Alprimo posto la disoccupazione e laprecarietà, al secondo l’inquina-mento e le tematiche ambientali, alterzo la violenza e la povertà. Lamaggioranza dei ragazzi (tra gliitaliani il 96%) considera il lavorotra i problemi più urgenti per lapropria generazione. Questo “di-sinteresse attivo”, come lo chiama-no i sociologi, si traduce in una ca-pacità d’aggregazione caratterizza-ta da un forte contenuto critico neiconfronti dei protagonisti dellascena politica del proprio Paese edi quella internazionale.
le (rispettivamente l’82 e il 74%).Il massimo dell’apatia si riscontrafra i giovani con meno risorse eco-nomiche, socialmente marginali,meno istruiti e non occupati, e tra igiovanissimi sotto i 18 anni.
... E SCONTENTOI ricercatori di “Euyoupart” li
hanno definiti “figli del disincan-to”. Sono i figli di una generazioneche ha visto, con la caduta del mu-ro di Berlino, la fine di un certomodo di vivere la politica, fatto dipassione e di ideali. I figli, cioè, diqualcuno già disincantato, di per-sone che si sono separate dalla po-litica anni addietro. Il disincantodei padri ha determinato il nuovoatteggiamento dei figli. Non un ri-fiuto tout court della politica,quanto una disaffezione per la poli-tica tradizionale. Le istituzioni, ipartiti, la classe politica non sonopiù centrali, tanto che i ragazziconsiderano politica fare un sit-ino aderire alla campagna di unaONG. Abbandono, quindi, presso-ché totale dell’attività partiticaclassica. Oltre il 90% degli intervi-stati afferma di non aver mai con-tattato un politico, dato soldi a ungruppo, indossato una spillettaelettorale, distribuito volantini. So-lo il 18% ha partecipato a una ma-nifestazione e solo il 7% ha soste-nuto una campagna elettorale. Allostesso modo quasi nessuno si è im-pegnato in un partito (5,8%) e an-cora meno nei gruppi giovanili(2,5%). Destra e sinistra sono poicategorie che i giovani europeimandano definitivamente in soffit-ta. Quasi la metà del campione di-chiara di non essere né di destra né
I giovani di oggi considerano politica fare un sit-in o aderire alla campagna di una ONG.
La ricerca “Euyoupart” ha fatto emergere il dato di un diffuso disinteresse dei giovani nei confronti della politica. Sono i “figli del disincanto” della “generazione E”.
MGS
Triv
enet
oM
GS T
riven
eto
LE PASSEGGIATEAUTUNNALI COME TEATRO DI ANIMAZIONEdi Martina Crivello
L e passeggiate autunnali sono il“testamento” di Don Bosco sulteatro di animazione, e anche ilvertice della lunga stagione
creativa salesiana, frutto di una pro-lungata esperienza di vita a contattodiretto con i giovani. In esse arriva amaturazione la sua pedagogia “diunità” che sa simpatizzare per tutti gliaspetti della personalità umana e per-ciò sa fondere gioco, cultura, festa,arte, musica, spiritualità. Quelle dicui si intende parlare sono le “gran-di” passeggiate autunnali che si svol-sero da Torino ai Becchi, il paese na-tio di Don Bosco, e poi da lì ad alcuni
centri circostanti, dal 1859 al 1864.Esse sbocciarono gradualmente apartire dalla consuetudine di contadi-no dei Becchi di recarsi presso i suoiparenti per alcuni giorni di vacanzanel mese di ottobre, il mese dellavendemmia in cui i suoi, contadini,alla fine di una lunga stagione di fati-ca e di attesa, raccoglievano i fruttidel loro lavoro; qui egli era solito de-dicarsi alla predicazione durante lanovena della Madonna del Rosario ecelebrare con i compaesani quella fe-sta solenne. Fu un voto formulato dadon Rua all’indomani della morte diDon Bosco: se si fosse ottenuto ilpermesso di tumulare la salma a Val-docco oppure nel collegio salesianodi Torino-Valsalice, avrebbe fatto de-corare l’intradosso della grande cu-pola della chiesa dell’Ausiliatrice.
COME NACQUEROA partire dal 1845 sappiamo della
presenza ai Becchi di alcuni giovanistudenti che ricevevano, come pre-mio dell’impegno dimostrato durantel’anno scolastico, un po’ di meritatoriposo in compagnia del loro prete.Nei primi tempi essi si limitavano apartecipare alle funzioni religiose.Ma, non oltre il 1849, iniziò la tradi-zione di concludere la festa con qual-che rappresentazione teatrale. DonGiovanni Battista Francesia, che haconservato le memorie di quelletournées per il Monferrato, testimo-nia che «fin dalla vigilia arrivavanoda Torino i musici di canto e di suo-
14
MARZO 2008 BS
ASA NOSTRAC
Gli studiosi sonoconcordi nell’affermareche le cosiddette“passeggiate autunnali”siano l’esperienza più significativa e culminante dell’attivitàeducativo-teatrale di Don Bosco.
Tradizionalmente il nome del fondatore dei salesiani è legato alla figura simpatica e disinvolta del saltimbanco che cammina sulla corda…
Don Bosco inventò le passeggiate autunnali che divennero per lui un’altra occasione educativa.
15
BS MARZO 2008
due volte e più ancora in un medesi-mo posto, senza doverci ripetere».
Si può notare subito che le indica-zioni date per i preparativi eranomolto generiche. Per quanto riguardail teatro, i comici si mettevano all’o-pera e non si hanno notizie circa in-terventi successivi di Don Bosco percorreggere quanto i ragazzi andavanopredisponendo: a loro veniva lasciatauna grande libertà e altrettanta re-sponsabilità. Il repertorio di solitoprevedeva alcuni lavori già rappre-sentati durante l’anno e meglio riu-sciti che venivano adattati agli am-bienti e al pubblico diverso a cui si ri-volgevano. Purtroppo, spesso riman-gono soltanto i titoli di quelle rappre-sentazioni, anche perché molto eralasciato alla libera interpretazione eperché, come si è detto, i testi veniva-no rimaneggiati.
UN GRANDE GIOCOESPRESSIVO
Che nel programma delle passeg-giate fosse previsto uno spazio spe-cifico per il teatro è chiaro; ma ciòche sembra più interessante sottoli-neare sono gli aspetti teatrali chepermeavano tutta quell’esperienza:la gita era un unico gioco espressi-
vo, come un grande copione, di cuilo spettacolo vero e proprio costitui-va un tassello. Si verificava cioè,anche lì, quella che è stata chiamatala “teatralizzazione del quotidiano”in cui i fatti che appartenevano alladimensione “privata” di Don Boscoe dei giovani si “teatralizzavano”.
Nelle Memorie Biografiche (vol.VI) si ricorda ad esempio il caso diTomatis, il quale era famoso per lesue lepidezze: un giorno voleva «cer-care le gambe che diceva di aversmarrite nelle escursioni del giornoprima. Pensava intanto a fare improv-visate serie o burlesche al padrone dicasa, le quali cagionavano prima sor-presa e poi un diletto senza fine».
Da ultimo non sembra forzato con-siderare quelle passeggiate come unasorta di esercizi spirituali itineranti. Èancora la testimonianza di don Fran-cesia a suggerirlo: «Alla sera ci ave-vano visti e sentiti a suonare, comepersone intese solo a divertimenti, edora erano meravigliati di vederci cosìraccolti in chiesa, come non si sareb-bero aspettato». Poiché «era questal’arte di Don Bosco, di trovare lapietà nella ricreazione, e direi quasila ricreazione nella pietà. Non parlo achi non conobbe né da vicino, né dalontano la industriosa carità di DonBosco ed i miracoli che esercitava sunoi per salvarci dal peccato; ma ècerto che noi non sentivamo diffi-coltà dal divertimento alla chiesa eviceversa, e si provava raccoglimentoe spirito non volgari». Di quelle espe-rienze lo stesso testimone ha lasciatoun ricordo pieno di nostalgia: «Ohsere gioconde, degne di essere narra-te da penna ben migliore! Ma questafosse anche la più eletta del mondo,non potrebbe forse dire a metà il no-stro entusiasmo, la nostra gioia, ondeci si riempiva il cuore». �
no, che, uniti a molti altri e studentied artigiani, portavano il bel numerodei nostri amici a cento e qualchevolta anche a cento cinquanta. […]Alla mattina poi della festa avevamotutti il nostro da fare; chi per la chie-sa, chi per la musica, chi pel teatro.Anche al teatro dovevamo pensare,per esilarare quella buona gente».Con i ‘fortunati’ che trascorrevanoqualche giorno in più ai Becchi, DonBosco compiva alcune brevi escur-sioni nei dintorni e così progressiva-mente maturò l’idea delle passeggiateautunnali. Normalmente erano fatte apiedi, con opportune tappe, con metediverse e di durata variabile. Le piùfamose, quelle del ’61 e del ’63, peresempio durarono una ventina digiorni; la prima, attraverso il Monfer-rato, giunse fino ad Alessandria; laseconda toccò Tortona, Genova eOvada. Ovunque arrivassero, i giova-ni godevano dell’ospitalità da parte diamici di Don Bosco, parroci oppurenobili signori e benefattori dell’Ora-torio; partecipavano attivamente allecelebrazioni liturgiche e alla sera siesibivano davanti alla popolazioneospitante.
L’ANTEPRIMAIl momento della preparazione era
estremamente importante e Don Bo-sco sapeva dargli tutto il suo valore.Ancora don Francesia ci ha lasciatouna pagina significativa al riguardo:«Don Bosco, credo verso la metà diagosto, ci poté dire una sera, parlan-doci dopo le preghiere, che la passeg-giata si sarebbe fatta anche in quel-l’anno […]. Il maestro della nostrabanda fu avvisato di pensarci pertempo, e preparare per i nostri piccolisuonatori una serie nuova di marce,con qualche variazione, per megliodilettare i paesi, che si sarebbero in-contrati nel nostro itinerario. Si mu-sicò pure per banda una Messa, unVespro, e vari Tantum ergo, perchéDon Bosco ci diceva, che le cosebuone e belle piacciono a tutti.
Alcuni dovevano pensare al teatro,e preparare una piccola raccolta didrammi e di farse, da poter recitare
Cipr
iano
Dem
arie
Anche oggi la tradizione continua con la passeggiata delle castagne, o la passeggiata dell’uva, o le passeggiate culturali…
La stagione propizia per le passeggiate di Don Bosco nei boschi e nelle campagne e nei paesi dell’Astigiano era l’autunno.
MARZO 2008 BS
PISANA, ROMA
IL CD-ROM DEL 25°In occasione del 25° della suafondazione l’Istituto StoricoSalesiano (ISS) ha pubblicatopresso l’editrice LAS dell’U-niversità Pontificia Salesianaun cd-rom che contiene le ol-tre 10 mila pagine pubblicatein tutti i fascicoli della pro-pria rivista semestrale “Ricer-che storiche salesiane” (1982– 2006). Il disco è allegato aln. 50 (2007) della stessa rivi-sta. La navigazione e la con-sultazione dei testi sono mol-to semplici e possono esserefatte mediante i sommari ditutti i fascicoli o attraverso la
RIMINI, ITALIA
8 DICEMBRE 2007La festa dell’Immacolata se-gna la nascita dell’oratoriosalesiano. Continua anche og-gi a essere una grande ricor-renza per tutta la Famiglia Sa-lesiana, sottolineata da feste,accademie, commemorazioni,e quant’altro. È anche una da-ta che viene scelta per il rin-novo dei voti religiosi o l’e-missione delle promesse dimolti rami della FS, e spesso
CITTÀ DEL VATICANO
VISITA DI CORTESIAÈ il 24 novembre 2007, da po-che ore sono stati eletti i nuovicardinali durante il concistoro.Tra essi il salesiano monsi-gnor Raffaele Farina, già Ret-tor Magnifico dell’UniversitàPontificia Salesiana (UPS),poi archivita e bibliotecario diSanta Romana Chiesa. È ilmomento delle cosiddette “vi-site di cortesia” ai neocardina-li, un’antica tradizione che ve-de gli eletti omaggiati da alcu-
BOX
16
redazionale
CITTÀ DEL VATICANO.Benedetto XVI è il primopapa che con tanta insi-stenza e partecipazionelancia appelli ai capi diGoverno ad aver cura ol-tre che delle persone an-che della Terra. Un Papacui sta a cuore la salutedella Terra, perché da essadipende anche la soprav-vivenza dell’uomo. Un Pa-pa “ecologista”.
ROMA. Dal 28 giugno2008 al 29 giugno 2009 èproclamato dal papa Bene-detto XVI “l’anno di sanPaolo”, ricorrono infatti iduemila anni dalla nascitadell’apostolo della gente eprincipale diffusore del cri-stianesimo. Sono in pro-gramma varie iniziative,anche ecumeniche. Si chie-
B R E V I S S I M E D A L M O N D O
derà al Primo Ministro chel’unico edificio di culto cri-stiano di Tarso (200 milaabitanti) non trasformatoin moschea possa venirusato dai cristiani di tutti iriti almeno in questo anno.
ROMA. Si susseguono lericerche e le scoperte neivari campi dello scibilescientifico. Papa Benedet-to XVI ha messo in guar-dia contro la tentazioneche la ricerca scientificacalpesti la dignità fonda-mentale dell’essere uma-no, come accade negliesperimenti con embrioniumani che poi vengono di-strutti. È indubbio che me-dicina e ingegneria geneti-ca siano campi eticamente“sensibili” in cui la vigi-lanza non è mai troppa.
ne personalità. Nella foto, lavisita al cardinale Farina. Dasinistra, il Postulatore dellacongregazione salesiana qui investe di segretario concistoria-le, don Enrico Dal Covolo; ilsegretario particolare del Papa,monsignor Georg Gänsweinche ha recato il saluto del Pon-tefice; il cardinale salesianoOscar Andrés Rodríguez Ma-radiaga in clergiman nero, ilneoeletto cardinale Farina e ilcapo delle ordinanze della se-greteria di Stato il salesianolaico Bruno Trevisan.
serie di nove indici prefissatio, ancora, ricercando una opiù parole. I testi, presentatiin formato pdf, sono di facilelettura, permettono l’esatta ci-tazione di un brano e anchel’eventuale stampa cartacea.
per l’inaugurazione di opere ealtri eventi. A Rimini, l’8 di-cembre scorso c’è stata granfesta: la professoressa ArdeaMontebelli ha emesso la suapromessa come salesiana coo-peratrice, alla presenza deisuoi alunni e della sorella delbeato Alberto Marvelli, la si-gnora Gede che torna semprevolentieri nella chiesa che vi-de il suo santo fratello comeassiduo frequentatore e lamamma come catechista e da-ma di carità.
BS MARZO 2008
17
PISANA, ROMAIl 15 dicembre u.s. si so-no riunite presso la Casageneralizia dei salesianila Giunta confederale de-gli exallievi e la presiden-za della Federazione ita-liana. È stato consegnatodallo stesso Rettor Mag-
giore don Pascual Chá-vez il Distintivo d’Oro del-la Confederazione mon-diale al professor Giusep-pe Acocella, exallievo diSalerno, ordinario di Eticasociale presso la Federi-co II di Napoli e vicepresi-dente del CNEL.
NAPOLI, ITALIAPresso l’istituto Don Boscoè stata avviata una nuovaesperienza: un centro poli-funzionale multietnico diur-no per ragazzi soggetti aprovvedimenti penali e agrave rischio di devianza.Il progetto si chiama “Le
Ali”. Gli educatori, attraver-so il Sistema Preventivo,tenteranno l’avventura di“rimettere le ali” a chi le haperdute perché possanotornare a vivere in pienez-za la vita che fu loro dona-ta. Nella foto l’inaugurazio-ne del centro.
RÍO CUARTO, ARGENTINALa scuola agrotecnica sa-lesiana “San Ambrosio” diRío Cuarto, nella provin-cia argentina di Cordoba,gode di molto prestigio intutta la regione per laqualità e la serietà dell’in-
segnamento. Lo scorsonovembre si è arricchitadi un nuovo padiglione, il“tambo” per l’allevamentodelle mucche. Grazie allemoderne tecnologie vi siproducono 10 mila litri dilatte al giorno. È conside-rata una scuola modello.
TORINO, ITALIAL’Oratorio salesiano Mi-chele Rua decide di ce-lebrare le grandi feste,scippate dal consumi-smo nel modo tradizio-nale: Natale è GesùBambino non babbo o,peggio, mamma Natale;Epifania è la manifesta-
zione del Signore non lasettimana bianca, Ognis-santi è la festa di tutti icristiani non “sant’Hallo-ween”! L’oratorio allorain queste feste sta insie-me come voleva Don Bo-sco tra giochi, canti, de-gustazioni, celebrazioni,preghiera.
NAPOLI, ITALIANel 1947 la chiesa sale-siana del s. Cuore del Vo-mero venne aggregata periniziativa del parroco donAnnibale Santoro alla ba-silica vaticana ottenendoda papa Benedetto XIV al-cune indulgenze per i visi-
tatori e i fedeli in determi-nate occasioni. Decadutidopo il Concilio sia l’ag-gregazione sia i privilegi,tutto è stato ora nuova-mente concesso da papaBenedetto XVI dopo la ri-chiesta dell’attuale parro-co don Mario Cipriani.
a cura del direttore
FRASCATI, ITALIAGli 850 allievi della scuolasalesiana “Villa Sora” han-no assistito in blocco all’av-vio della “Zeffirino’s cup”,un torneo “culturale” cheha visto emergere su tuttiFiammetta Catania (nellafoto con la coppa vinta),
prima liceo scientifico, cheha battuto tutti nelle rispo-ste alle domande sulla vitadel più illustre degli alunnidell’Istituto, il figlio del ca-cicco Manuel Namuncurà,Zeffirino, beatificato a no-vembre nella sua terra dalcardinale Bertone.
TRADIZIONI DI UN POPOLO… TRADITO
ne più aride ma libere ancora da in-filtrazioni coloniali. L’esodo comin-ciò a partire dal XVII secolo: incalza-ti dai bianchi non immaginavano diemigrare in un’altra nazione e in re-gioni abitate da altre tribù; la terranella loro concezione non aveva pa-droni, non aveva nazionalità. Mimeravigliò udire queste affermazio-ni dalla bocca del vecchio indio:“La terra è di tutti!”. Saggezza anti-ca e sempre nuova. Il processo difusione con gli autoctoni costò, ov-viamente, sudore e sangue; gli stori-ci, sempre pudichi nel linguaggio,la chiamarono “araucanizzazione”.
ORGANIZZAZIONESOCIALE
Il Jefe, il capo che guidò l’esodopiù massiccio dei mapuche al di làdella cordigliera andina, si chiama-
va Calfucurá (Pietra Azzurra). Erapadre di Manuel e nonno di Ceferi-no Namumcurá. Egli, adattando lavita alle nuove esigenze, riorga-nizzò la sua gente in gruppi di fami-glie di una sessantina di membri,assegnò a ciascun nucleo un territo-rio ben delimitato e vi stabilì un ca-cique come capo, scegliendo un uo-mo che sapesse usare bene l’armadella parola, per convincere quellidel suo clan a seguire le nuove re-gole. Il cacique, ovviamente, gode-va di qualche privilegio rispetto aimembri del clan: aveva più libertàdi movimento, maggiori pascoli,una quantità notevole di bestiame epoteva permettersi più mogli. Cal-fucurá, insomma, riuscì a creare unpo’ con la persuasione e un po’ conla forza, una confederazione indige-na, convincendo decine di cacicchie formando una specie di Stato den-
18
MARZO 2008 BS
IAGGIV
Fu il vecchio mapuche Ñancufíla raccontarmi la storia del suopopolo “il più numeroso e fa-moso della pampa patagoni-
ca”, disse con orgoglio. Proveniva-no dal Cile, dove gli spagnoli colo-nizzatori li chiamavano araucani,forse perché forti mangiatori del pi-nolo dell’araucaria, frutto fornito dipiù calorie della carne. Fu proprio acausa degli spagnoli che dovetterosloggiare dalle terre da sempre abi-tate e spostarsi forzosamente all’in-terno del territorio argentino, in zo-
I mapuche sono il popolo del beatoCeferino. Fino alla fineegli è rimasto unmembro della “gentedella terra”, la suagente, conservando nelcuore storia, folclore e tradizioni dei suoi avi.
Il toldo tehuelche che divenne dimora mapuche, dopo il passaggio in Patagonia.
Artigiani mapuche.
di Giancarlo Manieri
Fabi
ana
Di B
ello
A sinistra: le bolas, l’arma tipica usata soprattutto per la caccia e la guerra.A destra: La pifilca, strumento artigianale sacro, usato nella rogativa semestrale.
19
BS MARZO 2008
va il cultrún, il tamburo sacro, oltrealla trutruca e alla pifilca. DelNguillatún riparleremo. Punto noda-le della religione mapuche era il pil-lán, il culto degli antenati, nientesacerdoti, ma molte orazioni ognigiorno a cominciare dall’alba, pertenere lontani gli huecuvú, gli spiritimalefici.
TERRA MISTERIOSAUno dei motivi per cui molti colo-
ni di diverse nazioni (spagnoli e in-glesi in testa) tentarono l’avventuradi internarsi nella pampa fu la leg-genda che favoleggiava di una Cittàdei Cesari ricettacolo di immensericchezze, ritrovata da naufraghispagnoli verso gli anni Quaranta del1500. Un esploratore, certo Franci-sco Cesare, ufficiale di GiovanniCaboto, l’italiano navigatore edesploratore, si avventurò in quelleterre sconosciute, affermando al ri-torno di aver visto una città favolo-sa, fondata dagli araucani. Tanto ba-stò perché pionieri e avventurieri simettessero alla ricerca dell’inesi-stente “città di Cesare”, che divennepoi Città dei Cesari. Ci provò perfi-no un missionario famoso, il gesuitaitaliano padre Niccolò Mascardi,poliglotta (aveva imparato i varidialetti degli indio), evangelizzatore(pare abbia fatto 20 mila battesimi)ed esploratore. Ben quattro spedi-zioni tentò verso la Città dei Cesari.Ma durante la quarta venne cattura-to dai Poia e trapassato da frecce.La città non fu mai trovata “… emeno male, sentenziò un salesiano,se l’avessero trovata sarebbe costa-ta altro sangue, altre guerre, altridolori: l’uomo di fronte al luccichiodell’oro perde il luccichio del cer-vello! E l’uomo senza ragione di-venta peggio di una bestia”. Ancheper questa ragione, la terra dei ma-puche divenne appetitosa per colo-
ni, contrabbandieri, banditi, avven-turieri… Di fronte a questa invasio-ne, è ovvio che la sorte dei mapucheera segnata.
TERRA DI CONTRADDIZIONI
Della Patagonia è stato detto tuttoil bene e tutto il male possibile. Sidipinsero di volta in volta i mapu-che come feroci guerrieri (soprattut-to da parte dei coloni), ma altri lidescrissero come saggi e pacifici. Sigiurò su immense distese di terresterili, eppure emergevano, soprat-tutto lungo le sponde dei numerosifiumi, boschi ed estese colture. Lasi presentò come un immenso deser-to senza vita, poi lo si scoprì popo-lato di animali di ogni specie, alcunirarissimi. A una superficie aridacorrispondeva un sottosuolo imbot-tito di pietre preziose, petrolio egas. La Patagonia: terra poverissimae ricchissima, straordinariamentepericolosa e miracolosamente bella.Terra di tipacci, ma anche di santi.Terra di Ceferino, mapuche dalla te-sta ai piedi, che osservava le tradi-zioni e le leggi del suo popolo, pre-gava nella sua lingua, partecipavaalle cerimonie tradizionali... Ceferi-no Namuncurá, figlio del caciccoManuel, nipote del gran caciccoCalfucurá, ascendente dell’attualecacicco Celestino. �
tro lo Stato, con una capitale strate-gica – Salinas Grandes – per viadelle miniere di sale, essenziale perla conservazione della carne. Si feceproclamare imperatore della Pampa.Fu la sua gloria e la sua fine: tuttoquesto non poteva piacere a BuenosAires. “Noi mapuche, continuòÑancufíl, siamo guerrieri ma anchevalenti artigiani, tessitori abilissimie cacciatori infallibili”. Queste qua-lità fecero in modo che essi pren-dessero subito il sopravvento sugliautoctoni, così poté diffondersi eprevalere la loro lingua, ma anche leloro tradizioni, i costumi, il folclore,e perfino la religione. Dal canto lo-ro, essi si adattarono alla vita noma-de e al toldo, la casa tehuelche. InCile i mapuche/araucani erano se-dentari: lavoravano i metalli, fabbri-cavano oggetti di ceramica, confe-zionavano ceste, vassoi e piatti dilegno. Vestivano di cuoio, pelli, piu-me e lana. Mangiavano carne, fruttiselvatici, uova di ñandú e di struz-zo, mele, oltre che cacciagione e pe-scato. M’incuriosì l’arma da essipiù usata per la caccia e la guerra, leboleadora, tre palle di pietra rico-perte di cuoio e collegate da lunghestrisce intrecciate dello stesso mate-riale che, lanciate con maestria, im-brigliavano le zampe della predaimmobilizzandola a terra. Per laguerra usavano anche lunghe lance.Parlavano il mapudungun (“linguadella gente della terra”). La religio-ne, fatta di preghiere e cerimoniecome tutte le religioni del mondo,prevedeva un essere superiore,NGUENECHÉN (padrone del popo-lo), al quale dedicavano due voltel’anno una straordinaria cerimoniache poteva durare fino a tre giorni,chiamata Nguillatún, fatta di invo-cazioni, canti, danze, discussioni equant’altro, e accompagnata da stru-menti musicali di costruzione arti-gianale in cui parte importante ave-
L’araucaria, del cui frutto si nutrivano i mapuche soprattuttoquando dimoravano in Cile. L’albero può raggiungere i 30 metri di altezza.
Petrolio in Patagonia.
PASQUA 2008
LA SAGRA DEI TALAMI
Orsogna è un paesetto –poco più di quattromilaabitanti – della Marruci-na, che ha dato i natali a
personaggi come Camillo De Nar-dis (1857-1951), compositore e di-rettore d’orchestra, Mario Pomilio(1921-1990), scrittore e giornali-sta, e altri. Ma è conosciuto so-prattutto per la “Sagra dei Tala-mi”, la grande sfilata annuale diquadri biblici viventi, che chiude,il lunedì dell’Angelo, le feste pa-squali ed è interpretata da giovanie giovanissimi attori in costumed’epoca su palchi mobili, oggi trai-nati da trattori, che rappresentanoscene del Vecchio e del Nuovo Te-stamento. La sagra si celebra or-mai da secoli, risalendo al tardoMedio Evo.
UNA CATECHESI SPECIALEAnche il vescovo di Chieti, monsi-
gnor Bruno Forte, uno dei più noti eprestigiosi teologi della Chiesa italia-na, si è recato a Orsogna per i Talami,e non tanto per assistere alla sfilatadei carri biblici, quanto piuttosto percommentarli, dando nel contempol’importanza che merita alla sagra. Adetta di molti, presenti come turisti(non sono pochi i visitatori attirati dalsingolare evento) è stata una magnifi-ca catechesi, arricchita per di più danotazioni artistiche e culturali di altospessore, a volte perfino suggerendoagli attori la posizione più consona,sul palco mobile, per completare ilsenso religioso del quadro o ancheper avvicinarsi di più all’opera del-l’artista cui alcuni quadri si ispirano.E il vescovo teologo ha citato adesempio Rembrant per il talamo rap-presentante il sacrificio di Isacco.
TRA SACRO E PROFANOUna tradizione, quella di Orsogna,
che sa sapientemente mixare sacro eprofano, dove le due realtà si inte-grano quasi a sottolineare che le sto-rie bibliche, anche quelle più tragi-che, sono storie di salvezza e cometali vanno vissute: nella gioia, nelringraziamento, nella celebrazione,nell’invocazione e, perché no, nel sa-no divertimento. I drammi liturgici,in effetti, sono drammi “sicut inquantum”. Poiché, cruento che sia,quello liturgico è pur sempre undramma che redime, che salva, edunque che invita alla gioia, alla leti-zia, alla festa. “Perché mai non do-vrebbero sussistere eventi profani inconcomitanza o come conseguenzadi eventi sacri?, ha detto uno spetta-tore. Non è un ritorno al Medio Evo,in cui sacro e profano erano untutt’uno, semmai è una re/interpreta-zione di esso”. La processione deisette talami parte da sette quartieri diOrsogna per ritrovarsi dopo circadue ore nella piazza del paese dovesi tiene la sfilata conclusiva. Ma lafesta continua con stand gastronomi-ci e tutto il contorno delle antiche emoderne sagre paesane. �
20
MARZO 2008 BS
VENTIE
Una Pasqua davverospeciale quella diOrsogna di Chieti, doveun intero paese simobilita per chiudere lapiù grande festa religiosadell’anno con unasingolare sfilata, nellunedì dell’Angelo.
Quinto talamo 2005: La Pasqua di Gesù e Secondo talamo 2007:Elia all’Oreb.
di Filippo Manoni
21
BS MARZO 2008
dei più noti e celebrati missionari sa-lesiani di oggi che, con i suoi volon-tari, ha realizzato opere incredibili afavore dei campesini della Cordiglie-ra. Oggi la cattedrale è una splendidarealtà che onora la città e il Paese.
>> Il secondo evento di quel giornofortunato è stato la consacrazioneepiscopale di un altro – se così sipuò definire – dei volontari di donUgo, monsignor Gaetano Galbuserache, proprio per dare una mano alsuo amico missionario, dopo averricoperto vari incarichi, tra cui di-rettore e ispettore, in Italia, ha scel-to il Perù. Là è stato nominato retto-re del seminario maggiore di Pu-mallucay, dove si preparano al sa-
cerdozio anche alcuni volontari del-l’Operazione Mato Grosso che da-ranno continuità alle opere di padreUgo. Là lo ha raggiunto il decretodi nomina a vescovo di BenedettoXVI, che gli ha assegnato la diocesidi Pucallpa (terra colorata), in pie-na selva amazzonica: 52 168 km2 diterritorio, mezzo milione di abitantidi cui quasi 400 mila cattolici. Pu-callpa, fondata nel 1833, è oggi unacittà turistico-commerciale e portofluviale, posta sul fiume Ucayali, ilcentro di pesca più importante delPerù e uno dei maggiori del mondo,capitale della provincia del Santa esede universitaria.
Un magnifico campo di apostola-to attende don Gaetano. �
Chimbote, città di 350mila abitanti, è il centro di pesca più importantedel Perù; la città –protagonista il Segretariodi Stato Vaticano – è stata teatro di duememorabili avvenimenti:la consacrazione dellanuova cattedrale e quella di un nuovovescovo salesiano, nello stesso giorno, il 26 agosto 2007.
DUE CONSACRAZ IONI
UNA CHIESAUN VESCOVOdi Filippo Manoni
L’hanno definita la più bellacattedrale del Perù. Sorge aChimbote, voluta dal vesco-vo monsignor Luis Bam-
barén, disegnata dall’architetto italia-no Angelo Ripamonti, assegnata allaresponsabilità e all’intraprendenza didon Ugo De Censi (solo lui potevafarcela), costruita dai volontari del-l’Operazione Mato Grosso in cinqueanni, consacrata dal Segretario diStato Vaticano cardinale TarcisioBertone. Sembrava a molti impossi-bile innalzare una costruzione cosìgrande e complessa in un luogo sab-bioso come quello assegnato alla cat-tedrale. Ma i volontari di don Ugo cel’hanno fatta anche stavolta: sonoabituati ai “miracoli”, stando con uno
L’interno della cattedrale di Chimbote.
Due amici: monsignor Gaetano Galbusera e don Ugo De Censi.
Leggo sul tuo volto smagrito, visitato dalla nevrosisenza l’ombra di un sorriso, la tua delusione, il tuo sconforto, quasi ti avessero sequestrato l’amore,compromessa la vita, tolta la chiave di casa. Sei dicattivo umore. Di più. Hai il cattivo umore.Ti sei condannato agli arresti domiciliari. Non parli.Non vuoi vedere nessuno. Vuoi sbarazzarti in un sol colpo di 10 anni di vitadonata, di gratuità, di innocenza.Vuoi svuotare il cielo dei suoi angeli. Ti lamenti di Dio che hai mandato a quel paese. Chepensi ai fatti suoi!Ti manca la terra sotto i piedi. Ti manca l’odore del caffè visto crescere nei campiassolati. Ti manca l’Africa. Ti manca la risata delle amiche. Ti manca la compagnia dei bambini che ti chiamavano “maman”.Hai paura di te, del domani, di tutto. Hai paura di dimenticare, di non tornare proprio dadove sei fuggita.Se ancora sorridi è solo per smettere di piangere,come un canto africano piagnucola.Basta piangerti addosso! Dopo il terremoto,vengono i sorrisi, i pacchi-dono. Eccoli.Punto uno.Mi sembri un millepiedi. Non fai un solo passo inavanti se ti lasci imprigionare dallo sciame dei tuoirancori. Per spiegare il disastro occorre ammettereun errore o meglio ancora rimetterci nellacondizione di ricominciare. Peguy si pronuncia così: “L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivereperché vivere è cominciare sempre ad ogni istante. Quando mancaquesto senso si vorrebbe morire”.Punto due.Arrabbiati, non essere muta senza una parolainnanzi alla quale scateni la tua tempesta. Ribellatial silenzio che ti umilia. Non aver paura delle parole.Sono la chiave dell’anima.
2222
MARZO 2008 BS
Ci sono parole di incredibile dolcezza. Mettinequalcuna al posto dei puntini ………………………………………………La parola ti permette di sbirciare nell’infanzia, nellestagioni della vita. Ti permette di dire “è mio!”È mio il cielo nero dell’Africa, la terra assetata,l’orgoglio dei giovani che smaniano di diventaregrandi.È mia la vita che voglio, o Dio, ancora una volta donare a te.Punto terzo. Nessuno si è sbarazzato di te. C’è un momento della vita in cui devo mettermi incondizione di percepire che qualcuno sia, in me, piùme di me stesso.È un pensiero del tutto personale.Nella vita si può essere una, due, tre volte santi. La prima volta quando si dice sì. La seconda quando lo si ripete dopo una furiosatempesta e così via.Se hai una colpa, dalla a Gesù.Se soffri un dolore offrilo a sua Madre.Un albero non si spaventa se una foglia si distaccae tocca terra. Continua a vivere, a crescere e a darefrutti.Ho deciso di amarti di più, di non dimenticarmi di te, di rivedere i tuoi occhi, il tuo sorriso, il tuo volto bruciato dal sole.
Carlo Terraneo
BASTA PIANGERTI ADDOSSO!
L’ELOGIO DELLA PAROLA
AI GIOVANI LETTERA
Lettera “moderatamente”
provocatoria ai giovani...
a partire dalla realtà dei fatti
BS MARZO 2008
Presentiamo il Centro per la Comunicazione sociale
che si trova a Yaoundé, capitale della Repubblica del Camerun.
INSERTO
CULTURA
EDB UNA CASA DELLA
COMUNICAZIONE PER L’AFRICA
di Maria Antonia Chinello
L’Association Salésienne pour laCommunication sociale di Yaoundé(Cameroun) è nata per diffondere,attraverso la stampa e il linguaggioaudiovisivo, il carisma salesiano inAfrica. Salesiani e Figlie di MariaAusiliatrice si sono impegnati a farconoscere il sistema preventivo. E l’Editions Don Bosco è lo spazioche si fa casa per annunciare edevangelizzare, accettando la sfidadi una comunicazione di qualità.
La sede della EDB a Yaoundé.
MARZO 2008 BS
L’Association Salésienne pourla Communication sociale(A.S.C.S.) è un’associazione
senza scopi di lucro, costituita aYaoundé (Cameroun) l’8 feb-braio 2003, tra i Salesiani diDon Bosco dell’ispettoria dell’A-frica Equatoriale (ATE) e le Figliedi Maria Ausiliatrice dell’ispetto-ria dell’Africa Ovest che, allora,comprendeva otto paesi: Costad’Avorio, Togo, Benin, Malì,Congo-Brazzaville, Gabon, Ca-meroun e Guinea Equatoriale.Per realizzare i suoi progetti,l’Associazione ha promosso unCentre de Production et de Dif-fusion de Médias écrits et audio-visuels, con sede a Yaoundé,presso la Casa ispettoriale deisalesiani. L’Associazione, fin dalsuo inizio, si pone al serviziodella Chiesa in Africa e collabo-ra con tutti coloro che lavoranonell’ambito della stampa e dellaproduzione audiovisiva, attivan-do una risposta concreta ai pro-cessi di inculturazione e inve-
stendo nel settore della comuni-cazione sociale. Il Sinodo Afri-cano, infatti, insieme con i Pa-stori delle differenti chiese han-no a più riprese affermato chel’evangelizzazione oggi deve in-tegrarsi con i nuovi linguaggidella cultura moderna per parla-re di Gesù Cristo con uno stilecomprensibile e che, soprattutto,affascini.
LA COMUNICAZIONE NEGATA?
Il sistema dei mezzi di comuni-cazione in Africa funziona in mo-do diverso dal resto del mondo,soprattutto per quanto riguarda
l’accesso alle informazioni. Ac-cesso significa saper leggere, es-sere informati, conoscere il fran-cese o l’inglese o l’arabo classicoo la lingua nazionale per ascolta-re i notiziari nazionali, vivere inun luogo non soltanto con unaconnessione a Internet ma conuna buona connessione telefoni-ca, senza la quale è impossibileconsultare siti web e scaricaredocumenti; significa avere i soldiper comperare un giornale, nonavere un controllo statale checensura le fonti di informazione eperseguita i giornalisti, poter tro-vare una biblioteca con testi ag-giornati. Il tema dell’accesso, inAfrica, è strettamente collegatoalla diffusione dell’analfabetismo,
Il logo del Centro.
Suor Vilma Tallone con il signor Olaverri in riunione di lavoro.
L’immarcescibile Jean Baptist Beraud, salesiano responsabile del centro, al suo tavolo di lavoro.
Suor Micelle Nyangono al computer.
BS MARZO 2008
alla censura, alla negazione deidiritti umani, alle questioni lin-guistiche, al digital divide (il di-vario che esclude gran parte delSud del mondo dall’accesso alleinnovazioni tecnologiche) e, ov-viamente, è strettamente connes-so alle situazioni sociali, politi-che ed economiche delle singolearee territoriali.
FINALITÀLa firma che ha sancito l’impe-
gno delle ispettorie dei salesiani edelle Figlie di Maria Ausiliatrice acollaborare come partner per larealizzazione del Progetto diun’Associazione per la comuni-cazione sociale, è stata quella diOlaverri e di suor Wilma Tallone,allora ispettrice.
Sorgeva così, sulla carta, maancora più per la missione, unospazio organizzato, che riserva-va all’educazione forze econo-miche e risorse personali peraiutare i giovani a diventaresoggetti attivi nel tessuto socialedei diversi contesti dove sonopresenti le comunità dei salesia-ni e delle suore. Nell’Africa dilingua francofona, le ispettorieATE e AFO (dal 2004 vi è anchel’ispettoria delle Figlie di MariaAusiliatrice AEC) sono territo-rialmente estese su 10 paesi: Bé-nin, Cameroun, Congo-Brazza-
ville, Costa d’Avorio, Gabon,Guinea Equatoriale, Mali, Re-pubblica Centrafricana, Chad,Togo.
«Obiettivo prioritario dell’A.S.C.S.– spiega suor Laura Gaeta, primaFMA redattrice delle EditionsDon Bosco – è contribuire allaformazione umana e cristianadegli agenti pastorali e dei gio-vani in particolare, attraverso laproduzione di libri e materialeaudiovisivo. Si pensa così di fa-cilitare il processo di incultura-zione delle chiese africane e, inparticolare, offrire agli agenti pa-storali strumenti di lavoro piùadatti al contesto e di immediatae facile utilizzazione». «In parti-colare – continua Jean BaptisteBeraud, salesiano e capo redat-tore del Bollettino Salesiano – leproduzioni delle Editions DonBosco offrono al pubblico libri,opuscoli, dépliant dove il lin-guaggio e la metodologia d’ap-proccio tengono conto dellarealtà affinché la lettura sia pia-cevole e l’assimilazione dei con-tenuti possibile. Tutte le produ-zioni hanno come destinatari ibambini, i giovani e gli educatoried educatrici delle opere salesia-ne. Salesiani e Figlie di MariaAusiliatrice coordinano, infatti,Scuole, Centri Tecnici, Oratori eCentri giovanili, parrocchie nellezone sia urbane sia rurali. Nu-
merosi sono i collaboratori e lecollaboratrici laiche con cui laFamiglia salesiana condivide lamissione educativa ed evange-lizzatrice: catechisti, animatori,insegnanti, coordinatori».
Suor Micelle con un collaboratore. Suor Laura Gaeta al suo posto di lavoro.
Numero de “Bulletin Salesien”, edito dal Centro per l’ispettoria AFO (Africa Occidentale Francofona) che comprende Senegal, Guinea, Costa d’Avorio, Togo, Bénin, Burkina Faso, Mali.
Produzioni catechistiche della EDB.
MARZO 2008 BS
OBIETTIVI E PRODUZIONE
Sfogliando il fascicolo del Pro-getto dell’Associazione e, in par-ticolare, consultandone lo Statu-to, si coglie un lavoro di analisi edi ricerca che sfocia in un «lavo-ro di squadra» che ha obiettiviprecisi. Salesiani e Figlie di Ma-ria Ausiliatrice dell’Africa Centroequatoriale si impegnano attra-verso il Progetto di produzione ediffusione della stampa scritta edel materiale audiovisivo a:>> produrre e diffondere materia-le scritto e audiovisivo come ap-porto all’educazione e all’evan-gelizzazione dei giovani e dei cetipopolari; >> collaborare all’umanizzazionedella cultura dei media e contri-buire alla riflessione sulla base delloro impatto positivo sul mondodella comunicazione; >> permettere ai giovani e ai cetipopolari di beneficiare di prodottidi qualità a prezzi accessibili; >> divulgare la spiritualità sale-siana e il metodo educativo disan Giovanni Bosco;>> fare conoscere il carisma el’opera salesiana in Africa; >> proporre ai giovani modelliche possono ispirare il loro pro-getto di vita; >> offrire ai giovani ulteriorimezzi per la loro espressione:radio, produzioni multimediali,
videocassette e altri supporti di-dattici; >> creare rete con altri organismicattolici e non impegnati nelmondo dei media.
In generale, le pubblicazioniorientate alla formazione umanae cristiana si rivolgono a diversecategorie di agenti pastorali: ca-techisti, animatori della fede edel tempo libero, insegnanti del-le Scuole Catttoliche, formatorie formatrici dei Centri tecnici eprofessionali, simpatizzanti del-la Famiglia salesiana e giovaniin ricerca vocazionale.
Vi sono gli opuscoli che, perragioni pratiche, sono stati clas-sificati in differenti collane:«Animatori della fede»; «Anima-tori del tempo libero»; «Educa-zione ai valori rispetto al-l’AIDS»; «Biografie Salesiane»;«Documenti del Magistero dellaChiesa»; «Sussidi per pregare»;«ADS: Amici di Domenico Sa-vio»; «Formazione CooperatoriSalesiani». Importante è segna-lare che, per dare una rispostapronta alla chiesa locale, appe-na un documento ufficiale èpromulgato dalla Santa Sede iltesto viene immediatamente pub-blicato e immesso sul mercatoin edizione economica, per farein modo che tutti i fedeli possa-no acquistarlo e attingere cosìalla sorgente della comunicazio-ne ecclesiale.
FIORE ALL’OCCHIELLOCon il Bollettino Salesiano ci si
propone di far conoscere il cari-sma salesiano e le sue opere prin-cipalmente in Africa; di sostenereil collegamento tra i differentigruppi della Famiglia salesiana;di offrire, infine, ai collaboratori eai benefattori un organo di infor-mazione e di formazione. Le edi-zioni del Bollettino Salesiano nelmondo sono 56, in 29 lingue.Quella dell’Africa Centro Equato-riale è dunque l’edizione 54°. Se-condo la tradizione lasciataci daDon Bosco, noi non vendiamo ilBollettino Salesiano. Le ispettorieATE, AFO e AEC si impegnano apagare la stampa di due numeriall’anno. Per evitare gli invii po-stali inutili, ma soprattutto costosiper le tasche dell’Africa, ci si affi-da per la diffusione all’intrapren-denza e alla creatività delle co-munità locali dei salesiani e delleFiglie di Maria Ausiliatrice. Inpiù, sono state individuate alcunelibrerie di Yaoundé (Paoline,AMA, Clé, Paroisse Tsinga) cheaccettano un certo numero dellepubblicazioni, così come i con-tatti con alcuni istituti religiosidella città. La rete di collegamen-to si estende e coinvolge anchealtre città, tra cui Libreville (Ga-bon) e Malabo (Guinea Equato-riale).
Maria Antonia Chinello
Suor Laura con José Antonio Vega. Suor Michelle Nyargoro e Jean Baptiste Beraud.
27
ENRICAFEDE E CORAGGIO
Ogni giorno il cuore di Enrica si accende didesiderio per la vita. La viveva in pienezza,tranquilla, serena,responsabile. Questomodo di vivere diventa il suo stile, il suo abito piùbello. Giovane entusiasmoe servizio verso ilprossimo aderisconoperfettamente nella testa,nell’anima e nel volto diEnrica che, attraverso ilsuo sorriso, trovano la viaper raggiungere gli altri.
Nasce il 12 febbraio 1954 aCastano (Milano). Crescesviluppando con estrema
concretezza e decisione sia il ri-svolto intellettuale della sua perso-na, sia il risvolto spirituale; senzadimenticare quello sociale che nefa una ragazza attenta, pronta al-l’accoglienza, disponibile all’ascol-to, generosa nel dare, riconoscentenel ricevere… Interessi, impegni evalori si fondono in modo equili-brato e sereno rendendola a tuttisimpatica e desiderata. L’oratorioè la sua seconda casa e nel pocotempo libero che le rimane fra stu-dio e impegni casalinghi ella conti-nua a dedicarsi “mani e piedi” alleattività parrocchiali, soprattutto at-traverso la frequenza entusiasta econvinta a un corso per catechista e
partecipando a tutta una serie diiniziative in cui è sempre protago-nista attenta e sincera. Nel frattem-po segue con grande interesse e vi-va emozione le vicende che coin-volgono la sua famiglia, a causadella scelta coraggiosa di suo fra-tello che decide di entrare in semi-nario. Gli anni dell’adolescenza so-no dunque per Enrica un seriocammino di crescita umana e spiri-tuale che nulla toglie alla sua lim-pida vivacità e le consente un sanoe meritato divertimento che la ren-de ancor più amabile: sono in moltiche cercano la sua compagnia.
� Anche l’amore verso un ra-gazzo diventa il tassello di un mo-saico in cui nulla è messo a caso,non comportando turbamenti o sof-ferenze particolari per Enrica, laquale sa confrontarsi apertamentecon la sua guida spirituale, rima-nendo così fedele alla sua promes-sa: “Vogliamo formare una fami-glia cristiana… ci prepareremocon molta serietà”. La sua fedespesso esuberante e desiderosa direalizzarsi nel dono si concretizzanel raggiungimento dell’obiettivoche si era posta e dietro cui avevalavorato per qualche anno: diventa-re catechista “diplomata”. Ma que-sto fu anche il periodo che coincisecon l’avanzare minaccioso di unmale che le sarebbe stato fatale.Una cisti nel volto, precedentemen-te asportata, torna a minacciare lasua espressione sempre gioiosa esolare… Si accorge così che la suastrada sarebbe stata tutta in salita.Ma decide di non trascurare nessu-no dei suoi impegni: “Voglio che
27
BS MARZO 2008
nulla vada perduto”. È il suo attodi fede che sintetizza il valore diuna vita vissuta all’insegna del co-raggio, dell’onestà, della carità checonsiderava ogni esperienza (anchedura) una prova per migliorare.
� Discute febbricitante la tesiche conclude il suo cammino dipreparazione catechistica, e ricevedal vescovo il “mandato” e il cro-cifisso di ministro della Parola. Ilmale la indebolisce fisicamente,ma non abbatte la sua volontà chenella preghiera e nell’eucarestiatrova coraggio di continuare. Al-l’ospedale, poco prima di spegner-si, chiede alla mamma di avvici-narle un piccolo tavolo sopra ilquale per l’ultima volta prega ap-poggiando le braccia. E il 23 otto-bre 1971 Enrica muore. �
BAGLIORIdi Serena Manoni
Enrica Noè (1954-1971).
DOPO CENT’ANNI… CI SIAMO
quali impegni poteva riservare lanuova realtà che stava per nascere?La risposta di don Rinaldi non si fe-ce attendere: «Tenetevi unite ed aiu-tatevi». Su questi due verbi si è co-struita, lungo cent’anni, la storiadell’Associazione che ha visto e ve-de, in tutti continenti, una rete didonne e uomini (ora, c’è la presenzaanche di exallievi) che rispondonoalle domande d’aiuto, specie dei piùgiovani, secondo lo stile di Don Bo-sco e di Maria Mazzarello. Si trattadi migliaia di persone che, avendosperimentato l’amorevolezza sale-siana, la diffondono nei propri terri-tori, la vivono negli ambienti di la-voro, nelle parrocchie, nelle istitu-zioni educative, specie tra i più po-veri. Il sistema preventivo, cuore di
una pedagogia in cui chi educa fasempre il primo passo e crede che«in ognuno c’è un punto accessibileal bene», costituisce la trama delleloro relazioni e degli interventi edu-cativi, che sempre mirano alla for-mazione di tutta la persona, a co-struire “ buoni cristiani e onesti cit-tadini”.
28
MARZO 2008 BS
MAF
Era un piccolo gruppo di gio-vani donne quelle che stava-no attorno a don Filippo Ri-naldi, secondo successore di
don Bosco, quando espresse la suafelice intuizione profetica di orga-nizzare le forze di coloro che aveva-no fatto esperienza di case salesia-ne, perché potessero fare sinergia.Erano state allieve, oratoriane delleFiglie di Maria Ausiliatrice e aveva-no assimilato quello stile di solida-rietà concreta tipico della pedagogiadel santo dei giovani. Si erano giàmosse con generosità e intrapren-denza nel campo della cura deibambini, delle donne, dei giovani indifficoltà.
Tuttavia, di fronte alla proposta dicostituirsi in gruppo esprimevanoanche qualche perplessità. Il nuovogenera sempre un po’ di incertezza,a volte anche paura.
Quali prospettive, quali compiti,
In una piccola stanza, a Valdocco, nel marzo1908, don Filippo Rinaldirendeva concreto un nuovo progetto, in sintonia con i vastiorizzonti sognati da Don Bosco e da madreMazzarello: fondaval’associazione exallievedelle FMA.
di Graziella Curti
Una consigliera Confederale porta aiuti ai bambini colpiti dallo tsunami.
1983, 75° delle exallieve. Parla la Madre Generale suor Rosetta Marchese.
29
BS MARZO 2008
quelle aule dove si svolge buonaparte della loro vita… come educa-tori sono chiamati a qualcosa che vaoltre il programma da svolgere. Èl’attenzione del cuore. Di questahanno bisogno i bambini e gli ado-lescenti, ed è questa che ricorderan-no a distanza di anni». La stessa at-tenzione è espressa per i temi dellabioetica, dell’economia di mercato,delle migrazioni. È l’inedito di DonBosco e di Main che rivive nell’at-tenzione educativa di figlie e figliche hanno goduto dell’amorevolez-za salesiana.
MANI NEL MONDO RADICI NEL CUORE
Per celebrare il centenario del-l’Associazione, il Consiglio Confe-derale delle Exallieve ha indetto unConcorso in cui si proponeva dicreare un logo che esprimesse il si-gnificato dell’evento, la sintesi di unsecolo di vita e la proiezione nel fu-turo. La risposta all’iniziativa ha ri-velato entusiasmo e senso di appar-tenenza. Sono giunte molte produ-zioni grafiche con stili diversi comediversi sono i luoghi e le culture diprovenienza. È stata scelta l’opera disuor Alba Vernazza, FMA, delegatadi Unione nella Federazione ligure.La presidente Confederale, CarolinaFiorica, nel dare le motivazioni della
scelta, scrive: «Sono evidenti in essole mani nel mondo, ma pure unoscorcio della Basilica di Maria Ausi-liatrice di Torino e l’immagine dellaValponasca (Mornese) con la fine-strella: felice sintesi della nostra spi-ritualità salesiano-mornesina».
Il tema delle mani sul mondo è ilcuore del messaggio scelto per l’oc-casione. Le responsabili lo ritengono«l’essenza stessa dell’Associazione»e l’hanno articolato in un testo che èinsieme realismo e poesia: «Mani chepenetrano il mondo, mani che strin-gono al petto bambini soli, affamati,violentati, indifesi; mani che scavanonella terra arida e assolata dei Paesipiù poveri del pianeta fino a far sgor-gare l’acqua per dare da bere a quantinon hanno ancora libero accesso al-l’acqua potabile; mani che costrui-scono case per dare un tetto a ognicreatura, e scuole per ridare dignità aogni essere umano; mani che si strin-gono in una catena umana di solida-rietà e di difesa dei diritti; mani chenon temono di sporcarsi o contami-narsi, capaci di sopportare le lacera-zioni per lenire le lacerazioni deglialtri». E il messaggio continua richia-mando l’importanza del cuore, la ve-ra radice dell’azione educativa. Uncuore che sceglie la sobrietà comestile di vita, che sa portare gioia, chesa prendersi cura dell’altro, «che in-carna l’amorevolezza del Padre». �
NON UNO DI MENONel nome della ONLUS, che rea-
lizza il Progetto di sviluppo delleexallieve/i, c’è tutto un programma:niente e nessuno può essere dimen-ticato o emarginato, specie se gio-vane.
Destinatari privilegiati di ogni ini-ziativa di solidarietà sono infatti ibambini, le donne, le famiglie. Suquesta base, sono fioriti progetti dainomi originali, segno di interventinon programmati a tavolino, ma ela-borati sul territorio, dopo una raccoltadi dati reali che potessero disegnarela mappa concreta di un’azione soli-dale. Allora è nata la campagna per ilNord Vietnam: Un maialino per ognifamiglia; per la Lituania: Un cappot-to caldo caldo; per Gerusalemme:Adotta una classe; per la Bolivia: Unponte verso la vita; per l’Ucraina:Adesso più che mai… e tanti altriprogetti che toccano i vari Paesi delmondo dove c’è un’exallieva/o con ilcuore di don Bosco e di Main.
A sostegno di tali interventi, vieneedito ogni mese un buon organo dicomunicazione, la Rivista Unione,che raggiunge tutte le tesseratediffondendo, a rete, lo stile educati-vo salesiano e creando mentalità. Lerubriche e gli editoriali, redatti daldirettore responsabile, Silvana Aloi-si, graffiano la realtà, mettono a fuo-co le problematiche anche del mon-do occidentale e aiutano a leggeregli eventi in modo sapienziale, evan-gelico.
Si affrontano i problemi della pe-dofilia stimolando i genitori, glieducatori a osservare e a intervenire«cercare di capire che qualcosa nonva nello sguardo spento o nel com-portamento non abituale dei bambi-ni che ci vivono accanto». Ci si ri-volge, in particolare, agli «inse-gnanti – molto numerosi nell’Asso-ciazione – presenti per tante ore algiorno con i piccoli che sono là, in
L’attuale Consiglio Confederale nella casa di Castelnuovo.
Fanciulle e donne del villaggio di Waramel e Laithok (Sudan) attorno al pozzo. L’acqua in queste zone è la vita.
SPIRITUALITÀ
QUOTIDIANA PROBLEMI
EDUCATIVI
RICORDATIDELL’AMORE a cura di Ermes Ronchi e Sonia Spinelli Paoline, Milano, 2007 pp. 198
Il volume presenta nove let-ture bibliche che esploranola vicenda di personaggidell’Antico e del Nuovo Te-stamento, il cui rapporto conDio è stato intenso e a voltedrammatico: sono “i sedottida Dio”. Tra loro ci sonoMosè, Geremia, Maria diNazaret, Paolo di Tarso, maanche profeti e salmisti il cuinome non è stato traman-dato. Per molti di essi Dio siè fatto riconoscere e poi èsparito, divenendo l’Atteso.Queste storie cercano di ri-spondere alla domanda sulrapporto tra fede e datosensibile, assicurando cheogni evento d’amore, ancheil più umano, è decretatodal cielo. Oltre all’attenzioneal testo biblico si registraquella per la realtà della vitaodierna attraverso l’indivi-duazione di percorsi e si-gnificati attuali dei concettidi amore, coppia, famiglia.
LE GRANDI DOMANDEDEI PICCOLI Centro di “Evangelizzazionee Catechesi Don Bosco” ELLEDICI-ISG-EMP, 2007pp. 236
30
MARZO 2008 BS
a cura di Giuseppe Morante
IL MESE IN LIBRERIA
I RAGAZZI DELLA CROCESette storie di ragazziin cielo di Paolo Gariglio Effatà, Cantalupa (To)2006, pp. 192
Ecco le storie struggentie assolutamente vere disette giovani vissuti ap-pena 15, 17, 18, 19 e 32anni... In Valle Stretta,alta Val di Susa, c’è unaCroce sormontata dauna stele in bronzo coninciso: “Questi sono puricome vergini e seguonol’Agnello dovunque va-da. Sono scelti tra gliuomini per essere primi-zia offerta a Dio e all’A-gnello” (14, 4). Su quel-la Croce vengono con-tinuamente aggiunti no-mi di ragazzi con i quali,per un misterioso dise-gno di Dio, la vita è sta-ta avara di anni, perchémalattia o incidenti nehanno concluso prema-turamente l’esistenzaterrena. Oggi sono oltre200. Si chiama “Crocedei ragazzi in cielo” ed èmeta di continui pellegri-naggi! Spesso si trattadi animatori di gruppiparrocchiali, che posso-no essere di stimolo aben vivere l’adolescen-za oggi.
SPOSARSI
IN CHIESA
CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE riflettere, progettare,celebrare a cura di Gianfranco VenturiELLEDICI e altri ed.con CD, 2007 pp. 448
Si sta perdendo il sensodella parola “amore”. Checosa significa ti amo nellabocca di tante persone? Illibro si addentra nel cuoredelle parole d’amore, cer-cando di scoprirne il tesoronascosto, delineando l’i-dentità delle parole e collo-candole nello proprio cam-po, con l’aiuto delle inter-pretazioni di usi, tradizioni,esperienze, sentimenti, riti,gesti… Seguono poi 126schede isolate e nello stes-so tempo raccolte comeparti di un particolare cam-po di parole. Molte indica-zioni sono reperibili nel CD-Rom allegato. Si vuole invi-tare i fidanzati, gli sposi echi si occupa della forma-zione al matrimonio, di Ri-flettere (R) sul presente esul futuro di coppia; Proget-tare (P) con cura la celebra-zione e ciò che la segue;guidare nella preparazionedella Celebrazione (C).
Vivere con i bambini si-gnifica esporsi a domandecuriose; alcune divertenti,ricche d’inventiva, altre aeffetto elettroshock, per-ché sono gli interrogatividi tutti. Le risposte fatica-no a competere con l’ap-parente semplicità delledomande che nascondo-no significati profondi. Inparticolare nel libro si tie-ne conto delle domanderelative ai valori della vita.Le risposte date non han-no la pretesa di dire tutto.L’intento è quello di offrireuno spazio di discussio-ne, di proporre senza im-porre e aiutare il bambinoa trovare da solo ciò chegli sembra più giusto. Chesi usi questo libro siste-maticamente o a “piccoledosi”, il bambino ne saràedificato. Gli interrogativiesistenziali interpellano ibambini quanto gli adulti.Ignorare le domande èangosciante; parlarne in-sieme è consolante.
31
BS MARZO 2008
RACCONTI DEL VENTO di Paolo ValenteSan Paolo, Cinisello B. (Mi)2007, pp. 78
Dalla tradizione orale afri-cana nascono queste die-ci storie legate insieme daun soffio di vento; aiutanoa scoprire luci e profumilontani e parole di sag-gezza universale. Sonofavole del Benin (AfricaOccidentale). Si tratta diun Paese i cui bambinimagari hanno fame e se-te, hanno poche scuole eniente ospedali. Eppuresanno ridere e sorridere,qualità che spesso da noisono scomparse, perché inostri bimbi sono saziesteriormente e spessovuoti dentro, inariditi dalbenessere. Queste favoleda generazioni vengonoraccontate dai saggi nellelunghe serate africane epossono diventare un re-galo che i bimbi dell’Africafanno ai loro amici euro-pei. La vera sapienza nonha confini etnici, perché èradicata nel cuore dell’uo-mo che riflette la Sapien-za di Dio Creatore.
SAPIENZA
“INFANTILE”
NON SI FA VENDITA PER
CORRISPONDENZA. I libri
che vengono segnalati si pos-
sono acquistare presso le libre-
rie cattoliche o vanno richiesti
direttamente alle rispettive
Editrici.
IL DIALOGO RELIGIOSOAL LETTO DEL PAZIENTE di Massimo Petrini, Erickson, Trento, 2007pp. 314
SCOPRO-IMPARO LA BIBBIA GIOCANDOAlbi a cura del Centro di “Evangelizzazione e Catechesi Don Bosco” ELLEDICI-ISG, 2007
Contiene 4 libri di giochi, 2libri gratta e vedi, 4 penna-relli. I materiali dei 4 libri digiochi offrono possibilità dipassare ore di divertimentocon attività e giochi biblici:Tanti giochi in cui i bambinidovranno trovare le diffe-renze, scoprire i labirinti,completare i disegni, unire ipuntini, trovare l’intruso. Idue albi di gratta e vedi fan-no scoprire le avventure didue personaggi chiave del-la Bibbia (Mosè e Davide),perché si collocano nellastoria della salvezza comeliberazione dal male (Mosè)e come riferimento al veroLiberatore, Gesù, che si in-serisce nella discendenzadel re Davide. Il materialeofferto si colloca dentro unadidattica di educazione reli-giosa, che favorisce la sco-perta del valore trasmesso,attraverso attività di esplo-razione, manipolazione e ri-cerca guidata.
DOLORE E MORTE:
UN SENSO?DIDATTICA ATTIVA
Cerchi una rivista giovane fatta apposta per te, adatta alle tue esigenze?
Vuoi capire quello che pochi osano dirti?
Vuoi essere informato sul mondo dei giovani?
Allora DIMENSIONI
NUOVEè la rivista
che fa per te
Vai al sito www.dimensioni.orge chiedi subito una copiaomaggio
ConDIMENSIONI
NUOVEsei più giovane!
Puoi abbonarti anche on lineoppure con ccp n. 376103intestato a DIMENSIONI NUOVE ELLEDICI10096 LEUMANN TO
Scrivici:[email protected]
➡
Quale senso dare al dolo-re? Come affrontare l’affie-volirsi della speranza e vive-re la sofferenza? Ogni reli-gione ha dato una risposta.Dall’Ebraismo all’Islam, dal-l’Induismo al Buddhismo,dalla spiritualità africana alloShintoismo e alle tradizionireligiose giapponesi, il libroraccoglie quanto la teologiae la pratica religiosa hannoelaborato – in secoli di sto-ria – in materia di malattia,sofferenza, etica, medicina,lutto. L’informazione è stori-camente documentata, ca-pace di fornire strumenti im-portanti a lettori attenti alleesigenze non solo sanitarie,ma anche spirituali e umanedei malati. Medici, operatorisanitari, operatori religiosi einterculturali, pazienti, mala-ti e familiari vi troverannoquanto serve per capire i bi-sogni più intimi di chi spes-so è lasciato solo nella sof-ferenza fisica e spirituale.
32
MARZO 2008 BS
colo. Raccontava egli stesso che alla povera maestra del-le elementari ne combinava di tutti i colori. Tant’è che ungiorno lei non ne poté più e, incontrando la mamma unadomenica dopo la prima messa (erano tempi in cui amessa ci si andava tutti tutte le domeniche; e per convin-zione non per convenzione), le si avvicinò e la mise alcorrente delle monellerie di quel terremoto di suo figlio.Che cosa credete che abbia fatto la signora Maria De-matteis? Rincasando andò difilata nella camera del suo“Angelo” ancora beatamente in braccio al dio/sonno e giùquattro sonore sculacciate! Santa pedagogia, in barba aitanti telefoni azzurri di oggi!
GIRARE AL MASSIMOAnche i suoi pretendevano il massimo. E lui imparò daloro a pretendere il massimo sul lavoro, a scuola, inchiesa, in comunità. Quanto al lavoro: “Avevano bisognodi ingegneri e sono diventato ingegnere”, affermava consemplicità. Ma non ha fatto solo quello che strettamentegli competeva: aveva 24 ore di lezioni alla settimana econtemporaneamente faceva il preside dell’ITI e il segre-
Esistono persone le quali ciò chefanno o lo fanno “sul serio” o nonlo fanno proprio. Ecco annunciato il tratto essenziale del salesianocoadiutore, ingegnere AngeloDefilippi.
ON LINE ALESIANI COADIUTORI
Il profilo dell’ingegnere Angelo Defilippi, salesiano laico27/04/1934–10/04/2002.
L’INGEGNERESENZA MEZZE MISURE
di Giancarlo Manieri
“Educare non è fare prediche, non è comandare.Educare è risplendere! Educare è essere ciòche si vuole trasmettere. I valori, infatti, non s’in-
segnano: s’irradiano. Beati quei ragazzi che hanno edu-catori che ‘fanno’ il baule prima di parlarne, che hanno piùesempi che rimproveri, che possono dire ai professori:quello che siete ci colpisce a tal punto da indurci adascoltare quello che dite”. L’ha scritto un exallievo. Perlui, per il prof Defilippi. Non credo siano molti a meritareun elogio del genere da parte di un exalunno. Perché De-filippi era un uomo senza mezze misure, senza tentenna-menti. Non abborracciava: tendeva al meglio e volevache si tendesse al meglio. E proprio per questo non ri-sparmiava, se ne scorgeva l’opportunità, battute salacinon solo ai colleghi d’insegnamento ma anche ai suoiconfratelli sacerdoti. Era un tipetto sui generis fin da pic-
Il salesiano laico ing. Angelo Defilippi.
L’istituto salesiano “Edoardo Agnelli”, che fu la casa di Defilippi fino alla morte.
33
BS MARZO 2008
tario della scuola. Come riuscisse a far bene tutto, losapeva solo lui. A scuola era esigentissimo, eppure glialunni gli volevano un bene dell’anima. Non aveva biso-gno di alzare la voce: teneva la disciplina solo con lapresenza, ma era una presenza che riempiva. Anche ilcuore e la mente. Non per nulla, lo stimavano in modoquasi eccessivo. “Perché chiedeva fatica, ma il primo afaticare era lui”, dice chi gli è stato vicino. In chiesa eraesemplare, senza fronzoli o eccessivi pietismi. Lasobrietà unita a una profonda ma quasi nascosta inten-sità religiosa che ha sempre rifiutato ogni teatralità, era-no le sue caratteristiche. I suoi scolari lo sapevano bene.Quando li portava a Valdocco, in visita alla Casa Madredei salesiani e alle camerette di Don Bosco, era capacedi dire ai suoi ragazzi: “Ehi, adesso andiamo a confes-sarci tutti eh!”. Andiamo, non Andate! Lui, il preside,dava l’esempio, e trascinava gli altri. In comunità era lapuntualità fatta persona. Si faceva sempre avanti perleggere, per servire. Non buttava via nulla... l’avevaimparato in famiglia, una famiglia di contadini che sape-vano che cosa volesse dire “guadagnarsi il pane con ilsudore della fronte!”. – A tavola era anche un allegrone– e... “una buona forchetta, quando ciò che c’era sullatavola era buono”. Perfino troppo. Come quella volta chela trovò imbandita con il coniglio al “sivé”, che dovevaessere un intingolo piemontese, speziato e particolar-mente piacevole al palato, se perfino l’ingegnere quellavolta debordò un po’ e si ritrovò con un forte mal di pan-cia. Colpa del sivé o del coniglio? Di nessuno dei due.Probabilmente era solo colpa della gola!
L’AMICIZIAL’ingegnere, dicevamo, non usava mezze misure.Nemmeno a livello di amicizia. Raccontava che inmontagna a Peveragno con due dei suoi migliori amici(era ancora un ragazzino) sgattaiolò sul campaniledella chiesa per “contemplare il panorama”, segno evi-dente di un animo sensibile fino alla poesia alle bellez-ze del creato. Ci restarono un bel po’, ammaliati dallo
spettacolo di un paesaggio inimitabile. Li riportò allarealtà il campanone di mezzogiorno e, subito dopo, laramanzina del direttore. Ma capirono, i superiori, chequei ragazzi più che sbarazzini erano degli spiriti con-templativi e avrebbero avuto un grande avvenire nono-stante la marachella. Per l’amicizia era disposto a tutto, dicevamo, ma le sueerano amicizie serene, di riconoscenza più che di simpa-tia o di empatia: era il ringraziamento per chi collaboravacon lui, per chi l’aiutava, per chi si dava d’attorno peristruire e formare i ragazzi. E in molti collaboravano conDefilippi, ma in modo particolare alcuni ingegneri cheegli aveva conosciuto in Fiat, quelli dei cosiddetti “qua-dri”. Si era legato in amicizia con il direttore di sezioneing. Paladini, e da lui poté avere a disposizione speciali-sti in vari settori che venivano all’Agnelli a tenere lezionidi supporto. È stato un periodo glorioso per l’Agnelli eper Defilippi: tanti supertecnici per i suoi ragazzi... Citeneva, l’ingegnere, a questa “potenza culturale” a favo-re della sua scuola, tant’è che la domenica a volte lapassava, un po’ per riconoscenza ma un po’ anche percalcolo, in casa di “quadri Fiat” (ingegneri che avevaconosciuto e che voleva tenersi cari per i suoi ragazzi),perché poteva allargare conoscenze e possibilità.
FACEVA FUNZIONARE TUTTOUn’altra delle sue virtù era quella di essere uno chesapeva fare il suo mestiere: riusciva a far funzionaretutto. Ogni tanto faceva una visita al “Gino/Lisa”. Il“Gino/Lisa” era un ex aeroporto di guerra passato asuo tempo all’azienda automobilista torinese comedeposito di materiali di scarto, in disuso o in demolizio-ne. Lì Defilippi sapeva trovare tutto ciò che gli servivaper far ri/funzionare le sue macchine “in sciopero”!
L’ADDIONel 1993 un infarto l’avvisò che non tutto procedevaliscio nella sua salute. Non ci badò più di tanto. Neebbe un secondo qualche anno più tardi. Anche que-sto non lo fiaccò né lo immobilizzò nel timore. Cosìquando arrivò il terzo, non gli lasciò scampo. Se neandò senza disturbare il 10/04/2002 a 67 anni. �
ALESIANI COADIUTORI
Defilippi con la classe degli elettronici nel 1993 e il direttore don Aldo Spizzo.
L’ingegner Defilippi con l’avvocato Agnelli, presidente della Fiat.
COME DON BOSCO l’educatoredi Bruno Ferrero
34
INSEGNAREA CHIEDERE
SCUSATroppo spesso le minacce fatte ai figli non sono messe in atto.
La risolutezza deve essere una dote dei genitori.
bambino di tre anni ammettere: «Homangiato il dolce che la mammaaveva detto di lasciar stare» o: «Hospinto Nicolino»? Un’assunzione diresponsabilità a questo livello richie-de un notevole sforzo di attenzioneda parte dei genitori che devonocon pazienza correggere tutte lefrasi del tipo Si è rotto! in frasi checominciano per “io”: Io l’ho rotto!
� Il secondo passo per insegnareai bambini a chiedere scusa consi-ste nell’aiutarli a comprendere chele loro azioni influiscono sempresugli altri. «Se aiuti la mamma apreparare la tavola, la mamma èfelice. Se giochi con la palla incasa e rompi la lampada, la mam-ma è triste. Se dici alla sorellina tivoglio bene, lei si sente amata, sele dici ti odio, si sente ferita. Le tueparole e le tue azioni aiutano o feri-scono altri. Quando aiuti qualcuno,ti senti bene, quando invece ferisciuna persona, stai male».
� Il terzo passo per insegnare aibambini a chiedere scusa consistenell’aiutarli a comprendere che nel-la vita ci sono sempre regole. Lapiù importante è la regola d’oroinsegnata da Gesù: tratta gli altricome vorresti essere trattato tu. Vi sono però tante altre regole, mol-te delle quali sono finalizzate ad aiu-tarci a vivere bene. «Non si gioca apalla in casa» è una regola che mol-ti genitori hanno stabilito per ovvieragioni. «Non dobbiamo prenderenulla che non ci appartenga. Nondobbiamo dire cose non vere sualtre persone. Non dobbiamo attra-versare la strada senza aver accer-tato che non provengano veicoli dauna parte e dall’altra. Dobbiamo dire“grazie” quando una persona ci offrequalcosa o dice qualcosa di bellosul nostro conto. Dobbiamo andarea scuola tutti i giorni feriali, se nonsiamo ammalati o non c’è un proble-ma grave».
� Il quarto passo per aiutare i bam-bini a imparare a chiedere scusaconsiste nel far loro comprendereche è necessario chiedere scusa,per mantenere buoni rapporti inter-
Oggi è diffusa un’evidente diffi-coltà a chiedere scusa. Il con-cetto di perdono è largamente
ignorato. Uno dei motivi per cui moltiadulti hanno difficoltà a esprimersicon il linguaggio del perdono sta nelfatto che non hanno imparato quelvocabolario durante l’infanzia. Forseil clima falsamente neutrale in campomorale della società contemporaneaspiega la scarsità di materiale desti-nato a insegnare ai bambini a chie-dere scusa, e probabilmente il nostroamore per la libertà e la creatività ciha resi così miopi che non riusciamoad accorgerci che l’individualismoassoluto semina solo infelicità. Te-miamo stranamente di minare l’auto-stima dei bambini se insegniamo loroad ammettere che il loro comporta-mento può ferire altre persone. Mal’arte del perdono deve essere impa-rata durante l’infanzia. Un bambinopuò imparare a chiedere scusaquando è ancora piccolo e il suo li-vello di comprensione dell’importan-za del perdono, chiesto e donato, de-ve crescere con lui. In questo modopone le basi per la crescita morale erelazionale degli anni successivi. Igenitori devono accompagnare i
bambini attraverso una serie di tappesemplici ma decisive.
� Il primo passo per insegnare ainostri figli a chiedere scusa consistenel condurli ad assumersi la re-sponsabilità del loro comporta-mento. Questo percorso può co-minciare presto e in contesti moral-mente neutri. Il nostro atteggiamen-to da adulti che prevede di nascon-dere la polvere sotto il tappeto eaccusare gli altri spesso può esserericondotto alle abitudini infantili.Assumersi la responsabilità delleproprie parole e azioni è il primopasso per imparare a chiedere scu-sa. Generalmente, i bambini si as-sumono di buon grado la responsa-bilità delle loro azioni positive. «Homangiato tre forchettate di spinaci.Posso avere il budino, adesso?».«Sono il più veloce di tutti a corre-re.» «Ho disegnato una bella auto-mobile durante l’ora di arte.» Sonotutte affermazioni di assunzione diresponsabilità per azioni positive.Non sono, invece, così pronti adassumersi la responsabilità perazioni meno nobili. Qual è stata l’ul-tima volta in cui avete sentito un
Fabi
ana
Di B
ello
Un bambino può imparare a chiedere scusa quando è ancora piccolo.
il genitoredi Marianna Pacucci
M i impressionò, perché hosempre avvertito una certafatica in questa esperienza e
così decisi che la questione meritavauna chiacchierata davanti a una taz-za di tè. L’amica mi spiegò che lapossibilità di chiedere e di dare per-dono (disse proprio così, suggeren-domi che in questo sentimento c’è ilregalo più grande che ci si possa of-frire l’un l’altro) è, in fondo, l’unicacertezza nell’amore coniugale e nelrapporto fra genitori e figli, la sola co-sa che ti fa assaporare la speranzadel futuro, quando intorno a te le co-se non vanno affatto bene. Aggiunseanche che questa consapevolezzarinforzava continuamente la sua vo-cazione familiare; quanto più verifica-va nelle varie dimensioni della vitasociale lo spirito di competizione, l’ac-cumularsi di infiniti conflitti, l’esistenzadi fratture irrevocabili, tanto più rin-graziava Dio perché in casa potevaassaporare un clima ben diverso. An-zi, era quasi contenta che la sua fos-se una famiglia inquieta; la conside-rava una sorta di garanzia, perchéconsentiva la sovrabbondanza delperdono. Immediatamente, mi stupìmolto, in questa conversazione, co-me il saper guardare le cose da unaprospettiva diversa è sempre moltoistruttivo; se altre famiglie, di fronteall’emergere di situazioni difficili, ri-schiano di disintegrarsi, quella dellamia amica invece usciva addiritturamigliorata dalle stesse difficoltà. Conil tempo, mi sono resa conto che que-sti atteggiamenti non si possono im-provvisare; sono il punto di arrivo di
un cammino molto lungo, e spessodoloroso, in cui ci si lascia educaredagli altri e dalla vita stessa, metten-do in discussione i propri sentimen-ti, le reazioni emotive, un modo di ra-gionare che si dà per scontato anchequando si comprende che non servea nulla. Riversando tutta questa ri-flessione nel mio vissuto familiare, misono pian piano accorta anche di al-tre cose.
� La prima è che ci vuole un allena-mento costante a chiedere scusa; senon si comincia dalle piccole cose ese non si cerca di rendere abitualeuna certa sensibilità, sarà difficilescuotere la polvere che inesorabil-mente si accumula sul proprio orgo-glio. Quando si preferisce il silenzio, osi aspetta che il tempo da solo con-
BS MARZO 2008
LA COSA PIÙ BELLA IN FAMIGLIA?IL PERDONO
Una cara amica, donna molto esigente con se stessa, moglie e madre avvezza a misurarsi con le difficoltà del presente,
le differenze fra persone, le pressioni negative della realtà ambientale, impastata di realismo, generosità e religiosità, confessò una sera che avrebbe fatto a meno
di tante cose nella sua vita familiare, ma non dell’abitudine a chiedersi scusa e a perdonarsi reciprocamente.
personali. Quando ferisco una per-sona con le mie parole o con il miocomportamento, costruisco una bar-riera tra lei e me. Se non imparo achiedere scusa, la barriera rimane eil mio rapporto con lei è incrinato.Parole o azioni offensive allontana-no le persone e, in assenza di unarichiesta di scuse, esse continueran-no ad allontanarsi. Il bambino chenon impara questa realtà alla fine siritroverà isolato e solo.
� Tutto questo può essere riassun-to in una specie di scaletta a cinquegradini, che per i più piccoli puòessere quasi un gioco: 1. Esprimererammarico: «Mi dispiace»; 2. Assu-mersi le proprie responsabilità: «Hosbagliato»; 3. Cercare di rimediare:«Che cosa posso fare per ripara-re?»; 4. Impegnarsi per il futuro:«Cercherò di non farlo più»; 5.Chiedere scusa: «Mi perdoni?». L’o-biettivo è che i bambini acquisisca-no una specie di “mentalità del per-dono”. Il livello di capacità in questosenso dovrebbe crescere con l’etàed è molto simile al processo diapprendimento di una lingua. Inogni caso, il metodo più efficace perinsegnare ai bambini più grandi aparlare i linguaggi del perdono è l’e-sempio. Quando i genitori chiedonoscusa ai figli per parole dure o untrattamento ingiusto, offrono l’inse-gnamento più efficace. I bambinipiccoli fanno quello che dicono igenitori; i figli più grandi fanno ciòche fanno i genitori. Se i genitoriimparano a chiedere scusa unoall’altra, ai loro figli e ad altre perso-ne, allora anche i figli imparerannoa parlare i linguaggi del perdono. �
Ci vuole un allenamento costante a chiedere scusa.
Fabi
ana
Di B
ello
Fabi
ana
Di B
ello
Quando ferisco una persona con le mie parole o con il mio comportamento, costruisco una barriera tra lei e me.
36
MARZO 2008 BS
senta una riconciliazione, si coltiva-no pericolose illusioni: le cose nonpossono mai tornare a posto auto-maticamente e indipendentementeda noi e dalla nostra disponibilità adascoltare e a esprimere quel cheproviamo davvero.� La seconda è che occorre unapazienza intelligente per trasforma-re un muro in un ponte e senza ilperdono questo miracolo non puòrealizzarsi; le pietre che butti giù,se non hai nella mente e nel cuoreun progetto diverso per riutilizzarle,diventano solo un cumulo di mace-rie. Chiedere scusa è l’unico modoper rimettere ordine nelle relazioniaffettive, per dare loro un orienta-mento positivo, per comprenderecome certi materiali grezzi (e ognipersona lo è, soprattutto quando èacerba negli anni o nel suo proces-so di maturazione) possono diven-tare risorse preziose per costruire econdividere un’identità e una storia.� La terza può sembrare la più ov-via, ma non lo è affatto: le situazioniproblematiche devono essere af-frontate tempestivamente, così chenon imbocchino strade tortuoseche potrebbero rendere molto labo-riosa l’esperienza del perdono. So-prattutto nei confronti dei figli, biso-gna sforzarsi continuamente dimettere in sintonia educazione eprevenzione: questa sollecitudine(che è fatta di parole, ma soprattut-to di esempi, di presenze rassicu-ranti, di compagnie corroboranti)può consolidare il patrimonio deivalori familiari che fondano la realtàpersonale e far sì che le riconcilia-zioni quotidiane riguardino questio-ni che non determinano ferite incu-rabili. Quest’ultima considerazionemi spinge a dire una cosa che for-se non tutti condivideranno: è beneche in famiglia ci si abitui a chiede-re scusa, perché il perdono è un in-dicatore importante per compren-dere quanto teniamo alle personeche amiamo; non mi piacerebbeperò che questa esperienza venis-se continuamente riproposta, per-ché potrebbe mascherare una so-stanziale mancanza di orientamentietici e culturali validi; quando fareerrori diventa un’esperienza ricor-rente, temo che il ricorso alla ricon-ciliazione possa non costituire unamisura idonea a tamponare unadiffusa crisi di senso. �
L’artista frequenta l’istitutosalesiano “Ranchibile” diPalermo, dove consegue lamaturità classica e dove
sviluppa uno spiccato interesse peri soggetti a carattere sacro checostituiranno in seguito l’aspettoprevalente della sua poetica pittori-ca. Ha solo nove anni, quandodipinge a olio su un foglio ruvido ilritratto di Don Bosco. Piace ai sale-siani che lo premiano. Incoraggiatoanche da questo successo, si dedicacon impegno allo studio dei grandidella pittura e a dipingere cercandodi acquisire uno stile personale eautonomo. Ma non trascura, anzicura con intelligenza il confrontocon amici artisti. Tra essi GaetanoCorrenti che diventerà suo preziosoconsigliere.
>> È proprio il professor Corren-ti che inizia l’artista alla tecnica del“dipinto alla rovescia”, su vetro. Sitratta di una tecnica particolarmen-te complessa, utilizzata principal-mente verso la metà del XVII sec.da maestri pittori soprattutto inGermania, Inghilterra, Romania edaltri Paesi. Tale tecnica prevede chevenga dipinto per primo ciò che inaltre tecniche viene invece dipintoper ultimo in una continua e sa-
piente sovrapposizione di coloriche conduce a un risultato sorpren-dente, capace di sedurre e conqui-stare. La pittura viene realizzata suun solo lato del vetro, ma è soltan-to dal lato opposto che sarà possi-bile ammirare l’opera finita.
>> La tecnica della “pittura allarovescia” appassiona l’artista paler-mitano, a tal punto che egli decidedi dedicarvisi con tutto se stesso,pur senza trascurare la pittura tradi-zionale a olio. Oltre che soggettireligiosi, Perrino raffigura con mae-stria, su vetro, nature morte, paesag-gi agresti, ecc. che si impongonoper la nitidezza del tratto e la viva-cità dei colori. Le sue opere si carat-terizzano anche per la compiutezzae la precisione che risulta dall’insie-me. Anche il Cristo che presentiamoè stato eseguito con la tecnica deldipinto a rovescio. Un Cristo decisoma sofferente, lo sguardo perduto, ilvolto emaciato eppure nobile. Ilsontuoso drappeggio e il curatissimoricamo del vestito sembrano volerraccogliere tutto ciò che esiste nelmondo: il bene per espanderlo e ilmale per redimerlo. Le nubi, minac-ciose sulla destra sembrano schiarir-si a sinistra: un segno di speranzaper l’umanità. �
Aurelio Perrino nasce a Palermo nel 1948. Ha sempre avuto un profondo interesse per la pittura che non ha mai smesso di coltivare. Una delle opere più note dell’artista è il dipinto su muro nella cappella della Madonna del Carmelo all’internodella chiesa del Carmine Maggiore.
ARTE SACRA: CROCIFISSIdi Filippo [email protected]
AURELIO PERRINOLA PITTURA ALLA ROVESCIA
AFORISMI di Francesco Ferrara1) Molti non si sono accorti di essere nati.2) L’uomo saggio non sa di esserlo.
LAETAREET BENEFACERE…
37
BS MARZO 2008
Quotidiani e riviste,radio e TV sembrano ingara per le notizie piùferali. Una tragica garaal tragico, altruculento, allo scoopsanguinolento. È ora di cambiare strategia.Vogliamo in primapagina le BN – BuoneNotizie.
Guardando i notiziari tele-visivi, nazionali o locali,e leggendo i giornali ilprimo servizio e le prime
pagine portano sempre brutte noti-zie: omicidi, scandali, insulti in pub-blico di personaggi politici o dellospettacolo, polemiche, ecc. Sonoproprio queste le notizie che voglia-mo sentire sin dall’inizio dei giorna-li, sin dall’apertura? Tutti lamentia-mo questa consuetudine, ma ci ritro-
38
NON SE NE PUÒ PIÙ! DOVE SONO LE BN?di Giovanni Russo [email protected]
F I D E E T I C H Eper ragazzi, genitori, educatoriS
viamo sempre trattati allostesso modo. Quali sono leconseguenze per noi, per ilnostro buon umore, all’ini-zio o dopo una giornata dilavoro? Che cosa rimanedentro di noi di queste noti-zie, che influenza negativapossono esercitare questecontinue nebbie o temporalinella vita degli ascoltatori edella società in genere? Sepoi pensiamo ai nostri ragaz-zi, che impressione si fannodella vita, come crescono? In-somma, forse è il tempo di di-re “basta!”. Forse bisognereb-be operare una sorta di “scio-pero”: spegnere la tv, chiudereil giornale o non comprarlo af-fatto per un periodo, come se-gnale “profetico” agli operato-
ri. Certamente, le associazioni deiconsumatori qualcosa possono fare.
LE BN FANNO BENEAbbiamo bisogno di “buone no-
tizie”, non di quelle che tranquil-lizzano a buon mercato, ma diquelle vere, che nascono dalla ge-nerosità delle persone, dei bambi-ni, degli anziani, delle persone cheseppur in difficoltà sono segni disperanza, di quanti offrono belletestimonianze di altruismo, di soli-darietà e, in particolare in una so-cietà come la nostra, di persone
◗ Sempre brutte notizie: omicidi, scan-dali, insulti di personaggi politici odello spettacolo …
◗ I nostri ragazzi si fanno un’immagi-ne negativa della vita.
◗ Abbiamo bisogno di “buone notizie”,di quelle vere che nascono dalla ge-nerosità delle persone.
◗ Gesù è stato profeta positivo, ha an-nunciato la “buona notizia” per la vi-ta di ogni uomo.
VALORI in questione
In un mondo abituato a notizie di ogni genere e specie dalla globalizzazione mediatica, il misterioso, l’ambiguo, il torbido, il losco, il turpe, l’indegno conquistano i primi posti, perché solleticano il lato più oscurodella psiche umana.
Non di rado più una notizia è “truculenta” più le è concesso spazio dai media.
39
BS MARZO 2008
che donarsi agli altri dà tanta gioia achi dona. Anche la massima espres-sione del sacrificio, la sua morte incroce, è motivo di speranza, perchéè resa gloriosa dal segno e dalla lu-ce della risurrezione.
SPRINT DELLA BNInvitiamo i lettori a inviare ai di-
rettori delle principali testate gior-nalistiche televisive o di giornali(gli indirizzi si trovano facilmentesu Internet) una scheda simile a
capaci di perdono. Aprire un gior-nale, accendere la radio, iniziareun telegiornale con una notizia diquesto genere apre al futuro, spin-ge a fare lo stesso, incoraggiaquanti sono titubanti o incerti nelperdonare o nell’essere generosi.L’etica della buona notizia è l’eti-ca come segno di contraddizionein una cultura di profeti di sventu-ra, sempre a lamentarsi e a guarda-re cose nere. Invece, è splendidovedere, sentire o leggere notizie dipersone che sanno aiutare, di ini-ziative a favore di soggetti vulne-rabili, di amore per la natura el’ambiente, di umanità nei con-fronti degli animali, di piccoli geniche fanno crescere il mondo, dinonni e nipoti in perfetta integra-zione intergenerazionale, di segnipositivi lanciati a chi si meritavaumanamente parlando tutt’altro.
LA NOTIZIA PIÙ BELLAGesù, che era un eccellente comu-
nicatore, è stato profeta positivo(pur segnalando le negatività, nellasua diatriba con scribi e farisei), haannunciato la Buona Novella, per-ché lui stesso è la “buona notizia”per la vita di ogni uomo. Cristo èsegno di speranza, buona notizia perogni uomo che entra in contatto conil suo messaggio. È il segno che lavita è bella, che l’opera del Creatoreè meravigliosa, che perdonare èfonte di pace dentro e fuori di noi,
quella presentata nel riquadro diquesto articolo per dire che siamostanchi solo di notizie negative eche ci piacerebbe riconoscere diret-tori che impaginano i notiziari del-le rispettive testate con uno sguar-do positivo, perché non possonofarci credere che il mondo sia soloquello che ci presentano. Ci faccia-no vedere anche l’altra faccia diquesto nostro mondo, che esiste nesiamo certi, almeno per ragioni di“pari opportunità”, tra il bello e ilbrutto della vita. �
in Gruppo e in Famiglia◗ Condividi che i notiziari segnalano
quasi esclusivamente brutte notizie?◗ Che cosa rimane dentro di noi di
queste notizie negative?◗ La buona notizia può spingere a fa-
re altrettanto bene?◗ Che ne pensi di una sorta di “scio-
pero”: spegnere la tv, chiudere ilgiornale?
CONFRONTIAMOCI
Non solo i quotidiani, ma anche la stampa periodica, la tv, la Radio indulgono a notizie di cronaca nera anche in prima pagina.
S P R I N T D E L L A B E L L A N O T I Z I A
Al Direttore del
– quotidiano .................................................
– telegiornale .................................................
– radiogiornale .................................................
Caro Direttore,Le chiedo di mettere sovente la bella notizia in prima pagina. I giovani, lafamiglia, la società hanno bisogno certamente di sentire – oltre alle notiziedi omicidi, scandali, catastrofi, insulti di personaggi politici o dello spettacolo– anche notizie circa la generosità delle persone, dei bambini, degli anzia-ni, delle persone che seppur in difficoltà sono segni di speranza, di quantioffrono belle testimonianze di altruismo, di solidarietà, di perdono, di amoreper la natura e l’ambiente, di umanità nei confronti degli animali, di piccoligeni che fanno crescere il mondo, di nonni e nipoti in perfetta integrazioneintergenerazionale.La ringrazio sin d’ora per gli sforzi che mostrerà.
Cordiali salutiFirma
....................................................
La Giornata Mondialedell’Acqua si celebra il 22 marzo 2008 per la quinta volta. Far frontealla penuria di acqua è diventata ormaiun’emergenza. DiceBenedetto XV: “Il dirittoall’acqua si basa sulladignità umana”.
no, con un uomo che vola nel cielostellato alla ricerca dell’acqua.
Lo stress idrico avviene, secondol’ONU, se la disponibilità d’acqua èinferiore a 1500 metri cubi annui. Sistima che il minimo vitale a personasiano 50 litri di acqua al giorno, ne-cessari per i bisogni primari comebere, cucinare, lavarsi. Ma nel mon-do una persona su sei non ha acces-so a questa quantità. L’acqua è unodegli elementi che maggiormentesubiscono il cambio climatico: ladiminuzione delle precipitazioni fa-vorisce i processi di desertificazio-ne, con conseguente diminuzionedella portata dei fiumi e delle riser-ve di acqua potabile.
>> La “questione dell’acqua” staemergendo a livello mondiale comeil più difficile problema da risolvere.Tra poco la prima causa di guerrasarà il possesso di questa fonte di vi-ta. Ma la questione appare quasi inso-lubile se dipendente dall’effetto serra,principale imputato della penuriad’acqua. Il messaggio di BenedettoXVI per il 22 marzo 2008 afferma:l’acqua, bene comune della famiglia
umana, costituisce un elemento es-senziale per la vita; la gestione diquesta preziosa risorsa deve esseretale da permetterne l’accesso a tutti,soprattutto ai poveri, garantendo lavivibilità del pianeta sia della presen-te sia delle future generazioni. E suiprincipi di sussidiarietà, solidarietà eresponsabilità conclude: “In tale dire-zione, la gestione sostenibile dell’ac-qua diviene una sfida socio-economi-ca, ambientale ed etica, tale da coin-volgere non solo le istituzioni, ma lasocietà intera.”
>> “L’acqua salverà l’Africa”,ha gridato al XXVII festival delCinema Africano a Verona padreAlex Zanotelli, denunciando la ven-dita di armi. Il costo di un aereopuò salvare la vita all’intera popo-lazione di un villaggio. Il 22 marzosollecita la responsabilità dei go-vernanti, ma interpella ogni perso-na. Nella Bibbia, l’acqua è simboli-camente fonte e segno di vita, asso-ciata spesso alla gioia e alla ferti-lità, assumendo anche un ruolo dipurificazione e di rinascita. �
40
I l 22 marzo è il giorno in cui, ognianno, l’Onu ci ricorda che l’ac-qua è “elemento prezioso e vitaleda garantire a tutti i cittadini del
pianeta e da rispettare attraverso unuso sostenibile dell’ambiente”. Nu-merosi eventi proporranno la “que-stione dell’acqua” come prioritariaper il continente nero. All’ultimaBiennale d’Arte di Venezia, ha colpi-to la grande tela di un pittore africa-
I BAT T I T IGiornate MondialiD
LA GRANDE SETEdi Severino Cagnin
MARZO 2008 BS
� 41“immatura” da smarrirsi di fron-te al manifestarsi di segni che ri-mandano con evidenza a unaPresenza Suprema. Il linguaggio,a tratti forse un po’ troppo auli-co ed evocativo, è soccorso dauna melodia dal sapore arcaicoche scorre fluida e gioiosa inbuona simbiosi con le parole e
ne mette in luce la sacra-lità. Anche l’arrangiamento,nonostante la cura estremacon cui è realizzato, risulta effi-cace soprattutto perché nonprevale sul canto ma anzi lo va-lorizza fungendo da valido so-stegno su cui esso si staglia.L’intensa interpretazione e lasuggestione degli interventi co-rali fanno il resto.
>> Le parole, così trasfiguratedalla musica, alla fine danno l’i-dea di un’invocazione sincera esentita. E non è banale scoprirecome questo cammino di ricercaconduca sì alla propria essenzainteriore, ma anche e inevitabil-mente a Dio. �
Il recupero e lare-interpetazionedella musica tra-
dizionale e popo-lare è ormai praticacomune: produzio-ni in tal senso pro-vengono da ogniparte dello Stivalee costituiscono unadi quelle famose“nicchie” che tengono vivo ilmercato musicale e discografico.I TAZENDA sono stati tra i primisia a intraprendere questa strada(il loro primo disco è del 1988)sia a ottenere riconoscimenti tracritica e pubblico: Spunta la lunadal monte, presentata insieme aPierangelo Bertoli al Festival diSanremo, è del 1991; Pitzinnos insa gherra (anch’essa in gara aSanremo) e del 1992. Il loro stile,dopo quasi vent’anni, non ha su-bito mutamenti rispetto agli esor-di: la vocalità della tradizionemusicale sarda e l’uso di qualchestrumento tipico sono coniugatiabilmente con confezione ed ar-rangiamenti contemporanei. An-che nel recente album Vida è pa-lese la continuità stilistica edespressiva tra “vecchi successi”(inseriti in omaggio ad AndreaParodi, tra i fondatori e storicavoce solista del gruppo, prematu-ramente scomparso) e nuove can-zoni interpretate dall’attuale vo-calist Giuseppe Dettori.
>> Tra i brani colpisce La ricer-ca di Te, nel cui testo emerge lanecessità di non fidarsi troppodella nostra ragione ancora così
LA RICERCA DI TEdi Lorenzo Angelini
NOTE
SULLE NOTE
� La ragione e il pensiero, qualche volta, diventano limiti al desiderio mistico di unirsi al Divino.�A Teche accogli il mio canto insicuro / dolcele sere di quieteMuto nella notte dell’inconscio / il mioprofondo essere obbedisce A TeChe cogli il mio frutto immaturo / acerbaè la mia ragioneTrema al primo sibilo di vento / E cadenell’oblio del non ricordo di Te
Portami oltre il pensiero / aldilà del mi-steroAiuta la mia Essenza a andare via daogni ideaInvitami ogni giorno alla ricerca di meLa ricerca di Te
Io e Te Tra galassie e foreste / uccelli alla bru-ma dell’alba
I pesci negli abissi degli oceani / io pen-so con pensiero d’un bambino A TeCon quelli che sanno ascoltarTi / conquelli che sanno vederTi Con tutte le creature della luce / accen-do la scintilla nella notteCon Te
Portami oltre il pensiero / aldilà del mi-steroAiuta la mia Essenza a andare via daogni ideaInvitami ogni giorno alla ricerca di meLa ricerca di TePrendi i miei pensieri / guidami nei mi-steriPrendi anche il mio spirito / e quandovedi che mi cercoSto cercando TeLa ricerca di Te
LA RICERCA DI TE di Luigi Marielli - Giuseppe Dettori - Luigi Camedda
��
BS MARZO 2008
MARZO 2008 BS
I NOSTRI MORTIPER SOSTENERELE OPERE SALESIANE
Notifichiamo che la DirezioneGenerale Opere Don Bosco consede in Roma, riconosciuta conD.P.R. 2-9-71 n. 959, e l’Istitu-to Salesiano per le Missionicon sede in Torino, avente per-sonalità giuridica per Regio De-creto 13-1-1924 n. 22, possonoricevere Legati ed Eredità. Queste le formule:
se si tratta di un Legatoa) di beni mobili“… Lascio alla Direzione Ge-nerale Opere Don Bosco, consede in Roma (o all’Istituto Sa-lesiano per le Missioni, con sedein Torino) a titolo di legato lasomma di € … o titoli, ecc. peri fini istituzionali dell’Ente”.
b) di beni immobili“… Lascio alla Direzione Ge-nerale Opere Don Bosco, consede in Roma (o all’Istituto Sa-lesiano per le Missioni, con sedein Torino) l’immobile sito in…per i fini istituzionali dell’Ente”.
Se si tratta invece di nominareerede di ogni sostanza l’uno ol’altro dei due enti sopraindicati“… Annullo ogni mia prece-dente disposizione testamenta-ria. Nomino mio erede univer-sale la Direzione Generale Ope-re Don Bosco, con sede in Ro-ma (o l’Istituto Salesiano per leMissioni, con sede in Torino)lasciando ad esso quanto mi ap-partiene a qualsiasi titolo, per ifini istituzionali dell’Ente”. (Luogo e data) (firma per disteso)
NB. Il testamento deve essere scritto perintero di mano propria dal testatore.
INDIRIZZIDirezione Generale Opere Don BoscoVia della Pisana, 111100163 Roma-BravettaTel. 06.65612678 – Fax 06.65612679C.C.P. 462002
Istituto Salesiano per le MissioniVia Maria Ausiliatrice, 32 10152 TorinoTel. 011.5224247-8 – Fax 011.5224760C.C.P. 28904100
LA ROSA sig. Gianfranco,salesiano cooperatore,✝ Catania, il 24/11/2007, a 48 anni
Gianfranco La Rosa, papà di tre figli, è tor-nato alla casa del Padre ancora giovane enel pieno della maturità umana, spirituale eprofessionale. Da salesiano cooperatoreha impegnato tutta la vita per i giovani ecoinvolto famiglia e amici. Lascia un’ere-dità spirituale fatta di lavoro vissuto comemissione nella formazione professionale enell’educazione dei giovani più svantaggia-ti. Non prescindeva mai dalla relazioneeducativa. Il lavoro con e per i giovani èstato un donarsi totalmente per la loro sa-nità morale e un inserimento dignitoso nel-la società. Nel silenzio e nell’umiltà, affida-va ogni istante a Dio, parlava a Lui dei suoicari – come si legge nei suoi diari; un dia-logo che – ci piace pensare – è stato tal-mente gradito a Dio che non ha potuto farea meno di chiamarlo accanto! E quanto sipotrebbe dire sul suo impegno per la pro-mozione della famiglia, il sostegno con lamoglie alle giovani coppie, il suo esserestato modello per diversi che oggi sono mi-nistri di Dio. Lo ricordano così i suoi giova-ni: I l mondo piange la scomparsa digente che cambia la storia negli atti dellaquotidianità; il cielo ne guadagna in splen-dore e luminosità! Non guardiamo mai ab-bastanza il cielo azzurro, che peccato!Uno sguardo attento potrebbe cogliervi leanime del paradiso strette in ungrande abbraccio e tra queste oggi anchetu. (M. Pappalardo)
IOFRIDA sac. Leone, salesiano,✝ Vibo Valentia, l’11/08/2007, a 69 anni
Don Leo ha incarnato il carisma di Don Bo-sco operando per oltre 35 anni nella scuo-la, apprezzato sia come docente, sia comeeducatore, sia come sacerdote. Cultural-mente e teologicamente preparato, ha ge-nerosamente messo a disposizione di tutti,adulti e ragazzi, le sue qualità, con un ap-proccio improntato sempre al massimo ri-spetto verso qualunque interlocutore. Èstato un ascoltato predicatore, un preziosoconsigliere e un valente direttore spirituale.Le persone che lo cercavano sempre piùnumerose hanno trovato in lui un sacerdo-te saggio, equilibrato, impegnato e coeren-te, ma anche un uomo dal coraggio ada-mantino, pronto al dialogo con tutti, cre-denti o no, praticanti o meno. Un infartodevastante ha interrotto la sua attività sa-cerdotale e la sua vita. Non sarà facilmen-te dimenticato.
CAPORRO sig.ra Pierina,cooperatrice salesiana, ✝ Lanuvio (RM), il 04/04/2007, a 84 anni
La signora Pierina è stata una di quellepersone come ce ne sono poche: in cimaai suoi pensieri e alle sue preoccupazioninon c’era se stessa, c’erano invece gli altri.Si è divisa tra il lavoro e i suoi doveri dimoglie, madre, zia e infine nonna, sempreuguale a se stessa, sempre pronta a ognichiamata di chi aveva bisogno di lei. Cometutti anche lei ha passato giorni senza sole,momenti difficili in cui le è stata matrigna.Ha saputo accettare, lottare e superare gliostacoli con determinazione e confidando
nell’aiuto di Dio, che non le è mai mancato.Ai suoi figli e ai nipoti non ha mai cessatodi essere un esempio di saggezza, di one-stà, di cristiana carità, trasmettendo loro ivalori perenni in cui sempre aveva credutoe sempre vissuto.
COLOMBO don Pierino, salesiano,† Milano, il 12/12/2000, a 79 anni
Nell’anniversario della sua ordinazione sa-cerdotale che avvenne il 1° marzo del1947, exallievi, amici e scout vogliono ri-cordare don Pierino Colombo del quale asuo tempo non fu scritto il profilo su questecolonne. Don Pierino fu un salesiano distraordinarie capacità intellettuali, culturali,religiose e sacerdotali. “Signorile e amabilenel tratto”, “ricco di umanità”, “attento allepersone”, “fedele nelle amicizie”, “scrupo-loso nei doveri”, “delicato e sensibile contutti”, “esigente a scuola”, “profondo nellapredicazione”, “ispirato nel ministero dellaconfessione”... Sono alcuni dei giudizi checonfratelli, ex/alunni e scout - dei quali fuassistente nel Reparto Parma 5 - hannoscritto di lui. Questi ultimi aggiungono conriconoscenza e ammirazione: “Quandoavevi bisogno, lui c’era, ma senza essereinvadente. Ascoltava, poi suggeriva con di-screzione”. Un gesto di attenzione lo face-va gioire, la sciatteria, la superficialità, lascarsa sensibilità lo facevano soffrire. Sa-peva costruire legami solidi e duraturi distima con tutti coloro con i quali veniva acontatto. A otto anni dalla morte egli è an-cora vico nel ricordo e nell’affetto.
CORBÒ sr. Anna Maria, Figlia di Maria Ausiliatrice,✝ Roma, il 22/10/2007, a 80 anni
Suor Anna Maria era nata ad Alessandriad’Egitto. Laureata in Filosofia e poi in Peda-gogia svolse diversi compiti d’insegnamento.Coodinatrice del gruppo di redazione dei te-sti scolastici in collaborazione con don LuigiCalonghi, sdb. La tenacia unita al massimoimpegno le hanno fatto superare le difficoltàinerenti a un lavoro che richiedeva respon-sabilità e forte sensibilità educativa. Spirito dipreghiera e di servizio hanno caratterizzatole sue relazioni con le sorelle che la ricorda-no molto anche per la sua presenza in ri-creazione ricca di iniziative salesiane.
42
“Reciso in terra
torna a fiorire
nel giardino di Dio”
Agne
se G
aspa
rotto
IL BESTIARIO DELLA BIBBIAVOLPI DI SANSONE La volpe è il carnivoro selvaticopiù diffuso. Per la scaltrezza conla quale si procura il cibo, dasempre è simbolo di astuzia,simulazione e persino di eresie.Basti ricordare le favole di Eso-po, il “Purgatorio” dantesco (c.XXXII), “Pinocchio” di Collodi,oppure espressioni come “è unavecchia volpe”, “far come la vol-pe con l’uva”, ecc. A quest’ulti-mo contesto, curiosamente, fan-no riferimento due delle pochecitazioni bibliche: “Prendeteci levolpi… che guastano le vigne”(Ct 2,15). L’animale è ancheprotagonista di una scaltra rea-zione di Sansone quando, cattu-rate trecento volpi, le legò codaa coda e vi mise una fiaccola.Accese poi le fiaccole, lasciòandare le volpi per i campi digrano dei Filistei e bruciò i covo-ni ammassati, il grano, le vigne,gli oliveti (Gdc 15,4-5). Più notaè la risposta data da Gesù a unoscriba: “Le volpi hanno le lorotane… ma il Figlio dell’uomo nonha dove posare il capo” (Mt 8,20e Lc 9,58).
LA NOSTRA PATRIA EUROPA• 1° marzo 1998: in vigore l’ac-
cordo di partenariato e di coo-perazione con l’Ucrai-
na, e di asso-ciazione traUE e Tunisia.• 5 marzo1959: la Bei-Banca euro-
pea concede i primi prestiti.• 10 marzo 2006: documen-
to tra UE e Russia per la coope-razione nello spazio.• 11 marzo 2005: primo anniver-sario dell’attentato terrorista aMadrid (192 morti). • 13 marzo 1979: in vigore loSme (Sistema monetario euro-peo).• 14 marzo 2003: Patto di Sicu-rezza UE e Nato.• 16 marzo 1979: muore JeanMonnet, uno dei “padri” dell’UE. • 17 marzo 1948: Belgio, Francia,Lussemburgo, Paesi Bassi eRegno Unito firmano il Trattatodell’Unione occidentale.• 19 marzo 1958: Robert Schu-man è eletto presidente della nuo-va Assemblea parlamentare.• 20 e 21 marzo 1955: firma delPatto di stabilità per l’Europa cen-trale e orientale.• 24 marzo 1999: il Consiglioeuropeo adotta una dichiarazionesulla nomina di Romano Prodi anuovo presidente della Commis-sione europea.• 25 marzo 1957: i trattati istitutividella Comunità economica euro-pea (Cee) e della Comunità euro-pea per l’energia atomica (Eura-tom) sono firmati da Belgio, Fran-cia, Germania, Italia, Lussembur-go, Paesi Bassi a Roma. • 26 marzo1995: entra in vigore l’“accordo diSchengen” tra Belgio, Francia,Germania, Lussemburgo, PaesiBassi, Portogallo e Spagna.2002: è varato “Galileo”, il siste-ma europeo di navigazione e diposizionamento satellitare.• 27-30 marzo 1962: l’Assembleaparlamentare rielegge presidenteGaetano Martino e cambia il pro-prio nome in Parlamento europeo.• 28 marzo 1977: il Portogallopresenta la domanda di adesionealle Comunità europee.
• 29-30 marzo 1985: a Bruxelles,il Consiglio europeo accetta l’ade-sione della Spagna e del Porto-gallo.• 30 marzo 1994: si concludono inegoziati di adesione con l’Au-stria, la Svezia, la Finlandia e laNorvegia.• 31 marzo 1994: l’Ungheria pre-senta domanda di adesione all’U-nione.
LE MONETE AI TEMPI DI GESÙ
PRUTAH o LEPTONSi chiamava “prutah” in ebraico o“lepton” (cioè sottile) in greco lapiù piccola moneta in circolazioneall’epoca di Gesù. Bronzea e d’u-so quotidiano, è menzionata nellaBibbia come “spicciolo” nell’episo-dio della vedova che nel tesorodel Tempio getta appunto “duespiccioli, cioè un quattrino” (Mc12,42). Le prutah furono coniate,tra l’altro, da Erode (prive di raffi-gurazioni di persone o di animali,offensive agli occhi degli ebrei),da Filippo che riprodusse leimmagini di Augusto e di Tiberioe da Ponzio Pilato. Trattandosi dimoneta coloniale romana, vi com-paiono simboli pagani, come ilsimpulum, la coppa sacrificale,oppure il lituus, il bastone ricurvodell’augure, e attorno la scritta “diTiberio Cesare”. Sugli occhi del-l’Uomo della Sindone compaionodue figure rotonde, che alcunistudiosi hanno identificato comeprutah di Pilato: sarebbero un’ul-teriore prova della concordanzadel lenzuolo con l’epoca dellamorte di Gesù.
IL MESEIL MESE
43
Savina Jemina
BS MARZO 2008
Marzo
LETTERADI UN NONNO
Ecco una lettera piena di saggezza, scritta dal nonno alla nipote che iniziava il liceo in una scuola salesiana. L’ha intestata: “Lettera del nonno alla nipote
troppo assorbita da pianoforte, canto, canoa, danza, sci, karate… e ancora latino, greco, internet, ecc.”.
44
MARZO 2008 BS
P RIMA PAGINA Oreste Steccanella
C arissima,non so esprimerti la gioia che ho provatoappena ho saputo che ti sei iscritta al Liceo
Classico Salesiano Astori di Mogliano Veneto. Latua non è stata solo una scelta saggia ma anchecoraggiosa nel prediligere una scuola di indirizzoumanistico in luogo di quello scientifico. Inopina-tamente, sei venuta a far parte della Famiglia Sale-siana, così come ne faccio parte io e ne fece partemio padre che era stato nel collegio a Veronaassieme a don Renato Ziggiotti, V successore diDon Bosco nel 1915. Entrare nella Famiglia Sale-siana vuol dire entrare in un mondo completamen-te diverso dagli altri ed è, in qualche modo, come“immunizzarsi” contro le insidie della vita e con-temporaneamente beneficiare della protezione,estesa anche a più generazioni così come è statopromesso dalla Madonna a Don Bosco.
>> Non pensare di trovare il paradiso terrestre per-ché, qui in terra, come dice san Matteo: “Non estdie sine linea” (Mt 7,6) cioè non c’è giorno chenon lasci il suo segno, sia nel bene sia nel male.Anche lì troverai persone più o meno brave, più omeno simpatiche, ma convinte di dover attuareuna attenta presenza educativa e talune sostenutedalla “Sapientia cordis” di Don Bosco. Nello spiri-to di don Tassello (mio insegnante a Pordenonedeceduto anni fa all’Astori) s’incise la definizioneche don Ziggiotti formulò secondo un suo caratte-ristico modo di agire e pensare: “Un salesiano:come lo facciamo? Viso allegro e cuore in mano /ecco fatto il salesiano”. Don Bosco amava i giova-ni e non ha mai e mai e mai pensato a se stesso,ma ha sempre e sempre pensato agli altri; ed èproprio dalla generosità profusa verso il prossimoche sapeva cogliere la forza e il coraggio di affron-tare gli avversari e sfuggire agli agguati, talora aiu-tato dalla Provvidenza a mezzo anche del leggen-dario cane “Grigio”!
>> In questo nuovo ambiente troverai più serenitàe l’obiettività di riflettere e discernere il bene dalmale e di chiederti perché il mondo vada cosìmale. Vedrai allora che la risposta ti diventeràspontanea: il mondo va male perché l’uomo si èdimenticato del Signore e ha pure dimenticato loscopo per cui siamo stati creati. Poi c’è il prossimoche dobbiamo rispettare e l’obbligo di tenere com-portamenti idonei a tutelare il “neminen laedere”:non bisogna mai e mai danneggiare gli altri. Spes-so le parole dette agiscono come l’eco che amplifi-ca in intensità e profondità quanto viene detto!Quindi, non bisogna mai parlare male di nessuno.Nell’ultima mia intervista a SKY TV mi fecero unadomanda improvvisa e inaspettata: “Lei che è uncommercialista mi sa dire qual è la qualità princi-pale che deve avere un imprenditore?”. Mi sentiispiazzato e non trovai di meglio che narrare […]ciò che ho cercato di seguire anche nella mia atti-vità professionale. “La prima regola per un impren-ditore è quella di essere onesto! Ti dirò di più, perme essere stato onesto è stata la mia fortuna!”.
>> A noi vecchi piacciono le reminiscenze! Ricor-do che durante la guerra mancavano il cibo e ivestiti (non c’era né Armani né Pierre Cardin, né latelevisione, il computer, internet o altre attrazionifuorvianti) eppure in quella situazione di precarietàc’erano concordia, serenità e solidarietà e non esi-stevano cattiverie. Passavamo intere serate a gioca-re a carte, a pregare, ad ascoltare la radio! Perchéscrivo questa lettera? Per prevenirti (lo impareraidai salesiani il sistema preventivo) perché vedo cheil maligno sta avanzando di giorno in giorno conazioni diffuse e generalizzate. Ti prego, dunque,cara nipote, in considerazione di tutti i consigli diquesta lettera, di contribuire positivamente a salva-guardare la dimensione sacra della dignità umana.
Treviso 9 novembre 2007Il nonno
Fabi
ana
Di B
ello
A CINQUE MESI DI GESTAZIONE
Nel marzo 2005, a quasi cinquemesi di gestazione, ho perso ilbimbo che portavo in gremboper una trombosi. Io e mio mari-to abbiamo sofferto molto per-ché, sposati da poco, ci sem-brava sfumato il nostro grandedesiderio di famiglia. Per fortunaho incontrato un’équipe straordi-naria di dottori che mi assicura-vano la possibilità di altre gravi-danze. Rassicurata da loro, asoli sei mesi dalla perdita, rima-si nuovamente incinta. Una do-menica, dopo la consueta santaMessa, mia mamma mi confidòche il suo confessore le avevadetto di affidarmi a san Dome-nico Savio, il santo delle mam-me in attesa. Non conoscendoquesto santo, mi sono interes-sata alla sua vita e mi sono fattaarrivare a casa l’abitino. Lo misisubito al collo. Ogni sera legge-vo parti di preghiere suggeritealle mamme in attesa. Dopomesi di controlli e molte ansie, il27 maggio 2006 potei partorireGiorgia. Ora l’abitino è sulla suaculla. Quando sarà in grado dicapire, le racconterò quanto èstato determinante per la sua vi-ta questo santo. Ora desideria-mo un altro bambino: io conti-nuo ad affidarmi a san Domeni-co Savio, poiché dal giorno incui l ’ho conosciuto non hosmesso di pregarlo.
Sala Laura, Abbiategrasso (MI)
SOGNO SVANITOSiamo una giovane coppia. Findalla data del nostro matrimonioil nostro sogno è sempre statoquello di avere un figlio. Tra-scorsi pochi mesi, il sogno stavaper realizzarsi, ma tutto svanìdopo poche settimane, a causadi un aborto spontaneo. Il doloreè stato forte, ma non abbiamoperso la speranza. Esattamenteun anno dopo, è avvenuta unanuova gravidanza. Come dopola prima, però, sopravvenne unaborto spontaneo. Al dolore siaggiunse la paura di affrontarenuovamente la gravidanza. Taleangoscia ci accompagnò per
ben due anni, fino alla Pasquadel 2006, quando provammo unbarlume di speranza. Ma prestoprese il sopravvento la paura,quando, a poche settimane dal-la gravidanza, una prima minac-cia di aborto, seguita da tantealtre, mi costrinse a letto. Que-sta volta, superati i tre mesi, tut-to pareva andare per il meglio.Ma sopraggiunse una fortissimaemorragia che ci fece ripiomba-re nella paura. Trascorsi la gra-vidanza con grosse difficoltà, te-nendomi a riposo per sette me-si. Poi la situazione migliorò de-cisamente, finché l’11 dicembre,con nostra grandissima gioia esorpresa, è nato, tramite tagliocesareo, il nostro piccolo gran-de angelo, che abbiamo chia-mato Gabriele. Oggi, dopo che ilnostro piccolo ha subito a 40giorni un intervento di ernia, in-tendiamo esprimere la nostragratitudine, non solo al gineco-logo che ci ha seguito, ma so-prattutto al buon Dio e a sanDomenico Savio che abbiamocontinuamente pregato, e di cuiho indossato l’abitino per tutta ladurata della gravidanza. Ora l’a-bitino è passato a mio figlio, af-finché sia protetto giorno dopogiorno. È evidente che, senzal’intercessione dei santi, ora noinon avremmo la famiglia chetanto abbiamo desiderato for-mare nel nome di Dio.
Tonia e Giovanni, Bari
DIVENTARENONNI
Sono trascorsi otto anni dalgiorno in cui mia figlia, che abi-ta fuori del mio paese, mi disseche sarei diventata nonna. Pro-vai una gioia così grande chesubito lo confidai alla mia mi-gliore amica. Ella mi consigliò dimettere mia figlia sotto la prote-zione di san Domenico Savioe me ne procurò l’abitino. Anali-si e test davano risultati preoc-cupanti, tanto che il marito e isuoceri hanno insistito per unintervento, anche contro il vole-re di mia figlia di 36 anni. Se-guirono giorni di incubi. Io pre-gavo in continuità san Domeni-co Savio per mia figlia, affinchéle analisi risultassero negative.Quando mia figlia si recò all’o-spedale per ritirare gli esiti dalmedico e seppe da lui che pote-va stare tranquilla, la sua ango-sciosa attesa si trasformò inprofonda commozione. Ha po-tuto, infatti, partorire un bellissi-mo bambino, che teniamo sem-pre sotto la protezione di sanDomenico Savio.
Anzalone Alfina, Bronte (CT)
I NOSTRI SANTIa cura di Enrico dal Covolo postulatore generale
Per la pubblicazione non si
tiene conto delle lettere non
firmate e senza recapito. Su
richiesta si potrà omettere
l’indicazione del nome.MARZO 2008 BS
DUE GRAVIDANZESERENE
Trascorsi alcuni anni di matri-monio senza riuscire ad averebambini , ero molto t r is te epreoccupata. Finalmente ebbiun inizio di gravidanza cheperò s’interruppe a causa di unaborto. Rimasi molto demora-lizzata, finché seppi di esserenuovamente incinta. Ebbi variedifficoltà di salute, tanto da do-ver stare quasi sempre a letto,non riuscendo a reggermi inpiedi. Fui anche ricoverata inospedale per complicazioni.Ero molto preoccupata, finchéuna signora, abbonata al Bol-lettino Salesiano, mi donò l’a-bitino di san Domenicico Sa-vio. Iniziai a recitare con fedequotidianamente la preghieradelle mamme in attesa. Da al-lora cominciai a star meglio:potevo alzarmi e sbrigare lefaccende di casa. Il 14 maggio2001 nacque, senza nessunproblema, il mio bambino Davi-de. Quando aveva 9 mesi, miaccorsi di essere in attesa diun altro bambino. Allora pregaisubito san Domenico Savio difarmi dono di una gravidanzaserena. Essendo Davide anco-ra piccolo, non riuscivo a im-maginare come avrei potuto fa-re, se mi fossi trovata nelleprecarie condizioni di salute
46
B. Maddalena Morano B. Giuseppe Kowalski
IL MEDICO CURA I SANTI CONSOLANOSono una pensionata di 85 an-ni. Due anni fa ho avuto un ic-tus che mi ha paralizzato laparte sinistra del corpo. Il pri-mo di febbraio 2007 ho avutoun crollo vertebrale che mi ha
Alessandrina Mariada Costa.
costretta a stare 17 giorni aletto, immobile: ogni leggeromovimento mi recava doloriatroci. Il medico, per rinforzarele ossa, mi ha messo il bustoortopedico, esortandomi adaver pazienza con questa ma-lattia lunga e dolorosa. Hochiesto l ’aiuto della beataAlessandrina Maria da Co-sta, affinché intercedessepresso Dio. La malattia è statadolorosa sì, ma non lunga: èdurata 15 giorni. Ora, ritrovan-domi nelle condizioni in cui eroprima del crollo multiplo verte-brale, ritengo d’avere ottenutoun’importante grazia. Mi è ba-stato nominare la beata e su-bito ho trovato giovamento.Conosco l’efficacia della pre-ghiera rivolta ad Alessandrinae le sono infinitamente grata.Continuo a pregarla affinchéprotegga i miei quattro figli, inipoti e interceda anche perme presso lo Spirito Santo,Consolatore perfetto.
Argene Amali, Ostra Vetere (AN)
della precedente gravidanza.San Domenico Savio mi aiutò;infatti trascorsi una gravidanzatalmente serena, che potei la-vorare f ino all ’ult imo mese.Nacque il mio secondo bimbo,Giacomo, che ho affidato comeil primo a san Domenico, affin-ché li aiuti a crescere sani. An-che una mia amica, che hapartorito il suo bambino prema-turo, per il quale i medici nonosavano sciogliere la prognosimolto critica, dopo aver prega-to con me san Domenico Sa-vio, ha potuto constatare chela situazione è lentamente mi-gliorata. Il suo bambino Loren-zo ha superato quasi tutte ledifficoltà che i medici avevanoipotizzato.
O. P., Milano
• Monsignore, com’è il Madagascar?Un Paese dalle grandi risorse soprattutto dal punto di vista umano,
povero però come istruzione, formazione e mentalità di futuro. Lì sivive alla giornata. È un Paese agricolo, ma di una agricoltura condottaancora con metodi semiancestrali. Il Paese dispone purtroppo di scarsimezzi, è alto il tasso di analfabetismo e ancora maggiore l’analfabeti-smo di ritorno; mancano strutture tecnologiche, sanitarie, sportive...Insomma c’è da lavorare molto.
• I ragazzi e i giovani?...Sono molto ricettivi e dunque plasmabili. Si lasciano guidare. Da
chiunque, purtroppo. Nasce da questa situazione lo sforzo della Chiesae in particolare di salesiani e FMA per cercare di renderli responsabilidel loro futuro. Comunque, per smuovere i giovani in Madagascar bi-sogna lavorare sugli anziani: solo gli anziani hanno una vera grandeinfluenza e sono seguiti, o meglio obbediti. Essi, infatti, costituisconola più grande autorità morale del Paese.
• Come definirebbe la cultura malgascia?È decisamente una cultura valoriale: poggia su valori umani di alta
qualità, anche per questo sono recettivi al cristianesimo che è il latoreda sempre di una cultura valoriale.
• Quali pericoli individua?I malgasci, giovani o vecchi che siano, accettano acriticamente tutto
ciò che viene presentato come moderno, purché provenga dall’estero!E tuttavia la gente è accogliente, gioiosa, sincera…
• Ci offre qualche dato sulla sua diocesi?Ambanja è al nord, ha 34 mila km2 e un milione e 300 mila abi-
tanti. I cattolici sono l’8%, circa 110 mila. Vi sono villaggi dispersinella foresta difficilmente raggiungibili, presso alcuni si può arrivaresolo a piedi attraverso sentieri. Mancano ancora strade e chiamarepessime quelle che ci sono, almeno in certe regioni, è un compli-mento... Il clero è costituito da una cinquantina di preti e una ses-santina di suore.
• Auguri, Monsignore!
IN PRIMO PIANO redazionale
47
NNC’era un bambino di circa due
anni, malato d’AIDS che chiame-remo NN. Abbandonato. Una vo-lontaria lo raccoglie e lo porta alnostro centro. Non riesce neanchead alzare la testa. “Non arriverà adomani, sentenzia la dottoressa,non riesce a mangiare quasi nul-la, quello che mangia va via sottoforma di diarrea”. Non ha nessu-no, morirà solo. La dottoressa esuo marito sanno che le speranzesono praticamente inesistenti, malo portano a casa loro per curarlomeglio. Là iniziano la cura del-l’AZT, ma in Angola non è possi-bile fare tutte le analisi. La coppiadeve portarlo in Italia. I problemiburocratici li risolvono: lo adotta-no! Lui, malato di AIDS, lui chedesidera vivere, quasi in punto dimorte trova una famiglia: bravepersone. NN riceverà a giorni ilpassaporto e potrà andare in Italiaper continuare a lottare per la suavita, piccolo esserino di 3 anni.Loro lotteranno con lui sapendoche molto probabilmente questalotta avrà il suo vincitore felice inparadiso. Non smettono però diamare. Il giudice che deve firmarei vari permessi, incredibilmenteagevola tutto, non vuole neanche isoldi della tassa (qui in Angoladove si corrompe anche un cate-chista), ce li mette lui, i tempi bu-rocratici enormi vengono “sinte-tizzati”, abbreviati non rende l’i-dea. Sapete perché NN è statoadottato? Perché nessuno lo adot-terebbe.
BS MARZO 2008
MonsignorROSARIO VELLAClasse 1952, di Canicattì (AG).In Madagascar dal 1981 dove fu, più volte e in diverse case, direttore delle comunità salesiane.Nominato vescovo di Ambanja il 7 novembre 2007.
TAXE PERÇUE
TASSA RISCOSSA
PADOVA C.M.P.
In c
aso
di m
anca
to r
ecap
ito r
estit
uire
a: U
FF
ICIO
DI P
AD
OV
A C
MP
– Il
mitt
ente
si i
mpe
gna
a co
rris
pond
ere
la p
revi
sta
tarif
fa.
NEL PROSSIMO NUMERO
CASA NOSTRAdi Martina Crivello
Il teatro di Don Bosco
VIAGGI di Giancarlo ManieriCerimonie mapuche
INSERTO CULTURAdi Giovanni Eriman
Word & Life Publications
CHIESAdi Silvano StraccaQuo vadis Europa? (17)
Il ccp che arriva con il BS non è una richiesta di denaro per l’abbonamento che è sempre stato e resta gratuito.Vuole solo facilitare il lettore che volesse fare un’offerta.