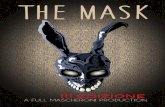L'ago di Clusane numero 12
-
Upload
lago-di-clusane -
Category
Documents
-
view
217 -
download
5
description
Transcript of L'ago di Clusane numero 12

C I R C O L O C u LT u R A L E C L u S A N E N S E Numero 12 Ottobre 2014
scriveteciil blog online
facebookla redazione
lagodiclusane.wordpress.comQui potrai scaricare tutti i giornaliniprecedenti, potrai anche interagire con noi commentando gli articoli del blog.
Pagina ufficiale: L’Ago di Clusane
Archetti Alessandra, Belotti Federico, Bertoletti Paola, Bianchi Paola,Bianchi Luigi, Bonardi Bruno, Cancelli Nicoletta, Colosio Laura,Ferrari Deborah, Lopizzo Nicola, Piccinelli Veronica, Regonini Simone,Treccani Carloalberto, Viti Benedetta.
Grafica: Andrea Sabadini.
Non pensate male, in questo ar-ticolo il termine click non si riferisce a qualcosa di compli-
cato, ad internet o a procedimenti macchinosi da compiere davanti ad un computer o altri marchingegni tecnologici, ma al rumore di una macchina fotografica nel momento in cui scatta.Avrei potuto utilizzare il più moderno termine inglese shot, ma da sempre nell’immaginario di molti la procedu-ra prevede: osservo, inquadro, scatto e il click è il segnale che qualcosa è stato impresso, qualcosa rimarrà nel-la mente e nella pellicola.Raccontare Clusane attraverso tanti scatti è stato l’obiettivo del secondo concorso fotografico “Clusane, luo-ghi e persone” indetto in occasione della settimana della Tinca in me-moria di Giovanni Gonzini, una delle persone più rappresentative della co-munità Clusanense.Sono tante le immagini pervenu-te che ci hanno affascinato, perché rappresentano Clusane visto nel suo essere paese lacustre, nella costan-te e imponente presenza del castello
Carmagnola, Clusane colto nel mo-mento di un tuffo dal pontile o nello sguardo fiero di chi osserva i frutti di una giornata di lavoro.Questo concorso è stato l’occasione per noi aderenti a L’Ago di Clusane di premiare le foto, che secondo il no-stro giudizio, illustravano meglio il paese, ma anche per dare l’occasione alla comunità stessa di raccontarsi!Girando tra le numerose foto esposte in sala civica, si narra come in un grande libro il passato, il presente e perché no, scorci del futuro di Clusa-ne; per coloro che non vivono quoti-dianamente sulle sponde del nostro lago, ogni scatto è una scoperta, una cartolina da conservare, come scritto anche da uno dei tanti visitatori.Sono state proposte sfumature diver-se e siamo consapevoli che magari qualcosa involontariamente è sfug-gito; l’atto di osservare e scattare una fotografica è anche il punto di partenza per un viaggio con la fan-tasia.Clusane è portatore di memorie e immagini che fanno parte del nostro immaginario collettivo, ma che spes-
so diamo per scontato: la giostra che ha accompagnato le nostre infan-zie da molti anni a questa parte, i luoghi-tappe del nostro paese, l’im-magine della Clusanina e dei “suoi” uomini che l’accompagnano.Il concorso si è sviluppato attraverso Facebook dove con i “like” espres-si dagli iscritti alla nostra pagina, sono stati votati due fotogrammi, due istanti: lo scorcio di Clusane visto in uno specchietto di un’auto quasi fosse un ricordo prezioso, un arrivederci speranzoso e nell’altro il tempismo nel catturare il momento in cui un fulmine si scatena nel cor-so di una partita a “portine” all’ora-torio. Tra effetti tecnici e colori sapien-temente utilizzati, foto abilmente studiate, oppure scattate sull’onda di un’emozione, ogni immagine ha suscitato nel visitatore un ricordo o ha permesso di scoprire un punto di vista diverso di alcuni particolari del nostro paese. Ci auguriamo di poter replicare questo concorso … Clusane ha sicuramente tanto altro da rac-contare!
“La fotografia è una cosa semplice. A condizione di avere qualcosa da dire.”
- Mario Giacomelli -
CLuSANE IN uN CLICKdi Alessandra Archetti

pag. 2 L’ago di Clusane
di Federico Belotti
Le vicende del passato sono tutte inevitabilmente affascinanti. In particolare, quando queste trat-
tano di luoghi che viviamo o di per-sone che conosciamo, destano ancor più interesse. Ricordo quanto mi stu-pì mio nonno descrivendomi il padre pescatore. Mi raccontò come durante le lunghe giornate in barca, suo pa-dre, come gli altri pescatori, beve-va direttamente dal lago utilizzando la cosiddetta paletta. Nonostante la paletta fosse lo strumento normal-mente utilizzato per svuotare la barca in caso di pioggia, veniva utilizzata anche per questo secondo scopo, ed addirittura c’era una vera e propria tecnica che consisteva nello schiaf-feggiare l’acqua superficiale preven-tivamente, in modo da spostare gli eventuali corpuscoli in sospensione, per poi con un altro colpo veloce pre-levare l’acqua. Molti potrebbero non trovare minima-mente significante questo racconto, io invece restai stupito per un sem-plice fatto: una volta l’acqua del lago si beveva. Oggi come oggi, le quali-tà di potabilità sono più che lonta-namente raggiungibili, eppure non sono passati tantissimi anni. Come mai stiamo vivendo questo repentino peggioramento delle condizioni del lago? Luogo comune rimane quello di incolpare le vecchie generazioni, od ancora quello secondo il quale il lago ha sempre posseduto una natu-rale propensione per il ristagno degli inquinanti.Fortunatamente c’è chi si è interes-sato, ed indagando direttamente con metodi scientifici il nostro lago, ci ha permesso di sfatare tutti quei miti basati sulle convinzioni popolari. Uno dei precursori che si occupò di questa materia fu proprio Francesco Salmoiraghi, che tra il 1897 e il 1898 descrisse la geologia delle zone limi-trofe al lago e studiò accuratamente
i meccanismi di variazione lacustre. Esattamente sessant’anni dopo, furo-no Giuliano Bonomi e Marco Gerletti ad integrare il quadro, fornendo quel-la che fu la prima “carta d’identità del lago”. Già loro notarono come il nostro bacino presentasse le carat-teristiche tipiche riconducibili ad uno stadio primitivo di eutrofizza-zione. Per eutrofizzazione si intende un eccesso di sostanze come nitrati e fosfati, che innescano un processo biologico di proliferazione degli orga-nismi vegetali (alghe e micro alghe). Questo squilibrio comporta durante la fase di biodegradazione un aumen-to dell’ attività batterica, che a sua volta, impone un alto consumo d’os-sigeno disciolto nell’acqua. In prati-ca, durante la decomposizione delle alghe, eccessivamente sviluppate a causa dei nitrati, l’ossigeno sottratto alle acque del lago determina a lungo andare la morte dei pesci. L’eutrofiz-zazione perciò è uno degli indicatori che denota lo stato di inquinamen-to di un corpo idrico, dato che viene causata dai nitrati e fosfati contenuti nei fertilizzanti, nei detersivi e negli scarichi civili (fogne…).Nella nota conclusiva della relazione del 1957 si legge “Possiamo invece chiederci, con una punta di realismo, se, nel quadro della generale eutro-fizzazione dei nostri laghi prealpini, il lago d’ Iseo mostri qualche sintomo in questo senso. In realtà alcuni indi-zi sono da considerarsi con interesse: l’elevato contenuto in nitrati, e la non elevata ossigenazione delle ac-que ipolimniche, la abbondantissima fauna macrobentonica profonda ...È quindi ragionevole attendersi che il lago d’ Iseo presenti in un futu-ro relativamente prossimo le ormai classiche modificazioni chimiche e biologiche che si sono verifica-te in altri laghi; è da sperare che si possano su questo lago, quanto
prima, svolgere delle ricerche atte alla documentazione dell’ evoluzio-ne trofica (livello d’ossigenazione), fornendo nel contempo le indicazio-ni per pianificare una difesa delle caratteristiche naturali del lago”.Consultando i dati ricavati durante i vari prelievi nell’ arco degli anni, si nota come il peggioramento riguar-do agli inquinanti presenti nel lago e contemporaneamente alla succes-siva diminuzione della percentuale d’ossigeno contenuta in acqua, abbia subito un notevole incremento negli ultimi sessant’ anni.Nonostante l’ipotesi di un inquina-mento ristagnante da lungo tempo venga meno, rimane primaria la ne-cessità di trovare un rimedio in grado di porre fine all’ immissione di certe sostanze nel lago e che nel contempo possa garantire un graduale riavvici-namento all’ormai perso naturale ciclo biologico. In questi ultimi anni, oltre al continuo prelievo di campioni ed al conseguente monitoraggio dei para-metri vitali del bacino, si è parallela-mente inaugurato uno studio che po-tremmo definire ambizioso. Ponendosi come obiettivo l’individuazione delle fonti di inquinamento e la descrizione accurata del meccanismo di ricambio dell’ acqua all’ interno del corpo idri-co, tale studio è riuscito a rispondere a molte domande che in precedenza parevano inspiegabili. Per quanto ri-guarda le fonti di inquinamento, oltre ai detersivi ed ai fertilizzanti che se-guendo il ciclo delle acque piovane vengono condotti al lago, non trascu-rabile rimane la quantità di materiali organici contenuti nel fiume Oglio.Questi sono principalmente dovuti dall’ immissione degli scarichi sia ci-vili che industriali nel fiume, che pur venendo trattati, non comportano danni laddove la velocità di scorri-mento dell’ acqua è elevata, ma non rimangono altrettanto inerti dove la velocità dell’ acqua diminuisce per-mettendo il deposito delle particelle trasportate. Per quanto compete il meccanismo di riciclo e di ossigena-zione dell’acqua, si è accertato che il lago per rigenerare completamen-te le acque al suo interno, impiega molto più tempo rispetto al passato, e che questo ciclo ha sempre subito un rallentamento nel procedere degli anni. Ciò in parte giustificherebbe

pag. 3 L’ago di Clusane
l’aumento della concentrazione delle sostanze dannose e darebbe risposta anche alla mancata “riossigenazione” dell’ acqua. Molti ora si chiederanno come sia possibile che il ciclo di ri-cambio possa variare, visto che po-trebbe sembrare influenzato solo dal rapporto tra acqua entrante e quella uscente; in realtà è molto più com-plicato di come appare, basti pensare che, oltre al rapporto tra entrata e uscita, il ciclo all’ interno di un lago viene influenzato da una miriade di variabili che possono essere: il vento, le variazioni di densità, la rotazione terrestre, le differenze di tempera-ture, i flussi d’acqua, le velocità dei flussi, e molte altre.Grazie alle ricerche effettuate, è sta-to possibile individuare il principale responsabile del rallentamento dei flussi lacustri: la differenza di tem-peratura. Quando il sole illumina lo specchio d’acqua, trasmette una quan-tità di energia media di circa 400GWh (periodo estivo) che comporta un ri-scaldamento medio di 0.26°C al gior-no per i primi venti metri d’acqua. A sua volta l’acqua riscaldata, essendo meno densa, tende a “galleggiare” al di sopra dell’ acqua più fredda(e quin-di più densa), imponendo che il ri-scaldamento avvenga principalmente per il primo substrato, e creando così due nuclei d’acqua separati.L’esistenza di questi due strati implica in primo luogo che lo strato inferiore denoti un’evidente difficoltà ad ossi-genare l’acqua, e ciò è facilmente de-ducibile confrontando i dati: nel 1973 la quantità di ossigeno per litro era di 6.8mg, mentre nel 2002 alla stessa profondità (200m) la quantità si atte-stava attorno ai 0.1mg per litro.I dati recenti affermano che la quan-tità di ossigeno limite per la vita del-la maggior parte della fauna ittica si ferma ad una quota di circa 120 me-tri. Un altro problema causato dalla separazione degli strati d’acqua così suddivisi sono i moti convettivi che vengono a prodursi al loro interno ottenendo una difficile circolazione e un conseguente rallentamento della velocità di scorrimento.Nonostante le cause di questa intera-zione siano ancora oggetto di studi, le prime ipotesi riconducono il com-portamento eccessivamente rapido di acquisire calore della porzione meno
profonda del lago nuovamente all’ec-cesso di sostanze inquinanti, le quali, velocizzando il processo di riscalda-mento, producono una separazione che non permette alla parte più profonda di scaldarsi in modo proporzionale alla profondità come avveniva in passato. Sapendo il ruolo fondamentale che un lago possiede negli ambiti sociali, culturali, paesaggistici, naturalistici ed economici, l’Unione Europea si è già pronunciata imponendo che tutti i corpi d’acqua superficiale vengano tutelati.Tramite la “direttiva quadro Europea sulle acque 2000/60/CE” è stato fis-sato il termine (2027) entro il quale “Gli stati membri devono adottare misure per impedire il deterioramen-to dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, per proteggere, miglio-
rare e ripristinare tutti i corpi idrici al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali” (Nel caso del nostro lago dovremmo ripristinare le condizioni del 1957).Il termine imposto potrebbe sembrare eccessivamente distante, in realtà per i tempi “fisiologici” di ripristino di un lago, non è nemmeno molto. Proprio per questo motivo mi domando: perché nessuno ancora interviene? Le ammi-nistrazioni sono a conoscenza dell’ob-bligo che sono tenute a rispettare?Personalmente spero che gli organi competenti, oltre ad incentivare la sensibilizzazione della popolazio-ne, intervengano concretamente per preservare, in modo lungimirante, quello specchio d’acqua che era, è, e dovrà rimanere il fiore all’occhiello del nostro paese.
“Cartolina di Clusane”
Quando si partecipa ai concorsi fotografici, si va alla ricerca degli scatti più significativi ed accattivanti, che colpiscano subito gli osservatori, si cerca quindi il momento di luce più favorevole (ad esempio al mat-
tino presto, all’imbrunire o dopo un temporale).Per questo concorso mi sono concentrato inizialmente sulla Clusane agrico-la, documentando la zona adiacente alla chiesa ed al cimitero, fotografando campi, contadini e vigneti; tutte immagini valide per arricchire il mio archi-vio personale, ma che non rispecchiavano la mia visione di Clusane, cioè un paese in cui il lago e la vita sul lago sono parte integrante.Lo scorso maggio, rientrando da un’uscita in barca per fotografare i pae-si che si affacciano sul lago, in condizioni di luce ottimali (cielo terso e sole splendente), dirigendo lo sguardo in direzione della chiesa vecchia, ho “visto” l’immagine perfetta e ho pensato “sembra una cartolina”: barriera galleggiante gialla e nera in primo piano e lo skyline del paese sovrastato da grosse nuvole bianche.Alzo la reflex e scatto!
Giuseppe Zanchi

pag. 4 L’ago di Clusane
di Paola Bertoletti
Volge al termine l’indagine sul castello Carma-
gnola che ha visto interessate la famiglia Bosio, detentrice del-la parte orientale del castello e, successi-vamente, la famiglia Anessi, proprietaria dell’ala occidentale. L’intero castello di Clu-sane e le aree annesse sono state dichiarate, secondo il decreto del 22 aprile 1995, “di in-teresse particolarmen-te importante” ai sensi della legge 1089/1939 e tutelati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. La richie-sta di vincolo venne avanzata con urgenza a causa del progressi-vo degrado in cui ver-sava l’immobile. Per contrastare il notevo-le decadimento, che avrebbe rapidamente portato alla perdita del Bene Culturale, nel 2007 intervenne nuo-vamente il Ministero che, con una ordinanza ministeriale, impose il recupero statico del castello. Oggi, pas-seggiando sul lungola-go di Clusane e volgendo lo sguardo verso il maniero che fa da sfondo meridionale al lago, si può facilmente notare una frattura stilistica lungo l’asse nord-sud che rimarca la diversa metodologia di approccio adottata dalle proprietà. Due interventi di recupero architettonico e strutturale com-pletamente diversi, il primo finalizzato ad un riuso nell’im-mediato, il secondo solo conservativo. Come si è arrivati ad avere due risultati tanto differenti? Una prima spiegazione la dobbiamo ricercare nei vincoli imposti dal decreto del 1995 e dalle norme tecniche di attuazione del vecchio Pia-no Regolatore, secondo cui l’iniziativa doveva essere pub-blica. Le destinazioni d’uso ammesse, compatibilmente con le strutture storiche, dovevano essere: attrezzature ricetti-ve, residenze, attrezzature terziarie e di servizio, attività sociali, culturali e di promozione turistica.La proposta, ambiziosa, sottintendeva una evidente desti-nazione Pubblica, ma la carenza di una definizione pun-tuale sul suo utilizzo, l’assenza di un Piano di Recupero dell’immobile e la mancanza di un progetto unitario sul palazzo hanno portato le Proprietà a perseguire strade del tutto personali.
Il recupero, struttu-rale, conservativo, può essere fatto per proprietà separate, ma solo se queste sono innervate in un programma più am-pio: la formazione di un Piano generale di Recupero delle opere sarebbe stata la via da seguire per poter par-lare di un intervento serio e concreto. Durante questi anni di dibattito, si sono avanzate delle linee guida per la redazio-ne di un Piano di Re-cupero di iniziativa pubblica. Le proposte emerse prevedevano la valutazione della proprietà secondo tre punti fondamentali: la previsione di un interesse pubblico, la dotazione di oppor-tuni standards urba-nistici (aree a verde, parcheggi, etc..) e la valutazione di una de-stinazione d’uso, ele-mento fondamentale per permettere una progettazione, poiché senza idee non esiste nemmeno progettuali-tà e senza progettua-
lità non è possibile prevedere alcuna valorizzazione reale e concreta.Nessuna delle amministrazioni succedutesi in questi anni è stata in grado di redigere il piano a cui si fa riferimento. Certamente i problemi di carattere giuridico presenti sono tutt’altro che ignorabili. L’area interessata dal vecchio Pia-no Regolatore comprendeva le zone circostanti al castel-lo, alcune delle quali di proprietà pubblica, ma l’apparente contraddizione della norma si riferiva all’elaborazione di un piano di iniziativa pubblica per un immobile completamen-te privato. Diverse fazioni politiche di entrambi gli schieramenti si sono interessate alla salvaguardia e alla valorizzazione del Castello avanzando interessanti proposte di utilizzo dell’im-mobile per la redazione di un Piano di Recupero:- utilizzo pubblico permanente della corte interna garan-tendo l’accessibilità da via Ponta, via Gere e via G. Pascoli;- richiesta di acquisizione da parte dell’amministrazione comunale di una parte consistente del piano terra, dove insediare funzioni pubbliche (sala civica, ufficio per il tu-rismo, sede delle diverse associazioni culturali presenti nel
CASTELLOCARMAGNOLA
DEBITO O RISORSA? uNA CHIACCHIERATA TRA LE vIE DEL PAESE E IL PuNTO DI vISTA TECNICO
- TERzA PARTE -

pag. 5 L’ago di Clusane
paese - ve ne sono ben cinque - ufficio per il commercio, ufficio della polizia urbana ed eventuale centro studi permanente del-le attività che ruotano attorno alla pesca e al lago);- reperimento degli standards nel territorio Clusanese escludendo a priori la possibilità di monetizzazione. In particolare valoriz-zando le aree a verde prospicienti il palazzo e creando una rete di percorsi pedonali;- discrezione delle proprietà riguardo alla destinazione del resto dell’edificio.Durante questi mesi di indagine, ho avuto modo di ascoltare pareri di ogni genere sul tema castello; in una chiacchiera-ta avvenuta con un ristoratore locale è emersa l’importanza di utilizzare gli strumenti giuridici in nostro possesso per consentire la reintroduzione all’interno delle Norme Tecni-che di Attuazione del nuovo Piano di Governo del Territorio della cessione dei privati di aree d’utilizzo pubblico. Azioni finalizzate a riconsegnare alla popolazione di Clusane luo-ghi di forte valore civico: “Garantire sale pubbliche, l’acces-sibilità del cortile interno e la fruizione del castello lungo i passaggi pubblici esistenti è un’occasione per far conoscere più da vicino le bellezze del nostro territorio affinché si possano sviluppare economie e potenzialità per la popola-zione locale.”Un conosciuto geometra clusanese che da vent’anni ha pre-so a cuore la salvaguardia del castello ha suggerito, in più incontri avvenuti con la popolazione, la seguente modali-tà di intervento da parte dell’amministrazione Comunale: “Il più grande cancro del castello è che sia privato (…). Tre sono le soluzioni possibili per combat-tere questa malattia: la prima - acquistarlo come fece Iseo per il Castello Oldofredi, la seconda - espro-priarlo se i proprietari non vogliono vendere l’immobile, la terza – cercare di mediare e trovare un accordo tra le parti.” Suggerimen-ti utopici e tutt’altro che realizzabili: i pri-mi due per mancanza di fondi comunali e statali. L’ultimo pun-to, visti i rapporti che intercorrono tra le
famiglie, pare sia ad-dirittura più imprati-cabile delle prime due proposte. In un incontro priva-to avvenuto con un progettista che ha lavorato sul castel-lo, si è sottolineata la mancanza di base di tutta la questione: “Trent’anni fa si do-veva imporre una de-stinazione d’uso con-creta. La norma del vecchio piano regola-tore era illegittima. Il progetto di iniziativa pubblica a cui il piano fa riferimento, sottin-
tendeva - e qui l’errore - che la destinazione sarebbe stata pubblica ma non ne definisce la modalità. Una maggiore specificità avrebbe dato chiarezza sciogliendo il vincolo micidiale dei proprietari che si sono illusi di poter fare ciò che volevano.”Il Comune di Iseo avrebbe dovuto esigere e ottenere, prima dell’inizio dei lavori di consolidamento iniziati nel 2008, un dettagliato studio stratigrafico dell’intero manufatto fi-nalizzato alla comprensione delle trasformazioni avvenute durante questi secoli, il tutto per mantenere l’integrità del nostro caro Castello. E’ quindi doveroso per la comunità locale creare un gruppo di persone competenti in grado di studiare l’edificio storico e consegnare un elaborato di ricerca che possa essere utile qualora si decida la modalità d’intervento.Per tutelare il Patrimonio Culturale del nostro territorio, è necessario redigere un Piano di Recupero di iniziativa pubblica dell’edificio del Castello e di tutta l’area di perti-nenza, ma, prima, si richiede necessariamente che questo sia preceduto da una indagine preliminare statica, storica
ed architettonica da sottoporre alla So-printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio al fine di acquisire un parere preliminare riguardo alle modalità di inter-vento e alle possibili funzioni compatibili.Cosa fare oggi del Ca-stello? Diversamen-te da quanto citano le Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, come archi-tetto mi trovo assolu-tamente ostile ad una destinazione d’uso re-

pag. 6 L’ago di Clusane
NOTE STORICHE:
NOTE ARCHITETTONICHE:
NOTE uRBANISTICHE:
• Alto medioevo (XI sec) presenza di un castrum della famiglia Longobarda dei Conti di Mozzo.• Nel XIV secolo, gli Ysei o Oldofredi costituiscono una struttura fortificata rendendo l’edificio più simile a una fabbricato militare.• Nel XV secolo risulta essere di proprietà della famiglia Malatesta.• Nel 1412 viene assorbito come proprietà della Repubblica di Venezia.• Nel 1428 la Repubblica di Venezia lo dona al suo capitano Francesco di Bussone detto il Carmangola.• Nel 1432 il Carmagnola viene giustiziato per tradimento e il palazzo viene nuovamente incamerato dalla Serenissima.• Nel XV secolo viene acquisito dalla famiglia Sala.• Nei secoli successivi viene diviso in quattro proprietà: Cordarelli, Maggi, Soncini e Lana.• Fine anni ‘70 Stato di abbandono del castello.• 22 aprile 1995 decreto di vincolo sul castello ai sensi della legge 1089/1939.• 2007 ordinanza Ministeriale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.• 2008 inizio dei lavori di restauro.• 2009 Atto di Convenzione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Luigi Bosio sull’apertura al pubblico del castello.
• Originariamente il palazzo risultava fortificato con la presenza di un profondo fossato (visibile ancora oggi) e di un ponte levatoio sul lato occidentale.• Presenza di poche finestrature denotano un primo impianto di difesa. Si presume inoltre che sul tetto vi fosse una merlatura.• Nel XV secolo l’edificio viene trasformato in residenza fortificata secondo i canoni rinascimentali con la realizzazione di loggette, archi, colonne e affreschi.• Nei secoli XVI e XVII il palazzo viene continuamente modificato rispetto alla struttura originaria a seguito di vari passaggi ereditari.
• Attualmente è riconoscibile la struttura principale dell’edificio a pianta quadrata, lo spazio occupato dal fossato, l’ingresso principale sul lato occidentale (dove avrebbe dovuto trovarsi il ponte levatoio) la posterla (o porta secondaria posta sul lato orientale dell’edificio) con il ponte in pietra.• Di notevole interesse risultano gli spazi attigui al castello: 1. Le aree situate sul lato prospiciente il lago; 2. Le aree in prossimità dell’ingresso principale ; 3. L’ampia area verde sul lato orientale.• Di notevole interesse risulta essere l’impianto urbanistico formatosi intorno al castello attestatosi su via Risorgimento con percorsi che conducono al palazzo.
sidenziale. Al contrario, ritengo che spazi per attività cul-turali, sociali, di promozione turistica e piccolo commercio dell’artigianato locale, possano essere un punto di forza e di attrazione per Clusane.Partendo dal presupposto che l’edificio è privato e che nemmeno un ricambio generazionale potrebbe giungere ad un accordo tra le due proprietà, finché la questione rimane tale, dobbiamo solo auspicare che il Bene rimanga preser-vato. Si chiede, quindi, all’Amministrazione locale di mo-nitorare tutti gli interventi che verranno eseguiti in futuro sul castello. Come cita la relazione dell’ingegnere Pagani,
protocollata agli atti il 31/08/2010, “al fine di evitare che il progetto (…) si riduca ad un mero assemblaggio delle pur legittime proposte delle due Proprietà”.Se per qualche fortuita ragione, l’intero castello venisse considerato nella sua integrità, trovando una mediazione tra i detentori del Palazzo, allo stato di fatto ci troverem-mo con un altro problema tutt’altro che irrilevante. Con le casse statali vuote, sarebbe complesso trovare i fondi per la gestione di spazi lasciati in cessione pubblica, come richiede il PGT. La situazione attuale di crisi economica renderebbe non impossibile, ma complesso qualsiasi inve-
stimento per creare un Polo attrat-tore che, nella mia idea progettuale, affiancherebbe alle proposte so-praccitate, sale civiche, biblioteca, ludoteca, centro congressi e la pos-sibilità di creare una foresteria di lusso ai piani alti con relativi servizi annessi. Un intervento di questa na-tura richiederebbe anche un nuovo progetto viabilistico e la previsio-ne di opportuni spazi a parcheggio (anche per autobus) da trovare sul territorio. La fattibilità di un inter-vento di questa natura renderebbe la previsione di un piano economico di rientro a lungo termine. Investimen-to non proprio alla portata di tutti.Fruibilità e Bellezza, Antico e Con-temporaneo… Apparenti contrad-dizioni che, se non prese in consi-derazione, rischiano di portare alla perdita dei patrimoni di pietra. Si tratta di scelte, proficue o conser-vatrici, che possono trasformare il Nostro Bene più grande in una sem-plice bellezza architettonica lontana dall’identità del luogo a cui appar-tiene. Nell’immaginario collettivo, queste parole, assumono un signifi-cato astratto, di sottrazione, come se esse possano trasferire un diritto nelle mani di un Ente, causando la perdita del valore più grande: quello fatto da chi quotidianamente pensa al suo paese fatto da un lago e da un castello. L’attenta lettura del passato at-traverso le stratificazioni storico-architettoniche è l’unico strumento che consente la corretta ricerca di un nuovo futuro. La vera trasforma-zione la dobbiamo compiere noi, di-ventando genitori di un luogo che fa parte della nostra vita. Come disse il premio Nobel per la letteratura Ber-trand Russell, “L’umanità è una sola famiglia con interessi comuni. (…) La collaborazione è più importante della competizione.”

pag. 7 L’ago di Clusane
di Nicoletta Cancelli
Centocinquant’anni in cinque. Sono voce, chitarra, basso, batteria e pia-noforte. Sono Francesco, l’altro Fran-
cesco, Giuseppe, Enrico ed Ottavia; lei, la caratterizzazione romantica del gruppo dopo il suono attraverso le sue dita. Sono i KARENINA, nome importante che ri-porta i più saggi alla letteratura russa moder-na di Tolstoj, mentre i più ingegnosi a loro, a questa miriade di suoni, di trame musicali. A loro, solo a loro, i KARENINA. “Scomparire in 11 semplici mosse” è stato l’album sotto il suggestivo nome di Triste Colore Rosa, nel
2010 e astuzia vuole che non abbiano rispet-tato il titolo di quel disco. Curioso è che fu proprio “Madame Kareni-na”, uno dei primissimi pezzi dei TCR, che non veniva mai suonato dal vivo. Mentre loro aggiungevano purezza alla forma delle loro canzoni e l’evoluzione di un percorso per mezzo della musica avve-niva, abbandonarono il nome TCR per il più completo KARENINA. Una nuova iden-tità, un nuovo inizio, la consapevolezza di non essere più quelle persone ed un di-sco, nel 2011, “Il futuro che ricordavo”.
Preceduto dall’Ep “Verso” ecco fra noi il ca-polavoro assoluto: VIA CRUCIS. La raffinatezza del loro suono è la stessa che li aveva contraddistinti come TCR, ma qui ha raggiunto un alto livello di perfe-zione. La sperimentazione del suono, for-temente voluta dal gruppo, la ritroviamo sugli arrangiamenti, nei testi, poesie di un certo spessore, nella struttura delle can-zoni. Le copertine dei dischi non pecca-no mai di eccentricità, di intemperanza. Sono sempre composte, ricercate, mai ba-nali. L’ultima è opera dell’artista Roberto Pesenti. L’ha tradotta in realtà nel modo più vero: ascoltando il disco. Ma ascoltare, stavolta, è capire.C’era un divano che era la parte per il tutto e c’è un sipario che racconta la loro sto-ria attraverso molte altre. Via Crucis è un viaggio ideale dove la partenza e l’arrivo coincidono, legate da un filo invisibile e tragico. È un viaggio emozionale che rac-conta in modo denso e graffiante il nostro Paese degli ultimi vent’anni. È anche un viaggio del corpo e della mente che, virtualmente, ripercorre l’Italia, scen-dendo e risalendo, dove partenza e ritorno si ricongiungono e nell’immaginario trac-ciano i punti di un percorso concretizzato nella forma di un coltello. (Se non ci ar-rivate acquistate la loro maglietta: è più semplice). È questa l’espressione che sim-boleggia bene il tema di Via Crucis: l’Italia dei suoi peccati, della contraddizione e dell’ indecisione. L’Italia della crisi attuale e delle sue tragiche condizioni e la donna che indistintamente è raffigurata in coper-tina è proprio lei. L’Italia. Ungaretti, oggi, ringrazierebbe.
DI LUGLIOdi G. Ungaretti
Quando su ci si butta lei,Si fa d’un triste colore rosa
Il bel fogliame.
Strugge forre, beve fiumi,macina scogli, splende,
È furia che s’ostina, è l’implacabile,Sparge spazio, acceca mete,
È l’estate e nei secoliCon i suoi occhi calcinanti
Va della terra spogliando lo scheletro.
LA SCuSA PER SMETTEREDI COMBATTERE
Come ho scattato la mia fotografia
Buongiorno, sono Mattia Prandelli, abito a Clusane e lavoro come came-raman in emittenti televisive.Era una mattina di marzo ed ero a Clusane per realizzare un sevizio
televisivo per un emittente locale riguardante i vecchi lavori tradizionali.Dopo essere stati a visitare la lavorazione della sardina in una piccola azienda del paese, siamo stati accompagnati dal proprietario a vedere il laboratorio del sig. Tonino, esperto maestro d’ascia locale che si dedica alla costruzione delle nostre splendide tipiche imbarcazioni da pesca. Come ho messo piede nel laboratorio, sono rimasto incantato dalla maestria con la quale Tonino (con alcuni aiutanti) si muovesse intorno alla barca con il martello di legno in mano a correggere e “picchiettare” le assi stesse dell’imbarcazione.Da buon appassionato di fotografia, appena finite le riprese televisive, sono corso in auto a recuperare la mia reflex e, tornato all’interno, ho iniziato a scattare. Ho realizzato una sequenza di circa trenta scatti con angoli e pose differenti, cercan-do di cogliere la spontaneità dei mio soggetto.La luce che entrava nel laboratorio quella mattina era quella tipica delle mattine invernali nebbiose e umide, cosa che per me è risultata positiva, perchè illuminava con perfetta diffusione l’in-terno del laboratorio. Le fotografie sono state scattate a luce ambiente con una Nikon D90 e un’ottica 12-24 mm Sigma.
Mattia Prandelli

pag. 8 L’ago di Clusane
di Deborah Ferrari
Nel numero precedente, dopo aver identificato la terminologia e la legislazione specifica attual-mente in vigore, abbiamo ripercorso brevemente
le tappe evolutive e sociali affrontate dalle persone disabili sino al giro all’adolescenza.In questa ardua fase, gli adolescenti con disabilità spesso si dimostrano desiderosi di costante incorag-giamento da parte dell’adulto, sia nello svolgimen-to dei compiti sia in ambito emotivo, segno di forte dipendenza e di un’unica ambizione: rendere felice l’adulto stesso.Il disagio e l’inadeguatezza che di frequente caratte-rizzano il percorso evolutivo impediscono il naturale sviluppo della persona disabile, ostacolando la comu-nicazione, provocando scarso interesse e poca motiva-zione, labilità dell’attenzione, indifferenza alla realtà circostante, rischio di isolamento sociale, difficoltà ad operare in modo valido associazioni, discriminazioni, analisi e sintesi.Nella ricerca di una nuova identità e dell’autonomia, durante l’adolescenza è fondamentale la funzione del gruppo dei coetanei: il gruppo, per il senso di appar-tenenza che fornisce, esercita da un lato una funzione di protezione, e dall’altro, aiuta ad emanciparsi dai genitori e fornisce il contesto e il sostegno necessari ad apprendere nuove capacità sociali, indispensabili per l’ingresso nel mondo adulto.L’esperienza di integrazione nella scuola superiore è per lo più accessibile solo a coloro che hanno un deficit in-tellettivo lieve, ed è in questo contesto che per il ragaz-zo disabile è possibile orientare sé stesso verso un per-sonale progetto di vita, pur nella difficoltà di affrontare i problemi legati al suo deficit, fatto che appesantisce la gestione della sua “progettualità” di vita e l’aspirazione ad una sfuggente quanto dolorosa “normalità”.La FASE ADULTA, nell’ambito della disabilità, è la più buia da un punto di vista socio-culturale: gli inter-venti educativi diminuiscono per intensità, il percorso integrativo scolastico si è concluso e il disabile, pur seguito e assistito, non è più stimolato come in pre-cedenza. I cambiamenti non sono più così rapidi ed evidenti e la persona disabile percepisce una sorta di “blocco del divenire”.
Anche a causa del pregiudizio sociale, il disabile è identificato come un eterno bambino, dipende anche economicamente dalla famiglia, non è addestrato a gestire da solo il proprio corpo, non può vivere na-turalmente la propria sessualità perché non è consi-derato un adulto.Egli rimane passivamente coinvolto nell’immagine sociale di sé stesso ed essere come gli altri vogliono che sia diventa una facile risposta esistenziale data-gli da coloro che gli stanno intorno. Venendo meno gli interventi educativi e terapeutici operati nell’età evolutiva, il primo problema è affina-re le capacità degli educatori che operano nelle co-munità di affrontare lo sconforto, il dolore e il senso di impotenza vissuto dal disabile.In età adulta, la persona disabile nel pieno svilup-po corporeo ha raggiunto anche il pieno sviluppo sessuale, ma questo è un tema scomodo da affron-tare: per lui o per lei, identificato/a come eterno bambino/a, non c’è futuro progettabile, e il fatto che non presenti esigenze sessuali è spesso una tranquil-lità per tutti.Negare la sessualità significa negare una parte con-sistente delle emozioni, in quanto essa è il luogo dove mente, corpo e relazione si innestano forte-mente tra loro.Correndo il rischio di vivere da “parassita”, legato ad una precaria condizione di dipendenza totale, egli è condannato alla frustrazione, alla solitudine, all’an-nichilimento.Tuttavia, se buona parte dei problemi sopra esposti è di natura sociale, culturale, educativa, è possibile cercare di risolverli, dando la possibilità alla persona disabile di vivere una vita dignitosa e felice, rimuo-vendo dal percorso dell’esistenza quegli ostacoli che gli rendono impossibile ancora oggi la piena realiz-zazione di sé.Vogliamo provarci? Arrivederci al prossimo numero!Se siete interessati, reperite in rete i cortometrag-gi “Cinquanta di questi giorni” italiano, toccante, e “Aglaée”, francese, di Rudi Rosenberg, premiato ai MYFFF. Scatenerànno dibattiti e riflessioni a profusione. Buona visione!
AMORE DISABILE- SECONDA PARTE -
DEDICATO A SuPER G E AI RAGAzzIDELL’I.T.A.S. PASTORI DI BRESCIA