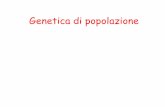Principi di GENETICA - · PDF filegenetica classica, affrontando poi la genetica molecolare e...
Transcript of Principi di GENETICA - · PDF filegenetica classica, affrontando poi la genetica molecolare e...

� Principi di
GENETICAD. Peter Snustad
Università del Minnesota
Michael J. SimmonsUniversità del Minnesota
Quartaedizione

In copertina�
In copertina è mostrata una riproduzione artistica di un gel di sequenza delDNA. Lo sviluppo delle tecniche di sequenziamento del DNA alla fine degli anni’70 ha dato inizio a una nuova era della genetica – l’era della genomica. Nel 1977 èstata pubblicata la sequenza del genoma di un piccolo virus, il batteriofago �X174.Nel 1995 sono state pubblicate le sequenze complete di genomi batterici, a cui sonoseguite negli anni successivi quelle di importanti organismi modello eucariotici. Nel2001 sono state pubblicate due bozze della sequenza del genoma umano. La tecno-logia attuale è tale che oggi è possibile sequenziare con facilità interi genomi.
Titolo originale :Snustad, SimmonsGENETICS - Fifth editionCopyright © 2009, 2006, 2003, 2000, 1997, John Wiley & Sons, Inc.
PRINCIPI DI GENETICA - Quarta edizioneCopyright © 2000, 2004, 2007, 2010, EdiSES S.r.l. – Napoli
9 8 7 6 5 4 3 2 1 02015 2014 2013 2012 2011 2010Le cifre sulla destra indicano il numero e l’anno dell’ultima ristampa effettuata
Fotocomposizione : EdiSES S.r.l. – Napoli
Fotoincisionee stampa:Tipolitografia Petruzzi Corrado & Co. s.n.c.Zona Ind. Regnano – Città di Castello (PG)
per conto dellaEdiSES – Napoli
http://www.edises.it e-mail: [email protected]
ISBN 978 88 7959 636 7
A norma di legge, le pagine di questo volumenon possono essere fotocopiate o ciclostilate o co-munque riprodotte con alcun mezzo meccanico. LaCasa Editrice sarebbe particolarmente spiacente didover promuovere, a sua tutela, azioni legali versocoloro che arbitrariamente non si adeguano a talenorma.
L’Editore

Serena AcetoUniversità degli Studi di Napoli “Federico II”
Silvana DolfiniUniversità degli Studi di Milano
Raffaella ElliUniversità degli Studi di Roma “La Sapienza”
Daniela GhisottiUniversità degli Studi di Milano
Ennio GiordanoUniversità degli Studi di Napoli “Federico II”
Roberto MantovaniUniversità degli Studi di Milano
Liana MarcucciUniversità degli Studi di Roma “La Sapienza”
Giuseppe SacconeUniversità degli Studi di Napoli “Federico II”
Traduzione a cura di�
Revisione a cura di�
Prof. Luciano Gaudio Dipartimento delle Scienze Biologiche Facoltà di Scienze MM.FF.NN.Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Prof. Catello Polito Dipartimento delle Scienze Biologiche Facoltà di Scienze MM.FF.NN.Università degli Studi di Napoli “Federico II”

� A Judy, mia moglie nonché la mia migliore amica
D.P.S.
� Alla mia famiglia, specialmente a Benjamin
M.J.S.
Dedicato�
D. Peter Snustad è Professore presso il Dipartimento diBiologia vegetale dell’Università del Minnesota, Twin Ci-ties. In questa Università ha conseguito la Laurea inScienze, mentre ha conseguito Master e Ph.D. in Geneticapresso l’Università della California, Davis. Durante i suoi43 anni di servizio presso l’Università del Minnesota, ha te-nuto corsi di tutti i livelli dalla biologia generale alla gene-tica biochimica avanzata. Per 20 anni si è occupato dellamorfogenesi del batteriofago T4 e della sua interazione conl’ospite, Escherichia coli. Negli ultimi 23 anni il suo gruppodi ricerca ha studiato il controllo genetico del citoscheletroin Arabidopsis thaliana e la famiglia genica della glutamminasintetasi in Zea mays. Ha lavorato per la Sezione di Studi diCitologia Molecolare dei National Institutes of Health ed èstato Presidente del Meeting Annuale della Genetics So-ciety of America. I suoi riconoscimenti includono i premicommemorativi Morse-Amoco e Stanley Dagley per l’inse-gnamento. Un amore imperituro per la natura canadese loha portato a restare nel vicino Minnesota.
Michael J. Simmons è Professore presso il Diparti-mento di Genetica, Biologia cellulare e Sviluppo dell’Uni-versità del Minnesota, Twin Cities. Ha conseguito la Lau-rea in Biologia al St. Vincent College di Latrobe,Pennsylvania, e Master e Ph.D. in Genetica presso l’Uni-versità del Wisconsin, Madison. È stato titolare di varicorsi, tra cui quelli di genetica e di genetica di popolazioni.È stato inoltre mentore di numerosi studenti impegnati inprogetti di ricerca nel suo laboratorio. Nelle prime fasidella sua carriera ha ricevuto il premio Morse-Amoco perl’insegnamento dall’Università del Minnesota come rico-noscimento ai suoi contributi all’istruzione universitaria.La sua attività di ricerca è incentrata sul significato geneticodegli elementi trasponibili presenti nel genoma di Droso-phila melanogaster. Ha lavorato per i comitati di consulenzadei National Institutes of Health ed è stato membro del-l’Editorial Board della rivista Genetics per 20 anni. Il patti-naggio artistico, una delle sue attività preferite, è partico-larmente compatibile con il clima del Minnesota.
Gli autori�

Nel preparare questa nuova edizione, è proseguito l’im-pegno per creare un testo che bilanci le nuove conoscenzecon i principi fondamentali. Come nelle precedenti edizio-ni, gli obiettivi principali che ci si è riproposti sono:• Focalizzare i principi fondamentali della genetica
presentando gli importanti concetti di genetica classica,molecolare e di popolazioni con attenzione e in modoapprofondito. La comprensione degli attuali progressi ingenetica e l’apprezzamento del loro significato praticodovrebbero basarsi su un forte fondamento. Inoltre, latrattazione dell’ampiezza e della profondità di ciascunadelle differenti aree della genetica – classica, molecolaree di popolazioni – dovrebbe essere bilanciata e la semprecrescente massa di informazioni in genetica dovrebbeessere organizzata attraverso una rete di concetti chiaverobusta ma flessibile.
• Focalizzare il processo scientifico mostrando come iconcetti scientifici si sviluppino dalle osservazioni e dallasperimentazione. Questo libro fornisce numerosi esem-pi che illustrano come i principi genetici siano emersi dallavoro di differenti scienziati. Viene enfatizzato il con-cetto che la genetica è un processo dinamico di osserva-zioni, sperimentazioni e scoperte. Ad esempio, ogni ca-pitolo contiene un inserto, chiamato Una pietra miliarenella genetica, che focalizza l’attenzione su un importanteavanzamento nella genetica e su come esso abbia avutoorigine. Sono presentate inoltre le evidenze sperimenta-li a sostegno di importanti principi genetici.
• Focalizzare la genetica umana includendo esempi uma-ni e mostrando l’importanza della genetica nella società.L’esperienza ci ha insegnato che i nostri studenti sono in-teressati maggiormente alla genetica umana e che, a causadi questo interesse, comprendono più facilmente concetticomplessi illustrati con esempi umani. Di conseguenza,sono stati utilizzati esempi umani per illustrare i principigenetici ogni volta che è stato possibile. Sono state ancheincluse discussioni su Progetto Genoma Umano, mappa-tura dei geni umani, malattie genetiche umane, terapia
genica e consulenza genetica. Argomenti come lo scree-ning genetico, il DNA fingerprinting, l’ingegneria gene-tica, la clonazione, la ricerca sulle cellule staminali e la te-rapia genica hanno aperto accesi dibattiti sugli aspetti so-ciali, legali ed etici legati alla genetica. È importante riu-scire a coinvolgere gli studenti in discussioni su tali argo-menti e si spera che questo libro di testo possa fornire lorodegli stimoli per farlo.
• Focalizzare lo sviluppo di capacità critiche enfatiz-zando l’analisi dei dati sperimentali e dei problemi. Lagenetica è sempre stata un po’ diversa dalle altre discipli-ne biologiche, a causa della grande importanza data allasoluzione dei problemi. In questo testo è stata sottoli-neata la natura analitica della genetica in molti modi –nello sviluppo dei principi in genetica classica, nella di-scussione degli esperimenti in genetica molecolare e nel-la presentazione dei calcoli in genetica di popolazioni. Intutto il libro è stata messa in risalto l’integrazione delleevidenze sperimentali con l’analisi logica nello sviluppodei concetti chiave. Alla fine di ogni capitolo ci sono duegruppi di problemi risolti – la sezione Esercizi di base, checomprende semplici problemi che illustrano l’analisi ge-netica di base, e la sezione Verifica delle conoscenze, checomprende problemi più complessi che integrano con-cetti e tecniche differenti. Ogni capitolo riporta ancheuna serie di Domande e problemi, che aiuta gli studenti acomprendere i concetti del capitolo e a sviluppare capa-cità analitiche. In questa edizione, ogni capitolo com-prende anche un Approfondimento sulla soluzione dei pro-blemi, un inserto che propone un problema, elenca fatti econcetti pertinenti e quindi analizza il problema e nepresenta una soluzione. Alla fine di ogni capitolo è stataaggiunta una nuova sezione, dal titolo Genomica sul Web,che pone domande a cui si può rispondere visitando il si-to web del National Center for Biotechnology Informa-tion. Grazie a queste sezioni, gli studenti potranno im-parare a utilizzare il vasto archivio di informazioni gene-tiche accessibile via internet e ad applicare le informa-zioni ottenute a specifici problemi.
VII
Negli ultimi anni la scienza della genetica è andata incontroa enormi cambiamenti. Il DNA dei genomi, anche di quellipiù grandi, adesso può essere analizzato in gran dettaglio; lefunzioni dei singoli geni possono essere studiate con unaserie impressionante di nuove tecniche; gli organismi pos-sono essere modificati geneticamente introducendo neiloro genomi geni estranei o alterati. Tutti questi sviluppihanno collocato la genetica al centro di una rivoluzione tec-
nologica che sta interessando l’agricoltura, la medicina e lasocietà. A livello di base, la genetica è diventata una scienzachiave – qualcuno direbbe la scienza chiave – della biologia.Oggi le informazioni e le analisi genetiche sono fondamen-tali per la ricerca in quasi tutte le discipline biologiche. Lanuova edizione di Principi di Genetica è stata preparata inmodo da fornire un’introduzione completa e aggiornata aquesta scienza così importante.
Prefazione�
Obiettivi�

VIII � Prefazione
L’organizzazione di questa edizione di Principi di Gene-tica è simile a quella delle edizioni precedenti. Tuttavia, al-cuni argomenti sono stati approfonditi e molti passaggisono stati riscritti per evidenziare il modo in cui la scienzadella genetica sia cambiata nel corso degli ultimi anni. An-che la grafica è stata completamente modificata. Sono stateincluse molte fotografie nuove, mentre le figure sono stateridisegnate per conferire uno stile chiaro e coerente a tuttoil testo.
Il testo comprende 25 capitoli – due in meno rispettoalla precedente edizione. I Capitoli 1-2 introducono lascienza della genetica, le caratteristiche di base della ripro-duzione cellulare e alcuni degli organismi modello per lagenetica; i Capitoli 3-8 presentano i concetti di geneticaclassica e le procedure di base per l’analisi genetica dei mi-crorganismi; i Capitoli 9-14 presentano gli argomenti dellagenetica molecolare, tra cui la replicazione del DNA, la tra-scrizione, la traduzione, la mutazione e le definizioni digene; i Capitoli 15-18 trattano argomenti più avanzati digenetica molecolare e genomica; i Capitoli 19-22 trattanola regolazione dell’espressione genica e le basi genetichedello sviluppo, dell’immunità e del cancro; i Capitoli 23-25presentano i concetti della genetica quantitativa, di popola-
zioni ed evolutiva. Durante la selezione del materiale da in-cludere in questa edizione di Principi di Genetica, si è cercatodi essere esaurienti ma non enciclopedici. Al fine di conte-nere la lunghezza del testo, sono state prese difficili deci-sioni su cosa includere e cosa escludere e si è dovuto riorga-nizzare parte del precedente materiale per dare spazio asviluppi recenti della ricerca in genetica.
Come nelle precedenti edizioni, si è cercato di produrreun testo che possa essere adattato a differenti tipologie dicorso. Molti insegnanti preferiscono presentare gli argo-menti secondo modalità simili alle nostre, iniziando con lagenetica classica, affrontando poi la genetica molecolare einfine la genetica quantitativa, di popolazioni ed evolutiva.In ogni caso, questo testo è costruito in modo tale da per-mettere ai docenti di presentare i vari argomenti in diffe-renti sequenze. Ad esempio, si può iniziare con la geneticamolecolare di base (Capitoli 9-14), poi presentare la gene-tica classica (Capitoli 3-8) e successivamente procedereverso argomenti più avanzati di genetica molecolare (Capi-toli 15-22), terminando il corso con la genetica quantita-tiva, di popolazioni ed evolutiva (Capitoli 23-25). In alter-nativa, i docenti possono inserire la genetica quantitativa edi popolazioni tra la classica e la molecolare.
Contenuti e organizzazione della quarta edizione�
Questo testo presenta speciali caratteristiche ideate persottolineare la rilevanza degli argomenti discussi, per facili-tare la comprensione di importanti concetti e per assisteregli studenti nel valutare l’apprendimento.• Brevi storie di apertura dei capitoli. Ogni capitolo si
apre con una breve storia che sottolinea l’importanza de-gli argomenti discussi nel capitolo stesso.
• Contenuto del capitolo. I paragrafi principali di cia-scun capitolo sono elencati in maniera appropriata nellaprima pagina del capitolo stesso.
• Sommari dei paragrafi. Il contenuto di ognuno dei pa-ragrafi principali del testo è brevemente riassunto all’ini-zio del relativo paragrafo. Tali sommari di apertura ser-vono a focalizzare l’attenzione sulle idee più importantisviluppate in un capitolo.
• Punti chiave. Questi supporti per l’apprendimento so-no presenti alla fine di ogni paragrafo principale di uncapitolo. Hanno lo scopo di aiutare gli studenti a ripete-re per gli esami e a ricapitolare le idee più importanti delcapitolo.
Approfondimenti. Nel testo, determinati argo-menti sono presentati in inserti di Approfondimento separati.
Il materiale contenuto in tali inserti supporta o sviluppaconcetti, tecniche o strumenti che sono stati introdotti nelcapitolo.
Approfondimenti sulla soluzione dei problemi.Ogni capitolo contiene un inserto che guida gli studenti at-traverso l’analisi e la soluzione di un problema rappresenta-tivo. Sono stati selezionati problemi che riguardano argo-menti importanti presenti nei vari capitoli. L’inserto elencai fatti e i concetti che sono rilevanti per il problema e quindispiega come ottenere la soluzione.
Una pietra miliare nella genetica. Ogni Pietramiliare esplora un avanzamento chiave della genetica – disolito un esperimento o una scoperta. Sono citate le pubbli-cazioni originali concernenti l’argomento della Pietra milia-re e sono incluse due Domande per la discussione per fornireagli studenti l’opportunità di investigare il significato attua-le dell’argomento. Tali domande sono adatte per attività diapprendimento collettivo da svolgere in aula o per temi diriflessione che vanno al di là degli aspetti tecnici dell’analisigenetica.
Organizzazione didattica della quarta edizione�

• Esercizi di base. Alla fine di ogni capitolo sono presen-tati diversi problemi svolti per rinforzare i concetti fon-damentali sviluppati nel capitolo. Questi semplici eserci-zi sono stati concepiti per illustrare l’analisi genetica dibase o per enfatizzare informazioni importanti.
• Verifica delle conoscenze. Ogni capitolo presenta an-che alcuni problemi svolti più complessi che aiutano glistudenti a sviluppare le loro capacità analitiche e di riso-luzione dei problemi. I problemi di questa sezione sonoconcepiti per integrare differenti concetti e tecniche.Nell’analisi di ogni problema si cerca di guidare passoper passo lo studente verso la soluzione.
• Domande e problemi. Ogni capitolo termina con unaserie di domande e problemi di varia difficoltà organiz-zati secondo la successione degli argomenti trattati nelcapitolo. Le domande e i problemi più difficili sono indi-cati con numeri arancioni. Questi gruppi di domande eproblemi forniranno agli studenti l’opportunità di po-tenziare la loro comprensione dei concetti proposti neicapitoli e di sviluppare ulteriormente le loro abilità ana-litiche.
• Genomica sul Web. Oggi esiste un vasto assortimentodi siti web in cui sono liberamente accessibili informa-zioni su genomi, geni, sequenze di DNA, organismi mu-tanti, sequenze polipeptidiche, vie biochimiche e rela-zioni evolutive. I ricercatori accedono a queste informa-zioni di routine e gli studenti dovrebbero acquisirvi fa-miliarità. A questo scopo è stata inserita alla fine di ognicapitolo una serie di domande a cui è possibile risponde-re utilizzando il sito web del National Center for Biote-chnology Information (NCBI), che è sponsorizzato da-gli U.S. National Institutes of Health.
• Glossario. Questa sezione del libro definisce i terminipiù importanti. Gli studenti la troveranno utile per farechiarezza sugli argomenti e prepararsi per gli esami.
• Risposte. Alla fine del libro sono state incluse le rispostealle domande e ai problemi con numero dispari.
Prefazione � IX
I docenti che utilizzano il testo a scopo didattico possonorichiedere il materiale iconografico del volume al fine di
preparare presentazioni Power Point o stampare lucidi adalta definizione.
Supporti didattici�

� Capitolo 1 La scienza della genetica 1Il genoma personale 1
Un invito 2
Tre importanti pietre miliari nella genetica 2MENDEL: I GENI E LE REGOLE DELL’EREDITARIETÀ 2WATSON E CRICK: LA STRUTTURA DEL DNA 3IL PROGETTO GENOMA UMANO: LA DETERMINAZIONE
DELLA SEQUENZA DEL DNA E LA CATALOGAZIONEDEI GENI 4
Il DNA come materiale genetico 5REPLICAZIONE DEL DNA: LA PROPAGAZIONE
DELL’INFORMAZIONE GENETICA 5ESPRESSIONE GENICA: L’USO DELL’INFORMAZIONE
GENETICA 6MUTAZIONE: IL CAMBIAMENTO DELL’INFORMAZIONE
GENETICA 8
La genetica e l’evoluzione 9
I livelli dell’analisi genetica 10GENETICA CLASSICA 10GENETICA MOLECOLARE 11GENETICA DI POPOLAZIONI 11
La genetica nel mondo: le applicazioni della genetica nelle attività umane 11
LA GENETICA IN AGRICOLTURA 11LA GENETICA IN MEDICINA 13LA GENETICA NELLA SOCIETÀ 14
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: ��X174, il primo genoma a DNA di cui è stata determinata la sequenza 14
� Capitolo 2 La riproduzione cellulare e gliorganismi modello in genetica 18Dolly 18Le cellule e i cromosomi 19
L’AMBIENTE CELLULARE 19LE CELLULE PROCARIOTICHE ED EUCARIOTICHE 19IL CROMOSOMA: IL SITO IN CUI SONO LOCALIZZATI
I GENI 22LA DIVISIONE CELLULARE 23
La mitosi 24
La meiosi 26MEIOSI I 27MEIOSI II E RISULTATI DELLA MEIOSI 31
La genetica in laboratorio: un’introduzione ad alcuniorganismi modello per la ricerca 33
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Conteggio di cromosomi e cromatidi 34
ESCHERICHIA COLI, UN BATTERIO 34SACCHAROMYCES CEREVISIAE, IL LIEVITO DI BIRRA 35ANIMALI INVERTEBRATI: DROSOPHILA MELANOGASTER,
IL MOSCERINO DELLA FRUTTA, E CAENORHABDITIS ELEGANS, UN VERME CILINDRICO 35
ANIMALI VERTEBRATI: MUS MUSCULUS, IL TOPO, E DANIORERIO, IL PESCE ZEBRA 37
ARABIDOPSIS THALIANA, UNA PIANTA A CRESCITA RAPIDA 37
HOMO SAPIENS, LA NOSTRA SPECIE 38
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: La coltura dicellule umane 39
� Capitolo 3 Mendelismo: i principi alla basedell’ereditarietà 43La nascita della genetica: una rivoluzione scientifica 43Lo studio di Mendel dell’ereditarietà 44
L’ORGANISMO SPERIMENTALE DI MENDEL, IL PISELLO DA ORTO 44
INCROCI TRA MONOIBRIDI: LE LEGGI DELLA DOMINANZA E DELLA SEGREGAZIONE 44
INCROCI TRA DIIBRIDI: LA LEGGE DELL’ASSORTIMENTOINDIPENDENTE 47
Applicazioni delle leggi di Mendel 49IL METODO DEL QUADRATO DI PUNNETT 49IL METODO DELLA BIFORCAZIONE O DELLO SCHEMA
RAMIFICATO 49IL METODO DELLA PROBABILITÀ 49
� APPROFONDIMENTO Regole della probabilità 50
Verifica delle ipotesi genetiche 52IL TEST DEL CHI-QUADRO 52
Principi mendeliani in genetica umana 55ALBERI GENEALOGICI 56SEGREGAZIONE MENDELIANA NELLE FAMIGLIE UMANE 57CONSULENZA GENETICA 57
� APPROFONDIMENTO Probabilità binomiali 58
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Come formulare previsioni in base agli alberigenealogici 59
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Il lavoro diMendel del 1866 60
Indice generale�

XII � Indice generale
� Capitolo 4 Estensioni del mendelismo 67La genetica si diffonde oltre il giardino del monastero diMendel 67Variabilità allelica e funzione genica 68
DOMINANZA INCOMPLETA E CODOMINANZA 68ALLELI MULTIPLI 69SERIE ALLELICHE 70SAGGIO DELL’ALLELISMO DELLE MUTAZIONI GENICHE 70VARIABILITÀ DEGLI EFFETTI DELLE MUTAZIONI 71LA FUNZIONE DEI GENI È LA PRODUZIONE DI POLIPEPTIDI 72PERCHÉ ALCUNE MUTAZIONI SONO DOMINANTI E
ALTRE RECESSIVE? 72
� APPROFONDIMENTO Simboli genetici 73
Azione genica: dal genotipo al fenotipo 75INFLUENZA DELL’AMBIENTE 75EFFETTI DELL’AMBIENTE SULL’ESPRESSIONE DEI GENI
UMANI 75PENETRANZA ED ESPRESSIVITÀ 76INTERAZIONI GENICHE 76EPISTASI 77PLEIOTROPIA 79
Inincrocio: un altro sguardo agli alberi genealogici 80EFFETTI DELL’ININCROCIO 80
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Dalle vie metaboliche ai rapportifenotipici 81
ANALISI GENETICA DELL’ININCROCIO 81
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Gli erroricongeniti del metabolismo di Garrod 84
MISURAZIONE DELLE RELAZIONI GENETICHE 87
� Capitolo 5 Le basi cromosomiche del mendelismo 93Sesso, cromosomi e geni 93I cromosomi 94
IL NUMERO CROMOSOMICO 94I CROMOSOMI SESSUALI 94
La teoria cromosomica dell’ereditarietà 95L’EVIDENZA SPERIMENTALE CHE COLLEGA L’EREDITARIETÀ
DEI GENI AI CROMOSOMI 96IL CROMOSOMA COME INSIEME DI GENI 97LA NON-DISGIUNZIONE COME PROVA DELLA TEORIA
CROMOSOMICA 97LE BASI CROMOSOMICHE DEI PRINCIPI DI MENDEL
DELLA SEGREGAZIONE E DELL’ASSORTIMENTOINDIPENDENTE 99
I geni legati al sesso negli esseri umani 101L’EMOFILIA, UN DISORDINE DELLA COAGULAZIONE
DEL SANGUE LEGATO AL CROMOSOMA X 101IL DALTONISMO, UN DISTURBO GENETICO LEGATO
AL CROMOSOMA X CHE COLPISCE LA VISTA 101
I GENI SUL CROMOSOMA Y UMANO 102
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Percorso dell’eredità legata all’X eautosomica 103
I GENI PRESENTI SIA SUL CROMOSOMA X CHE SUL CROMOSOMA Y 103
� APPROFONDIMENTO Emofilia 104
I cromosomi sessuali e la determinazione del sesso 105LA DETERMINAZIONE DEL SESSO NEGLI ESSERI UMANI 105LA DETERMINAZIONE DEL SESSO IN DROSOPHILA 106LA DETERMINAZIONE DEL SESSO IN ALTRI ANIMALI 107
La compensazione del dosaggio dei geni legati alcromosoma X 108
IPERATTIVAZIONE DEI GENI LEGATI AL CROMOSOMA X NEI MASCHI DI DROSOPHILA 108
INATTIVAZIONE DEI GENI LEGATI AL CROMOSOMA X NELLE FEMMINE DEI MAMMIFERI 108
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: La “stanzadei moscerini” di Morgan 109
� Capitolo 6Variazioni nel numero e nellastruttura dei cromosomi 115Cromosomi, agricoltura e civiltà 115Tecniche citologiche 116
ANALISI DEI CROMOSOMI MITOTICI 116IL CARIOTIPO UMANO 117VARIAZIONI CITOGENETICHE: UNA RASSEGNA GENERALE 118
Poliploidia 119POLIPLOIDI STERILI 120POLIPLOIDI FERTILI 121LA POLIPLOIDIA TESSUTO-SPECIFICA E LA POLITENIA 122
Aneuploidia 123LA TRISOMIA NEGLI ESSERI UMANI 124MONOSOMIA 125
� APPROFONDIMENTO Amniocentesi e biopsia coriale 127
DELEZIONI E DUPLICAZIONI DI SEGMENTI CROMOSOMICI 128
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Schema della non-disgiunzione dei cromo-somi del sesso 128
Riarrangiamenti della struttura cromosomica 130INVERSIONI 130TRASLOCAZIONI 131
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Tjio e Levanscoprono il corretto numero dei cromosomi umani 132
CROMOSOMI COMPOSTI E TRASLOCAZIONI ROBERTSONIANE 132

� Capitolo 7Associazione, crossing over emappe cromosomiche neglieucarioti 140La prima mappa cromosomica al mondo 140Associazione, ricombinazione e crossing over 141
PRIME EVIDENZE DELLA CONCATENAZIONE E DELLA RICOMBINAZIONE 141
IL CROSSING OVER COME BASE FISICA DELLA RICOMBINAZIONE 143
PROVE CHE IL CROSSING OVER DETERMINA RICOMBINAZIONE 145
I CHIASMI E IL MOMENTO DEL CROSSING OVER 145
Mappe cromosomiche 146CROSSING OVER COME MISURA DELLA DISTANZA
DI MAPPA 147MAPPATURA PER RICOMBINAZIONE CON REINCROCI
A DUE PUNTI 147MAPPATURA PER RICOMBINAZIONE CON REINCROCI A TRE
PUNTI 148
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Usare la mappa genetica per predire il risul-tato di un incrocio 151
FREQUENZA DI RICOMBINAZIONE E DISTANZA DI MAPPA 151FREQUENZA DEI CHIASMI E DISTANZA DI MAPPA 153
Mappe citogenetiche 153LOCALIZZAZIONE DEI GENI MEDIANTE L’UTILIZZO
DI DELEZIONI E DUPLICAZIONI 153DISTANZA GENETICA E DISTANZA FISICA 155
Analisi delle tetradi nei funghi 156ANALISI DELLA CONCATENAZIONE E MAPPATURA DEI GENI
IN LIEVITO 157MAPPATURA DEI CENTROMERI USANDO I DATI
DELLE TETRADI ORDINATE 159
Analisi di associazione nell’uomo 161
Ricombinazione ed evoluzione 163SIGNIFICATO EVOLUTIVO DELLA RICOMBINAZIONE 163INVERSIONI COME SOPPRESSORI
DELLA RICOMBINAZIONE 163
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Mappaturadel gene del morbo di Huntington 164
CONTROLLO GENETICO DELLA RICOMBINAZIONE 167
� Capitolo 8 La genetica dei batteri e dei lorovirus 177I batteri con ampio spettro di resistenza agli antibiotici 177
Virus e batteri in genetica 178
La genetica dei virus 178I BATTERIOFAGI T4 E LAMBDA 179MAPPATURA DEI GENI NEI BATTERIOFAGI 182IL BATTERIOFAGO T4: UN CROMOSOMA LINEARE
CON UNA MAPPA GENETICA CIRCOLARE 184
La genetica dei batteri 186GENI MUTANTI NEI BATTERI 187TRASFERIMENTO GENICO UNIDIREZIONALE NEI BATTERI 187
Meccanismi di scambio genetico nei batteri 188TRASFORMAZIONE 189CONIUGAZIONE 192TRASDUZIONE 196PLASMIDI ED EPISOMI 198
� APPROFONDIMENTO Abuso di antibiotici 199
I FATTORI F� E LA SESDUZIONE 200USO DEI DIPLOIDI PARZIALI PER LA MAPPATURA DI GENI
STRETTAMENTE ASSOCIATI 201
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Mappatura dei geni con la coniugazione in E. coli 202
Il significato evolutivo dello scambio genetico nei batteri 203
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA:La coniugazione in Escherichia coli 204
� Capitolo 9 Il DNA e la struttura molecolaredei cromosomi 210La scoperta della nucleina 210Funzioni del materiale genetico 211
Dimostrazione che l’informazione genetica è contenutanel DNA 211
LA PROVA CHE IL DNA MEDIA LA TRASFORMAZIONE 211DIMOSTRAZIONE CHE IL DNA PORTA L’INFORMAZIONE
GENETICA NEL BATTERIOFAGO T2 212DIMOSTRAZIONE CHE IN ALCUNI VIRUS L’INFORMAZIONE
GENETICA È CONTENUTA NELL’RNA 214I VIROIDI, MOLECOLE DI RNA NUDE, INFETTIVE
ED EREDITABILI 215I PRIONI, PROTEINE INFETTIVE ED EREDITABILI 215
Struttura del DNA e dell’RNA 215LA NATURA DELLE SUBUNITÀ CHIMICHE CHE COMPONGONO
IL DNA E L’RNA 216STRUTTURA DEL DNA: LA DOPPIA ELICA 217STRUTTURA DEL DNA: FORME ALTERNATIVE DELLA
DOPPIA ELICA 220
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Calcolare il contenuto in basi del DNA 221
STRUTTURA DEL DNA: SUPERAVVOLGIMENTI NEGATIVIIN VIVO 221
Struttura del cromosoma nei procarioti e nei virus 222
Struttura dei cromosomi negli eucarioti 224COMPOSIZIONE CHIMICA DEI CROMOSOMI
DEGLI EUCARIOTI 224UNA SOLA GRANDE MOLECOLA DI DNA PER
CROMOSOMA 225I TRE LIVELLI DI IMPACCHETTAMENTO DEL DNA
NEI CROMOSOMI DEGLI EUCARIOTI 228CENTROMERI E TELOMERI 232
Indice generale � XIII

XIV � Indice generale
� APPROFONDIMENTO Ibridazione in situ 234
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: La doppiaelica 236
LE SEQUENZE DI DNA RIPETUTE 239
� Capitolo 10 Replicazione del DNA e deicromosomi 244I gemelli monozigoti sono davvero identici? 244Caratteristiche fondamentali della replicazione del DNA in vivo 245
REPLICAZIONE SEMICONSERVATIVA 245
� APPROFONDIMENTO Tecniche di centrifugazione 246
VISUALIZZAZIONE DELLE FORCINE DI REPLICAZIONEMEDIANTE AUTORADIOGRAFIA 248
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Predire il profilo di marcatura con 3H dei cromosomi 249
ORIGINI DI REPLICAZIONE PECULIARI 251REPLICAZIONE BIDIREZIONALE 252
DNA polimerasi e sintesi del DNA in vitro 255LA SCOPERTA DELLA DNA POLIMERASI I IN ESCHERICHIA
COLI 255TANTE DNA POLIMERASI 256DNA POLIMERASI III: LA REPLICASI DI ESCHERICHIA
COLI 257ATTIVITÀ DI CORREZIONE DELLE BOZZE
DELLE DNA POLIMERASI 258
Il complesso apparato della replicazione 260SINTESI CONTINUA DI UN FILAMENTO E SINTESI
DISCONTINUA DELL’ALTRO FILAMENTO 260CHIUSURA COVALENTE DELLE INTERRUZIONI NEL DNA
PER AZIONE DELLA DNA LIGASI 260INIZIO DI CATENE DI DNA CON INNESCHI DI RNA 261SVOLGIMENTO DEL DNA AD OPERA DI ELICASI,
PROTEINE CHE LEGANO IL DNA E TOPOISOMERASI 262L’APPARATO DI REPLICAZIONE: PROTEINE PREINNESCO,
PRIMOSOMI E REPLISOMI 265REPLICAZIONE A CERCHIO ROTANTE 268
Aspetti peculiari della replicazione dei cromosomieucariotici 269
IL CICLO CELLULARE 269REPLICONI MULTIPLI IN OGNI CROMOSOMA 269DUE O PIÙ DNA POLIMERASI A OGNI SINGOLA FORCINA
DI REPLICAZIONE 270DUPLICAZIONE DEI NUCLEOSOMI ALLA FORCINA
DI REPLICAZIONE 271TELOMERASI: LA REPLICAZIONE DELLE ESTREMITÀ
DEI CROMOSOMI 272LUNGHEZZA DEI TELOMERI E INVECCHIAMENTO
NELL’UOMO 273
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Il DNA èreplicato in modo semiconservativo 274
� Capitolo 11 Trascrizione e maturazionedell’RNA 282Conservazione e trasmissione dell’informazione attraversocodici semplici 282Trasferimento dell’informazione genetica: il dogmacentrale 283
TRASCRIZIONE E TRADUZIONE 283CINQUE TIPI DI MOLECOLE DI RNA 284
Il processo dell’espressione genica 286UN INTERMEDIO: L’mRNA 286ASPETTI GENERALI DELLA SINTESI DELL’RNA 286
� APPROFONDIMENTO Prova dell’esistenza di unRNA messaggero instabile 287
Trascrizione nei procarioti 289RNA POLIMERASI: ENZIMI COMPLESSI 289
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Distinzione tra gli RNA trascritti dal DNAstampo virale e quelli trascritti dal DNA stampo dellacellula ospite 290
INIZIO DELLE CATENE DI RNA 290ALLUNGAMENTO DELLE CATENE DI RNA 291TERMINAZIONE DELLE CATENE DI RNA 291TRASCRIZIONE, TRADUZIONE E DEGRADAZIONE
CONTEMPORANEE DELL’mRNA 293
Trascrizione e maturazione dell’RNA negli eucarioti 293TRE RNA POLIMERASI/TRE GRUPPI DI GENI 295INIZIO DELLE CATENE DI RNA 295ALLUNGAMENTO DELLA CATENA DI RNA E AGGIUNTA
DEL CAP DI METIL GUANOSINA AL 5� 297TERMINAZIONE PER TAGLIO DELLA CATENA E AGGIUNTA
DELLA CODA DI POLI(A) AL 3� 298EDITING DELL’RNA: ALTERAZIONE DELL’INFORMAZIONE
CONTENUTA NELLE MOLECOLE DI mRNA 298
Geni interrotti negli eucarioti: esoni e introni 299ALCUNI GENI EUCARIOTICI SONO MOLTO LUNGHI 299INTRONI: SIGNIFICATO BIOLOGICO? 300
Rimozione delle sequenze introniche tramite splicingdell’RNA 300
SPLICING DEI PRECURSORI DEI tRNA: ATTIVITÀ NUCLEASICA E LIGASICA SPECIFICHE 301
SPLICING AUTOCATALITICO 301SPLICING DEI PRE-mRNA: snRNA, snRNP E SPLICEOSOMA 303
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA:Gli introni 304
� Capitolo 12 La traduzione e il codicegenetico 312L’anemia falciforme: gli effetti devastanti dellasostituzione di una singola coppia di basi 312La struttura delle proteine 313
I POLIPEPTIDI: VENTI SUBUNITÀ AMINOACIDICHE DIFFERENTI 313

LE PROTEINE: COMPLESSE STRUTTURE TRIDIMENSIONALI 313
Sintesi proteica: la traduzione 316UNO SGUARDO GENERALE ALLA SINTESI PROTEICA 316COMPONENTI RICHIESTI PER LA SINTESI PROTEICA:
I RIBOSOMI 317COMPONENTI RICHIESTI PER LA SINTESI PROTEICA:
GLI RNA TRANSFER 318TRADUZIONE: LA SINTESI DEI POLIPEPTIDI UTILIZZANDO
STAMPI DI mRNA 321
Il codice genetico 329LE PROPRIETÀ DEL CODICE GENETICO: UNA VISIONE
GENERALE 329TRE NUCLEOTIDI PER CODONE 329LA DECIFRAZIONE DEL CODICE 331CODONI D’INIZIO E DI TERMINAZIONE 331UN CODICE DEGENERATO E ORDINATO 331UN CODICE QUASI UNIVERSALE 332
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Predire sostituzioni aminoacidiche indotteda mutageni 333
Interazioni codoni-tRNA 334RICONOSCIMENTO DEI CODONI DA PARTE DEI tRNA:
IPOTESI DEL VACILLAMENTO 334MUTAZIONI A SOPPRESSORE CHE PRODUCONO tRNA
CON ALTERATE CAPACITÀ DI RICONOSCIMENTO 335
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Ladecifrazione del codice genetico 336
La conferma in vivo della natura del codice genetico 338
� Capitolo 13 Mutazione, riparazione del DNAe ricombinazione 343Xeroderma pigmentosum: un difetto nella riparazione delDNA danneggiato nell’uomo 343La mutazione: fonte della variabilità genetica necessariaper l’evoluzione 344
La mutazione: caratteristiche fondamentali del processo 344
LA MUTAZIONE: SOMATICA O GERMINALE 344LA MUTAZIONE: SPONTANEA O INDOTTA 345LA MUTAZIONE: UN PROCESSO DI SOLITO CASUALE
E NON ADATTATIVO 345LA MUTAGENESI ADATTATIVA, O IN FASE STAZIONARIA,
NEI BATTERI 347LA MUTAZIONE: UN PROCESSO REVERSIBILE 348
La mutazione: effetti fenotipici 349MUTAZIONI CON EFFETTI FENOTIPICI: SOLITAMENTE
DANNOSE E RECESSIVE 349EFFETTI DELLE MUTAZIONI NEI GENI DELLE GLOBINE
UMANE 350LA MUTAZIONE NELL’UOMO: BLOCCHI NELLE
VIE METABOLICHE 351MUTAZIONI LETALI CONDIZIONALI: UN POTENTE
STRUMENTO PER GLI STUDI GENETICI 351
� APPROFONDIMENTO La malattia di Tay-Sachs, una tragedia dell’infanzia 352
Basi molecolari della mutazione 354MUTAZIONI INDOTTE 355MUTAZIONI INDOTTE DA SOSTANZE CHIMICHE 356MUTAZIONI INDOTTE DA RADIAZIONI 358
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Predire sostituzioni aminoacidiche indotteda mutageni chimici 360
MUTAZIONI INDOTTE DA ELEMENTI GENETICI TRASPONIBILI 361
ESPANSIONE DI RIPETIZIONI DI TRIPLETTE NUCLEOTIDICHE E MALATTIE UMANE EREDITARIE 362
Identificazione di sostanze chimiche mutagene: il test diAmes 363
Meccanismi di riparazione del DNA 364RIPARAZIONE DIPENDENTE DALLA LUCE 365RIPARAZIONE PER ESCISSIONE 365ALTRI MECCANISMI DI RIPARAZIONE 366
Malattie umane ereditarie causate da difetti nella riparazione del DNA 368
Meccanismi di ricombinazione del DNA 369LA RICOMBINAZIONE: TAGLIO E RICUCITURA
DELLE MOLECOLE DI DNA 370
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Mullerdimostra che i raggi X sono mutageni 372
LA CONVERSIONE GENICA: SINTESI DI RIPARAZIONE DEL DNAASSOCIATA CON LA RICOMBINAZIONE 374
� Capitolo 14 Definizione del concetto di gene 382Che cos’è la vita? 382Evoluzione del concetto di gene: riassunto 383
Evoluzione del concetto di gene: funzione 385MENDEL: FATTORI COSTANTI CHE CONTROLLANO
I CARATTERI FENOTIPICI 385GARROD: UN GENE MUTANTE-UN BLOCCO METABOLICO 385BEADLE E TATUM: UN GENE-UN ENZIMA 386UN GENE-UN POLIPEPTIDE 386
� APPROFONDIMENTO Genoma umano: quanti geni? 388
Evoluzione del concetto di gene: struttura 388IL CONCETTO ANTERIORE AL 1940: IL FILO DI PERLE 388SCOPERTA DELLA RICOMBINAZIONE ALL’INTERNO
DEL GENE 389RICOMBINAZIONE TRA COPPIE NUCLEOTIDICHE
ADIACENTI 389COLINEARITÀ TRA LA SEQUENZA CODIFICANTE DI UN GENE
E IL SUO PRODOTTO POLIPEPTIDICO 390
Una definizione genetica del gene 393IL TEST DI COMPLEMENTAZIONE COME MEZZO PER DEFINIRE
IL GENE OPERATIVAMENTE 393COMPLEMENTAZIONE INTRAGENICA 395
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Attribuzione delle mutazioni ai geni 398
Indice generale � XV

XVI � Indice generale
LIMITI DELLA VALIDITÀ DEL TEST DI COMPLEMENTAZIONE 399
Il locus rII del batteriofago T4 399I MUTANTI rII SONO LETALI CONDIZIONALI 399IL TEST DI COMPLEMENTAZIONE DIMOSTRA CHE IL LOCUS rII
È COSTITUITO DA DUE GENI 400MAPPATURA DELLE MUTAZIONI rII ATTRAVERSO INCROCI
A DUE FATTORI 400MAPPATURA PER DELEZIONE 400IL LOCUS rII: MOLTE MUTAZIONI IN DUE GENI ADIACENTI 403
Geni nei geni nel batteriofago �X174 404
Relazioni gene-proteina 406SPLICING ALTERNATIVO: ISOFORME PROTEICHE 407
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: L’effetto diposizione cis-trans di Lewis 408
ASSEMBLAGGIO DEI GENI DURANTE LO SVILUPPO: LE CATENE DEGLI ANTICORPI UMANI 408
� Capitolo 15 Le tecniche della geneticamolecolare 418Trattamento del nanismo ipofisario con l’ormone dellacrescita umano 418Tecniche fondamentali usate per identificare, amplificare eclonare i geni 419
LA SCOPERTA DELLE ENDONUCLEASI DI RESTRIZIONE 420LA PRODUZIONE IN VITRO DI MOLECOLE DI
DNA RICOMBINANTE 422AMPLIFICAZIONE DELLE MOLECOLE DI DNA RICOMBINANTE
NEI VETTORI DI CLONAGGIO 422AMPLIFICAZIONE DI SEQUENZE DI DNA TRAMITE
LA REAZIONE DI POLIMERIZZAZIONE A CATENA (PCR) 429
Costruzione e analisi di librerie di DNA 431COSTRUZIONE DI LIBRERIE GENOMICHE 431COSTRUZIONE DI LIBRERIE DI cDNA 431ANALISI DI LIBRERIE DI DNA PER L’ISOLAMENTO DI GENI
D’INTERESSE 432
Mutagenesi sito-specifica utilizzando la PCR 433
L’analisi molecolare di DNA, RNA e proteine 435ANALISI DEL DNA MEDIANTE IBRIDAZIONE PER
SOUTHERN BLOT 435ANALISI DELL’RNA MEDIANTE IBRIDAZIONE PER
NORTHERN BLOT 437
� APPROFONDIMENTO Identificazione del gene mu-tante che causa la fibrosi cistica 438
ANALISI DEGLI RNA CON LA TECNICA RT-PCR 439ANALISI DELLE PROTEINE CON LA TECNICA DEL
WESTERN BLOTTING 439
L’analisi molecolare di geni e cromosomi 441MAPPE FISICHE DI MOLECOLE DI DNA BASATE SUI SITI
DI TAGLIO DEGLI ENZIMI DI RESTRIZIONE 441
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA:Endonucleasi di restrizione 442
SEQUENZE NUCLEOTIDICHE DI GENI E CROMOSOMI 444
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Determinazione delle sequenzenucleotidiche di elementi genetici 448
� Capitolo 16 Genomica 456Prospettive della genetica umana in Islanda 456
� APPROFONDIMENTO GenBank 459
Genomica: un quadro generale 461
Correlazione tra mappe genetiche, citologiche e fisiche deicromosomi 462
MAPPE DEI POLIMORFISMI DI LUNGHEZZA DEI FRAMMENTI DI RESTRIZIONE (RFLP) E DEI MICROSATELLITI 463
MAPPE CITOGENETICHE 464MAPPE FISICHE E BANCHE DI CLONI 465
Clonaggio posizionale dei geni 466CAMMINI CROMOSOMICI 467SALTI CROMOSOMICI 468
Il Progetto Genoma Umano 469MAPPATURA DEL GENOMA UMANO 470SEQUENZIAMENTO DEL GENOMA UMANO 471IL PROGETTO HAPMAP NELL’UOMO 473
Saggi su RNA e proteine per lo studio delle funzioni delgenoma 475
SEQUENZE ESPRESSE 475IBRIDAZIONI SU ARRAY E GENE-CHIP 476UTILIZZO DELLA GREEN FLUORESCENT PROTEIN COME
MARCATORE DELLA SINTESI PROTEICA 477
Genomica comparativa 479BIOINFORMATICA 480GENOMI PROCARIOTICI 482I GENOMI DEI CLOROPLASTI E DEI MITOCONDRI 484I GENOMI MITOCONDRIALI 484I GENOMI CLOROPLASTIDIALI 486GENOMI EUCARIOTICI 486L’EVOLUZIONE DEI GENOMI DEI CEREALI 489L’EVOLUZIONE DEI GENOMI DEI MAMMIFERI 489
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Due bozzedella sequenza del genoma umano 490
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Uso della bioinformatica per lo studio di sequenze di DNA 493
� Capitolo 17 Applicazioni della geneticamolecolare 499Identificazione della mutazione Tay-Sachs in pre-embrioni umani di otto cellule 499Uso della tecnologia del DNA ricombinante perl’identificazione di geni umani 500
LA MALATTIA DI HUNTINGTON 500LA FIBROSI CISTICA 501

� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Analisi per gli alleli mutanti che causano ri-tardo mentale da X fragile 503
Diagnosi molecolare delle malattie umane 505
Terapia genica nell’uomo 506
DNA fingerprint, l’impronta del DNA 511TEST DI PATERNITÀ 512APPLICAZIONI FORENSI 512
Produzione di proteine eucariotiche nei batteri 513L’ORMONE DELLA CRESCITA UMANO 513PROTEINE CON APPLICAZIONI INDUSTRIALI 514
Piante e animali transgenici 515ANIMALI TRANSGENICI: MICROINIEZIONI DI DNA IN UOVA
FECONDATE E TRASFEZIONE DI CELLULE STAMINALIEMBRIONALI 515
PIANTE TRANSGENICHE: IL PLASMIDE TI DI AGROBACTERIUMTUMEFACIENS 517
Genetica inversa: dissezione dei processi biologiciattraverso l’inibizione dell’espressione genica 519
� APPROFONDIMENTO Cibi GM: sono sicuri? 520
RNA ANTISENSO 520MUTAZIONI KNOCKOUT NEL TOPO 522INSERZIONI DI T-DNA E DI TRASPOSONI 524
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Ripetizionidi trinucleotidi e malattie umane 526
INTERFERENZA A RNA 529
� Capitolo 18 Elementi genetici trasponibili 535Il mais: un alimento di base con un retaggio culturale 535Elementi trasponibili: una visione d’insieme 536
Elementi trasponibili nei batteri 537ELEMENTI IS 537TRASPOSONI COMPOSITI 538ELEMENTI Tn3 539L’IMPORTANZA DEI TRASPOSONI BATTERICI IN MEDICINA 540
Elementi trasponibili taglia-e-cuci negli eucarioti 541ELEMENTI Ac E Ds NEL MAIS 541
� APPROFONDIMENTO Barbara McClintock, lascopritrice degli elementi trasponibili 542
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Analizzare l’attività dei trasposoni nel mais 544
ELEMENTI P E DISGENESI DEGLI IBRIDI IN DROSOPHILA 544MARINER, UN TRASPOSONE ANTICO E MOLTO DIFFUSO 546
Retrovirus e retrotrasposoni 547RETROVIRUS 547ELEMENTI RETROVIRUS-SIMILI 549RETROPOSONI 552
Elementi trasponibili nell’uomo 553
Il significato genetico ed evolutivo degli elementitrasponibili 555
I TRASPOSONI E L’ORGANIZZAZIONE DEL GENOMA 555
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA:Trasformazione di Drosophila con elementi P 556
TRASPOSONI E MUTAZIONE 556ASPETTI EVOLUTIVI RIGUARDANTI GLI ELEMENTI
TRASPONIBILI 557
� Capitolo 19Regolazione dell’espressionegenica nei procarioti e nei lorovirus 563Il sogno di d’Hérelle di curare la dissenteria nell’uomo con la terapia fagica 563Espressione genica costitutiva, inducibile e reprimibile 564
Regolazione positiva e negativa dell’espressione genica 566
Operoni: gruppi di geni regolati in modo coordinato 568
L’operone del lattosio in E. coli: induzione e repressioneda catabolita 570
INDUZIONE 570REPRESSIONE DA CATABOLITA 572
� APPROFONDIMENTO Interazioni proteine-DNA checontrollano la trascrizione dell’operone lac 574
L’operone del triptofano in E. coli: repressione e attenuazione 576
REPRESSIONE 576ATTENUAZIONE 576
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Verifica la comprensione dell’operonelac 577
Il batteriofago lambda: repressione dei geni del ciclo liticodurante la lisogenia 581
Sequenza temporale dell’espressione genica durantel’infezione fagica 583
Controllo traduzionale dell’espressione genica 583
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Jacob,Monod e il modello dell’operone 586
Meccanismi di regolazione post-traduzionali 588
� Capitolo 20 Regolazione dell’espressionegenica negli eucarioti 593I tripanosomi africani: un guardaroba di travestimentimolecolari 593Modalità di regolazione dell’espressione genica neglieucarioti: una panoramica 594
Indice generale � XVII

XVIII � Indice generale
LIVELLI DELLA REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI 594TRASCRIZIONE CONTROLLATA DEL DNA 594SPLICING ALTERNATIVO DELL’RNA 595CONTROLLO CITOPLASMATICO DELLA STABILITÀ
DELL’RNA MESSAGGERO 596
Induzione dell’attività trascrizionale da parte di fattoriambientali e biologici 596
LA TEMPERATURA: I GENI HEAT-SHOCK 596LA LUCE: I GENI DELLA RIBULOSIO 1,5-BISFOSFATO
CARBOSSILASI NELLE PIANTE 597MOLECOLE SEGNALE: GENI CHE RISPONDONO
AGLI ORMONI 597
Controllo molecolare della trascrizione negli eucarioti 600LE SEQUENZE DI DNA COINVOLTE NEL CONTROLLO
DELLA TRASCRIZIONE 600PROTEINE COINVOLTE NEL CONTROLLO
DELLA TRASCRIZIONE: FATTORI DI TRASCRIZIONE 602
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Definizione delle sequenze richieste per l’espressione genica 603
Regolazione post-trascrizionale dell’espressione genicamediante RNA interference 604
ASPETTI DELLA RNAi 604
� APPROFONDIMENTO GAL4, un fattore ditrascrizione di lievito 606
FONTI DI SHORT INTERFERING RNA E microRNA 606
Espressione genica e organizzazione cromosomica 609TRASCRIZIONE NELLE ANSE DEI CROMOSOMI
A SPAZZOLA 609TRASCRIZIONE NEI “PUFF” DEI CROMOSOMI POLITENICI 609ORGANIZZAZIONE MOLECOLARE DEL DNA
TRASCRIZIONALMENTE ATTIVO 610RIMODELLAMENTO DELLA CROMATINA 611EUCROMATINA ED ETEROCROMATINA 611SILENZIAMENTO GENICO 612METILAZIONE DEL DNA E IMPRINTING 616AMPLIFICAZIONE GENICA 616
Attivazione e inattivazione di interi cromosomi 618INATTIVAZIONE DEL CROMOSOMA X NEI MAMMIFERI 618IPERATTIVAZIONE DEL CROMOSOMA X IN DROSOPHILA 619
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: La scopertadella RNA interference 620
IPOATTIVAZIONE DEL CROMOSOMA X IN CAENORHABDITIS 622
� Capitolo 21 Il controllo genetico dellosviluppo animale 627Terapia delle cellule staminali 627Organismi modello per l’analisi genetica dellosviluppo 628
ASPETTI GENERALI DELLO SVILUPPO DI DROSOPHILA 628ASPETTI GENERALI DELLO SVILUPPO DI C. ELEGANS 629
Analisi genetica dei programmi di sviluppo 630DETERMINAZIONE DEL SESSO IN DROSOPHILA 631DETERMINAZIONE DEL SESSO IN C. ELEGANS 634
Attività dei geni materni durante lo sviluppo 635GENI A EFFETTO MATERNO 635
� APPROFONDIMENTO Fruitless 636
DETERMINAZIONE DEGLI ASSI DORSO-VENTRALE E ANTERO-POSTERIORE NEGLI EMBRIONI DI DROSOPHILA 637
Attività dei geni zigotici durante lo sviluppo 640SEGMENTAZIONE DEL CORPO 640FORMAZIONE DEGLI ORGANI 642SPECIFICAZIONE DEI TIPI CELLULARI 644
Analisi genetica dello sviluppo nei vertebrati 645
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Dissezione di un programma di differenziamento cellulare usando le mutazioni 646
GENI DEI VERTEBRATI OMOLOGHI A QUELLI DEGLI INVERTEBRATI 646
IL TOPO: MUTAZIONI INSERZIONALI CASUALI E MUTAZIONI KNOCKOUT GENE-SPECIFICHE 647
IL PESCE ZEBRA (ZEBRA FISH): MUTAZIONI KNOCKDOWN CON IL MORFOLINO 648
STUDI CON LE CELLULE STAMINALI DEI MAMMIFERI 649CLONAZIONE RIPRODUTTIVA 650CAMBIAMENTI GENETICI DURANTE IL DIFFERENZIAMENTO
DELLE CELLULE IMMUNITARIE DEI VERTEBRATI 651
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Mutazioniche alterano la segmentazione in Drosophila 652
� Capitolo 22 Le basi genetiche del cancro 659La storia molecolare di una famiglia 659Il cancro: una malattia genetica 660
LE MOLTEPLICI FORME DI CANCRO 660CANCRO E CICLO CELLULARE 661CANCRO E MORTE CELLULARE PROGRAMMATA 661LE BASI GENETICHE DEL CANCRO 662
Oncogeni 662RETROVIRUS CHE INDUCONO TUMORI E
ONCOGENI VIRALI 663OMOLOGHI CELLULARI DEGLI ONCOGENI VIRALI:
I PROTO–ONCOGENI 664ONCOGENI CELLULARI MUTANTI E CANCRO 665RIARRANGIAMENTI CROMOSOMICI E CANCRO 667
Geni oncosoppressori 668CANCRO EREDITARIO E IPOTESI DEI DUE COLPI
DI KNUDSON 668RUOLO DELLE PROTEINE SOPPRESSORI DI TUMORE
NELLE CELLULE 669
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Stima dei tassi di mutazione nelretinoblastoma 671
Vie genetiche che portano al cancro 676
� APPROFONDIMENTO Cancro e consulenza genetica 678
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA:L’identificazione del gene BRCA1 679

� Capitolo 23 Ereditarietà dei carattericomplessi 684Malattie cardiovascolari: una combinazione di fattorigenetici e ambientali 684Caratteri complessi 685
CARATTERI COMPLESSI QUANTIFICABILI 685FATTORI GENETICI E AMBIENTALI INFLUENZANO
I CARATTERI QUANTITATIVI 685PIÙ GENI INFLUENZANO I CARATTERI QUANTITATIVI 685CARATTERI SOGLIA 687
Statistica della genetica quantitativa 687DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA 688LA MEDIA E LA CLASSE MODALE 688LA VARIANZA E LA DEVIAZIONE STANDARD 689
Analisi dei caratteri quantitativi 690L’IPOTESI MULTIFATTORIALE 690SCOMPOSIZIONE DELLA VARIANZA FENOTIPICA 690EREDITABILITÀ IN SENSO LATO 691EREDITABILITÀ IN SENSO STRETTO 691PREVISIONE DEI FENOTIPI 692SELEZIONE ARTIFICIALE 693LOCI DEI CARATTERI QUANTITATIVI 694
� APPROFONDIMENTO Selezione artificiale 695
Correlazioni tra parenti 699CORRELAZIONE DEI FENOTIPI QUANTITATIVI TRA PARENTI 699
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Scoprire la dominanza nei QTL 701
INTERPRETAZIONE DELLE CORRELAZIONI TRA PARENTI 701
Genetica quantitativa del comportamento umano 703INTELLIGENZA 703
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Studio suigemelli separati del Minnesota 704
PERSONALITÀ 705
� Capitolo 24 Genetica di popolazioni 709Una colonia lontana 709La teoria delle frequenze alleliche 710
STIMA DELLE FREQUENZE ALLELICHE 710RELAZIONE TRA FREQUENZE GENOTIPICHE E ALLELICHE:
IL PRINCIPIO DI HARDY-WEINBERG 711APPLICAZIONI DEL PRINCIPIO DI HARDY-WEINBERG 711ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI HARDY-WEINBERG 712UTILIZZO DELLE FREQUENZE ALLELICHE
NELLA CONSULENZA GENETICA 714
La selezione naturale 715SELEZIONE NATURALE A LIVELLO DI GENE 715SELEZIONE NATURALE A LIVELLO DI FENOTIPO 717
La deriva genetica casuale 718CAMBIAMENTI CASUALI DELLE FREQUENZE ALLELICHE 719EFFETTI DELLE DIMENSIONI DELLE POPOLAZIONI 719
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Applicazione della deriva genetica all’isoladi Pitcairn 720
Popolazioni in equilibrio genetico 721SELEZIONE BILANCIATA 721BILANCIAMENTO MUTAZIONE-SELEZIONE 722BILANCIAMENTO MUTAZIONE-DERIVA 723
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: Il principiodi Hardy-Weinberg 724
� Capitolo 25 Genetica evolutiva 730Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 730La nascita della teoria evolutiva 731
LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE DI DARWIN 731GENETICA EVOLUTIVA 732
Variabilità genetica nelle popolazioni naturali 733VARIABILITÀ FENOTIPICA 733VARIABILITÀ DELLA STRUTTURA CROMOSOMICA 734VARIABILITÀ DELLA STRUTTURA DELLE PROTEINE 735VARIABILITÀ DELLE SEQUENZE NUCLEOTIDICHE 736
Evoluzione molecolare 737LE MOLECOLE COME “DOCUMENTI DELLA STORIA
EVOLUTIVA” 737FILOGENESI MOLECOLARE 738TASSI DI EVOLUZIONE MOLECOLARE 740
� APPROFONDIMENTO SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI Uso del DNA mitocondriale per stabilireuna filogenesi 741
L’OROLOGIO MOLECOLARE 742VARIABILITÀ DEI TASSI EVOLUTIVI 743
� APPROFONDIMENTO Tassi evolutivi 744
LA TEORIA NEUTRALE DELL’EVOLUZIONE MOLECOLARE 746EVOLUZIONE MOLECOLARE ED EVOLUZIONE
FENOTIPICA 747
Speciazione 749CHE COS’È UNA SPECIE? 749MODALITÀ DI SPECIAZIONE 750LA GENETICA DELLA SPECIAZIONE 752
Evoluzione dell’uomo 753L’UOMO E LE GRANDI SCIMMIE 753EVOLUZIONE UMANA NEI RESTI FOSSILI 753
� UNA PIETRA MILIARE NELLA GENETICA: La teorianeutrale dell’evoluzione molecolare 754
VARIABILITÀ DELLE SEQUENZE DI DNA E ORIGINE DELL’UOMO 756
Glossario 763
Risposte a domande e problemicon numero dispari 783Indice analitico 801
Indice generale � XIX


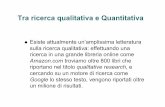







![Glossario Di Genetica [Dispense Genetica Biologia]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5460bdb1af795949708b53b0/glossario-di-genetica-dispense-genetica-biologia.jpg)