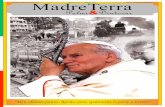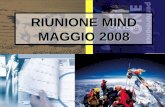NIM.libri . Numero 9 . Maggio 2008
-
Upload
nim-magazine -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of NIM.libri . Numero 9 . Maggio 2008

IN QUESTO NUMERO:
Alberto AbruzzeseL’occhio di Joker. Cinema e modernità p. 2
Sergio BrancatoSenza fine. Immaginario e scrittura della fiction seriale in Italia p. 3
Alessia MandatoRi-mediare la scuola.
Cultura dei media e cultura della scuola: il significato sociale di un processo in fieri p. 5
Roberto Maragliano, Ilaria Margapoti, Ornella Martini, Mario PiredduDidattica e comunicazione di rete. Racconto di un’esperienza universitaria p. 6
Simon MartinCalcio e fascismo. Lo sport nazionale sotto Mussolini p. 7
Andrea PannocchiaTerrorismo e disturbi comunicativi p. 9
Franco RellaScritture estreme. Proust e Kafka p. 10
Jean-Marie SchaefferL’immagine precaria. Sul dispositivo fotografico p. 12
Antonio TursiEstetica dei nuovi media. Forme espressive e network society p. 13
Rubrica di recensioni diNIM - Newsletter Italiana di Mediologiahttp://www.nimmagazine.itNumero 9, maggio 2008
NIM.libri
9

* * *
Alberto AbruzzeseL’OCCHIO DI JOKER. Cinema e modernitàCarocci, Roma 2006pp. 175, € 18,60ISBN 88-430-3804-4
Recensione di Guido Vitiello
In un passo del Manifesto del Partito Comunista che ha per tema lo sviluppo del sistema capitalistico,osserva Fredric Jameson, “Marx ci costringe a fare l’impossibile, ossia a pensare questo sviluppo negativa-mente e insieme positivamente”. Se c’è una cosa da evitare, è “la caduta da questo austero imperativo dia-lettico nella più comoda condizione di prendere posizioni morali”. È stato il peccato mortale dei franco-fortesi, da cui il solo Walter Benjamin si è dimostrato immune, intuendo che l’industria culturale era unasciagura per le stesse ragioni che ne facevano un’occasione di liberazione. Al suo magistero, non per caso,si rifà da trent’anni Alberto Abruzzese.
Proprio dall’“austero imperativo dialettico” di cui parla Jameson sembrano nascere gli scritti raccolti neL’occhio di Joker, saggi e interventi degli ultimi quindici anni che ruotano intorno al nesso tra cinema emodernità – e di conseguenza tra fine del cinema e postmodernità. Curatore della selezione è il giovane stu-dioso Fabrizio Denunzio, il quale nella postfazione ricorda quel giornalista che salutò in Abruzzese “unodegli ultimi hegeliani”; giudizio corretto, a suo dire, “a condizione però di riconoscere che gli ultimi hege-liani (…) sono i primi marxisti”. È vero, aggiungeremmo noi, ma non è tutto. Certo anche qui, come giànell’esordio di Forme estetiche e società di massa (1973) e nelle altre opere dedicate al cinema, la lezionehegeliana sulla morte dell’arte occupa il centro della scena; ma via via che il percorso teorico di Abruzzesesi è arricchito ed evoluto, lasciandosi felicemente contaminare dai suoi oggetti di studio, più che lo Hegel“capovolto” di Marx sembra di vedere all’opera uno Hegel impuro e “imbastardito”, quello passato nel-l’incandescente crogiuolo antropologico del Collège de sociologie e della rilettura di Kojève; uno Hegel incui il negativo, l’eccedente non si annullano, a giochi fatti, nella contabilità razionale della dialettica ma pos-seggono una loro irriducibile sostanza di part maudite. Di più: negli scritti che compongono L’occhio diJoker è ben viva, ancora una volta, la lezione sombartiana e simmeliana sul lusso – o, più sottotraccia, quel-la vebleniana sul consumo vistoso – ma essa si confonde sempre più con l’enfasi di Bataille sulla dissipazio-ne, la dépense, la combustione sacrificale degli ordini culturali. Il consumo, sottratto alle nozioni ristrettedella scienza economica o delle ricerche di mercato, è qui ricondotto alle sue radici antropologiche profon-de; è presentato di volta in volta come riappropriazione, pratica identitaria esercitata a spese del mondo,gesto in cui convergono il massimo della socialità e dell’antisociale, distruzione vorace, perfino tortura, can-nibalizzazione, consumazione del mondo e della barriera che esso oppone ai desideri.
Tutta questa costellazione di significati, nel saggio di apertura Sfigurare il Moderno, è incarnata dallafigura di Joker, l’antagonista di Batman, per com’è raffigurato nella straordinaria rivisitazione di TimBurton, Batman (1989). Nulla di più fuorviante che vedere in questa coppia di rivali una riedizione del con-flitto nicciano tra Apollo e Dioniso, perché Batman, in un certo senso, li incarna entrambi: è lo sdoppia-mento moderno di norma e caos, il garante dell’ordine culturale che però emerge dalle tenebre del crimi-ne, il fondamento extralegale della Legge; Joker al contrario, “non è doppio, ma singolare e multiplo”. Nonha “la determinazione esclusiva dell’individuo, ma l’indeterminazione inclusiva della moltitudine”. È unasemidivinità burlesca e proteiforme, un trickster inafferrabile, o ancora “un dandy post-moderno in cui lafilosofia dell’arte per l’arte si è trasformata in quella del consumo per il consumo”. È il nume tutelare chepresiede alla catastrofe attuale – anche qui: catastrofe non come sciagura, ma come punto di crisi, raduradove le cose si fanno visibili – in cui si passa dai linguaggi unificanti del cinema e della televisione genera-lista agli idioletti barbarici dei personal media.
Questa raccolta di saggi si presenta come la compensazione – aggiungeremmo: come il “lavoro del lutto” –per un’opera mai scritta, una storia del cinema finalmente affrancata dalla sudditanza rispetto al modelloletterario fatto di autori, scuole e poetiche; una storia del cinema riconsegnata al suo territorio di apparte-
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
2

nenza, quello dell’immaginario. Prima ancora che farsi arte tra le arti, il cinema nasce infatti dal bisognosociale di creare una mappa, una segnaletica mentale ed emotiva per leggere il territorio spaesante dellametropoli; è una reazione adattativa a un ambiente selvatico e inospite – non dimentichiamo che il darwi-nismo è nella cassetta degli attrezzi di Abruzzese, memore della lezione di Brunetière “salvata” da FrancoMoretti in Opere Mondo. La televisione nella sua lunga stagione generalista si fa erede di questa vocazione,ma nella fase neotelevisiva Joker è già all’opera, e i grandi schermi unificanti si frantumano e moltiplicanoall’infinito.
L’occhio di Joker si posa dunque sulla nascita e la morte dell’audiovisivo di massa, sulla sua genesi otto-centesca e il suo disfarsi tardonovecentesco. Questa ossessione archeologica e genealogica anima anche glialtri saggi presenti nel volume, e porta Abruzzese a far splendere di luce nuova quelle teorie del cinema –da Canudo a Barjavel – che i manuali non cessano di dismettere come “pionieristiche” o “ingenue”, e cheinvece colgono sia pur confusamente la natura esorbitante del loro oggetto – d’amore prima e più che distudio – guardandosi bene dal rinchiuderlo nel giardinetto delle Belle Arti. Come potrebbero riuscirvi, d’al-tronde? Sarebbe, per usare un’altra metafora cara all’autore, come pretendere di ospitare King Kong nelgabinetto di un naturalista alla Buffon. O come trasformare Batman e Joker in figurine da gipsoteca, inaddomesticati abitanti di un pantheon neoclassico, dimenticando la loro folle rincorsa tra le rovine dellaGrande Città.
Alberto Abruzzese insegna Sociologia della comunicazione alla Liberà Università IULM di Milano, dovedirige anche l’Istituto di Comunicazione. È autore di saggi sulla comunicazione e sui nuovi media, in unlungo percorso teorico che va da Forme estetiche e società di massa (Marsilio 1973) fino a Sociologie dellacomunicazione (Laterza 2007, con Paolo Mancini). Si occupa di politiche culturali ricoprendo il ruolo didirettore del Master in Ideazione, Management e Marketing degli Eventi Culturali presso la Facoltà diScienze della comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma.
* * *
Sergio BrancatoSENZA FINE. Immaginario e scrittura della fiction seriale in ItaliaLiguori, Napoli, 2007pp. 184, € 14,00ISBN 978-88-207-4090-0
Recensione di Emanuela Gatto
Che il consumo di televisione riesca a scindere spettatori e critici non è una novità, anzi: è piuttostobanale considerare radicata la storica divisione tra apocalittici e integrati quanto frequente la sua identifi-cazione nella dicotomia tra il pubblico e chi giudica il pubblico. Solo che oggi l’occhio umanista, capace didiagnosticare in ogni dove la lobotomia del consumatore di fiction, rivela definitivamente di essere affettoda un inguaribile strabismo. Lo stesso che vent’anni fa invece, ai tempi di Sentieri o più tardi in Beautiful,si faceva passare per sguardo divino imperando nell’universo del giudizio; un punto di vista distante, dasempre restio ad accettare l’intercedere dei meccanismi industriali all’interno del panorama culturale.
Sergio Brancato, con quest’ultimo libro, si inserisce nel flusso della letteratura dedicata alla fiction, e neldibattito profondamente attuale sulla serialità, suggerendo una riflessione attenta a ripercorrere la storia deiconsumi della televisione italiana, ma soprattutto della sua produzione. Sezionando attentamente gli stra-volgimenti del presente con la lama doppia dello sceneggiatore e del sociologo, interna ed esterna all’uni-verso della produzione culturale, Brancato riconsegna la meccanica ritualizzante della scrittura creativa alleradici della modernità identificandone il continuum spazio temporale.
Centro del discorso la ripetizione infinita delle istanze mitiche del nostro immaginario in contenitorisempre nuovi, un processo che rivela la cruciale e molteplice funzione di rinnovare e riadattare i simbolidella cultura, di riconsegnare al pubblico i significati condivisi, familiari, come di riorientare lo sguardoall’interno delle nuove forme e delle nuove estetiche della postmodernità.
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
3

Senza Fine attraversa i paradigmi del sistema romanzesco del feuilleton per arrivare al consumo de-mas-sificato di fine secolo, analizza la complessa diatriba su cui è sorta la televisione italiana nell’era pedagogi-ca per comprendere gli intricati sistemi sottesi alla fine del monopolio con la nascita delle emittenti priva-te, e nello scontro con esse, negli anni Ottanta-Novanta. Oggi il terreno in cui abita la fiction in Italia portaancora con sé un’aridità da rintracciare nella mancanza di coraggio, e nell’eccessivo conservatorismo, diuna produzione che per lungo tempo ha creduto di trovare una strategia risolutiva non nello «spingere leforme del medium verso lo spazio “antropologico” della nazione, ma piuttosto nello spostamento di que-sta dentro l’orizzonte culturale della televisione».
In un secondo momento l’analisi ripercorre le vicende della serialità del testo narrativo tratteggiando icontraccolpi innescati dalle visioni di confine provenienti dall’estero quanto le grammatiche in evoluzioneall’interno del nostro panorama culturale, riservando uno sguardo d’eccezione ai meccanismi sottesi allacreazione della sceneggiatura. Muovendosi su un solco abruzzesiano, Brancato invita ad abbandonare loscontro storico tra arte e televisione, tra autore e scrittore seriale, per concepire il testo come la prolifera-zione virale di simboli e, insieme, territorio di ritrovo di gusti e emozioni del pubblico; purchè innestatoall’interno di una dinamica di produzione ad incastro industriale. Una liquidità, quella del postmoderno,che ha rotto definitivamente la struttura della narrazione classica per aprirsi a finali rinviati e al continuorilancio di un’attesa. Ma allo stesso tempo una deriva, ci ricorda l’autore, originaria di altre produzioni,della pittura come della letteratura, e solo successivamente assorbita e maturata nella televisione.Affrontata la complessa evoluzione dell’affrancamento della fiction Brancato ci regala, nella terza e ultimaparte, l’esperienza diretta con il primo vero esperimento, ora del tutto consolidato, di serial italiano: UnPosto al Sole, qui utilizzato come pre-testo per disegnare lo scenario ideale del futuro della scrittura di set-tore dal quale hanno preso le mosse le altre produzioni nazionali.
Complessivamente i tre capitoli mostrano una scorrevole omogeneità, tenuti insieme sostanzialmente dauna prima parte ben delineata in cui viene districato il discorso sull’integrazione delle strategie seriali nel-l’immaginario della nostra società.
All’interno del grande chiacchiericcio fumoso, generato dagli ultimi fenomeni mediatici comeSex&TheCity, Dr.House, E.R, questo testo offre spunti interessanti ad una riflessione ad ampio respiro,senza soffiare con toni banali su polemiche anacronistiche. Se in Italia qualcosa non ha funzionato e nonregge il confronto con l’importazione, se non in rarissime eccezioni, occorre capirne le motivazioni e neces-sariamente provvedere a cambiare la testa oltre che il braccio. Senza Fine può essere letto, da questo puntodi vista, come un’occasione per ragionare concretamente sul presente proiettandosi nel domani: un aspet-to per cui, almeno in fatto di produzione televisiva, il nostro Paese sembra invece zavorrato.
Sergio Brancato insegna Sociologia della Comunicazione di Massa presso l’Università di Salerno, Sociologiadell’Industria Culturale e Elementi di Sceneggiatura all’Università di Napoli “Federico II”. Sceneggiatoredelle soap opera Un posto al Sole e Vivere dal 1996 al 2001, ha scritto Fumetti. Guida ai comics nel sistemadei media (Roma 1994), Sociologie dell’immaginario (Roma 2000), Introduzione alla Sociologia del Cinema(Roma 2001), La città delle luci. Itinerari per una storia sociale del cinema (Roma 2003) e la raccolta di rac-conti Città del sole e della luna (Napoli 2005).
* * *
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
4

Alessia MandatoRI-MEDIARE LA SCUOLA.Cultura dei media e cultura della scuola: il significato sociale di un processo in fieriPensa Multimedia, Lecce 2007pp. 156, € 15ISBN: 8882325296
Recensione di Demetro Ria
Da quando sir Karl Raimund Popper sostenne l’idea che i mezzi di comunicazione di massa dovevanoessere controllati e gestiti da persone competenti, in grado di prevederne le conseguenze (anche quelle inin-tenzionali) e possibilmente in possesso di una adeguata formazione, molto si è fatto e soprattutto dettointorno ai rapporti tra media e società. Anche questo lavoro di Alessia Mandato affronta la questione aper-ta di come leggere e come intervenire produttivamente nel reticolo di relazioni che si producono nell’usoe nella fruizione dei media all’interno del particolare contesto scolastico.
Com’è noto, la scuola è un campo sociale peculiare che storicamente ha ostacolato l’uso di questi stru-menti a fini didattici e, come mostra la stessa autrice, vive ancora oggi uno iato tra “vera” attività didatticae prassi accessorie. Le relazioni dinamiche che si instaurano all’interno del rapporto insegnamento-appren-dimento costituiscono un setting complesso di relazioni tra universi di identità in costante mescolamento.Le esperienze, la quotidianità dei singoli elementi del setting (e dunque docenti, allievi, personale ATA,etc.), si intrecciano in modo vorticoso dando vita a diversi intrecci socio-culturali, e per certi versi a metic-ciamenti identitari, tali da essere difficilmente colti da qualsivoglia sistema di misurazione. Un “ambiente”vitale, come quello della microsocietà classe, richiede una attenzione particolare: locale rispetto alla funzio-ne globale cui essa mira nell’ufficio che esercita. La riflessione della Mandato si sofferma quindi sulla fun-zione dei media in rapporto al mondo giovanile, e allo scopo di sfatare i ben noti pregiudizi sui giovani e illoro rapporto con i media, sottolinea che l’iniziale passività con cui si fruivano (o meglio si subivano) i primimultimedial-tools oggi non può essere più sostenuta come elemento fondamentale di critica. Assistiamoinfatti sempre più di frequente ad eventi mediatici provocati da una lettura oggi più “attiva”, dall’interpre-tazione e riformulazione della funzione di tali strumenti.
Proprio questi eventi richiedono attenzione nella revisione critica della loro responsabilità, e diventa cosìnecessario che una corretta cultura dei media si faccia spazio nell’overcoming prodotto dall’era digitale.Cultura, quindi, che ponga come obiettivo il concreto e fattivo sviluppo di una coscienza critica; ed è lascuola che deve farsi carico di tale obiettivo strategico, senza che ciò sia più demandato ad altre agenzieeducative. Ovviamente, rispetto a quanto finora si è fatto in ambito pedagogico non si può sostenere la“irrilevanza” del rapporto tra uomo-cittadino e media. Secondo l’autrice, poi, una opportuna revisione cri-tica della funzione dei media ed una corretta media education potrebbero concorrere alla revisione deipunti critici della didattica contemporanea e potrebbe anche costituire con un gioco di parole il rimedio algap che si è andato formando tra scuola e società civile e produttiva.
Allo scopo di colmare tale deficit occorre superare l’atteggiamento meramente traslatorio che taluniinsegnanti hanno riservato agli strumenti della medialità (si pensi a quanto è stato detto sull’e-book), unatteggiamento che non può più essere considerato sufficiente vista la funzione sociale che tali dispositivihanno acquisito nel tempo. L’autrice mostra che per ri-mediare allo scollamento prodotto dall’ostracismointellettuale di alcuni e alla tenace pigrizia di altri, occorre ritessere la trama e l’ordito delle relazioni edu-cative. La trama in questo caso è costituita dall’insieme delle procedure educative che vengono messe inatto e che sono controllate dai docenti. Sono questi ultimi, infatti, che nel trasformarsi in media educators,sono protesi verso una responsabilità di guide dell’apprendimento e affiancano gli allievi nell’apprenderele metodologie disciplinari insieme ai contenuti veri e propri. Dall’altra parte, gli allievi imparano a condi-videre il sapere appreso, ricostruiscono l’ordito delle cooperazioni finalizzate al raggiungimento di obietti-vi e sviluppano le competenze metodologiche necessarie per la propria attiva ed efficace partecipazione allanew (digital) society.
Il lavoro raccoglie riflessioni teoriche intrecciate ad analisi di dati riguardanti casi specifici, in particola-re esperienze didattiche localizzate che possono essere considerate best practices; è opportuno sottolinearetuttavia che, essendo tali esempi limitati e ristretti nello stesso territorio di riferimento, non possono esse-
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
5

re considerati rappresentativi di una realtà più grande. Il loro valore resta comunque inalterato se si leggo-no ed interpretano come indirizzo e orizzonte di riferimento per valutare la capacità della media educationdi rispondere in tempi ragionevoli ai gap cui si è accennato.
Alessia Mandato è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazionedell’Università degli Studi del Salento. Si è occupata di media education e di e-learning.
* * *
Roberto Maragliano, Ilaria Margapoti, Ornella Martini, Mario PiredduDIDATTICA E COMUNICAZIONE DI RETE. Racconto di un’esperienza universitariaStripes Edizioni, Rho (MI) 2007pp.150, € 16,00ISBN 978-88-88952-02-4
Recensione di Gian Marco Pinna
La società tecnologica odierna può essere divisa tra emigranti e nativi digitali. I nativi digitali sono lagenerazione che usa le tecnologie con la capacità di chi nasce con esse a disposizione, mentre con emigran-ti ci si riferisce a coloro che hanno appreso ad usarle nel corso della propria esistenza. Allo stesso temponon si può riflettere obiettivamente sulla propria esistenza se non raccontandola ad altri continuamente,accettando di adattare la modalità narrativa in relazione del punto di vista e delle capacità dell’interlocuto-re che interverrà per esprimere opinioni, contribuire con le proprie esperienze e talvolta per fare parte delpercorso. Per rendere possibile ciò è fondamentale che vi sia un’omogeneità culturale e lessicale che age-voli uno scambio reciproco tra gli elementi individuali e quelli appresi nei rapporti comunitari. La naturacomunicativa delle competenze informatiche consente infatti di ridefinire i ruoli dell’apprendimento, cre-ando nuovi scenari che offrono agli studenti opportunità in cui vengono privilegiate le capacità atte a situa-re l’abilità comunicativa in relazione all’uno o all’altro sapere, ossia a poterne fare un uso consapevole.
Didattica e comunicazione di rete è il vissuto esperienziale di un percorso comunicativo del Laboratoriodi Tecnologie Audiovisive dell’Università Roma Tre che ha evidenziato come, con l’utilizzo di strumentitecnologici e tramite la sperimentazione di modalità anche innovative (ma non solo), si realizzi e ottenga unefficace quanto reciproco profitto culturale. Gli utenti hanno avuto a disposizione tecnologie che, oppor-tunamente presentate, non hanno lesinato ad utilizzare per partecipare e apprendere, come mai era statopossibile prima, attraverso una serie di strumenti comunicativi che hanno consentito un’assoluta libertà diespressione dei propri bisogni e la possibilità di accedere a forme di sapere non veicolate o strutturate.
Attribuire all’istruzione universitaria una finalità di formazione delle abilità cognitive svincolata da atti-vità pratiche specifiche vuol dire anche ritenere neutro il contesto nel quale si svolge una certa esperienzarispetto alle capacità che si vogliono sviluppare. L’usuale distinzione tra “comunicatori” e coloro che “subi-scono” la comunicazione è in questo testo volutamente ignorata a favore di un confronto che assecondainvece necessità conoscitive in cui l’utilizzo della tecnologia è solo l’opportuna “modalità” didattica.Le tipologie di e-learning presentate mostrano infatti come la personalizzazione dei tempi e delle modalitàdi apprendimento sia proficua e per il discente che per il docente e di come vi sia un ulteriore vantaggionella condivisione di ambienti dove abitualmente regna, e si insegna, l’individualità. Gli ambienti informa-tici di apprendimento sono difatti orientati a dare enfasi alle fasi di realizzazione della conoscenza, e nonmeramente alla sua riproduzione, tramite anche l’utilizzo di esercitazioni autentiche che offrono alcunerappresentazioni multiple della realtà (come quelle presentate negli articoli di Martini e Pireddu) o altreesperienze tese a favorire la cooperazione attraverso pratiche di negoziazione sociale o momenti di lucidariflessione professionale (come negli interventi di Margapoti e Maragliano).
Proprio Maragliano, nell’ormai lontano “anno informatico” 1996, affermava come i processi informati-vi in ambito scolastico portavano inevitabilmente il superamento delle modalità didattiche lineari e mono-mediale. La conoscenza, utilizzando un concetto caro a Wittgenstein, è un territorio in cui è necessario pas-
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
6

sare ripetutamente da direzioni diverse nello stesso luogo, affinché i contenuti siano riutilizzati e concet-tualmente rivisitati in molteplici occasioni, in tempi e in contesti differenti. In breve, agli studenti è offertala possibilità di acquisire gli strumenti culturali cronologicamente idonei e tecnologicamente adeguati.L’anomia telematica è una reazione a situazioni di carenza o mancanza di integrazione causate da un muta-mento nelle condizioni materiali di esistenza di determinati gruppi sociali a cui non corrisponde, in modoesaustivo, un cambiamento sociale.
È facile compito dedurre come sia una precisa responsabilità di ogni istituzione prevenirne i sintomi oaffrontarne gli effetti: una realtà sempre più tecnologica deve essere necessariamente affrontata anche construmenti sempre più avanzati.
Anche se ricco di spunti teorici, il testo non è scritto da o per sacerdoti del sapere ma da e per coloroche ritengono la comunicazione un bisogno intrinseco della natura umana di fronte alla quale è anche leci-to esprimere la difficoltà di sentirsi non adeguati. Accettare la rete come una dimensione in cui è impera-tiva la comprensione dell’altro, sia dei suoi bisogni che delle aree di criticità, è uno dei presupposti per farecomunicazione e non leggere di comunicazione. L’altro presupposto è la continua pratica comunicativanella consapevolezza che non esiste “il metodo” ma che vi sono individui, come gli studenti e i professoriche nel testo raccontano la loro comune esperienza, capaci di apprendere l’utilizzo degli strumenti tecno-logici esistenti allo scopo di rispecchiare e far vedere agli altri la loro personale realtà e di comprendere,sinceramente, quella altrui.
Roberto Maragliano è professore ordinario all’Università Roma Tre dove insegna “Tecnologie dell’istruzio-ne e dell’apprendimento”. Responsabile del Laboratorio di Tecnologie Audiovisive direttore del master online “Multimedialità per l’e-learning”.Ilaria Margapoti è dottoranda di ricerca in “Innovazione e valutazione dei sistemi di istruzione” pressol’Università Roma Tre.Ornella Martini è professore associato all’Università Roma Tre dove insegna “Comunicazione di rete perl’apprendimento”. È direttore del master on line “La scuola in rete”.Mario Pireddu collabora con il Laboratorio di Tecnologie Audiovisive dell’Università Roma Tre. È dotto-rando di ricerca in “Teoria dell’informazione e della comunicazione” presso l’Università di Macerata.
* * *
Simon MartinCALCIO E FASCISMO.Lo sport nazionale sotto Mussolini[Ed. or. Football and Fascism. The National Game under Mussolini, Berg, Oxford 2004]Traduzione di Giovanni GarbelliniMondadori, Milano 2006pp. 339, € 10,40ISBN 88-04-55566-1
Recensione di Rayco GonzálezTraduzione dallo spagnolo di Marcello Serra
Non ci si deve meravigliare del fatto che Simon Martin inizi il suo lavoro su “calcio e fascismo” con ladescrizione della vittoria della nazionale italiana nel mondiale del 1938 in Francia. Non era infatti una sem-plice vittoria sportiva, come quella casalinga del 1934, dal momento che si trattava della prima dimostra-zione estera di quello che teorici dello sport fascista come Lando Ferretti consideravano il maggior e prin-cipale elemento del regime: la disciplina.
Il fascismo promosse fondamentalmente gli sport di squadra perché considerava come società esempla-re quella in cui l’individuo viene sempre dopo il collettivo, questo al contrario del nazismo che incentravala sua retorica sulla superiorità e purezza razziale. Mussolini, seguace di Le Bon, pensava il calcio comedimostrazione e riflesso della disciplina e dell’unione dell’Italia fascista, tuttavia i fatti di cronaca ci rivela-
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
7

no il persistente, conflittuale, spirito campanilistico; di fronte al tentativo di trasformazione del corpo, lapsiche ed i comportamenti attraverso la diffusione del calcio e l’educazione fisica, i tifosi costringevano allasospensione delle partite per scontri, come quelli della finale scudetto del 1925 tra Bologna e Genoa, chesi giocò 5 volte, l’ultima delle quali a porte chiuse. Mentre il fascismo promuoveva la vittoria di squadra,tra le altre cose perché le immagini dei campioni non rivaleggiassero con quella del Duce, i tifosi fomenta-vano il proprio mutuo odio, fatto che spinse Mussolini a chiedere ufficialmente aiuto ai giornalisti per rag-giungere la desiderata unità. «Oggi il giornalismo sportivo è una forza attiva e vivente nel regno del fasci-smo e deve necessariamente essere all’altezza della propria missione» recita il decreto 29/1929, ed è conquesto spirito che nascono i molti quotidiani e settimanali sportivi dell’epoca: La Gazzetta dello Sport, LoSport Fascista, Il Calcio Illustrato, La Vita Sportiva ecc.
Martin ci racconta come in Inghilterra, Francia e Germania fu la nobiltà a formare le prime organizza-zioni sportive come simbolo di evoluzione della forza dell’individuo. In questo senso De Coubertin vede-va nel pubblico un elemento contingente, attribuendo al superamento personale il vero significato dellosport. Tuttavia esisteva un’altra visione, già presente nell’Olimpiade parigina del 1900. Una volta che que-sta fu inclusa nell’Esposizione Universale, De Coubertin fu significativamente estromesso dall’organizza-zione, con la ragione che i Giochi rispondevano in quel caso a una visione borghese dello sport, che inten-deva l’Olimpiade come spettacolo dell’evoluzione umana. È quest’ultima prospettiva che si afferma in Italia,dove le prime organizzazioni sportive furono appunto fondate da borghesi e si basavano nel gusto per l’os-servazione invece che per il culto del superamento personale – anche per via del fatto che in Italia l’unicoindividuo riconosciuto in quanto tale doveva essere Mussolini.
A riprova di queste tesi Martin descrive come l’architettura futurista avesse come riferimento per la pro-gettazione degli impianti sportivi la massa degli spettatori e, dunque, lo spettacolo. Barbero, uno degliarchitetti protagonisti della rivista Quadrante, affermava: «l’architettura sportiva futurista si occupa dellosport come spettacolo, funziona per l’evento sportivo e per la folla del pubblico». Tuttavia l’architetturaveniva utilizzata con un duplice obiettivo, apparentemente contraddittorio: da un lato si voleva recupera-re il classicismo romano e greco e, con questo, la grandezza imperiale; dall’altro si cercava di creare,mediante una concezione moderna, un luogo per «sviluppare la cultura fisica del collettivo in maniera piùaccurata, ordinandolo in modo da ottenere maggior efficienza e da formare una nuova mentalità» (p. 116).Questa apparente incompatibilità tra architettura antica e futurista scompariva nella prospettiva dei gran-di architetti del fascismo come, ad esempio, Marcello Piacentini, che descriveva lo Stadio del PNF, suagrande opera, come un «antico gimnasium modernizzato».
Martin, che si inserisce nella migliore tradizione dei cultural studies, descrive con attenzione molti altriaspetti della relazione tra calcio e fascismo, ma quello che ci interessava sottolineare in questa sede è comeil libro permetta di osservare lo sviluppo del calcio italiano come sport-spettacolo, sempre legato a un gustodi alto contenuto politico tipico della figura mussoliniana, secondo cui già Giovanni Pisano, nel XIIIº seco-lo, pensava al fascismo nel momento in cui collocava un’aquila nel pulpito del Battistero di Pisa.
Simon Martin è ricercatore alla British School of Rome. Calcio e fascismo ha ricevuto il Lord AberdareLiterary Prize for Sports History nel 2005.
* * *
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
8

Andrea PannocchiaTERRORISMO E DISTURBI COMUNICATIVIIpermedium, S. Maria C. V. (CE) 2007pp. 125, € 12ISBN 978-88-86908-69-6
Recensione di Francesca Marsilio
«Comunicare è difficile»: da tale assunto prende spunto l’analitica e attenta riflessione svolta da AndreaPannocchia nel suo testo. Ma cos’è che ostacola l’agire comunicativo? Quali sono gli errori commessi chehanno interdetto la perfetta trasparenza delle dinamiche di comunicazione? E, inoltre, qual è il filo rossoche collega il terrorismo alla comunicazione?
Il lavoro di ricerca condotto dall’autore parte da considerazioni fondamentali che riguardano l’indivi-duo moderno quale essere affetto da sintomi scaturiti dall’immersione totale in un mondo mediatizzato esopraffatto, al contempo, dal bombardamento costante di notizie, immagini, suoni, del suo trovarsi in unostato di sovraeccitazione tale da renderlo incapace di discernimento. Tra innocentismo e deresponsabiliz-zazione morale ci muoviamo nel mare magnum della comunicazione mediatica con estrema ed enorme dif-ficoltà, sfuggendo a volte alla comprensione della incompleta obiettività di ciò che i media ci propinanocostantemente. Lo scrittore ci conduce direttamente alla realtà dei fatti, sottoponendo alla nostra attenzio-ne case studies quali il caso Gladio, così come è stato affrontato da alcune testate giornalistiche nazionali ele immagini riprese da varie emittenti televisive sugli scontri del G8 di Genova, dimostrando come il giu-dizio e l’attenzione a determinate immagini dipendano esclusivamente da una valutazione soggettiva, impli-cante la predominanza di un determinato punto di vista. Il disturbo comunicativo si origina inoltre, secon-do l’autore, da una forte interrelazione che questo intrattiene con un altro termine: la devianza. Affrontatae analizzata da un’angolazione prettamente sociologica, come fenomeno legato a pratiche, metodi “tra-sgressivi” e “punti di vista alternativi”, si declina anche nel suo carattere plurale di devianze, correlandosial suo aspetto propriamente pericoloso in termini di relativismo nell’attimo in cui si coniuga alla volontà dicostruzione di «tante parziali verità», quali possibili effetti collaterali devianti.
Il ricercatore analizza, inoltre, quella fuorviante relazione che essa stabilisce con la comunicazione. Inbase a tale constatazione i media portano a compimento il proprio ruolo fondamentale, esplicitato nellacapacità di alterazione della realtà stessa, conforme alle aspettative e al desiderio di verità dei pubblici diriferimento, declinandolo nella missione attiva di forti catalizzatori sociali, in grado di far convogliare l’at-tenzione dell’opinione pubblica verso quella che è la loro visione. Una realtà deformata può inoltre, secon-do Pannocchia, influenzare la “visione oggettiva” dei fatti agendo mediante la teoria e la retorica del com-plotto e la tecnica del montaggio: ciò è quanto ci è stato fornito e dimostrato nel film/documentario diMichael Moore, Fahrenheit 9/11, relativo agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, in cui è ben visi-bile quella che è la schiera di pregiudizi volutamente messi in scena dal regista che accompagnano il filonedell’antiamericanismo, quale sentimento avverso, nutrito contro l’integralismo islamico. Spostando l’anali-si da un fatto prettamente politico a uno specificatamente sociologico, lo studioso si concentra su un altrofilm, City of God di Fernando Meirelles, per ragionare in termini di “associazionismo differenziale”, di una“comunicazione interattiva” in cui vengono appresi determinati rapporti, anche di tipo deviante.
Comunicazione, devianza e terrorismo sono dunque i temi cardine del libro, che prende le mosse da unariflessione sull’attentato terroristico al World Trade Center di New York. Nella sua ricostruzionePannocchia ritesse con minuziosità i fili spezzati dall’attentato facendo convergere la nostra attenzione suimotivi scatenanti che hanno appiccato il grande fuoco della distruzione apocalittica della superpotenzaamericana. Nel centellinare fatti ed eventi della storia arabo-musulmana l’indagine si muove oltre la memo-ria storica e l’attualità, entrando negli ambiti specialistici degli studi militari strategici, interrogando edintervistando operatori inviati sul campo di battaglia, al fine di poter meglio comprendere le menti chehanno fornito le direttive per gli attentati terroristici, individuando le sottovalutazioni degli Stati Uniti equelle degli “uomini bomba”. Ma il punto nodale del discorso si concentra su due questioni fondamenta-li: una inerente l’identificazione del nemico, l’altra relativa al significato del terrorismo, additato quale«Male Assoluto, gnosi, nichilismo, terzo totalitarismo», definizioni convogliate nell’identità stessa del ter-rorismo islamico, tra «ordine e disordine», «illusione e tradimenti».
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
9

Per far fronte al pericolo terrorista l’autore lancia una sfida implicita a quelle propriamente tecniche:«l’inclusione comunicativa» è l'invito che chiude la riflessione, una proposta per superare i pregiudizi ana-lizzati e dove la forza “centripeta” della comunicazione è necessaria al superamento delle barriere che inter-feriscono e interdicono il dialogo tra le realtà politiche per la comune lotta e sconfitta dell’agente distur-bante, ossia del terrorismo stesso, per cercare di vedere oltre la realtà dei fatti, tra rapporti di forza e azio-ni coraggiose, di osare al di là del senso comune e individuare delle «strategie cognitive e comunicative dicontrasto».
Andrea Pannocchia, dottore di ricerca in Sociologia della comunicazione, è professore a contratto di Teoriee pratiche del giornalismo e di Sociologia della devianza presso la Facoltà di Scienze Politiche “CesareAlfieri” dell’Università di Firenze. Giornalista pubblicista, è autore di numerosi contributi scientifici suvolumi collettanei e co-autore, con Giovanni Bechelloni, del libro Mirare il futuro (Mediascape Edizioni,Roma-Firenze, 2004). Fa parte della Scuola Fiorentina di Comunicazione e i suoi ultimi temi di studioriguardano la comunicazione disturbata e i conflitti.
* * *
Franco RellaSCRITTURE ESTREME. Proust e KafkaFeltrinelli, Milano 2005pp. 156, € 14ISBN 9788807103940
Recensione di Luca Reitano
«Solo ciò che è inumano è artistico» scriveva Felix Emmel nel 1914 nella sua introduzione al “teatro delsangue”. Ed è esattamente questo – per entrare in medias res – il tratto comune, «lo scoglio metafisico» che,secondo Franco Rella, illumina reciprocamente la scrittura di Kafka e Proust. In un libro denso e acumina-to, Rella affronta da una angolazione inedita il senso complessivo della loro opera e, partendo da una indi-cazione di Walter Benjamin su un possibile confronto tra i due, ne ricerca il punto d’intersezione, che indi-vidua nel carattere estremo delle loro scritture.
Entrambi hanno infatti inteso la scrittura come un «assalto al limite», un luogo o uno «spazio intersti-ziale» tra la scrittura e un oltre che ne rappresenta il nucleo segreto, irrappresentabile, inumano. Un’oltranza che può essere indicata dall’istante del risveglio (che Rella descrive nel secondo capitolo dellibro): una breccia aperta nel modo abituale di essere nel mondo, in cui si annuncia e si rivela qualcosa chesfugge alle maglie del tempo quotidiano, e da cui muove la scrittura di Kafka e di Proust. In questo istan-te, che si configura come una soglia, il tempo si dilata e si arresta facendo intravedere il tempo illimitato,disumano, che è il tempo di un «sentimento di esistenza quale può fremere al fondo di un animale», iltempo della carne, di un oltre che è l’incommensurabile stesso della vita in cui l’io si dissolve: l’istante senzaforma e limite della morte.
Da questo punto di vista il tempo e la morte sono i due temi privilegiati attraverso cui Rella scandagliail senso riposto delle opere kafkiane e proustiane manifestandone il carattere estremo.
Così come diventa decisivo, nell’economia del libro, un altro fondamentale concetto benjaminiano, cheè il tema della frammentazione allegorica. Se l’età moderna si apre con «la rottura del patto tra le parole eil mondo», la scrittura di Proust e Kafka si muove nel solco di questa perdita, di una condizione creatura-le in cui la totalità del simbolo, della felice rispondenza tra le parole e le cose, tra l’esperienza e il raccon-to, è definitivamente perduta. Al suo posto appare un mondo in cui il tutto originario è andato in frantu-mi, una molteplicità di frammenti che si rispecchia nel caleidoscopio d’immagini dell’allegoria Barocca. L’allegoria così comporta una frattura profonda nel rapporto col tempo, in particolare con la dimensionedel passato, che si manifesta soltanto come un abissale «cumulo di rovine» dove si dissolve la continuitàdella storia e delle storie individuali.
Questa frattura metafisica, separando definitivamente i segni dalle cose, rende il mondo infinitamenteinterpretabile e dunque sostanzialmente indicibile (come in Kafka, dove la vicenda dei romanzi non è altro
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
10

che l’esegesi infinita di fatti che rimangono chiusi nella loro enigmaticità). Il compito della letteratura estre-ma appare cosi essere nient’altro che la narrazione dell’impossibilità di ogni narrazione vera: la testimonian-za di una condizione d’esilio tra le macerie. È proprio in questo paradosso che, secondo l’autore, va indi-viduato il tema comune alle scritture di Kafka e Proust: un rapporto con un nucleo duro ed enigmatico cheaffiora dentro la scrittura come qualcosa che rimane non-interpretabile, indicibile, disumano.
Vista in questa luce, la ricerca del tempo perduto di Proust assume tutt’altro significato, e la pienezza deltempo ritrovato – cui sembra alludere «l’istante carico di tempo» cercato da Proust, in cui passato e presen-te sono simultaneamente – si ribalta nel passato livido e irrecuperabile di «un’esperienza defunta» che appar-tiene fatalmente a un io irrimediabilmente altro, che non è più. Il viaggio di Proust nella recherche mostracosì l’affiorare di uomini che assumono i connotati di esseri mostruosi, abitanti «un luogo prolungato senzamisura, perché toccano simultaneamente, come giganti sprofondati negli anni, epoche vissute da loro cosìdistanti, tra le quali tanti giorni sono venuti a collocarsi nel tempo». Fantasmi irriconoscibili a se stessi e aglialtri, i personaggi di Proust appaiono disumanizzati dal tempo, che trascorre separandoli da quel passato chetutta l’opera dell’artista intendeva redimere e riscattare, svelando come la morte, e non la pienezza del temporitrovato, sia «la vera cifra dell’opera proustiana», l’epilogo mostruoso e disumano della recherche.
In Kafka, invece, è il tema ricorrente dell’animalità a farsi figura «della fuga attraverso l’uomo verso ilnon umano». Dal Gregor Samsa delle Metamorfosi al cane de Le indagini di un cane le bestie sono il segnodi questa tensione metafisica che spinge la sua scrittura verso «l’assalto al limite». Venuto meno il senso piùintimo della tradizione (la narrativa di Kafka è una «malattia della tradizione» ricorda Rella citandoBenjamin), che è il proiettarsi del passato nell’avvenire, allo scrittore non rimane altro spazio che quello diuna scrittura intesa come luogo interstiziale, in cui affiora la condizione dell’uomo senza memoria che è«come un animale, meno di un animale, una cosa». Quest’universo inorganico e postumano, un mondo cheha la stessa superficie dura e refrattaria della pietra, è propriamente il nucleo metafisico dell’opera di Kafka,la sua dimensione profetica (un mondo inorganico, fatto di pietra e privato del tempo, tornerà, dopoAuschwitz, nella poesia di Celan).
Per concludere, Scritture estreme è un libro quanto mai necessario perché mette in luce il destino di unaletteratura che si espone al fuoco delle domande che contano (non ultima quella sulla morte) in un tempoin cui queste domande sembrano essersi appannate. Rella ci ricorda così il lato tragico di una scrittura cheper rimanere fedele a se stessa – tentando di dare voce, forma e incarnazione a qualcosa che rimane irrap-presentabile, senza figura – deve uscire fuori da se stessa, traendo dai propri «punti di rottura» il proprioparadossale, necessario, significato.
Franco Rella (Rovereto 1944) insegna Estetica alla facoltà di Design e arti di Venezia. Ha pubblicato numerilibri e saggi tra cui: Bellezza e Verità (1990), L’enigma della bellezza (1991), Miti e figure del Moderno (1993),Le soglie dell’ombra (1994), L’io nello specchio del mondo (1998), Ai confini del corpo (2000), Figure del male(2002), Dall’esilio (2004). Molti dei suoi libri sono stati tradotti in inglese, spagnolo, tedesco e francese.
* * *
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
11

Jean-Marie SchaefferL’IMMAGINE PRECARIA. Sul dispositivo fotografico[Ed. or.: Jean-Marie Schaeffer, L’image précaire. Du dispositif photographique, Paris, Editions du Seuil,1997]Signorini R., Andreani M. (a cura di)CLUEB, Bologna 2006pp. 199, € 18,00ISBN: 88-491-2539-9
Recensione di Gerardo Regnani
La fotografia è «un segno selvaggio». Così la immagina Jean-Marie Schaeffer nel suo saggio tradotto initaliano da Marco Andreani e Roberto Signorini circa vent’anni dopo la sua originaria pubblicazione inFrancia (1997). Questo ritardo è esso stesso un segno dell’ambito “selvatico” in cui, manifestamente, sitrova almeno parte della produzione culturale nostrana a riguardo. In Italia, come sottolinea Signorini nellasua nota introduttiva, è infatti circoscritta, ma più di ogni altra cosa è solitaria e sparpagliata, la realizzazio-ne di testi dedicati alla riflessione teorica inerente questo medium. Ma questo è un altro discorso, peraltroalieno al testo.
Si leggerà invece del carattere «selvaggio» della fotografia, considerato come un segno «intermittente»che è (semmai) tale in fase di realizzazione dell’immagine, ma diviene qualcos’altro, un segno sempre nuovo,per chi poi concretamente lo riceve. Relativamente a quest’ultimo aspetto, l’idea di fondo di Schaeffer è chela fotografia sia sostanzialmente «un segno di ricezione». Nei differenti contesti di ricezione in cui giungel’immagine fotografica - traccia visuale di un eventuale (s)oggetto originario - è, in effetti, un segno sempremolto incerto che veicola una «sostanza semiotica» che può condurre, secondo i casi, a letture anche diame-tralmente opposte tra loro. Da qui i rischi di possibili errate interpretazioni dei segni contenuti nell’immagi-ne; rischi propri di quella ‘flessibilità pragmatica’ che porta la fotografia ad essere utilizzata al servizio dellepiù svariate strategie comunicative. Pragmatica, va specificato, intesa come orientamento all’agire che, dalpunto di vista dell’analisi semiotica, è posto in relazione con chi usa poi i segni «come forme d’azione».
Da questi primi elementi emerge con evidenza il rilievo che un simile testo può avere per uno studiosodi media. Rilievo, ad esempio, in una prospettiva d’analisi mediologica, ove la fotografia assuma la conno-tazione di un cruciale strumento di interazione simbolica, e insieme sociologica, dove essa divenga unpotente strumento di ridefinizione delle relazioni sociali, oltre che semiotica e informazionale.Riguardo a quest’ultima, Schaeffer è interessato al medium anche dal punto di vista della teoria dell’infor-mazione e, più specificatamente, è stimolato dagli aspetti inerenti alle figure dell’emittente e del riceven-te dei flussi fotonici prodotti dagli apparati fotografici e alla natura di canali di informazione degli stessi.Inoltre, l’autore si interessa anche alla dimensione artistica dell’immagine fotografica, e la analizza con glistrumenti della semiotica nell’ottica, si aggiunge, di un valido strumento di analisi dei fenomeni sociali eculturali. Più in dettaglio, ricollegando l’analisi estetica a quella dell’estetico (inteso come visibile), è aCharles S. Peirce e alla sua celebre tripartizione ‘simbolo, icona e indice’, piuttosto che a Ferdinand deSaussure, che l’autore fa riferimento. Il legame della fotografia con il proprio referente è, in effetti, moltoparticolare poiché richiama alla memoria qualcosa che, secondo una celebre affermazione di RolandBarthes , da qualche parte un tempo «è stato».
Da qui all’indicalità il passo sembra essere molto breve. Riprendendo, infatti, le nozioni peirceane, è larelazione indicale, afferma Schaeffer, il principio di provenienza, il vero e proprio arché dell’immagine foto-grafica. Ne derivano le necessarie considerazioni inerenti alle connessioni tra l’aspetto indicale - vale a direla stretta connessione tra la rappresentazione e il suo referente - e la dimensione iconica della fotografia,dove si delineerebbe una similitudine tra lo “sguardo” del medium e la visione umana. La dialettica di que-sta «icona indicale», con il perenne portato di ambiguità dei suoi segni e la conseguente varietà di interpre-tazioni possibili, trasforma il mezzo in una «entità dinamica» che si colloca, in relazione alle diverse situa-zioni di fruizione, lungo un teorico continuum teso fra l’indice e l’icona. Su quest’asse ideale, l’automatici-tà dell’immagine fotografica risente comunque delle forme culturali della rappresentazione che, costante-mente, ne regolamentano sia culturalmente che socialmente la relativa ricezione. Analizzando una fotogra-fia, per quanto questa possa apparire un oggetto semplice all’apparenza, si dovrà tener conto del fatto che
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
12

è caratterizzata da uno statuto semiotico articolato e talvolta difficile da analizzare. Essa può essere anchericonosciuta come «un segno non convenzionale», ma non per questo risulterà sempre perfettamente «tra-sparente». Analogamente ai segni codificati, anche la valutazione di quelli “naturali”, precisa ancoraSchaeffer, è possibile soltanto nell’ambito di una determinata sfera di sapere.
Non è estranea da quest’onere neanche l’analisi dell’utilizzo della fotografia nel campo dell’arte, peral-tro connotato da due aspetti emblematici. Il primo inerente alla constatazione del fatto che l’immaginefotografica è ormai divenuta uno degli elementi fondamentali, un’autentica quintessenza in certi casi, ditanta arte contemporanea. Il secondo, contrapposto, riguarda il parallelo delinearsi di una sorta di pauradel mezzo ad essere se stesso e a tendere, piuttosto, a rifarsi ai modelli espressivi della pittura, riempiendo-si in tal modo di «stereotipi visivi e culturali». Ragioni, queste, per cui Schaeffer definisce la fotografia come«l’arte di tutti i pericoli».
Jean-Marie Schaeffer (1952), già noto in Italia per alcuni suoi saggi, è uno studioso francese specializzatoin estetica e teoria letteraria. Directeur de recherche al CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)e direttore del CRAL (Centre de recherches sur les arts et le langage). Ha scritto: L’arte dell’età moderna.Estetica e filosofia dell’arte dal XVIII secolo ad oggi, Bologna, Il Mulino, 1996; Les Célibataires de l’art. Pourune esthétique sans mythes, Paris, Gallimard, 1996; Addio all’estetica, Palermo, Sellerio, 2002.
* * *
Antonio TursiESTETICA DEI NUOVI MEDIA. Forme espressive e network societyCosta & Nolan, Milano 2007,pp. 180, € 17,40ISBN: 8874370628
Recensione di Alessandra Campo
Le argomentazioni del volume di Antonio Tursi si muovono attraverso una ricca varietà di tematiche:dalla riflessione sul rapporto tra arte e tecnologia dal punto di vista della filosofia quanto degli studiosi deinuovi media - McLuhan in prima linea -, alla perlustrazione dei nuovi territori di sperimentazione dellanet art e della transarchitettura.
Sussiste tuttavia un nesso tra tali questioni, sintetizzabile, ci pare, in quattro categorie fondamentali: laquestione teoretica della relazione conoscitiva nell’epoca della «esteriorizzazione del foro interiore»; i pro-blemi pratici legati alla diffusione della comunicazione “di massa”; il problema delle relazioni sociali e dellacostituzioni di uno spazio di abitabilità all’interno della società della Rete; la domanda, infine sul ruolo del-l’arte nell’età della sua digitalizzazione. Per quanto il testo proponga al lettore una tale eterogeneità di argo-menti, le cui connessioni possono non apparire a prima vista evidenti, non è comunque difficile coglierequella domanda sotto cui si riuniscono i diversi percorsi di indagine: che cosa accade all’arte e all’esteticanella network society, in una società, cioè, letteralmente irretita, innervata dai media della comunicazione?È la questione sul ruolo dell’estetica, disciplina che, smesse le vesti esclusive e tradizionali di una filosofia del genio arti-stico e della creatività, si interroga nuovamente sui “sensi” in relazione al ruolo essenziale che essi svolgono come inter-faccia tra noi e mondo. In questo contesto, l’estetica è posta inevitabilmente in rapporto alla mediologia, laddove le moda-lità percettive attuali appaiono sempre più tecnologicamente ibridate e mai completamente dissociabili dai sistemi dicomunicazione mediatica e di massa.
Così, Tursi evidenzia la necessità di un ripensamento dell’arte, di cui recupera il ruolo di fondazione del«nostro precipuo orizzonte di senso». E’ una posizione in linea con una certa - forse “non detta”, macomunque presente - ereditarietà heideggeriana, della quale vengono recuperati soprattutto gli aspetti“positivi” della riflessione sul rapporto tra arte e tecnica, piuttosto che quelli più propriamente critici. Inparticolare, la domanda sul ruolo istitutivo dell’arte viene riletta attraverso i contribuiti dell’ermeneutica,con particolare riferimento alla nozione gadameriana di “gioco”. Quest’ultima è utilizzata dall’autore per
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
13

interpretare l’interattività quale modalità propria dell’arte digitale, e forse del sentire e dell’agire stessiall’interno della Rete. Un’interpretazione sicuramente non pacifica ma che stimola comunque a porsi il pro-blema della possibilità di relazione e di incontro in uno spazio la cui «liquidità» ne mette sempre di nuovoin questione i confini. Così, lo stesso Tursi: «Che cosa permetterà mai ai cibernauti fluttuanti nello spaziodei flussi […] di riconoscere la presenza dell’altro, degli altri o addirittura dei multipli di sé?». E ancora:in che modo l’arte può rendere abitabile un tale mondo, mediaticamente innervato? Problema dell’abitabi-lità, del sentire – dell’incontro con l’altro e con se stessi.
La proposta dell’autore in risposta a tale questione si muove nella direzione del post-umano: l’“essereall’altezza della tecnica” - già ribadito da Heidegger - viene qui compreso come la necessità che l’uomo con-temporaneo si assuma la responsabilità e la consapevolezza del suo essere naturalmente artificiale: «Non siè all’altezza delle macchine [...] perché si è poco umani, cioè poco dotati delle tecnologie sociali (linguag-gi) necessari ad affrontare il mutamento: non è proprio l’artificiale il naturale peculiare dell’uomo?». Maessere all’altezza della network society vuol dire che la cura politica di cui essa ha bisogno non deve tantocercare uno statuto percettivo e artistico del nostro abitare ormai superato, quanto ripensare radicalmentela novità delle possibilità sensoriali e comunicative della rete. La proposta dell’autore in tal senso recuperala nozione di “percezione distratta” di Walter Benjamin e interpreta il interpreta il click - lo scarto istanta-neo tra i link - come quel salto originario e fondante di cui si nutre ogni viaggio nel ciberspazio, salto chepuò così divenire un possibile spazio dell'incontro e della fondazione socio-politica.
Si tratta del rapporto problematico tra la liquidità della Rete, che sembra consentire l’accesso ad unadimensione interattiva e dialogata - e quindi politica nel senso arendtiano di polis - e la sua radicale inca-pacità di consolidarsi in strutture simboliche comuni che permettano l’effettiva apertura di questo stessospazio politico. L’arte appare, allora, in questo contesto, in bilico tra il suo assorbimento in protocolli disignificato programmabili e ottimizzabili e un suo possibile ruolo di contro-movimento, capace di fondareancora di nuovo uno spazio veramente plurale.
Su questo crinale il testo di Tursi, più che proporre soluzioni definitive, stimola suggestioni e interroga-tivi, e rientra per questo nel più generale quadro di sfida che i media lanciano all'arte e che la mediologiarivolge all’estetica: la ricerca della pensabilità e realizzabilità di un'arte che sia in grado di aprire canalicomunicativi e interrativi dall’interno del sistema mediatico, senza tuttavia lasciarsi omologare ed assorbi-re completamente in esso.
Antonio Tursi è dottore di ricerca in Teoria dell’informazione e della comunicazione e senior fellow delMcLuhan Program in Culture and Technology. Su questi temi ha pubblicato Internet e il Barocco. L’operad’arte nell’epoca della sua digitalizzazione (2004) e ha curato il volume Mediazioni. Spazi, linguaggi e sog-gettività delle reti (2005). Insieme a Derrick de Kerckhove ha pubblicato Alla ricerca della sfera pubblicanell’epoca della connessioni digitali (2004).
* * *
http://www.nimmagazine.it
Redazione:Mario Pireddu ([email protected])Marcello Serra ([email protected])
NIM.libri - http://www.nimmagazine.it/ numero 9, maggio 2008
14