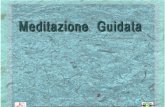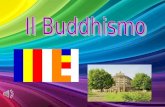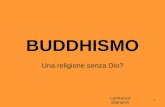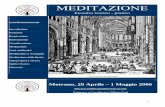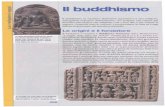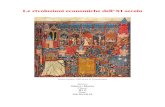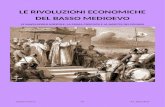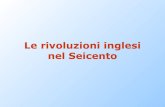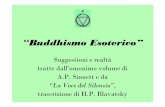Meditazione e Rivoluzioni Psicosociali_Il Buddhismo
-
Upload
sara-marte -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of Meditazione e Rivoluzioni Psicosociali_Il Buddhismo
-
8/17/2019 Meditazione e Rivoluzioni Psicosociali_Il Buddhismo
1/6
Meditazione e rivoluzioni psicosociali: il Buddhismo
di Sara Myriam Marte
1. Premesse
Non sono una praticante buddhista nè un'esperta di Buddhismo. Sono parte del Movimento
Umanista e all'interno di questo mi trovo a praticare varie forme di meditazione e lavori su me
stessa, e a domandarmi come contribuire a un cambiamento positivo nell'ambiente in cui vivo. a
qui il mio interesse per alcuni momenti storici in cui !li esseri umani hanno realizzato delle
trasformazioni positive del mondo in cui vivevano, e in particolare per il Buddhismo antico. "!!i
vorrei condividere delle inquietudini e alcuni aneddoti che mi hanno colpito e appassionato
facendomi pensare a un antecedente di quello che vorremmo fare o!!i come umanisti# un
cambiamento sociale e personale al contempo.
$o scelto di mettere un punto di vista che !uarda alle trasformazioni costruttive che il Buddhismo
ha introdotto nella societ% dell'epoca e l'eredit% positiva che ha lasciato, piuttosto che a quei limiti
che non è stato possibile superare. &n un momento storico di crisi come il nostro mi sembra utile
riscattare la nostra capacit%, come specie, di rinnovarci e fare passi avanti# per questo ho scelto di
soffermarmi sui passi rivoluzionari nei campi psicolo!ico, sociale e culturale che siamo stati in
!rado di fare in un momento di crisi del passato.
Nel definire cosa è positivo o costruttivo prender come linea !uida ci che ha dato pi( di!nit% e
valore alle persone, alla loro u!ua!lianza, al rispetto della diversit% e della libert% di pensiero, al
superamento dei pre!iudizi e della violenza. )uesti sono i cardini dell'umanesimo universalistacome atte!!iamento e, poichè o!ni persona che studia un fenomeno lo !uarda da un particolare
punto di vista, credo sia !iusto rendere esplicito il mio.
*redo inoltre in una coscienza umana attiva e nella storia come frutto dell'a!ire con!iunto dei
popoli, e non di sin!ole personalit% che influenzano masse passive. Non esistono !randi
inse!namenti senza !randi popoli che li facciano propri e le !randi personalit% emer!ono dai popoli
sintetizzandone le ricerche.
2. Il Buddhismo come fenomeno rivoluzionario dal punto di vista dei modi di
pensare e sentire di una società
Ecco il contesto in cui ha luogo il nostro racconto.
Siamo circa +-- anni fa nella vallata dell'&ndo/an!e, ed è un momento di cambiamento. 0rima
d'allora assistevamo a un’or!anizzazione sociale basata sulle trib(# !ruppi umani relativamente
piccoli, che si !overnano attraverso un'assemblea formata dai capifami!lia. & nuclei di queste
societ% sono fami!lie molto allar!ate rispetto alle nostre. al punto di vista dei rapporti umani,
esiste il senso di appartenenza a una comunit%# ci si conosce, c'è solidariet%. 1'economia è
un'economia di sussistenza# d% quello che serve per vivere e non di pi(.0oi l'a!ricoltura, con il suo diffondersi, inizia a produrre un surplus che alimenta i commerci e
l'arti!ianato# sor!ono le citt%, in cui si concentrano i proprietari terrieri e !li appartenenti a queste
-
8/17/2019 Meditazione e Rivoluzioni Psicosociali_Il Buddhismo
2/6
nuove cate!orie di lavoratori. 1e citt% sono circondate dalle campa!ne coltivate, in parte mischiate
con esse2 ancora intorno ci sono le foreste e i boschi, le terre non ancora utilizzate, selvatiche. *ol
commercio aumentano le comunicazioni sia all'interno del subcontinente che con altre aree
!eo!rafiche e culture# l'&ndia commercia con la 0ersia, la /recia, 3oma, e a est la *ina. *'è
circolazione di idee e di visioni del mondo differenti.
Nascono dei veri e propri stati, spesso in !uerra tra loro per espandersi. 4ppaiono le fi!ure dei
sovrani assoluti# le assemblee tribali cedono pro!ressivamente il posto alle monarchie. *'è pi(ricchezza ma nelle citt% !li individui hanno perso quelle relazioni di solidariet% che li sostenevano
nelle trib(. &l tessuto di relazioni sociali rispetto a prima è dis!re!ato# le persone vivono un
anonimato sociale del tutto nuovo. *'è anzi un irri!idimento delle differenze# dalle cate!orie
presenti nel periodo vedico come varna 5colori6 nascono le vere e proprie caste, separate tra loro
da ri!ide re!ole endo!amiche. 7' forte l'emar!inazione verso le popolazioni abori!ene locali,
rele!ate ai lavori pi( umili, praticamente prive di diritti e il solo contatto con le quali è considerato
una forma di contaminazione# ha ori!ine cos8 il !ruppo dei senza casta.
1a reli!ione dal suo canto è in forte crisi. Sta vivendo un momento di esteriorizzazione in cui i
picchi di poesia e profondit% presenti nei 9eda hanno ceduto il passo a un ritualismo esasperato. &l
rituale, in particolare il sacrificio, è visto come una sorta di strumento ma!ico con cui asso!!ettarele forze cosmiche e !li stessi dei. 1a sua corretta esecuzione è l'unica cosa che pu !arantire
prosperit% in questa vita e in quelle future. & prota!onisti dei rituali sono i sacerdoti, i brahmani. &
destinatari delle fortune 5o sfortune, nel caso di un sacrificio non ese!uito correttamente6 sono i
si!nori benestanti che pa!ano per realizzarli. 0i( i rituali sono complessi e costosi 5spesso cruenti,
con l'uccisione di molti animali6, pi( sono considerati efficaci. /ran parte delle attivit% quotidiane,
come il contatto con qualunque forma di sporcizia, con !li animali, con i senza casta, o lo stesso
ciclo mestruale o la nascita, sono viste come contaminanti e richiedono complesse purificazioni
affinchè non producano cattivi frutti nel presente e una cattiva rinascita. Si radica il sentimento
che il benessere e la felicit% in questa vita e in quelle future siano ra!!iun!ibili solo da chi è
benestante# la !ran parte della popolazione, che non pu permettersi di pa!are i sacerdoti per icostosi sacrifici, vede davanti a sè un susse!uirsi di vite se!nate da indi!enza e sofferenze. 1e
donne dal canto loro partecipano ai momenti reli!iosi fondamentalmente come mo!li dei
capofami!lia, ma non hanno alcun ruolo attivo. 1'istruzione, che è essenzialmente istruzione
reli!iosa ed è impartita dai brahmani, è solo per !li uomini e di casta elevata.
'altra parte nelle citt% vive una classe media relativamente libera da oppressione che partecipa di
comunicazione e scambi culturali tra strati sociali e tra diversi popoli.
&n questo contesto, in cui la reli!ione ridotta ad azioni esteriori non pu pi( dissetare lo spirito
umano, nasce una ricerca spirituale intensissima e varie!ata. Molti persona!!i lasciano le citt% e si
rifu!iano nella natura, cioè nelle foreste, fondando scuole di pensiero o vivendo da soli o in piccoli!ruppi come asceti erranti.
Il principe Siddharta otama! il futuro Buddha, lascia il suo palazzo alla ricerca di risposte a un
problema in particolare, quello della sofferenza# cerca un modo per liberare sè e !li altri esseri
umani dal fatto di soffrire. Sperimenta le scuole spirituali pi( affermate del momento, imparando
molto, ma senza rimanerne soddisfatto. :enta la via della mortificazione del corpo, ma capisce che
questa strada lo indebolisce e non produce nessun frutto. Sce!lie cos8 quello che chiamer% il
cammino medio, coltivando uno stile di vita che d% salute al corpo, aiutando cos8 le pratiche
meditative, ma non cerca i piaceri nè !li eccessi. a qui in poi si dedica alla meditazione cercando
al proprio interno le risposte di cui ha biso!no. 1a tradizione vuole che le ra!!iun!a una notte sottoun albero di 0ippala, trovando l'illuminazione e nuove comprensioni. a qui in poi per
quarant'anni si dedicher% a inse!nare un cammino per liberarsi dalla sofferenza.
-
8/17/2019 Meditazione e Rivoluzioni Psicosociali_Il Buddhismo
3/6
Il Buddha si pone in contrasto con molti elementi della società in cui vive. & suoi discorsi,
contenuti nel *anone 0ali, sono pieni di questi punti di vista che non hanno nulla a che fare con
quelli comunemente accettati, anche se il dissenso non è mai espresso con dialettica diretta. 4lcuni
mi hanno colpito particolarmente.
&nnanzitutto, in contrasto con l'esteriorità di quella società, il Buddha porta lo sguardo
sull"esperienza interna degli esseri umani. Non si fa mai menzione, nei suoi discorsi, a forzecosmiche da pie!are nè a divinit% da in!raziarsi. /li dei sono lontani, e anzi a volte sono o!!etto di
una certa compassione, perchè la condizione dell'uomo che si è liberato definitivamente !razie
all'esperienza nel Nirvana è considerata di molto preferibile a quella delle divinit%. 1'o!!etto di
studio è invece il funzionamento della mente, che viene osservata con attenzione, descrivendo
processi e stati. Siamo veramente di fronte a una psicolo!ia di tipo descrittivo 5non interpretativo6.
9iene descritto un cammino con il quale ci si pu liberare dalla sofferenza, conquistando serenit% e
benessere in questa vita, e che contemporaneamente crea le mi!liori condizioni possibili per il
dopo questa vita. 7 questo cammino passa per la meditazione, per la comprensione dei
meccanismi della propria mente, e per un comportamento assolutamente etico, che aiuta !li altri.
*os8 siamo di fronte a un sistema di idee che ha l'uomo al centro ed è assolutamente coerente# ci
che crea benessere vero lo crea per sè e per altri, per il presente e per il futuro.
1a scala di valori viene totalmente riformulata, e il vissuto umano ne diventa il fulcro. *ontaminanti
non sono più i contatti con cose o persone considerate impure, ma !li stati d'animo ne!ativi,
sofferenti. 4lla parola ;arma, che si!nifica azione ma era usata all'epoca dai brahmani soprattutto
per indicare il rituale, viene attribuito un si!nificato totalmente nuovo#
-
8/17/2019 Meditazione e Rivoluzioni Psicosociali_Il Buddhismo
4/6
fami!lia, impartendo inse!namenti come faceva ovunque andasse, e assiste alla morte serena del
padre. opo un certo tempo la madre del Buddha, la re!ina /otami, si reca da lui e !li chiede di
ricevere l'ordinazione come monaca. Ma il Buddha risponde che non è ancora tempo di acco!liere
le donne nel San!ha, e quindi rifiuta. )uindi parte per la citt% di 9esali. Ma la re!ina /otami doveva
avere un bel temperamento. &nfatti, dopo essersi consultata con quella che era stata la mo!lie del
Buddha, raduna le donne di Gapilavastu desiderose come lei di ricevere l'ordinazione, e tutte
indossano l'abito tipico dei monaci, si radono il capo come loro, e si avviano a piedi fino alla dimora
del Buddha. 18, ad avvistarle per primo è 4nanda, discepolo del Buddha e suo cu!ino. 4nanda
promette di intercedere per loro e va dal Buddha, domandado!li# Si!nore, è possibile per una
donna ottenere & frutti supremi della vita spiritualeE >*ertamente?, risponde il Buddha. 7 4nanda
svela delle cinquanta donne in attesa della sua risposta.
$o trovato questa storia interessante per la luce che !etta sulla tenacia delle antiche monache, ma
o!!i, !razie all'analisi delle fonti, sappiamo che non è autentica. 1a verit% è invece che il Buddha
accolse da subito le donne nella sua comunit%, e ce lo svela la testimonianza della monaca
Bhadda. )uesta nei suoi versi racconta come avvenne la sua ordinazione# il Buddha,
semplicemente, le disse >9ieni, Bhadda?, e cos8 lei fu ordinata. "ra, questa formula fu realmente
usata per acco!liere i primi monaci# è la formula di ordinazione pi( antica, che venne presto
trasformata in quella dei :re 3ifu!i, usata tuttora. 1'uso di questa breve frase ci svela che Bhadda fu
tra le prime persone ad essere accolte dal Buddha nel San!ha.
Din dalle ori!ini quindi il Buddha costruisce la propria comunit%, sia di monaci che di se!uaci laici,
con persone di tutte le caste 5e fuori casta, ovviamente6, e con uomini e donne. )uesto ha
conse!uenze enormi, perchè in quell'epoca l'istruzione passava unicamente attraverso la reli!ione.
a questo momento in poi, nelle comunit% buddhiste le donne potranno studiare e discutere di
filosofia2 persone di qualunque ori!ine e di ambo i sessi daranno il loro contributo al sapere. 1o
sviluppo spirituale sar% offerto a tutti e l'imma!ine della felicit%, svincolata dai beni materiali e
associata con forza ad atte!!iamenti praticabili da chiunque, ne diventa alla portata.
Nel *anone 0ali ci sono molti episodi che, autentici o meno, testimoniano un'assoluta volont% di
nondiscriminazione. Uno che ho trovato molto toccante racconta la conversione del temuto
bri!ante 4n!ulimalo. )uesti era, dice il racconto, non solo un predone ma un assassino spietato,
tanto che il suo soprannome si!nifica $ollana di dita< e allude proprio all'uso di fare una collana
con le dita delle proprie vittime. &l Buddha, incontrandolo, ha con lui un colloquio appassionato#
alla fine il criminale !li chiede di ricevere l'ordinazione, il che si!nificava entrare a far parte della
comunità dei monaci e vivere con loro, a fianco del Buddha stesso. 7 questi, senza esitazioni, lo
acco!lie. 1a storia continua mostrandoci la conversione interiore di 4n!ulimalo, che sce!lie unavita fru!ale persino per un monaco e sopporta le vendette dei passanti che, riconoscendolo, !li
lanciano pietre e o!!etti, per poi andare con la testa rotta a cercare consolazione dal Buddha...fino
al momento in cui l'eH bri!ante ra!!iun!e l'illuminazione.
)uesta storia ci porta a un valore simbolo del Buddhismo# la nonviolenza, nelle sue diverse
sfumature, che comprendono il non nuocere ad altri, la sensibilit% ai sentimenti altrui, il rispetto
per le altrui credenze, la coltivazione della concordia. 1a nonviolenza è vissuta come una necessità
interiore, è la via di una mente che non accetta di essere turbata, che rifiuta l'astio e le meschinit à
perchè la allontanano dalla sua meta, la liberazione. Non si tratta solo di evitare azioni che
danne!!ino altri. Si tratta di mantenere uno stato d'animo tranquillo e ben disposto in qualunque
4 5herigatha $anti de&&e #"na$he7, 4.
-
8/17/2019 Meditazione e Rivoluzioni Psicosociali_Il Buddhismo
5/6
circostanza. Nel celebre discorso del 0ara!one della se!a I, il Buddha ricorda ai monaci che le
persone potranno parlare con loro in civile o villano, amorevole o mali!no, sensato o insensato, e
che come è impossibile pensare di svuotare il /an!e della sua acqua, cos8 non si possono eliminare
le azioni altrui che ci sono s!radite. 4llora esorta & monaci, di fronte a qualunque comportamento,
a non esserne turbati, a non lasciarsi sfu!!ire cattive parole e a restare amichevoli e
compassionevoli, senza se!reta malizia. 4ddirittura arriva a dire che anche se dei bri!anti li
ferissero con una se!a loro dovrebbero conservarsi privi di rancore. Non siamo di fronte al
semplice evitare di nuocere, reprimendo la rabbia# non è l'imposizione di un comportamento, ma
la coltivazione di uno stato interno positivo per chi lo sperimenta, non doloroso, a dispetto dei
comportamenti altrui.
7' quindi una nonviolenza interna oltre che esterna, determinata, forte, intelli!ente. 7 lascer à
un'eredità enorme nella cultura del subcontinente. Sarà, due secoli e mezzo dopo, il principio
ispiratore di 4so;a, l'imperatore buddhista che rifiutò la !uerra, protesse tutte le reli!ioni, coltivò
una politica di Jelfare ante litteram. Sarà assorbita dall'&nduismo e rimarrà come patrimonio anche
quando il Buddhismo scomparirà dall'&ndia.
#. $"origine del cam%iamento.
*ome è successo che qualcuno, immerso in un mondo con i suoi valori e le sue credenze, abbia
introdotto prima in sè stesso e poi nella societ% qualcosa di realmente nuovo e positivoE *ome è
stato possibile che un insieme di persone uscisse dai condizionamenti della cultura in cui erano
nate e cresciute iniziando a sentire !li altri come pi( simili a sè, a vivere un'u!ua!lianza che non era
parte della propria educazione, a comunicare una fiducia nell'uomo illimitata in un'epoca di
pessimismo e chiusuraE
)uale esperienza interna ha ispirato questi cambiamentiE
7' difficile dirlo e non ne ho la pretesa. :uttavia ci sono de!li elementi che, nel buddhismo antico,
mi sono saltati a!li occhi.
&l primo è una ricerca che, a priori, punta al superamento della sofferenza propria e altrui. "!ni
esperienza, meditativa o no, viene ricondotta a questo scopo, e assume il proprio si!nificato in
base a questo. Non è lo stesso scoprire tecniche meditative che danno splendide emozioni e usarle
per arricchirsi o al contrario usarle per superare i desideri che mi incatenano. Nel primo caso
continuer a vedere le altre persone come qualcosa da usare2 nel secondo conquister un po' pi(
di libert% e non avr biso!no di usare nessuno, cosa che è un primo passo in un cammino verso la
capacit% di essere solidali.
&l secondo è una costante ricerca della lucidit%. Nei testi si insiste molto su questo punto# la
pratiche sulla lucidit% sono considerate esercizi da praticare quotidianamente, sia per & monaci che
per & laici. 1a >retta presenza mentale? è uno dei punti dell'ottuplice sentiero, che riassume il
percorso per la liberazione. )uesto esercizio a rendersi conto di s@ stessi e di tutto ci che è
intorno ha sicuramente aiutato a non dare per buono tutto quello che veniva dal trasfondo
culturale in cui si era immersi, aumentando la capacit% di critica e di riconoscimento di convinzioni
radicate ma false, illusorie.
&noltre, la conoscenza dei propri meccanismi mentali, la riflessione sulle proprie emozioni e in
6 8aka$9a#a (utta, 0ahi#a Nikaya 21
-
8/17/2019 Meditazione e Rivoluzioni Psicosociali_Il Buddhismo
6/6
!enerale sui propri vissuti, hanno forse permesso di riconoscere quei meccanismi comuni a tutti !li
esseri umani che ci rendono tanto simili, dando vita a quel senso di u!ua!lianza e compassione di
cui abbiamo parlato.
"vviamente, nulla posso dire dell'esperienza spirituale de!li antichi buddhisti in sè, ma le scritture
mi convincono che essa abbia !iocato un ruolo essenziale, dando si!nificato alla vita e aprendo il
futuro.
&. Infine, non sempre ci sono le condizioni perch@ possa esserci un cambiamento radicale nel
trasfondo di una societ%. *ome abbiamo visto, all’epoca del Buddha c’erano alcuni elementi
particolari# una comunicazione tra luo!hi e strati sociali mai avuta prima, la crisi di un sistema di
credenze e valori che non poteva pi( dissetare lo spirito umano, una ribellione a una situazione di
asfissia non solo sociale ma anche culturale e spirituale, unKintensa ricerca nel campo psicolo!ico
spirituale 5una ricerca di felicit% e libert%, in sintesi6 che rispondeva a una nuova sensibilit% ancora
in boccio ma biso!nosa di risposte.
Sono convinta che o!!i ci siano molte caratteristiche in comune con quell’epoca in cui un
cambiamento cos8 importante e positivo sbocci. *Kè un aumento delle comunicazioni mai avuto
prima su scala planetaria. *Kè sicuramente una !rande crisi nei sistemi di valori, mentre quelli che
sopravvivono si mostrano asfissianti, come il mito del denaro2 e cKè una !rande ricerca spirituale
che si manifesta nei modi pi( vari. Ma soprattutto credo che ci sia una sensibilit% nuova che cerca il
modo di manifestarsi.
Bi%liografia
'onti pali
• *anone 0ali, :ipita;a, trad. all'in!lese di aa.vv. , JJJ.accesstoinsi!ht.or!Ltipita;a
• *anone 0ali, Sutta 0ita;a, trad. all'italiano di 7nzo 4lfano, JJJ.sutta.it
• 3. /noli 5a cura di6, 1a 3ivelazione del Buddha & :esti antichi, Mondadori +--=
(utori
• 0. *ornu, izionario del Buddhismo, Mondadori +--
• D. /arcia, $umanism in &ndia, Doundation for $umanization +-=F
• 3. /ombrich, &l 0ensiero del Buddha, 4delphi +-=+
• 9. ha, *aste, Untouchability and Social ustice# 7arly North &ndian 0erspective, Social
Scientist, 9ol. +, =O
• S. 0iano, 1ineamenti di Storia culturale dell'&ndia antica, 1ibreria Stampatori +--F
• P. 3ahula, 1'&nse!namento del Buddha, 0aramita =QF
• Silo, iscorsi, Multima!e =Q
• :hich Nhat $anh, 9ita di Siddhartha il Buddha, Ubaldini =+
• M. :orri, Storia dell'&ndia, 1aterza +-=-
http://www.accesstoinsight.org/tipitakahttp://www.sutta.it/http://www.sutta.it/http://www.accesstoinsight.org/tipitaka