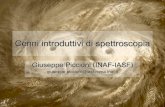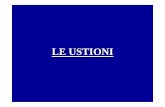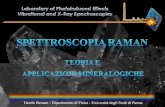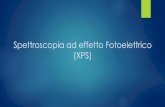La Spettroscopia Ottica Studia La Separazione Di Radiazioni Prodotte Da Una Particolare Sorgente
-
Upload
silvia-squaw-neri -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of La Spettroscopia Ottica Studia La Separazione Di Radiazioni Prodotte Da Una Particolare Sorgente

La spettroscopia ottica studia la separazione di radiazioni prodotte da una particolare sorgente; può suddividersi in spettroscopia atomica, molecolare, elettronica e nucleare. Una combinazione di spettroscopia e fotometria è detta spettrofotometria. Ai tempi di Maxwell , la luce visibile e le radiazioni infrarosse e ultraviolette erano le uniche radiazioni conosciute. Hertz scoprì quelle che oggi sono dette onde radio e verificò che si muovevano con la stessa velocità della luce visibile. L’intero spettro che oggi conosciamo merita l’appellativo di ‘’arcobaleno di Maxwell’’ ed è su questo spettro che gli astronomi indagano l’universo. I corpi possono trasferire energia all’ambiente attraverso tre meccanismi: convezione, conduzione e radiazione (figura 2). Il terzo metodo consiste nello scambio di energia tra il corpo e l’ambiente per mezzo di onde elettromagnetiche, l’energia così trasferita è detta radiazione termica. La teoria dell’irraggiamento termico si ricollega a quella del corpo nero quale sorgente di energia E – si intende per corpo nero, un corpo che assorba il 100% delle radiazioni che gli pervengono – Nel 1894 misure sperimentali portarono J. Stefan e successivamente per via teorica teorica ,da considerazioni termodinamiche, L.Boltzmann alla legge nota
come: legge di Stefan – Boltzman E = σ T 4 dove σ è una costante e T è la temperatura assoluta .Questa
legge, che fa dipendere l’energia emissiva di un corpo dalla quarta potenza della sua temperatura assoluta, riveste particolare importanza perché molti oggetti celesti possono essere considerarti corpi neri (es. Il sole e le stelle). La ‘’luce’’ emessa da un corpo opportunamente eccitato inviata, mediante un sistema di lenti, su di un prisma o reticolo di diffrazione viene scomposta nelle sue componenti e si ottiene uno spettro colorato dal rosso al violetto , non sono visibili, al nostro occhio, le radiazioni infrarosse e quelle ultraviolette.Lo studio degli spettri permette, come per primo Bohr intuì, l’individuazione della specie chimica dell’atomo che assorbe o emette una determinata radiazione elettromagnetica, la cui frequenza (o la lunghezza d’onda) è in relazione con l’energia fornita dal corpo, a specie aventi temperature o composizioni diverse saranno associati spettri diversi (fig). Gli astronomi dall’analisi degli spettri traggono preziose indicazioni in relazione alla temperatura, oltre che alla composizione chimica di un corpo celeste. Gustav Kirchoff ottenne empiricamente tre leggi che spiegavano come luce e materia interaggissero. Egli notò che si possono presentare tre tipi di spettri a seconda delle condizioni: Spettri continui, spettri di emissione a righe, spettri di assorbimento a righe (fig). Gli spettri che si ricavano dall’osservazione delle stelle sono spettri a righe di assorbimento, gli spettri stellari possono essere suddivisi in gruppi, detti tipi spettrali, in base a delle affinità, come il colore o la presenza di certe righe spettrali. In particolare, ci si accorse che il tipo e l'aspetto delle righe variava al variare del colore della stella, la classificazione moderna dei “tipi spettrali” è O,B, A, F, G, K, M, a loro volta divisi in sottoclassi da 0 a 9. Successivamente Wilhelm Wien nell’ambito dei suoi studi elaborò un’espressione che permettesse di calcolare la lunghezza d’onda λmax del picco di emissione di un corpo nero in funzione della sua temperatura T: λmax T = b essendo b una costante, la proporzionalità inversa tra λmax e T suggerisce che tanto più caldo è un oggetto, tanto più piccola è la lunghezza d’onda a cui emetterà radiazione .Tale equazione è stata largamente impiegata nell’ambito dell’interpretazione degli spettri stellari al fine di determinare la temperatura superficiale dei corpi celesti: ad esempio la lunghezza d’onda del picco del sole corrisponde a 502 nm allora la sua temperatura T è pari a: T = b/ λmax = 2.89777 x 10-3 m K/ 5.02 x 10-7 m = 5778 K. La spettroscopia che fino a non molti anni fa richiedeva strumenti complessi e costosi, ora grazie a filtri economici tutti possono accedere al mondo della spettroscopia a bassa risoluzione. A seconda che si tratti di spettroscopia ottica o di altri tipi (infrarossa,ultravioletta, a raggi x, ecc.) vengono adottati strumenti diversi, più o meno sensibili, ma essenzialmente uno spettroscopio è costituito da quattro componenti: l'elemento dispersivo, prisma o reticolo, la fenditura, l’ottica collimatrice e l’ottica della camera o di osservazione.

, definendo il parametro z di Red shift di una sorgente in allontanamento dall’osservatore come:
z=λo
λE
−1= ΔλλE
dove λ0 la lunghezza d’onda di una riga emessa dalla sorgente in riposo eλE la lunghezza
d’onda delle stessa riga quando la sorgente si muove di moto radiale con velocità v rispetto all’osservatore, si
può calcolare la velocità della stella infatti: 1+z=[1+v /c ]/¿ ] il fattore ( vc )
2
può essere trascurato in
quanto la velocità della stella è sempre piccola rispetto a c e quindi abbiamo z = ∆λ / λE = v/c da cui si
ricava v.
altri rivelatori sono l’interferometro di Michelson o il Fabry-Perot entrami votati a misurare le ‘’deformazioni spaziali’’.