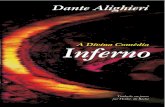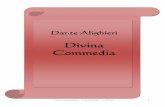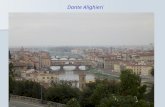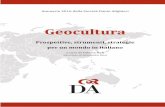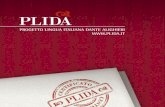La Concezione Politica Di Dante Alighieri e Il Contesto Storico in Cui Nacque
description
Transcript of La Concezione Politica Di Dante Alighieri e Il Contesto Storico in Cui Nacque

Elisa Farris III F
La concezione politica di Dante Alighieri e il contesto storico in cui nacque.
LA CONCEZIONE POLITICA DI DANTEDante Alighieri (1265-1321) aveva una concezione ancora tradizionalista dell’autorità politica, che nel corso del tempo aveva smesso di appartenere al Papa e all’imperatore tedesco, ma durante il Trecento si stava lentamente accentrando nelle mani di nuove figure come il re di Francia o d’Inghilterra.Dante invece sosteneva che il potere fosse collegato direttamente a Dio, e scrisse le proprie teorie in un trattato intitolato De monarchia (1311-1312). Esso è articolato in tre libri.Nel primo, Dante esprime la sua concezione riguardo la duplice natura ed esistenza dell’uomo: quella materiale, ovvero il corpo, con cui egli vive un’esistenza terrena e pertanto temporanea, e quella spirituale, cioè l’anima, mediante cui condurrà una vita eterna. Questa duplice “essenza” dell’uomo è la ragione per cui Dio avrebbe istituito il potere imperiale, assegnando ad egli due strumenti che avrebbe dovuto utilizzare (nella vita terrena la ragione, nella vita ultraterrena la fede). Per mezzo di due “guide”, quali il Papa e l’Imperatore, e servendosi di questi strumenti, secondo Dante l’uomo può raggiungere, nella vita terrena la felicità e in quella ultraterrena la beatitudine.Per Dante, inoltre, l’autorità politica ha il compito primario di limitare l’avidità umana, amministrando la giustizia in caso di controversie e riportando la pace tra le varie classi della società.Nella seconda parte, Dante asserisce che l’esercizio dell’autorità imperiale spetta esclusivamente al popolo romano. Nell’ultima parte, invece, Dante sostiene la tesi secondo cui il potere temporale dell’Imperatore gli è stato attribuito direttamente da Dio, pertanto il Papa non deve intromettervisi. D’altra parte, essendo il ruolo del Papa predominante su quello dell’Imperatore, quest’ultimo non deve intervenire nelle questioni che spettano al Papato.Nella conclusione del De monarchia, Dante attribuisce un certo rilievo alla vita terrena e all’uomo, ma allo stesso tempo esalta la vita ultraterrena, più importante perché più vicina a Dio.DANTE E IL PAPATONel 1313, dopo la morte dell’imperatore tedesco Enrico VII, tenuto in gran considerazione da parte di Dante, costui riprese le sue tesi politiche del De monarchia anche nella Commedia.Qui egli si proclama come profeta condotto da Dio in un viaggio attraverso il regno dei morti per mezzo di una missione profetica. Tale missione aveva lo scopo di annunciare la venuta di Dio per salvare il mondo dal caos, scaturito dalle teorie ierocratiche sostenute da molti pontefici, il cui peccato più grande era l’avidità di beni materiali.Dante sosteneva che l’inviato da Dio per compiere questa missione dovesse essere una figura, ad esempio un imperatore, capace di imporre la propria autonomia su tutti i comuni italiani e sul Papato, che cercava costantemente di arrogarsi il potere temporale.A più riprese Dante andò contro i pontefici che sostenevano una politica ierocratica, in particolare Bonifacio VIII, contro cui egli si era schierato spesse volte, ma non andò mai contro l’istituzione del Papato, perché ritenuto sacro in quanto fondato da Dio stesso.PAPATO E IMPERO NEL TRECENTOIl contesto storico in cui Dante elaborò le sue teorie politiche riguarda il rapporto tra Papato e Impero nel Trecento.Dal 1305, con la nomina del pontefice Clemente V, fino al 1378, i pontefici collocarono la sede pontificia lontano da Roma, per sfuggire al crescente peso

Elisa Farris III F
politico delle nobili famiglie romane. Questa sede fu la città di Avignone, un’area profondamente influenzata dal re di Francia.Dante non accettò il comportamento dei pontefici, e nel 1314 inviò loro una lettera in cui li accusava di aver contribuito al declino della Chiesa, non solo a causa della loro avidità di ricchezze materiali, ma anche per aver abbandonato Roma, ribadendo ancora una volta la sua missione profetica a cui Dio l’aveva inviato.Nello stesso periodo, in Germania fu nominato imperatore Ludovico detto il Bavaro, il quale in breve tempo entrò in conflitto con il Papato, che non gli riconosceva l’autorità politica: nel 1328 Ludovico fece deporre il papa Giovanni XXII, proclamandolo Anticristo.Grazie al prezioso appoggio del filosofo italiano Marsilio da Padova, nello stesso anno Ludovico fu incoronato imperatore. Egli pose la sua sede a Roma e riprese la concezione del suo sostenitore, secondo cui il potere temporale viene attribuito all’imperatore esclusivamente da parte del popolo, dunque non da Dio e non dal Papato.Si giunse infine, nel 1356, a un trattato in cui veniva nominato un gruppo di persone, per lo più principi, con il compito di eleggere l’imperatore. Questo trattato era chiamato Bolla d’oro; esso prevedeva sette principi, tra cui tre ecclesiastici e quattro laici, che amministravano stati autonomi, e portò il titolo imperiale a una regressione in fatto di peso politico, poiché assunse le sembianze di un titolo onorifico e non di una carica con potere universale, quale era stata nei secoli addietro.