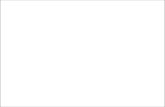IL MOBBING nella GIURISPRUDENZA - newsfemcaveneto.it MOBBING nella... · La sentenza in rassegna,...
Transcript of IL MOBBING nella GIURISPRUDENZA - newsfemcaveneto.it MOBBING nella... · La sentenza in rassegna,...
IL MOBBING nella GIURISPRUDENZA Una tutela frammentata, indiretta e incompleta
1. Condotte inquadrabili nel mobbing 2. Straining: risarcibilità civile e penale 3. Mobbing come violenza privata 4. Mobbing come maltrattamenti in famiglia 5. Mobbing come atto persecutorio (stalking) 6. Mobbing e onere della prova 7. Mobbing e licenziamento 8. Mobbing e responsabilità penale
La sentenza in rassegna, Cassazione penale 3 luglio 2013, n. 28603, conferma che nell'ordinamento giuridico italiano, in assenza di un reato ad hoc per reprimere le vessazioni sul lavoro (previsto, ad esempio in Francia, il
reato di harcèlement moral) [1], la tutela penale dal mobbing risulta essere frammentata, indiretta e incompleta.
Frammentata perché, in ossequio ai principi generali del diritto penale, il legislatore può decidere di non accordare una tutela incondizionata alla lesione o messa in pericolo di certi beni giuridici ma punire solo certe forme di aggressioni all'oggetto della tutela. Tuttavia, nel caso del mobbing, tale risultato non è il frutto di una scelta consapevole del legislatore, quanto piuttosto della sua inerzia (colpevole, visti i solleciti provenienti
dall'Unione europea a intervenire specificamente in materia [2], eccezion fatta per le molestie sessuali sul luogo
di lavoro [3]) delegando così al Giudice l'ingrato compito di garantire indirettamente la sussunzione delle condotte mobbizzanti in fattispecie incriminatrici. E la giurisprudenza, come vedremo, riconosce la rilevanza penale di alcune manifestazioni del fenomeno in analisi, riconducendolo a fattispecie già esistenti all'interno del codice penale (ad esempio, maltrattamenti, minacce, violenza privata, lesioni personali, estorsione, abuso d'ufficio, violenza sessuale, atti persecutori, ecc.).
Tale tutela penale del mobbing, tuttavia, proprio per le ragioni appena indicate, finisce per essere incompleta in quanto deve adattarsi alle ontologiche caratteristiche strutturali delle varie figure criminose: nella pronuncia in esame, infatti, si ribadisce l'orientamento, che tende a cristallizzarsi in Cassazione, secondo il quale «le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rapporto supremazia-soggezione), dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di
supremazia, e come tale destinatario, quest'ultimo, di obblighi di assistenza verso il primo» [4].
La sentenza, seppure mossa dall'intento di evitare il travalicamento di interpretazioni estensive del dettato normativo verso meccanismi analogici in malam partem (che si porrebbero in contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 25 Cost.), finisce per non essere condivisibile in quanto, come vedremo, richiede tra gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti, il requisito della natura para-familiare tra il datore di lavoro e il dipendente, non richiesto, invece, dall'art. 572 cod. pen.
La soluzione della Suprema Corte, quindi, lascia sfornite di tutela le condotte mobbizzanti poste in essere non solo all'interno delle aziende di grandi dimensioni, ma anche di quelle medio-piccole laddove manchi tale tratto di parafamiliarità del rapporto di sovraordinazione, creando palesi disparità di trattamento in quanto non possono
essere certo le dimensioni della società o del contesto lavorativo che rendano o meno punibili le medesime condotte vessatorie di mobbing.
1. CONDOTTE INQUADRABILI NEL MOBBING
Prima di addentrarsi nell'analisi degli spazi di repressione penale del mobbing, conviene verificare la tipologia delle condotte usualmente inquadrate sotto quest'etichetta, «giacché, se è scontato che con tale termine si allude a contrasti insorti sul luogo di lavoro - spesso, ma non solo, nei rapporti tra superiore/subalterno -, d'altro canto bisogna tener presente che non tutti i conflitti lavorativi (alcuni di essi inevitabili) costituiscono mobbing e
meritano quindi di ricevere rilevanza giuridica in senso penale, civilistico o giuslavoristico» [5].
A seconda che tali comportamenti siano assunti sul luogo di lavoro, tra lavoratori pari - ordinati o in rapporto di subordinazione tra loro, si distingue innanzitutto tra mobbing "orizzontale" e mobbing "verticale". Il primo è quello posto in essere tra colleghi, il secondo è quello che si verifica tra superiore gerarchico e sottoposto, e può essere discendente (il c.d. bossing), se è il primo a vessare il secondo, o ascendente se è il sottoposto - più spesso, i sottoposti - a mobbizzare il superiore.
Si è abbondantemente occupata di vessazioni sul luogo di lavoro anzitutto la giurisprudenza civile e del lavoro che tende ad offrire al mobbizzato una tutela di tipo risarcitorio, ascrivendo al datore di lavoro una responsabilità di tipo contrattuale ex art. 2087 cod. civ. o, talvolta, extracontrattuale in base all'art. 2043 cod. civ., nel caso in cui dalla violazione degli obblighi imposti al datore di lavoro sia derivata una lesione dei diritti spettanti al lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro.
In base ad un consolidato orientamento della Suprema Corte, nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.), ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta
illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i suddetti diritti [6].
Tali comportamenti, anche ove non siano determinati ex ante da norme di legge, sono suscettibili di tutela risarcitoria previa individuazione, caso per caso, da parte del giudice del merito, il quale, senza duplicare le voci del risarcimento, è chiamato a discriminare i meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi
di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili - dai danni che vanno invece Risarciti [7].
Fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate rientra il mobbing che designa «comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità, la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica). Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti:
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento
vessatorio [8]; ���
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente [9];
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio» [10].
2. STRAINING: RISARCIBILITÀ CIVILE E PENALE
Secondo la definizione datane dal versante della psicologia, lo straining è una condizione di profondo disagio lavorativo dovuto a demansionamenti, privazioni degli strumenti di lavoro, isolamento professionale e relazionale, trasferimenti illegittimi, ecc. Situazioni in cui il mobbing è escluso dalla mancanza oggettiva ed empiricamente verificata di una frequenza idonea di azioni ostili attive, casi, insomma, in cui le azioni ostili che la vittima ha effettivamente subito sono poche e troppo distanziate nel tempo, spesso addirittura limitate ad una singola azione, come un demansionamento o un trasferimento disagevole.
Studi in materia, hanno accertato che, pur non essendo mobbizzati, le vittime di queste situazioni presentavano ugualmente serie ripercussioni non solo sulla salute in senso stretto, con sintomi psicosomatici anche gravi, spesso sconfinanti nella patologia vera e propria, ma anche a livello di autostima e di qualità di vita in senso lato. In alcuni casi tali effetti erano del tutto paragonabili, se non a volte addirittura più gravi, di quelli derivanti da un'azione mobbizzante vera e propria.
D'altra parte, queste situazioni erano più di quello che poteva essere identificato come stress occupazionale, stress cioè dovuto al tipo o alle condizioni di lavoro. Queste persone infatti erano vittime di un tipo di stress forzato, cioè superiore a quello normalmente richiesto dalle loro mansioni lavorative e diretto nei loro confronti in maniera intenzionale e discriminante: in sostanza, solo a loro - fossero essi una sola persona o un gruppo - veniva riservato quel tipo di trattamento illecito e dannoso. Se non era mobbing e neppure semplice stress occupazionale, doveva oggettivamente e ragionevolmente trattarsi di qualcos'altro a cavallo tra i due. Occorreva semplicemente trovare un nome al loro disagio.
Straining è il termine che si è scelto, con chiara allusione allo stress e con altrettanto evidente differenza con il mobbing. Lo straining in effetti è un fenomeno che potrebbe essere facilmente scambiato per un semplice caso di
stress occupazionale [11], se non fosse per il fatto che la vittima di solito lo percepisce come mobbing, data l'alta componente di intenzionalità e di discriminazione.
Il legame tra straining e stress occupazionale è evidente: in una situazione di straining, l'aggressore (definito strainer) sottomette la vittima facendola cadere in una condizione particolare di stress con effetti a lungo termine. Tale stress può derivare dall'isolamento fisico o relazionale o dalla passività ed indifferenza generale nei
confronti della vittima, dalla privazione, dalla riduzione o dall'eccesso del carico lavorativo [12].
Lo straining ha dapprima trovato riconoscimento nella giurisprudenza di merito. In particolare si segnala una pronuncia del Tribunale di Brescia ove, rifacendosi alle conclusioni del Ctu, ha concluso che la vicenda conflittuale non poteva essere ricondotta nel fenomeno del mobbing (in assenza dei parametri della frequenza delle azioni ostili e della progressione dinamica della vicenda), ma andava inquadrata nel diverso fenomeno dello straining che si definisce come «una situazione lavorativa conflittuale in cui la vittima ha subito azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo, tuttavia tali da provocarle una mortificazione in negativo costante e permanente della sua condizione lavorativa. Lo straining è una sorta di "stress forzato": ciò significa
che la vittima subisce un tasso di stress ben superiore a quello normalmente richiesto dalla sua mansione lavorativa, ovvero che lo stress inflitto alla vittima è superiore a quello dei colleghi o degli altri addetti alla sua stessa mansione o afferenti alla sua stessa qualifica; tale stress viene provocato appositamente e deliberatamente ai suoi danni; per rilevare una situazione di straining deve poi essere presente e attestata almeno un'azione ostile, che abbia una conseguenza duratura e costante a livello lavorativo; la vittima di straining dunque deve aver subito almeno un'azione negativa che non si è esaurita, ma che continua a far sentire i suoi effetti a livello
lavorativo a lungo termine e in modo costante» [13].
Successivamente la Cassazione lavorista, in un'importante pronuncia, pur senza nominarlo direttamente, ha statuito che anche laddove «le diverse condotte denunciate dal lavoratore non si ricompongano in un unicum e non risultano, pertanto, complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignità, ciò non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorché finalisticamente non accumunate, possano risultare, se esaminate separatamente e distintamente, lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati, di cui si è detto (arg. ex Cass. pen., sez. VI, 8
marzo 2006 n. 31413)» [14].
La sentenza in commento, emessa dalla Cassazione penale, sez. VI, 3 luglio 2013, n. 28603, prende atto di taluni comportamenti discriminatori subiti dal lavoratore: la sottrazione di responsabilità in favore di altra dipendente, ingiustificatamente favorita dai suoi dirigenti durante il servizio espletato presso l'unità «Customer care» della Lombardia; le ingiuste ed aspre critiche alla sua professionalità; la convocazione di un incontro intersindacale finalizzato a criticare il suo comportamento proprio nel periodo in cui si era messo in ferie per riprendersi dalle dure critiche ricevute dai suoi superiori; la sua estromissione dal servizio «Customer care» nell'agosto del 2005; il successivo inserimento in mansioni dequalificanti, con allocazione in un vero e proprio "sgabuzzino", spoglio e sporco, e l'assegnazione a mansioni meramente esecutive e ripetitive, prima come componente di staff del direttore, poi alle dipendenze del P., come addetto all'unità di controllo rischi, ecc.
Si tratta di comportamenti complessivamente ritenuti idonei a dequalificarne la professionalità, comportandone il passaggio da mansioni contrassegnate da una marcata autonomia decisionale a ruoli caratterizzati, per contro, da «bassa e/o nessuna autonomia», e dunque tali da marginalizzarne, in definitiva, l'attività lavorativa, con un reale svuotamento delle mansioni da lui espletate.
Tale situazione di fatto - ricordano gli ermellini era «astrattamente riconducibile alla nozione di "mobbing", sia pure in una sua forma di manifestazione attenuata, dai Giudici di merito denominata nel caso di specie come "straining"».
3. MOBBING COME VIOLENZA PRIVATA
Diverse sono le opzioni che sono state prospettate nella giurisprudenza penale per quanto riguarda la sussunzione del fenomeno del mobbing in una norma incriminatrice.
In alcuni casi, in assenza di una specifica fattispecie incriminatrice di mobbing si è collocato il singolo episodio
di aggressione verbale, di vessazione o di violenza nei delitti di minacce (art. 612 cod. pen.) [15], ingiuria (art.
594 cod. pen.) [16], diffamazione (art. 595 cod. pen.) e violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.).
Tuttavia, «le norme più spesso richiamate sono quelle relative alla violenza privata, anche tentata, e ai maltrattamenti in famiglia. L'art. 610 cod. pen. entra in campo in quei casi in cui la condotta vessatoria sia finalizzata ad ottenere uno specifico comportamento da parte del mobbizzato (spesso le dimissioni o il
trasferimento)» [17].
Così, la condotta del datore di lavoro e del dirigente che, al fine di estromettere il lavoratore dal posto di lavoro, pongano in essere nei suoi confronti comportamenti vessatori, con carattere sistematico e duraturo (cd. mobbing), si è ritenuto integrare il delitto di violenza privata, quantomeno allo stadio del tentativo.
In particolare, è configurabile il reato di violenza privata, consumata o tentata, a carico di datori di lavoro i quali costringano o cerchino di costringere taluni lavoratori dipendenti ad accettare una novazione del rapporto di lavoro comportante un loro "demansionamento" (nella specie costituito da declassamento dalla qualifica di impiegato a quella di operaio) mediante minaccia di destinarli, altrimenti, a forzata ed umiliante inerzia in ambiente fatiscente ed emarginato dal resto del contesto aziendale, nella prospettiva di un susseguente
licenziamento [18].
La Suprema Corte ribadiva che la singolare vicenda oggetto del processo si innestava nell'ambito del fenomeno sociale generalmente noto come mobbing, già esaminato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e consistente in atti e comportamenti (violenza, persecuzione psicologica) posti in essere dal datore di lavoro che mira a danneggiare il lavoratore al fine di estrometterlo dal lavoro, atteggiamenti svolti con carattere sistematico e duraturo. Proprio questa giurisprudenza «implicava chiaramente la possibilità del travalicamento dei confini
meramente civilistici o giuslavoristici della condotta di mobbing con la integrazione di ipotesi di reato» [19].
Ancora, si integra il delitto di tentata violenza privata, la condotta del datore di lavoro che convochi la dipendente - rientrata al lavoro dopo un periodo di astensione obbligatoria per maternità - in un locale fatiscente e le prospetti di farla lavorare in un luogo degradato ed in condizioni invivibili nel caso di mancata accettazione delle condizioni imposte dalla società preordinate ad ottenere contro la sua volontà le dimissioni o il
prolungamento del periodo di allontanamento dal lavoro mediante l'astensione facoltativa post-partum [20].
Nell'ipotesi di mobbing sessuale, invece, il delitto di violenza privata concorre con quello di violenza sessuale. Le condotte moleste, persecutorie e mortificanti poste in essere sul luogo di lavoro da parte del datore di lavoro al fine di ottenere prestazioni sessuali da una subordinata, che viene messa nella condizione di subire molestie sessuali senza opporsi sotto la duplice minaccia di atti persecutori e dannosi o addirittura della perdita del posto, così causando anche danni psico-fisici alla vittima, configurano atti di c.d. mobbing di natura sessuale e integrano gli estremi sia del delitto previsto dall'art. 610 cod. pen. che quelli del delitto previsto dall'art. 609 bis cod. pen., allorquando dette molestie si spingano fino all'effettivo contatto fisico, entrambi aggravati dall'abuso di prestazione d'opera ex art. 61 n. 11 cod. pen. [21].
Come evidenziato da attenta dottrina, tuttavia, la norma descrittiva della fattispecie incriminatrice del delitto di violenza privata «sconta però due "deficit di struttura" che la rendono non perfettamente sovrapponibile alla definizione di mobbing: anzitutto è un reato d'evento, quindi se alla condotta vessatoria (che deve essere
determinata) [22] non consegue (o non sarebbe conseguito, nella forma tentata) l'evento, la violenza privata non è configurabile; in aggiunta la violenza privata incentra il giudizio di disvalore su un singolo episodio criminoso, ed è inadatta a reprimere il mobbing in quanto fenomeno caratterizzato da condotte reiterate nel tempo. Questo spiega, pertanto, poiché la giurisprudenza abbia più spesso tentato una repressione penale del mobbing con il delitto di maltrattamenti in famiglia che, in quanto reato abituale, è integrato da una pluralità di condotte ripetute nel tempo ed è quindi potenzialmente adatto ad abbracciare tutta la condotta complessivamente mobbizzante» [23].
4. MOBBING COME MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
Elementi costitutivi del delitto
La copiosa e vasta giurisprudenza di legittimità sugli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) è stata ben riassunta dalla Cassazione penale, sez. VI, 19 - 25 giugno 2012, n. 25183, ove si è rammentato che nella nozione di «maltrattamenti» rientrano i fatti lesivi dell'integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare
traccia [24]. Non è necessario, quindi, un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto [25], perché il reato è caratterizzato da un'unità significante costituita da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze. Ad integrare l'abitualità della condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed unificati, anche se per un limitato
periodo di empo [26]. Pur sottolineando che il lasso di tempo, ancorché limitato, è tuttavia utile alla realizzazione della ripetizione di atti vessatori idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa
della parte offesa [27], anche se (pare opportuno rimarcarlo) uno degli indici obiettivi è rappresentato proprio dalla seriazione di atti che contrassegna, di norma l'abitualità.
Per la configurabilità del reato non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della
convivenza [28]. Tanto che nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, senza che assuma rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi
lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito [29]. Si è parlato di atti di sopraffazione sistematica tali da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza.
Con il verbo «maltrattare» il legislatore ha utilizzato un espressione polidesignante, comprensiva sia della condotta tipica, sia dell'elemento soggettivo del reato. Proprio con riferimento ai profili più strettamente legati all'elemento psicologico, la giurisprudenza è costante nel senso che per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 cod. pen. non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità, né il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in
modo continuo ed abituale [30]. Non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni. Esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita,
posta in essere già altre volte [31]. È, perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il
patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze [32]. Si è insistito, più in particolare, sull'unitarietà del dolo, in modo da non confonderlo con la coscienza e volontà di
ciascun frammento della condotta, tanto da negare che l'elemento psicologico debba scaturire da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto (l'espressione «quasi programmatica» viene perciò intesa obiter); vale a dire, non occorre che debba essere fin dall'inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi; quel che la legge impone, infatti, è che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi dell'integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale. Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata ad un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il risultato; la conseguenza è che il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso a
costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive [33].
In definitiva «il reato appare contrassegnato, di norma, da una progressione anche psicologica che prende sempre più maggiore consistenza fino a tradursi nell'intenzione di maltrattare. Non necessariamente, dunque, un programma ab inizio, ma la consapevolezza della lesione della personalità del soggetto passivo che, man mano realizza la volontà prevaricatrice; fermo restando che l'unità dell'elemento soggettivo è da intendersi, meglio, come entità che trascende i singoli atti ciascuno dei quali può anche non integrare un'ipotesi di reato; così usando
alla lettera l'espressione "maltrattare"» [34].
Affinità tra mobbing e maltrattamenti
Inquadrati brevemente il fenomeno e la norma, è ora possibile chiedersi se le condotte mobbizzanti siano sussumibili nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia. Si chiariranno così quali sono i tratti di affinità tra il mobbing e l'art. 572 cod. pen. - grazie ai quali questa fattispecie è diventata la norma di riferimento per la giurisprudenza penale che si occupa di mobbing - e quali, invece, sono gli aspetti sui quali si registra una maggiore distanza tra le due figure, e che agitano le acque dell'applicazione pratica del diritto.
Un primo importante elemento di vicinanza tra i due termini del confronto è sicuramente la continuità e sistematicità nel tempo della condotta presa in considerazione nel delitto di maltrattamenti e nella definizione di mobbing: tanto quest'ultimo si caratterizza per la reiterazione nel tempo e la perpetuazione in modo sistematico del comportamento vessatorio, quanto il delitto di maltrattamenti necessita proprio, per essere integrato (a prescindere dal fatto che lo si consideri reato abituale, permanente o complesso), di una pluralità di atti ripetuti nel tempo.
Inoltre, i singoli atti od omissioni che complessivamente costituiscono mobbing possono anche essere singolarmente legittimi, perché ciò che li unisce in un unica condotta illecita è la finalità perseguita dall'autore di tali atti od omissioni, vale a dire la volontà di cagionare una sofferenza psicofisica al destinatario. Parallelamente, anche il delitto di maltrattamenti può essere costituito da atti singolarmente illegittimi o irrilevanti, perché ciò che li rende penalmente rilevanti è per l'appunto, oltre alla continuità e all'effetto, il dolo perseguito dal maltrattante, e cioè la coscienza e volontà di maltrattare il soggetto passivo. La finalità vessatoria quindi è un ulteriore elemento che avvicina il mobbing al fatto di reato di maltrattamenti.
Infine, l'art. 572 cod. pen. fa espresso riferimento, tra le relazioni che possono degenerare nel maltrattamento di una parte nei confronti dell'altra, al rapporto d'autorità o all'altrui affidamento per l'esercizio di una professione. Proprio in tale espressione la giurisprudenza fa rientrare il rapporto di lavoro che s'instaura tra datore e lavoratore subordinato, in virtù dei poteri disciplinari e direttivi che il primo esercita nei confronti del secondo: l'art. 572 cod. pen. diventa così norma per reprimere penalmente il mobbing verticale discendente, e cioè quello posto in essere dal datore di lavoro (o da altro superiore cui il datore deleghi l'esercizio dei suoi poteri) nei
confronti dei suoi subordinati, con ciò stravolgendo il corretto svolgimento della prestazione lavorativa [35].
Anche se l'ipotesi di più frequente verificazione è quella che da il nome alla rubrica dell'art. 572 cod. pen. («maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli»), la norma incriminatrice prevede altresì l'ipotesi di chi commette maltrattamenti in danno di «persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte». Più frequentemente la giurisprudenza ha ritenuto le fattispecie di mobbing riconducibili appunto all'art. 572 cod. pen., evidenziando come anche le pronunce che hanno seguito tale impostazione hanno posto in evidenza come il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, ponga quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma, di «persona sottoposta alla sua autorità», il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il
reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente [36].
Maltrattamenti nelle grandi imprese: due diversi orientamenti
Un primo, e più datato, orientamento di legittimità che si è occupato di mobbing, riteneva integrato il delitto di maltrattamenti tutte le volte in cui il superiore, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione lavorativa, ponesse in essere in modo continuativo e sistematico condotte finalizzate a creare una sofferenza psicofisica a un
subordinato, sia che la subordinazione al datore di lavoro fosse giuridica, sia che fosse di mero fatto [37].
Per un più recente orientamento, ormai da ritenersi maggioritario, non tutti i rapporti di lavoro potrebbero dirsi coincidenti col rapporto d'autorità per ragioni di professione cui fa riferimento l'art. 572 cod. pen.: e ciò per considerazioni attinenti al bene giuridico tutelato dalla norma. Secondo questa parte della giurisprudenza, in effetti, solo laddove le dimensioni dell'impresa siano particolarmente ridotte e le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore siano intense e abituali e caratterizzate da consuetudini di vita, dalla soggezione di un soggetto nei confronti dell'altro e dalla fiducia riposta dalla parte debole nei confronti della parte in posizione di supremazia, solo se cioè il rapporto tra lavoratore e superiore abbia natura para-familiare, la condotta del superiore potrebbe
integrare il delitto di maltrattamenti [38].
Tale orientamento viene confermato dalla sentenza in rassegna (Cass. pen. n. 28603/2013) la quale afferma testualmente: «secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rapporto supremazia - soggezione), dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, e come tale destinatario, quest'ultimo, di obblighi di assistenza verso il primo».
La modulazione di tale rapporto, dunque, avuto riguardo alla ratio della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen., deve comunque essere caratterizzata dal tratto della «familiarità», poiché è soltanto nel limitato contesto di un tale peculiare rapporto di natura para-familiare che può ipotizzarsi, ove si verifichi l'alterazione della sua funzione attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo, il reato di maltrattamenti: si pensi, in via esemplificativa, al rapporto che lega il collaboratore domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera o a quello che può intercorrere tra il maestro d'arte e l'apprendista.
L'inserimento di tale figura criminosa tra i delitti contro l'assistenza familiare si pone in linea, del resto, con il ruolo che la stessa Costituzione assegna alla famiglia, quale società intermedia destinata alla formazione e all'affermazione della personalità dei suoi componenti, e nella stessa prospettiva ermeneutica vanno letti ed interpretati soltanto quei rapporti interpersonali che si caratterizzano, al di là delle formali apparenze, per una
natura para-familiare.
Per gli ermellini siffatta connotazione «deve escludersi nel caso in esame, considerato che la posizione lavorativa del ricorrente, come si è poc'anzi accennato, era inquadrata all'interno di una realtà aziendale complessa (la Bnl), la cui articolata organizzazione - attraverso la previsione di "quadri intermedi" - non implicava certo l'instaurarsi di quella stretta ed intensa relazione diretta tra il datore di lavoro ed il dipendente, che appare in grado di determinarne una comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare. Ne discende, inevitabilmente, il manifestarsi di una realtà connotata da una marginalizzazione dell'intensità dei rapporti intersoggettivi, nel senso che non ne viene esaltato quell'aspetto personalistico strettamente connesso alla dinamica relazionale "supremazia - soggezione", individuabile fra soggetti che si trovano ad operare su piani diversi. Conseguentemente, sulla base di quanto concordemente evidenziato, con congrue ed esaustive argomentazioni, dai giudici di merito, non è in alcun modo apprezzabile, all'interno di tale vicenda storico - fattuale, la riduzione del soggetto più debole in una condizione esistenziale dolorosa ed intollerabile a causa della sopraffazione sistematica di cui egli sarebbe rimasto vittima all'interno di un rapporto quanto meno
assimilabile a quello di natura familiare» [39].
La questione è scottante in particolare nelle organizzazione lavorative complesse, dove il datore di lavoro è formalmente uno solo, ma i superiori possono essere in gran numero (si pensi ai dipendenti di un punto vendita di una grande catena di distribuzione il cui datore di lavoro è la società che svolge l'attività commerciale, la quale avrà un organo d'amministrazione, ma che avranno sopra di loro il direttore, il capo reparto e così via).
In conclusione, «vi è una tendenza recente nella prassi a restringere gli spazi per applicare il delitto di maltrattamenti al mobbing rispetto ai primi arresti della giurisprudenza: basta leggere le sentenze citate per riscontrare che i rapporti di lavoro che questa prassi pretoria ritiene abbiano natura para-famigliare, e rispetto ai quali quindi consente la tutela del lavoratore mobbizzato, sono essenzialmente quelli che s'instaurano tra le persone della famiglia e il collaboratore domestico, tra il maestro d'arte e l'apprendista: insomma in quei contesti aziendali in cui il numero di lavoratori è talmente ridotto da rendere la comunità lavorativa paragonabile
a una famiglia» [40].
Criterio delle dimensioni aziendali: critiche
La sentenza n. 28603 del 2013, come detto, è in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui il fenomeno del mobbing può assumere rilevanza penale solo quando le condotte vessatorie si inseriscono in un rapporto lavorativo di tipo para-familiare, in un contesto lavorativo di ridotte dimensioni in cui il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore subordinato si incardina sull'informalità e sulla fiducia.
Parte della dottrina ha espresso forti critiche contro il criterio delle dimensione aziendali.
A tale criterio si rimprovera in particolare di trascurare l'aspetto relazionale e di fiducia che può contrassegnare
anche alcuni rapporti lavorativi all'interno di un'azienda di notevoli dimensioni e avente struttura complessa [41].
Inoltre, non è corretto affermare che l'art. 572 cod. pen. miri in generale a far sì che la subordinazione ad altri non diventi sopraffazione dell'altro, giacché i rapporti sociali presi in considerazione dalla norma non possono essere visti tutti in una prospettiva esclusivamente verticistica. Ciò che la norma tutela, in realtà, è l'interesse del
soggetto al rispetto della propria personalità nello svolgimento del rapporto interpersonale [42], perché in occasione dei rapporti sociali cui l'art. 572 cod. pen. fa riferimento, la «dignità di essere umano è impegnata con
estrema tensione» [43], e proprio perché impegnata, è esposta al pericolo della lesione se l'altra parte del rapporto travalica i limiti di correttezza e legittimità della relazione stessa. Il soggetto passivo del reato - che è
prima di tutto parte di un rapporto sociale qualificato - fa affidamento a che l'altro si comporti con correttezza e non abusi della particolare prossimità o del particolare ascendente di cui gode in virtù del rapporto stesso per nuocergli. E l'ordinamento si aspetta che in un ambito in cui la personalità dell'individuo è particolarmente esposta e dovrebbe essere esaltata o comunque protetta - in famiglia, sul luogo di lavoro, a scuola - non accada il contrario.
In conclusione, il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice non è la famiglia in quanto tale: essa mira piuttosto a tutelare il benessere psicofisico dell'individuo, quando questo possa essere turbato nell'ambito di rapporti sociali di particolare pregnanza sul cui regolare svolgimento egli confida, e nei quali la sua persona
entra particolarmente in gioco [44].
Nell'attesa che la Suprema Corte possa rivisitare il suo più recente orientamento, tendente ad escludere la punibilità del mobbing verticale ascendente nelle aziende di grandi dimensioni attraverso la sussunzione delle condotte mobbizzanti nella fattispecie incriminatrice dei maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen., si segnalano, in senso contrario a siffatto orientamento, alcuni arresti della giurisprudenza di merito secondo cui il fenomeno del mobbing può integrare il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi anche in strutture aziendali complesse «nei quali tuttavia il rapporto relazionale si sia sviluppato in un contesto specifico, che valga
a dare concretezza ad una significativa relazione intersoggettiva» [45].
Il principio espresso in tali pronunce, seppure in via di obiter, è quello per il quale il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti della «persona sottoposta all'altrui autorità per ragioni di professione» può configurarsi anche nell'ambito di imprese di grandi dimensioni, sempre che tra il superiore gerarchico e il lavoratore intercorra un rapporto interpersonale stringente, caratterizzato da relazioni intense e abituali tra i due soggetti, consuetudini di vita, soggezione di una parte nei confronti dell'altra.
Altra strada da percorrere per garantire la punizione penale del fenomeno mobbing nelle imprese di grandi dimensioni è quella di riqualificare le condotte vessatorie nella fattispecie di violenza privata continuata (ex artt. 81 e 610 cod. pen.) aggravata dell'abuso di relazioni di prestazioni d'opera di cui all'art. 61 cod. pen., n. 11. Tale escamotage è stato utilizzato in qualche caso dalla Suprema Corte, laddove si è ritenuto che integra il reato di violenza privata, «e non il reato di maltrattamenti in famiglia, la condotta violenta e minacciosa reiteratamente posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico, in modo da costringere il lavoratore, nel contesto di un'azienda organicamente strutturata, a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento
delle sue qualità lavorative» [46]. In tal modo è possibile superare, nell'ambito del rapporto di lavoro, la presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo, con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura para-familiare.
5. MOBBING COME ATTO PERSECUTORIO (STALKING)
Il sentiero interpretativo più idoneo da percorrere per la punibilità di qualunque forma di mobbing (e non solo quello verticale discendente) è l'inquadramento delle condotte mobbizzanti nel delitto di atti persecutori descritto nell'art. 612 bis cod. pen.
Attenta dottrina ha evidenziato quali tratti comuni al mobbing e allo stalking che entrambi possono realizzarsi attraverso atti in sé leciti, tratto caratterizzante di entrambi sono gli episodi di molestie e presuppongono una reiterazione delle condotte vessatorie. Diversa sarebbe, invece, la finalità in quanto il mobbing è volto a porre fine alla vita lavorativa del collega o al rapporto di lavoro tra l'autore e la vittima, mentre lo scopo dello stalker è
normalmente quello di entrare in contatto con la vittima o, addirittura, di imporle un rapporto [47].
Tale elemento di differenziazione, tuttavia, oltre che essere più apparente che reale (si riconosce, infatti, che il mobber non agirebbe esclusivamente con la finalità esclusiva di espellere il lavoratore, quanto piuttosto di svilire
o ledere la dignità personale o professionale del dipendente) [48], comporta che il mobbing troverà punizione nell'alveo del reato di stalking solo laddove integrerà uno degli eventi alternativi previsti dalla norma. A tale proposito, l'art. 612-bis c.p. recita: «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».
Come si evince dalla lettera della norma, è irrilevante (nel senso che rientrano entrambi nell'area di applicazione dell'art. 612 bis cod. pen.) che ci troviamo di fronte allo stalking occupazionale (ove si perseguita la vittima nell'ambiente lavorativo quale strategia aggiuntiva al mobbing, nelle forme del bossing - che ha come obiettivo quello di esercitare una pressione psicologica sulla vittima per indurla a dare le dimissioni - oppure del mobbing orizzontale, ove l'azione discriminatoria è messa in atto tra individui di pari grado, in genere colleghi, ed ha lo scopo di isolare la vittima e distruggerne l'immagine sia in campo lavorativo che nella sfera privata), o allo stalking comune, ossia quello che non si ferma nei luoghi di lavoro ma che si consuma oltre siffatti luoghi per invadere la sfera privata della vittima (ad esempio con pedinamenti dal luogo di lavoro a casa della vittima, telefonate moleste, sms, e-mail fuori dell'orario lavorativo) provocandole uno stato di ansia e di paura e/o la costringa a cambiare le proprie abitudini di vita (in questo caso lo scopo dello stalker è quello di avvicinare, e non di allontanare la vittima). In quest'ultimo caso, l'effettiva finalità persecutoria si esercita nella vita privata della vittima, ma la motivazione proviene dall'ambiente di lavoro dove lo stalker ha realizzato, subito o desiderato una situazione di conflitto, persecuzione o mobbing.
La fattispecie di atti persecutori è inoltre idonea a reprimere tutti i fenomeni di mobbing, non solo quello verticale discendente (bossing), ma anche verticale ascendente e orizzontale.
Con riferimento a quest'ultimo, le Sezioni unite civili si sono occupate di alcuni casi in cui le condotte persecutorie sono state consumate da un magistrato a danni di un collega o di una collega. In particolare, il Procuratore è stato ritenuto responsabile degli illeciti di cui al D.Lgs. n. 109/2006, art. 4, lett. d), in relazione all'art. 612 bis cod. pen., e di cui al medesimo D.Lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. d), con relativa inflizione di sanzione disciplinare, per avere molestato la collega del medesimo ufficio assillandola con continue telefonate, messaggi telefonici, richieste di incontri, e ciò nonostante il netto rifiuto opposto dalla vittima, in tal modo arrecandole profondo turbamento alla vita personale e familiare, con lesione del prestigio della magistratura in considerazione della notorietà che dette condotte avevano ricevuto; ed ancora, quanto al secondo illecito, il fatto di avere, con la condotta ossessiva di cui al primo, creato pregiudizio allo svolgimento del lavoro della collega, entrando continuamente nel suo ufficio per sollecitare incontri, trattenendovisi ogni volta a lungo nonostante le chiare manifestazioni di insofferenza oppostegli, nonché di avere inviato alla collega, a seguito del netto rifiuto dalla stessa oppostogli, una lettera con la quale segnalava la situazione di incompatibilità in cui la medesima collega si sarebbe trovata a causa dell'esercizio della professione legale da parte della sorella, e di
avere poi segnalato la detta incompatibilità al Consiglio superiore della magistratura [49].
Con riferimento, infine, al mobbing verticale ascendente, si segnala una decisione del Gip del tribunale di Milano in cui il mobber-stalker era il dipendente (che si era opposto ad una riorganizzazione aziendale ed era stato messo in cassa integrazione) e la vittima il superiore, il quale veniva perseguitato con minacce, rivolte anche alla sua la sua famiglia, da uno dei lavoratori coinvolti dalla cessione di un ramo d'azienda nel quadro di una pesante ristrutturazione societaria. Nel caso di specie, il Gip presso il Tribunale di Milano, ha emesso nei confronti del lavoratore licenziato, indagato per il delitto di stalking ex art. 612 bis cod. pen., il divieto di avvicinamento di cui all'art. 282 ter cod. proc. pen., prescrivendo allo stalker di non avvicinarsi più all'ufficio del manager, di stare lontano da casa sua, di andar via dai luoghi frequentati nel tempo libero dai suoi familiari.
La misura cautelare si è resa necessaria per arginare l'escalation delle condotte aggressive dell'indagato, che
hanno «preso spunto da una vicenda civilistica ma che ora ne rappresentano uno sviluppo del tutto autonomo che trascende lo scopo di tutela dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro per assumere una finalità persecutoria nei
confronti del ragioniere e della sua famiglia» [50].
La sentenza ���Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2013, n. 28603, Pres. De Roberto, Rel. De Amicis
Considerato in fatto
1. Con sentenza del 2 ottobre 2012 la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile per rinuncia l'appello del P.M. avverso la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Milano in data 30 settembre 2011 nei confronti di S.L. e P. M., confermandola nel resto e condannando l'appellante parte civile - C.S. - al pagamento delle spese processuali del grado.
2. Con sentenza del 30 settembre 2011 il Tribunale di Milano aveva assolto S.L. e P.M., nelle rispettive qualità di direttore dell'area territoriale Lombardia della B.N.L., e di direttore dell'unità di controllo dei rischi di area del predetto istituto, dal reato di cui all'art. 110 cod. pen., art. 572 cod. pen., comma 2, con la formula perché il fatto non sussiste, in relazione ad atti di maltrattamento sul lavoro, e segnatamente di «straining», posti in essere nei confronti di C.S., funzionario amministrativo della filiale di (omissis) - Centro della B.N.L., nel periodo intercorrente fra il mese di gennaio 2005 ed il mese di luglio 2008, dai quali era derivata, secondo l'accusa, la grave lesione consistita nella causazione di un'incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni.
La sentenza di primo grado aveva escluso che i fatti oggetto dell'imputazione potessero integrare la fattispecie incriminatrice del delitto di maltrattamenti, pervenendo alla decisione assolutoria sulla base di una ricostruzione ermeneutica degli elementi costitutivi del «tipo» di reato poi fatta propria anche dal Giudice di secondo grado, che ha posto in evidenza come l'ambito lavorativo risultasse comunque incompatibile con la nozione di «famiglia» o di ambiente «parafamiliare» cui fa riferimento la contestata norma incriminatrice.
3. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ex art. 606, lett. b) e lett. e), cod. pen.p., in relazione all'art. 572 cod. pen., dovendosi ritenere irragionevole l'esclusione a priori dell'applicabilità della su indicata norma incriminatrice agli ambienti lavorativi di grosse dimensioni, come quello in cui lavora il ricorrente: il criterio dimensionale dell'azienda, infatti, non avrebbe nulla a che vedere con la natura del bene giuridico protetto dalla norma, rilevando ai fini della punibilità solo il valutare se le condotte prevaricatrici tenute dal superiore gerarchico del lavoratore, con il quale questi aveva un rapporto personale e diretto, abbiano o meno influito sulla sua personalità e sulla sua integrità psico-fisica.
Ai fini della configurabilità del reato contestato, peraltro, diversamente da quanto affermato In sentenza, non si richiede che l'imputato abbia realizzato la pluralità di condotte in un'unica ed ininterrotta sequenza temporale, ben potendo le stesse essere intervallate da periodi di forzata inattività del lavoratore - durante i quali, pertanto, il soggetto attivo non ha avuto modo di proseguire la propria condotta vessatoria - e tuttavia causalmente riconducibili proprio a quella condotta, contribuendo a rendere insostenibile la condizione lavorativa ed esistenziale della vittima.
È altresì pacifico che gli imputati, pur non essendo formalmente datori di lavoro del ricorrente, erano i suoi superiori gerarchici ed avevano con lui un rapporto diretto e costante di interazione personale, decidendo le sue mansioni quotidiane ed i suoi spostamenti di ruolo: essi, pertanto, esercitavano in concreto un potere di gestione e di controllo della sua intera attività lavorativa, esprimendo nei suoi confronti quell'«autorità» richiesta dalla norma per la configurazione del reato.
Ne discenderebbe, in tal senso, l'irrilevanza dell'affermazione circa l'inesistenza di un potere disciplinare dei prevenuti nei confronti del C.
3.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 cod. pen.p., lett. e), in ordine al proscioglimento degli imputati dal reato di lesioni personali, contestato nel capo d'imputazione a titolo di aggravante del reato di maltrattamenti, in quanto la Corte d'appello, una volta venuto meno l'assorbimento delle lesioni gravi nell'aggravante del reato di cui all'art. 572 cod. pen., avrebbe dovuto valutare le conseguenze dell'accertamento in fatto dell'esistenza delle lesioni cagionate dagli imputati alla ricorrente parte civile, lesioni che riacquisterebbero un rilievo autonomo, una volta esclusa la configurabilità della fattispecie assorbente.
4. Con memoria depositata in data 11 marzo 2013, i difensori di fiducia di S.L. hanno illustrato un'articolata serie di argomentazioni a sostegno della necessità della presenza di una matrice essenzialmente «familiare» dell'ipotizzata fattispecie di reato, contestando, altresì, nel merito le deduzioni della parte civile e chiedendo il rigetto del ricorso dalla stessa presentato.
5. Con memoria depositata nell'interesse di P.M. in data 22 marzo 2013, il difensore di fiducia ha svolto una serie di considerazioni critiche in ordine ad entrambi i motivi di ricorso dedotti dalla parte civile, chiedendo che ne venga dichiarata l'inammissibilità, o comunque la manifesta infondatezza, traducendosi le relative doglianze in un indebito tentativo di rivisitazione del fatto, la cui ricostruzione, come è noto, è intangibile in sede di legittimità.
6. Con memoria presentata nell'interesse della parte civile in data 14 marzo 2013, la difesa ha svolto ulteriori argomenti a sostegno dei motivi posti a fondamento del proprio ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Considerato in diritto
���7. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
8. Infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, ove si consideri il lineare percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, che, nel confermare le valutazioni al riguardo già esaustivamente espresse dal Giudice di prime cure, ha fatto buon governo della legge penale, avvalendosi di un apparato argomentativo strettamente ancorato a precise emergenze processuali, ed offrendo un'adeguata e logica giustificazione delle ragioni individuate a sostegno della conclusione cui la stessa è, sotto tale profilo, pervenuta.
In particolare, i Giudici di merito hanno evidenziato, all'esito di un'analisi critica ed approfondita delle risultanze probatorie, il dato dell'oggettiva incompatibilità, con la nozione, pur semanticamente dilatata, di «famiglia» o di «ambiente parafamiliare», dell'ambito lavorativo in cui sono maturate le azioni ostili poste in essere nei confronti del C. (azioni, peraltro, numericamente limitate e temporalmente distanziate, poste in essere in assenza di un potere disciplinare nei suoi confronti effettivamente esercitabile da parte degli imputati, ma comunque tali da realizzare in suo danno, come rilevato nella sentenza del Giudice di prime cure, un ingiustificato demansionamento, oltre che un «disturbo dell'adattamento», seppur di grado lieve, insorto dal 2005 come diretta conseguenza della situazione lavorativa penalizzante in cui egli si è trovato ad operare).
Dalla motivazione della sentenza di primo grado emergono, infatti, taluni comportamenti discriminatori subiti dal C., e segnatamente: la sottrazione di responsabilità in favore di altra dipendente, ingiustificatamente favorita dai suoi dirigenti durante il servizio espletato presso l'unità «Customer Care» della Lombardia; le ingiuste ed aspre critiche alla sua professionalità;
la convocazione di un incontro intersindacale finalizzato a criticare il suo comportamento proprio nel periodo in cui si era messo ferie per riprendersi dalle dure critiche ricevute dai suoi superiori; la sua estromissione dal servizio «Customer Care» nell'agosto del 2005;
il successivo inserimento in mansioni dequalificanti, con allocazione in un vero e proprio «sgabuzzino», spoglio e sporco, e l'assegnazione a mansioni meramente esecutive e ripetitive, prima come componente di staff del direttore S., poi alle dipendenze del P., come addetto all'unità di controllo rischi, ecc..
Si tratta di comportamenti complessivamente ritenuti idonei a dequalificarne la professionalità, comportandone il passaggio da mansioni contrassegnate da una marcata autonomia decisionale a ruoli caratterizzati, per contro, da «bassa e/o nessuna autonomia», e dunque tali da marginalizzarne, in definitiva, l'attività lavorativa, con un reale svuotamento delle mansioni da lui espletate.
Sotto altro, ma connesso profilo, i Giudici di merito hanno sottolineato come l'ambito lavorativo fosse generalmente connotato dall'instaurazione di un rapporto distaccato e formale, le cui modalità di esecuzione comunque consentivano al dipendente di avvalersi di un complesso di garanzie idonee a reagire alle ingiuste offese subite, e che, per le dimensioni stesse della multinazionale B.N.L. ed in ragione della sua complessa articolazione strutturale, non potevano propriamente ricollegarsi al contenuto della nozione cui fa riferimento la contestata fattispecie incriminatrice.
8.1. Pur essendo tale situazione di fatto astrattamente riconducibile alla nozione di «mobbing», sia pure in una sua forma di manifestazione attenuata, dai Giudici di merito denominata nel caso di specie come «straining», occorre tuttavia rilevare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. «mobbing») possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rapporto supremazia-soggezione), dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, e come tale destinatario, quest'ultimo, di obblighi di assistenza verso il primo (Sez. 6, n. 26594 del 06/02/2009, dep. 26/06/2009, Rv. 244457; Sez. 6, n. 685 dei 22/09/2010, dep. 13/01/2011, Rv. 249186; Sez. 6, n. 43100 del 10/10/2011, dep. 22/11/2011, Rv. 251368; Sez. 6, n. 16094 del 11/04/2012, dep. 27/04/2012, Rv. 252609).
La modulazione di tale rapporto, dunque, avuto riguardo alla ratìo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen., deve comunque essere caratterizzata dal tratto della «familiarità», poiché è soltanto nel limitato contesto di un tale peculiare rapporto di natura para-familiare che può ipotizzarsi, ove si verifichi l'alterazione della sua funzione attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo, il reato di maltrattamenti: si pensi, in via esemplificativa, al rapporto che lega il collaboratore domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera o a quello che può intercorrere tra il maestro d'arte e l'apprendista.
L'inserimento di tale figura criminosa tra i delitti contro l'assistenza familiare si pone in linea, del resto, con il ruolo che la stessa Costituzione assegna alla «famiglia», quale società intermedia destinata alla formazione e all'affermazione della personalità dei suoi componenti, e nella stessa prospettiva ermeneutica vanno letti ed interpretati soltanto quei rapporti interpersonali che si caratterizzano, al di là delle formali apparenze, per una natura para-familiare.
Siffatta connotazione, tuttavia, deve escludersi nel caso in esame, considerato che la posizione lavorativa del ricorrente, come si è poc'anzi accennato, era inquadrata all'interno di una realtà aziendale complessa (la B.N.L.), la cui articolata organizzazione - attraverso la previsione di «quadri intermedi» - non implicava certo l'instaurarsi di quella stretta ed intensa relazione diretta tra il datore di lavoro ed il dipendente, che appare in grado di determinarne una comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare. Ne discende, inevitabilmente, il manifestarsi di una realtà connotata da una marginalizzazione dell'intensità dei rapporti intersoggettivi, nel senso che non ne viene esaltato quell'aspetto personalistico strettamente connesso alla dinamica relazionale «supremazia-soggezione», individuabile fra soggetti che si trovano ad operare su piani diversi.
Conseguentemente, sulla base di quanto concordemente evidenziato, con congrue ed esaustive argomentazioni, dai Giudici di merito, non è in alcun modo apprezzabile, all'interno di tale vicenda storico- fattuale, la riduzione del soggetto più debole in una condizione esistenziale dolorosa ed intollerabile a causa della sopraffazione sistematica di cui egli sarebbe rimasto vittima all'interno di un rapporto quanto meno assimilabile a quello di natura familiare. Se, da un lato, è vero che l'art. 572 cod. pen. ha «allargato» l'ambito delle condotte che possono configurare il delitto di maltrattamenti anche oltre quello strettamente endo-familiare, è pur vero, dall'altro, che la fattispecie incriminatrice è inserita nel titolo dei delitti in materia familiare ed espressamente indica nella rubrica la limitazione alla famiglia ed ai fanciulli, sicché non può ritenersi idoneo a configurarla il mero contesto di un generico rapporto di subordinazione/sovraordinazione. Da qui la ragione dell'indicazione del requisito della parafamiliarità del rapporto di sovraordinazione, che si caratterizza per la sottoposizione di una persona all'autorità di un'altra in un contesto di prossimità permanente, d abitudini di vita (anche lavorativa) proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per l'affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all'azione di chi ha ed esercita su di lui l'autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità.
Se così non fosse, come peraltro si è già avuto modo di osservare in questa Sede, ogni relazione lavorativa caratterizzata da ridotte dimensioni e dal diretto impegno del datore di lavoro dovrebbe, per ciò solo, configurare una sorta di comunità (para)familiare, idonea ad imporre la qualificazione in termini di violazione dell'art. 572 cod. pen., di condotte che, pur di eguale contenuto ma poste in essere in un contesto più ampio, avrebbero solo rilevanza in ambito civile (il cd «mobbing» in una realtà lavorativa, cui fa riferimento, tra le altre, la su citata sentenza della Sez. 6, n. 685/2011), con evidente profilo di irragionevolezza del sistema (Sez. 6, n. 12517 del 28/03/2012, dep. 03/04/2012, Rv. 252607).
Né, infine, potrebbero trarsi, al riguardo, argomenti in senso contrario dall'analisi della recente interpolazione del testo normativo attraverso la modifica introdotta dalla novella legislativa n. 172 del 1 ottobre 2012, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno».
L'art. 4, comma 1, lett. d), della legge sopra citata ha sostituito l'art. 572 cod. pen., novellandone la rubrica, ora denominata «Maltrattamenti contro familiari e conviventi», ed aggiungendo i conviventi nel novero dei soggetti passivi del reato, ma la natura (abituale) e la struttura del reato di maltrattamenti (prima «in famiglia o verso fanciulli», ora «contro familiari e conviventi») sono rimaste sostanzialmente immutate. Le novità, infatti, riguardano essenzialmente la previsione di un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio e l'estensione della tutela nei confronti di persone «comunque conviventi», in una prospettiva orientata, per un verso, a valorizzare l'incidenza della relazione intersoggettiva nell'ambito di operatività della fattispecie, e, per altro verso, ad allargare anche ad un rapporto di mera «convivenza» - non necessariamente qualificato dalla particolare natura del legame che ha portato alla sua instaurazione - la rilevanza del rapporto «familiare», ferme restando le altre relazioni di tipo non propriamente familiare, la cui elencazione è rimasta immutata.
9. Meritevole di accoglimento, per contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza dai ricorrente prospettato, ove si consideri che il fatto della causazione di lesioni consistite in «disturbo dell'adattamento, reazione depressiva prolungata da problemi sul lavoro», comportante un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni quaranta (condizione psichica riscontrata il 6 ottobre 2005 e perdurante al 14 dicembre 2009), costituiva oggetto di una chiara ed espressa contestazione all'interno del tema d'accusa, sì da imporne un complessivo apprezzamento da parte della Corte distrettuale. L'impugnata pronuncia, dunque, pur avendo escluso la sussistenza del reato di maltrattamenti, non poteva certo pretermettere la valutazione della rilevanza di condotte - emergenti, peraltro, dalla stessa ricostruzione del compendio storico-fattuale - idonee a configurare altre fattispecie di rilievo penale, pur meno gravi, che come tali dovevano comunque essere prese in considerazione nell'ambito della cognizione di merito (arg. ex Sez. 6, n. 28481 del 17/04/2012, dep. 16/07/2012, Rv. 253695).
La contestazione, sia pure a titolo di circostanza aggravante ex art. 572, comma 2, cod. pen., di un nucleo della condotta autonomamente isolabile nei suoi contorni storico-fattuali, non ne determina certo la giuridica irrilevanza, una volta che sia stata esclusa la configurabilità del delitto di maltrattamenti.
Al riguardo, invero, sulla base di una costante linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, deve rilevarsi come, nella materialità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. rientrino non soltanto percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima, ma anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione ed asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali alla vittima. Ne consegue che è riservato alla valutazione del giudice di merito accertare se singoli episodi vessatori rimangano assorbiti nel reato di maltrattamenti (ad esempio, lesioni non volute), oppure integrino ipotesi criminose autonomamente volute dall'agente e, pertanto, concorrenti con il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. (Sez. 6, n. 16661 del 29/05/1990, dep. 19/12/1990, Rv. 186109).
Entro tale prospettiva, infatti, si è più volte affermato che il delitto di lesioni personali volontarie non può ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di illeciti che concorrono materialmente tra loro per la diversa obiettività giuridica (Sez. 6, n. 12936 del 07/05/1986, dep. 19/11/1986, Rv. 174326), sì da configurare un reato autonomo in concorso materiale con quello di maltrattamenti (Sez. 1, n. 757 del 09/05/1969, dep. 13/10/1969, Rv. 112914; da ultimo, v. Sez. 6, n. 28367 del 11/05/2004, dep. 23/06/2004, Rv. 229591; Sez. 6, n. 13898 del 28/03/2012, dep. 12/04/2012, Rv. 252585; v., inoltre, Sez. 1, n. 7043 del 09/11/2005, dep. 24/02/2006, Rv. 234047).
10. Conclusivamente ne discende, per quel che attiene al reato di lesioni personali, l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, con il rinvio al giudice civile ex art. 622 cod. pen.p., seconda parte, quale statuizione oggettivamente limitata alle ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venendo «in toto» respinti altri ricorsi rilevanti agli effetti penali. Un epilogo decisorio, quello or ora indicato, ricavabile, oltre che dalla lettera della norma, dalla sua stessa «ratio», che è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale quando non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali (Sez. 6, n. 6645 del 21/04/1997, dep. 09/07/1997, Rv. 209727; Sez. 2, n. 12831 del 20/02/2002, dep. 19/03/2003, Rv. 224295).
La parte civile, infatti, nonostante la modifica dell'art. 576 cod. pen.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, il potere di affermare la responsabilità dell'imputato agli effetti civili - come indirettamente conferma il disposto dell'art. 622 cod. pen.p., - e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, n quanto l'accertamento incidentale equivale, virtualmente, alla condanna di cuiall'art. 578 cod. pen.p. (Sez. 1, 26 aprile - 7 maggio 2007, n. 17321, Rv. 236599), ma certamente non può emettere sentenza di condanna anche agli effetti penali, senza violare il giudicato in assenza, come nei caso in esame, dell'impugnazione del P.M. (Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, dep. 14/11/2011, Rv. 251061).
P .Q.M.
annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con riferimento al reato di lesioni personali e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Note:
[1] La legge francese del 17 gennaio 2012, n. 73, prevede l'introduzione di una specifica figura di reato relativa al mobbing, tramite l'inserimento nel codice penale di una sezione intitolata all'harcèlement moral e di un articolo, il 222-33-2, che sanziona «il fatto di molestare gli altri attraverso comportamenti ripetuti aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibili di ledere i suoi diritti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale o di compromettere il suo avvenire professionale». La pena prevista è della reclusione fino a un anno o la multa di 15.000 euro.
[2] La Risoluzione del Parlamento europeo A5-0283/2001 del 20 settembre 2001, prendendo atto della diffusione del fenomeno al par. 10, «esorta gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la propria legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare e ad uniformare la definizione della fattispecie del «mobbing»».
[3] Le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono state oggetto di definizione normativa, in ambito giuslavoristico, a seguito della Direttiva Cee n. 2002/73 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002. Il legislatore italiano, recependo le linee guida comunitarie, ha statuito che sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ossia «quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo» (art. 2, comma 1c, D.Lgs. n. 145/2005, ora trasfuso nel D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, o Codice delle pari opportunità, all'art. 26, comma 2).
[4] In questo senso, da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2013, n. 19760.
[5] C. Parodi, Ancora su mobbling e maltrattamenti in famiglia, in http://penalecontemporaneo.it (3 ottobre 2012).
[6] Da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2014, n. 2626.
[7] Cfr. Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2009, n. 10864; Cass. sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2006 n. 4774; Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2009 n. 3785.
[8] Tra le tante, e le ultime, Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 2013, n. 18093.
[9] Cass. civ., sez. lav., 9 settembre 2008, n. 22858, rv. 604787.
[10] Cass. civ., sez. lav., 31 maggio 2011, n. 12048, in Resp. civ. e prev. 2012, 1, 136, che sotto il profilo processuale specifica che «la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore per il mobbing subito è soggetta a specifica allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi».
[11] Per Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2014, n. 2886, nel caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da stress lavorativo, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l'inadempimento datoriale, non discendendo automaticamente tale danno dalla violazione del dovere datoriale e richiedendo il danno non patrimoniale una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione.
[12] H. Ege, Mobbing, straining, stalking: prevenzione, strategie, soluzioni. Sempre lo stesso A., in Tratto da H. Ege, Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, ed. Franco Angeli, Milano, 2005, distingue le situazioni di stress occupazionale, quale situazione di pressione (dovuta alla natura o alla cattiva organizzazione), lo straining, quale situazione di stress forzato (dovuta a discriminazione) e il mobbing, quale situazione di conflitto (dovuta a persecuzione).
[13] Trib. Brescia, sez. lav., 15 aprile 2011; Trib. Massa Carrara, sez. lav., 11 ottobre 2011; Trib. Sondrio, sez. lav., 7 giugno 2007; Trib. Bergamo, sez. lav., 21 aprile 2005.
[14] Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2012, n. 18927, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=19567; e sul versante processuale «a ciò non è di ostacolo neppure la eventuale originaria prospettazione della domanda giudiziale in termini di danno da mobbing, in quanto si tratta piuttosto di una operazione di esatta qualificazione giuridica dell'azione che il giudice è tenuto ad effettuare, interpretando il titolo su cui si fonda la controversia ed anche applicando norme di legge diverse da quelle invocate dalle parti interessate, purché lasciando inalterati sia il petitum che la causa petendi e non attribuendo un bene diverso da quello domandato o introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto».
[15] Per Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2009, n. 23923, in Diritto & Giustizia 2009, «Provocare ansia e stress nel dipendente con comportamenti ingiuriosi e minacciosi è una forma di mobbing che, come tale, va risarcita indipendentemente dalla responsabilità penale per i reati commessi». Nella specie, la Corte ha confermato il verdetto d'appello che aveva condannato un dirigente di un ufficio giudiziario a risarcire gli stati ansiosi e depressivi provocati dalla sua condotta aggressiva nei confronti di una cancelliera, nonostante i reati di cui era stato accusato - ingiuria, minaccia e lesioni personali colpose - si fossero prescritti.
[16] Cfr. Cass. pen., sez. V, 15 luglio 2013, n. 30502, in Diritto & Giustizia (16 luglio 2013), per la quale addebitare pubblicamente al dipendente gli insuccessi aziendali e accusarlo pubblicamente senza prove non serve a migliorare l'andamento o il clima aziendale, ma solo ad esasperare i rapporti lavorativi e interpersonali, configurando il delitto di ingiurie.
[17] C. Parodi, Ancora su mobbing e maltrattamenti in famiglia, cit. ���[18] Cass. pen. sez. VI, 8 marzo -21 settembre 2006, n. 31413, con nota di De Falco, La rilevanza penale
del mobbing approda in Cassazione, in Cass. pen., 2008, 182.
[19] Continua, ancora, Cass. pen. sez. VI, 8 marzo-21 settembre 2006, n. 31413: «In definitiva, per la sussistenza del fenomeno occorre che diverse condotte, alcune o tutte di per sé legittime, si ricompongano in un unicum, essendo complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico- fisico del lavoratore. Ciò non toglie, ovviamente, che tali condotte, esaminate separatamente e distintamente, possano essere illegittime e anche integrare fattispecie di reato».
[20] Cass. pen., sez. V, 30 aprile 2012, n. 36332, in Ced Cass. pen. 2012, rv 253524. ���[21] Ufficio indagini preliminari Trani, 28 novembre 2007, in Giurisprudenzabarese.it 2007.
[22] Come ricorda Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2008, n. 35237, in Ced Cass. pen. 2008, rv 241159, «l'elemento oggettivo del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché, in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria ma non quello di violenza privata».
[23] C. Parodi, Ancora su mobbing e maltrattamenti in famiglia, cit. ���[24] Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 1990,
Mengo; Id., 22 dicembre 1992, Sortini. [25] Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 1991, Faranda. ���[26] Cass. pen., sez.
V, 9 gennaio 1992, Giay. ���[27] Cass. pen., sez. VI, 9 dicembre 1992, Gelati.
[28] Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 1996, Gazzetto. [29] Cass. pen., sez. VI, 7 giugno 1996, Vitiello. [30] Cass.
pen., sez. VI, 3 luglio 1990, Soru. ���[31] Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 1991, Faranda. [32] Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 1992, Giay.
[33] Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 1994, Fiorillo; Id., 14 luglio 2003, Miola; Id., 11 dicembre 2003, Bonsignore.
[34] Cass. pen., sez. VI, 19-25 giugno 2012, n. 25183. ���[35] C. Parodi, Ancora su mobbing e maltrattamenti in famiglia, cit.; A.M. Maugeri, Lo stalking tra
necessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, 2010, 205 s.
[36] Cass. pen., sez. V, 29 agosto 2007, n. 33624, rv. 237439, per la quale il fenomeno del mobbing «appare più prossimo alla fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen., la cui integrazione richiede, comunque, la ravvisabilità dei parametri di frequenza e durata nel tempo delle azioni ostili al fine di valutarne il complessivo carattere persecutorio e discriminatorio».
[37] Una delle prime sentenze della Cassazione a prospettare l'inquadramento del mobbing nella condotta descritta dall'art. 572 cod. pen. è Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 1997, n. 2609. Cfr. anche più recentemente Cass. pen., sez. V, 29 agosto 2007, n. 33624, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, p. 409, con nota di G. Giappichelli e in Dir. pen. proc., 2008, 892, con nota di M. Verrucchi; Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2008, n. 27469.
[38] Cfr. Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2012, n. 16094; Cass. pen., sez. VI, 22 novembre 2011, n. 43100; Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 685; Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2009, n. 26494.
[39] Tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2009 (ud. 6 giugno), n. 26494, in Foro it., 2009, II, 533, con nota di Di Fresco; Cfr. Cass. pen., sez. VI, 16094/2012, cit., dove la Corte esclude sussista un rapporto di subordinazione tra il vice presidente di un'azienda e una centralinista, mancando al primo poteri direttivi e disciplinari nei confronti della seconda; Cass., pen., sez. VI, 43100/2011, dove si esclude il rapporto di subordinazione tra il sindaco e un dipendente comunale.
[40] Sempre, C. Parodi, Ancora su mobbing e maltrattamenti in famiglia, cit.
[41] In questo senso R. Bartoli, Fenomeno del mobbing e tipo criminoso forgiato dalla fattispecie di maltrattamenti in famiglia, in http://penalecontemporaneo.it (28 ottobre 2011), nonché C. Parodi, Ancora su mobbing e maltrattamenti in famiglia, ibidem, 3 ottobre 2012.
[42] G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale, parte speciale. I delitti contro la persona, Bologna, 2007, 346.
[43] F. Coppi, Maltrattamenti, in Digesto It., 230. ���about:blank Pagina 20 di 21
16/07/14 15:55
[44] C. Parodi, Ancora su mobbing e maltrattamenti in famiglia, cit.. ���[45] Trib. Milano, Sez. Cassano d'Adda, 14 marzo 2012, in http://penalecontemporaneo.it.
[46] Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 2010, n. 44803, in Cass. pen., 2011, 10, 3444, con nota di Renzetti, per la quale sussiste «il reato di violenza privata continuata aggravata potendo ricondursi ai puntuali episodi, contestati nell'imputazione cui si è fatto cenno, caratteri di una condotta moralmente violenta e psicologicamente minacciosa, idonei a costringere il lavoratore a tollerare uno stato di deprezzamento delle sue qualità lavorative nel contesto di una condotta articolata in più atti consequenziali ad un medesimo disegno criminoso, con l'intuibile aggravante della commissione del fatto con abuso di relazioni di prestazioni d'opera ex art. 61 cod.
pen., n. 11. In tale senso va opportunamente qualificato il fatto, proprio avuto riguardo alle concludenti emergenze tipicizzanti il rapporto tra un capo officina ed un meccanico nel contesto di un'azienda organicamente strutturata in termini affatto riconducibili a situazioni ancorate ad ambiti familiari come innanzi segnalati».
[47] Cfr., A.M. Maugeri, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, 2010, 201.
[48] F. Amato - M.V. Casciano - L. Lazzeroni - A. Loffredo, Il mobbing - Aspetti lavoristici: nozione, responsabilità, tutele, Milano, 2002, 30.
[49] Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2012-21 marzo 2013, n. 7042. Anche nel caso deciso da Cass. civ., sez. un., 28 maggio 2012, n. 8407, in Giust. civ. Mass., 2012, 5, 677, il Supremo collegio ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che, su richiesta del Procuratore generale presso questa Corte, ha disposto in via cautelare il trasferimento provvisorio dal Tribunale di Trani a quello di Matera, con le stesse funzioni di giudice, di un magistrato donna, che era stata sottoposta a procedimento penate per i reati di atti persecutori, ingiuria, diffamazione, lesione personale, percosse, danneggiamento, commessi in danno del collega, all'epoca dell'esaurimento di una loro travagliata relazione sentimentale.
[50] L. Ferrarella, Stalking al capo: il Giudice gli ordina di non avvicinarsi, in http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10maggio4/ferrarellastalking-1602952462330.sbody (4 maggio 2010).
6. MOBBING E ONERE DELLA PROVA ���
Cassazione civile, sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 898 ���
E’ il lavoratore che deve provare la sussistenza del mobbing
Il lavoratore ha l'onere di provare, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., il carattere persecutorio dei comportamenti del datore di lavoro, l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico e l'intento persecutorio. Elementi questi che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla.
Nel caso in esame, una dipendente del Consorzio nazionale concessionari (poi Equitalia) si era rivolta al tribunale per sentir dichiarare la illegittimità delle note di qualifica («mediocre») attribuite dal datore di lavoro e la illegittimità della condotta di mobbing di cui era stata vittima. Inoltre, aveva chiesto la condanna dello stesso Consorzio al pagamento del premio di rendimento in merito agli anni dal 1998 al 2002, cioè per il tempo di attribuzione del giudizio di mediocre; e al risarcimento di tutti i danni causati dall'illegittima condotta persecutoria: danno biologico, danno esistenziale e danno alla professionalità.
Nella specie il tribunale ha ritenuto che le allegazioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio non fossero idonee a fondare una pronunzia favorevole alla R. in relazione alla genericità delle medesime.
La Corte d'appello ha confermato questa valutazione con motivazione ampia, puntuale ed immune da vizi logici. Ha considerato la Corte territoriale che è mancata la specificazione delle circostanze di luogo, di tempo e dei
singoli soggetti che avrebbero realizzato i singoli comportamenti denunziati. È mancato nel ricorso introduttivo ogni riferimento alla correlazione tra professionalità precedentemente acquisita e le nuove mansioni. In particolare la R. nulla ha detto sulla personalizzazione e specifica discriminazione in suo danno rispetto ai colleghi di lavoro inseriti nelle medesime articolazioni organizzative; e comunque - aggiunge la Corte territoriale - ogni intento persecutorio risultava escluso posto che la R. fu trasferita e spostata dall'uno all'altro dei settori o uffici unitamente agli altri colleghi di lavoro per ragioni organizzative che erano risultate documentate. Inoltre generica, perché priva di riferimenti temporali, era l'allegazione relativa alla mancata concessione dei permessi nelle giornate richieste.
Ed anche la deduzione relativa all'esclusione dalla partecipazione ai corsi di formazione sul nuovo sistema informatico era generica, per la mancata precisazione del tempo in cui il corso sarebbe stato effettuato. Analoghe considerazioni ha svolto la Corte d'appello in merito alla allegazione relativa alla mancata ammissione alla effettuazione di lavoro straordinario; la R. non aveva riferito del tempo in cui avanzò richieste in tal senso, nulla specificando in merito alla effettuazione di prestazioni straordinarie di colleghi del suo medesimo ufficio o settore.
Quanto poi alla dotazione di strumentazione informatica di lavoro, la Corte d'appello ha ritenuto il ricorso essere generico posto che la R. non aveva precisato se e per quale ragione il personal computer che assumeva di non avere ottenuto, a differenza degli altri lavoratori (quali, quanti, a quale servizio e mansioni adibiti nulla era stato specificato) e quello che sarebbe stato sostituito non fossero idonei allo svolgimento delle sue mansioni.
La Corte d'appello ha poi condiviso la valutazione di merito del tribunale secondo cui i singoli fatti denunziati come ascrivibili ad un unico intento persecutorio ciascuno in sé considerato non presentavano il carattere della ritorsività ed ostilità.
In questo contesto la richiesta di Ctu aveva effettivamente natura inammissibilmente esplorativa - come ritenuto dai giudici di merito - e non poteva valere a colmare le carenze in termini di allegazione di circostanze di fatto astrattamente significative della lamentata condotta di mobbing.
A fronte di questa puntuale motivazione le censure mosse dalla R. si risolvono in un mero dissenso valutativo degli elementi di fatto allegati dalla ricorrente a fondamento della sua domanda.
Cassazione civile, sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2038 ���
Conseguente onere dell'accusato di provare di aver adottato le cautele per evitare il danno
L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una «causa di servizio» implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.
Cassazione civile, sez. lav., 22 gennaio 2013, n. 1471
Prova della responsabilità del datore di lavoro per condotte mobbizzanti poste in essere da altri colleghi
La riconducibilità della responsabilità del datore di lavoro alla previsione delle norma di cui all'art. 2087 cod. civ. consente l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. a carico del datore di lavoro, che pertanto dovrà dimostrare di avere adottato tutte le misure dirette ad impedire la protrazione della condotta illecita.
Cassazione civile, sez. lav., 25 luglio 2013, n. 18093 ���
Datore di lavoro esente da responsabilità se prova che manca il rapporto di occasionalità necessaria
La fonte della responsabilità a carico del datore di lavoro nelle ipotesi di mobbing posto in essere da altri dipendenti non si esaurisce nell'art. 2087 cod. civ. ma, anche al fine di evitare pericolose sacche di impunità risolventisi in pregiudizi per l'integrità del lavoratore che rappresenta un valore costituzionalmente garantito in uno alla sua sicurezza, concorre con l'istituto previsto dall'art. 2049 cod. civ. che disciplina il sistema delle responsabilità dei padroni e dei committenti per fatto del dipendente.
Il datore di lavoro va esente da responsabilità solo nel caso in cui il dipendente autore del fatto illecito abbia agito con dolo e al di fuori del cd. «rapporto di occasionalità necessaria» con le proprie mansioni, vale a dire quando l'evento lesivo si sia verificato sul luogo di lavoro solo in via del tutto accidentale e casuale.
Non basta quindi ad escludere ex sé la responsabilità del datore di lavoro la condotta dolosa del dipendente in quanto ciò non è sufficiente ad elidere il rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni affidategli, tutte le volte in cui tale condotta sia resa possibile oppure agevolata dal rapporto di lavoro con il committente, il quale quindi è chiamato a risponderne ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. La responsabilità è configurabile in tutti quei casi nei quali la mansione affidata dal datore di lavoro al suo dipendente abbia reso possibile il fatto illecito, collegando, in tal modo, l'esercizio delle incombenze, cui un lavoratore è adibito, e la commissione da parte del datore di lavoro se non proprio con un nesso di causalità, quanto meno con un rapporto di occasionalità necessaria.
Ma è evidente che una eventuale defaillance da parte del datore di lavoro sul piano della organizzazione dell'impresa e del lavoro all'interno di essa costituisce dato di partenza per enucleare una fonte autonoma di responsabilità per il datore di lavoro.
Invero muovendo dalla considerazione della sempre maggiore frequenza di episodi di molestie e/o violenze sessuali all'interno dei luoghi di lavoro, non può certo considerarsi inesigibile l'obbligo gravante esclusivamente sul committente di predisporre modelli organizzativi tali da prevenire la commissione di reati da parte dei dipendenti, le cui modalità di svolgimento delle singole attività lavorative potrebbero agevolare la commissione del fatto illecito laddove per esempio non siano state adottate tecniche organizzative tali da scongiurare eventi del tipo di quelli all'esame di questa Corte.
Può quindi, conclusivamente, affermarsi il principio che ove il comportamento dell'agente venga ritenuto riferibile sia pure marginalmente o indirettamente alle mansioni in concreto esercitate ed affidategli dal datore di lavoro questi deve essere chiamato a rispondere per fatti illeciti commessi dal dipendente in danno di terzi, mentre quando la condotta sia frutto di una iniziativa estemporanea e personale del tutto incoerente rispetto alle mansioni svolte (oltre che affidate) manca quel nesso di occasionalità necessaria che solo può giustificare una
attribuzione di responsabilità in capo al datore di lavoro, non ponendo rientrare in tale concetto un semplice elemento di collegamento di tipo temporale o spaziale. Solo ove tali incombenze abbiano reso possibile o almeno agevolato il verificarsi dell'illecito può parlarsi di responsabilità a carico del datore di lavoro.
Cassazione civile, sez. lav., 5 novembre 2012, n. 18927
Prova presuntiva del carattere vessatorio delle condotte …
La prova presuntiva del carattere vessatorio è tratta dal fattore oggettivo, in applicazione dei principi di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.; costituisce corretta inferenza logica ritenere che il riferito comportamento integri una serie causale idonea, per le sue caratteristiche di ripetitività e protrazione nel tempo e idoneità lesiva, a integrare in modo inequivoco la prova indiretta del carattere vessatorio della condotta datoriale, secondo una sequenza deduttiva che da elementi noti tragga la certezza dell'esistenza del fatto ignoto.
Cassazione civile, sez. lav., 5 novembre 2012, n. 18927 ���.
…mutuata dalla giurisprudenza in materia di prova del danno da demansionamento
Con riguardo all'onere della prova, anche prima dell'entrata in vigore dei citati D.Lgs. n. 215 e n. 216 del 2003, nel nostro ordinamento processuale era già previsto che, nel rito del lavoro, il principio dispositivo deve essere contemperato con quello della ricerca della verità materiale, con l'utilizzazione da parte del giudice anche di poteri officiosi oltre che della prova per presunzioni, alla quale, specialmente in casi come quello in oggetto, va attribuito precipuo rilievo, secondo la giurisprudenza di questa Corte.
Infatti, la prova presuntiva (o indiziaria) - la quale esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri e quindi esclude che il giudice, avendo a disposizione una pluralità di indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. 9 marzo 2012, n. 3703) - consente attraverso la complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, gravità, frustrazione personale e/o professionale, altre circostanze del caso concreto) di poter risalire coerentemente, con un prudente apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
Ciò, del resto, è conforme al consolidato orientamento di questa Corte in materia di prova del danno da demansionamento (Cass. S.U. 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass. S.U. 24 marzo 2006, n. 6572 del 2006; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832; Cass. 26 novembre 2008, n. 28274), oltre che trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa in materia di mobbing (Cons. Stato 21 aprile 2010, n. 2272).
Cassazione civile, sez. lav., 19 dicembre 2013, n. 28448
Non basta riportarsi alla Ctu per provare il mobbing...
Posto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma solo uno strumento di controllo dei fatti costituenti la prova, il lavoratore che adduca di aver subito condotte discriminatorie e persecutorie è gravato del relativo onere probatorio, non essendo sufficiente riportarsi ad episodi riferiti dal Ctu (nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav., 18 settembre 2013, n. 21344).
Cassazione civile, sez. lav., 28 giugno 2013, n. 16413 ���
…la C.T.U. invece assume grande valore per la determinazione del danno
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, nei giudizi in cui sia stata esperita Ctu medico-legale, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell'ausiliare giudiziario, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica (cfr, ex plurimis, Cass., n. 17324 del 25 agosto 2005; id. n. 7049 del 22 marzo 2007; n. 18906 del 7 settembre 2007; n. 8654 del 3 aprile 2008).
Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto di avvalersi degli accertamenti e delle valutazioni del consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado il quale aveva ritenuto, allo stato delle conoscenze, che non vi fosse alcuna evidenza scientifica ed empirica che uno stato depressivo, anche se protratto nel tempo, potesse determinare l'insorgenza di un processo tumorale. Dunque, ad avviso della Corte leccese non vi erano elementi per sostenere che un evento stressante potesse essere all'origine di quelle complesse trasformazioni, a livello cellulare, che portano alla comparsa della malattia tumorale (ancorché quest'ultima fosse stata diagnosticata nel giugno del 1999 e cioè due anni dopo l'arrivo del dipendente presso la sede lavorativa ove egli era stato posto in una condizione di isolamento e svilimento della sua dignità di uomo e lavoratore).
Tar Liguria - Genova, sez. II, 11 dicembre 2012, n. 1629
Cautela di giudizio nei processi per mobbing
Nell'esaminare i casi di preteso mobbing il giudice deve evitare di assumere acriticamente l'angolo visuale prospettato dal lavoratore che asserisce di esserne vittima. Da un lato, infatti, è possibile che i comportamenti del datore di lavoro, pur se oggettivamente sgraditi, non siano tali da provocare significative sofferenze e disagi, se non in personalità dotate di una sensibilità esasperata o addirittura patologica. Dall'altro, è possibile che gli atti del datore di lavoro (pur sgraditi) siano di per sé ragionevoli e giustificati in quanto indotti da comportamenti reprensibili dello stesso interessato, ovvero da sue carenze sul piano lavorativo, o da difficoltà caratteriali, etc. Non si deve cioè sottovalutare l'ipotesi che l'insorgere di un clima di cattivi rapporti umani derivi, almeno in parte, anche da responsabilità dell'interessato. Tale ipotesi può, anzi, essere empiricamente convalidata dalla considerazione che diversamente non si spiegherebbe perché solo un determinato individuo percepisca come ostile una situazione che invece i suoi colleghi trovano normale. Tale cautela di giudizio si impone in particolare laddove l'ambiente di lavoro presenti delle peculiarità, come nel caso delle Amministrazioni militari o gerarchicamente organizzate (come i Corpi di Polizia), caratterizzate per definizione da una severa disciplina e nelle quali non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e non tutte le carenze possono essere tollerate: infatti, in questa situazione un approccio condizionato dalla rappresentazione soggettiva (se non strumentale) fornita dall'interessato può essere quanto mai fuorviante.
Cassazione civile, sez. lav., 21 gennaio 2014, n. 1149
In Cassazione niente censure di fatto sul mobbing ...
Nel giudizio di Cassazione non è possibile svolgere delle mere censure di fatto che esprimono un dissenso in ordine alla valutazione operata (negli stessi termini) dai giudici di merito, sia in primo grado che in grado d'appello, i quali entrambi hanno ritenuto che non risultassero provati né la dequalificazione né i comportamenti di mobbing che il ricorrente imputava all'azienda.
Cassazione civile, sez. lav., 28 giugno 2013, n. 16413
... e niente valutazione delle risultanze probatorie
Deve ribadirsi l'indirizzo consolidato in base al quale la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta, tra queste, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, con la conseguenza che il controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova, non essendo conferito alla Suprema Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è, appunto, riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. ex plurimis Cass. n. 6288 del 18 marzo 2011, id. n. 27162 del 23 dicembre 2009 e n. 17477 del 9 agosto 2007). Ond'é che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in tali termini, cfr. Cass. 23 maggio 2007 n. 120520).
Nel caso in rassegna con sentenza n. 246/2007 del 18 febbraio 2008 la Corte d'appello, giudice del lavoro, di Lecce confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in parziale accoglimento della domanda di un lavoratore nei confronti della società, aveva ritenuto che il ricorrente, con il trasferimento presso la base di Taranto della divisione ... fosse stato privato, di fatto, di ogni compito lavorativo e posto in una condizione di isolamento e svilimento della sua dignità di uomo e lavoratore causativa dello stato depressivo in cui era caduto.
Per i giudici di legittimità, in aderenza alla suddetta regola di diritto, rileva questa Corte che il giudice del merito ha fatto corretta applicazione della legge e della logica ed ha compiutamente esposto le ragioni per cui, sulla base delle deposizioni testimoniali era da confermare la ricostruzione operata dal Tribunale secondo la quale il lavoratore al momento del suo trasferimento presso la base di Taranto della divisione ..., era stato privato, di fatto, di ogni compito lavorativo restando così pregiudicato nella sua identità culturale e professionale. Inoltre la Corte territoriale ha chiaramente escluso che l'inoperosità del dipendente potesse essere la conseguenza di una oggettiva carenza di lavoro o di problemi di carattere organizzativo derivanti da accordi conclusi in ordine siderurgico per contenere l'espulsione di manodopera, con ciò dando atto di un
completo esame di tutte le risultanze di causa e dei rilievi della parte appellante.
Cassazione civile, sez. lav., 15 gennaio 2014, n. 687
Autonomia e separazione dei giudizi penale e civile
In applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile - in presenza di un giudicato penale - di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (Cass. n. 15112 del 2013). La valorizzazione della sentenza penale ha costituito - come è reso evidente dal tenore della sentenza impugnata ("non va inoltre trascurato, quale ulteriore elemento dotato di sinergica convergenza, che con la sentenza ...») - un elemento solo integrativo dell'iter formativo del convincimento giudiziale, di talché la censura che investe tale punto è priva del carattere di decisività.
Cassazione civile, sez. lav., 18 settembre 2013, n. 21344 ���
Per risarcire il danno da mobbing occorre allegare l'esistenza del pregiudizio e del nesso di causalità
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass., n. 19785 del 2010).
Cassazione civile, sez. lav., 22 ottobre 2013, n. 23949
Risarcibilità dei danni da mobbing maturati nel corso del processo
Proposta domanda per l'accertamento di un comportamento di dequalificazione e mobbing tra i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto fornire prima e che il giudice alla prima udienza deve ammettere (art. 420, comma 5, c.p.c.), rientrano anche quelli relativi a fatti avvenuti successivamente al deposito del ricorso, purché rientranti nella causa petendi e nel petitum della domanda.
Questa Corte ha già precisato (cfr. ex plurimis Cass. n. 10045/1996) che la domanda giudiziale di risarcimento
del danno si fonda su di una causa petendi identificabile in uno specifico accadimento lesivo spazialmente e temporalmente determinato, sicché, una volta che essa sia stata proposta in relazione a determinati fatti, il riferimento all'eventualità che nelle more del giudizio abbiano a verificarsi nuovi accadimenti (siano pur essi omogenei rispetto ai precedenti), suscettibili di ledere ancora la situazione giuridica protetta e di cagionare così una ulteriore ragione di danni, non introduce alcuna valida domanda, né, una volta che tali fatti si siano verificati, può legittimare alla sua proposizione nel corso del giudizio. Ne deriva che la richiesta di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa comporta un non consentito mutamento della primitiva domanda, con la conseguente inammissibilità della stessa anche in appello, senza che, in contrario, possa argomentarsi dalla deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 345, primo comma, c.p.c, trovando tale norma applicazione solo quando nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, e giustificandosi tale deroga solo nel presupposto che si incrementino le conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, senza che gli ulteriori danni siano ricollegabili anche a fatti nuovi e diversi.
In definitiva, la Cassazione ammette la risarcibilità degli ulteriori danni maturati nel corso del processo, ma, allo stesso tempo, sottolinea la necessità, a questi fini, che si tratti di «conseguenze risarcitorie dipendenti dall'unico fatto dedotto con il ricorso introduttivo», e non di eventi provocati da circostanze diverse successive alla proposizione della domanda, sulle quali si renda necessaria un'ulteriore indagine in punto di fatto. Proprio nel caso di specie, le ulteriori conseguenze dannose che si assumono verificate dopo il deposito del ricorso introduttivo sono dipendenti da ulteriori sviluppi della vicenda lavorativa.
Tribunale della funzione pubblica Ue, sez. I, 5 novembre 2013, causa F-63/12
Rimborso spese per giudizio mobbing
La Banca europea per gli investimenti (Bei) deve restituire senza indugio le spese legali saldatele da un suo dipendente che, in primo grado, aveva visto respinto il suo ricorso per mobbing, accolto, però, in appello. È irrilevante che il Tribunale Ue. non abbia ancora sciolto la riserva sulle spese di questo giudizio.
È quanto stabilito dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, sez. I, (caso F-63/12, De Nicola c. Bei) con questa sentenza del 5 novembre 2013: ha condannato la Bei alla ripetizione delle spettanze, versatele dal dipendente soccombente in prime cure, dopo che il Tribunale Ue aveva annullato parzialmente la decisione impugnata.
Nel caso di specie, un agente della Bei la citava in giudizio presso questa Corte per chiedere
«l'annullamento della decisione del 14 dicembre 2007 con cui il comitato per i ricorsi della Bei aveva respinto il suo ricorso volto, da un lato, a riesaminare il giudizio attribuitogli per il 2006 e, dall'altro, all'annullamento delle decisioni della Bei del 13 luglio 2007 relative alle promozioni attribuite per l'anno 2006, in quanto esse non lo avevano promosso nella funzione D; in secondo luogo, l'annullamento del suo rapporto informativo del 2006 e delle decisioni del 13 luglio 2007, in quanto esse non lo avevano promosso in detta funzione; in terzo luogo, la constatazione che egli era stato vittima di molestie psicologiche; in quarto luogo, la condanna della Bei al risarcimento dei danni che egli riteneva aver subìto a causa di tali molestie e, infine, l'annullamento della decisione di rifiuto di presa in carico di determinate spese mediche di laserterapia». Con la sentenza F-55/08 del 30 novembre 2009 il Tribunale della funzione pubblica dell'Ue respingeva il ricorso e lo condannava a saldare una parcella da euro 6.000,00. Dopo vari solleciti onorava il suo debito e, nel frattempo, gravava la decisione presso il Tribunale, sez. impugnazioni, che lo accoglieva limitatamente ai primi motivi sopra indicati (mancato avanzamento di carriera, mobbing e risarcimento del danno), riservandosi sulle spese di lite, non ancora quantificate dato che la sentenza del 27 aprile 2012 (T-37/10) non è stata ancora inserita nella raccolta giurisprudenziale, pur essendo consultabile sul sito istituzionale. Inascoltati i solleciti di refusione, ricorreva in
ottemperanza di questa pronuncia presso questa Corte che lo accoglieva.
Il Tribunale smentisce la tesi della Bei che rifiutava detta restituzione, sostenendo di non essere tenuta a farlo finché il Tribunale non si pronuncerà sulle spese di entrambi i gradi di giudizio. Infatti l'art. 115 del regolamento di procedura, approvato il 1° novembre 2007, sancisce che l'annullamento di una sentenza o di un'ordinanza di rinvio a questa Corte da parte del Tribunale comporta che questi decida l'attribuzione delle spettanze di entrambi i gradi di giudizio. Ciò vale anche se l'accoglimento dell'appello è parziale, sì che questa sentenza «ha l'effetto di annullare le disposizioni con cui il Tribunale (della funzione pubblica, ndr), in tale sentenza o in tale ordinanza, ha statuito sulle spese». La Bei dovrà, perciò, restituire euro 6.000,00 incassati oltre interessi calcolati «sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo considerato, maggiorato di due punti». Ovviamente, appena sciolta la riserva, dovrà pagare anche le altre competenze così come quantificate dal Tribunale.
7. MOBBING E LICENZIAMENTO
Cassazione civile, sez. VI, 27 settembre 2012, n. 16503
Mobbing orizzontale e licenziamento del mobber: legittimo
Sono riscontrabili gli estremi della giusta causa di licenziamento nella condotta del lavoratore consistita nell'avere posto in essere un vero e proprio comportamento persecutorio nei confronti di un collega di lavoro, per di più affetto da grave handicap psichico, e nell'aver pesantemente insultato altri colleghi intervenuti per difenderlo.
L'ordinanza de qua presenta estremo interesse laddove il ricorrente ritiene innanzitutto che la sanzione applicata è assolutamente sproporzionata, anche perché - viene evidenziato nel ricorso proposto in Cassazione - l'azienda, pur essendo da tempo al corrente della situazione, non aveva adottato «alcuna misura idonea a salvaguardare la disciplina aziendale e l'incolumità del lavoratore pesantemente offeso. Chiara l'ottica proposta: i vertici aziendali, alla luce dei ripetuti episodi, avevano il compito di intervenire prima, piuttosto che aspettare il fattaccio e arrivare all'estrema conseguenza del licenziamento. Ma tale prospettiva non trova assolutamente accoglimento in Cassazione. Al contrario, secondo i giudici di legittimità, era doveroso l'intervento drastico dell'azienda per far cessare siffatto comportamento, già ripetuto in passato, anche tenendo presente il rischio che essa avrebbe potuto essere chiamata in causa, ai sensi degli artt. 2087 e 2049 cod. civ., come responsabile di danni da mobbing.
Cassazione civile, sez. lav., 18 settembre 2009, n. 20272
���Mobbing verticale e licenziamento dell'autore delle molestie sessuali: legittimo
Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. sicché deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro, a nulla rilevando la mancata previsione della suddetta ipotesi nel codice disciplinare ed avendo il datore di lavoro in ogni caso l'obbligo di adottare i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, provvedimenti tra i quali può certamente ricomprendersi anche il licenziamento dell'autore delle molestie sessuali minando un tale illecito disciplinare fortemente l'elemento
fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro e rendendo dunque proporzionata la sanzione del licenziamento in tronco dell'autore di una tale violazione; nel caso di specie, sussiste proporzione tra sanzione disciplinare applicata e mancanza commessa, avuto riguardo a tutti gli aspetti del caso concreto e tenuto conto che le molestie sessuali sono state compiute durante l'orario di lavoro, nel corso del turno di notte, da un lavoratore sovraordinato (capo squadra), provocando nella vittima una profonda lacerazione dello stato psico-fisico con ripercussioni anche in ambito familiare.
Il fenomeno del c.d. mobbing verticale si configura come obbligo del datore di lavoro di rispettare la personalità del suo lavoratore evitando ogni comportamento che, pur formalmente corretto, possa risolversi in una forma di pressione, di accerchiamento, sì che il lavoratore possa avvertire questa sorta di presenza costante, il fiato sul collo, la consapevolezza che ogni manifestazione della sua personalità non gradita al datore possa comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano del rapporto contrattuale.
Cassazione civile, sez. lav., 2 ottobre 2013, n. 22538
Licenziamento del lavoratore assente per malattia dovuta a mobbing del datore di lavoro: illegittimo
È illegittimo il licenziamento di un dipendente per lo scavalcamento del periodo di comporto qualora le assenze per malattia sono conseguenza dell'ambiente lavorativo e della condotta aziendale posta in essere nei confronti del lavoratore, in particolare con le numerose sanzioni disciplinari poi accertate come illegittime, da ciò derivando la loro non computabilità ai fini del calcolo del periodo di comporto. Pertanto la società va condannata alla reintegrazione del dipendente nel suo posto e al risarcimento del danno.
Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 2013, n. 14643
���Malattia dovuta a mobbing: assenza da non conteggiare per il comporto e licenziamento illegittimo
Nel caso in cui la malattia, per la quale si superi il periodo di comporto, è causata da demansionamento illegittimo e da altri comportamenti datoriali integranti la condotta di mobbing, con conseguente lesione della salute della dipendente, che ne aveva determinato il superamento del periodo di comporto per malattia, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento.
Decisiva, per considerare acclarato questo quadro, è la ricostruzione del clima aziendale nei confronti della dipendente: svuotamento di mansioni ai danni della lavoratrice, col chiaro obiettivo di renderle la vita impossibile e di costringerla a dimettersi.
Nessun dubbio è possibile, chiariscono i giudici, sulla condotta tenuta dall'azienda, che può essere legittimamente qualificata come mobbing, e che si è concretizzata con la mortificazione morale e l'emarginazione della dipendente, tanto da lederne l'equilibrio psico-fisico e la personalità.
Ciò comporta, di conseguenza, che le assenze per malattia della lavoratrice siano legate all'illegittimo e discriminatorio comportamento datoriale: quindi, tali assenze, concludono i giudici, non sono da computare ai fini del periodo di comporto. Per questo motivo, il licenziamento operato dall'azienda, in questo caso, è assolutamente illegittimo.
Cassazione civile, sez. lav., 25 luglio 2013, n. 18093 ���
Licenziamento disciplinare provocato da mobbing del datore di lavoro: illegittimo
È illegittimo il licenziamento laddove il quadro che aveva portato alla massima sanzione disciplinare - il lavoratore, armato di barra metallica, avrebbe aggredito fisicamente il suo superiore, rivolgendogli anche pesanti insulti e minacce - oltre a risolversi in una mera minaccia, andava ampiamente ridimensionato per effetto del «capillare comportamento vessatorio» da tempo realizzato dal datore di lavoro, idoneo a ledere la capacità di autocontrollo del dipendente.
La sussistenza di un tale contesto vessatorio emergeva inconfutabilmente dagli atti acquisiti nel giudizio penale svoltosi a carico del B. per il reato ex art. 572 c.p.c, (maltrattamenti) nei confronti del P., sfociato nelle condanna del primo in entrambi i gradi di giudizio; ciò che rendeva del tutto sproporzionata l'irrogata sanzione del licenziamento e che giustificava un risarcimento, a carico del datore di lavoro, responsabile ex art. 2087 cod. civ., per le sofferenze subite dal dipendente, equitativamente determinato in euro 5.000,00.
Cassazione civile, sez. lav., 13 settembre 2012, n. 15353
���Licenziamento disciplinare (ingiurie) provocato da mobbing del datore di lavoro: illegittimo
Il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato in conseguenza di un comportamento, l'avere rivolto ai datori di lavoro epiteti offensivi, per il quale è stato poi sottoposto a procedimento penale per ingiuria, in seguito a querela delle persone offese costituitesi parti civili nel processo penale, non può, in considerazione dell'identità del fatto materiale, rispettivamente vagliato in sede penale quale ingiuria e in sede civile quale condotta che ha determinato il licenziamento, considerare ininfluente la sentenza dibattimentale penale di assoluzione conclusiva del suindicato procedimento penale divenuta cosa giudicata e le prove ritualmente raccolte in sede penale, ai fini della valutazione della condotta del lavoratore e della prova della giusta causa del licenziamento, a maggior ragione quando in sede penale il comportamento addebitato al lavoratore-imputato sia stata ritenuto non punibile perché provocato da «una condotta mobbizzante» del datore di lavoro.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore fatto oggetto di ben dieci sanzioni disciplinari conservative, quindi licenziato per aver rivolto parole offensive al datore di lavoro. Il lavoratore aveva subito un processo penale per ingiuria dal quale era stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Infatti, il giudice penale aveva ritenuto sussistere l'esimente della provocazione (prevista dall'art. 599, comma 2, c.p., quando l'ingiuria è stata commessa nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo lo stesso), in quanto il lavoratore era stato sottoposto a mobbing nel luogo di lavoro.
Cassazione civile, sez. lav., 21 novembre 2013, n. 26143
Dipendente registra conversazioni di colleghi per provare il mobbing verticale discendente: licenziamento legittimo
Costituisce comportamento grave, tale da giustificare il licenziamento del dipendente, quello del medico di una struttura ospedaliera che abbia registrato e diffuso le conversazioni intrattenute dai colleghi in un ambito strettamente lavorativo alla presenza del primario ed anche nei loro momenti privati svoltisi negli spogliatoi o nei locali di comune frequentazione, utilizzandole strumentalmente per una denunzia di mobbing, rivelatasi, in seguito, infondata, con evidente violazione del loro diritto alla riservatezza.
Nel caso specifico, la reazione dei medici coinvolti, quale riportata nella lettera da loro inviata alla Direzione
sanitaria con la richiesta di adozione di provvedimenti necessari per la prosecuzione da parte di ciascuno di loro di un sereno ed efficace rapporto lavorativo, ha consentito ai giudici di merito di prendere atto del clima di mancanza di fiducia che si era venuto a creare nei confronti del ricorrente, fiducia indispensabile per il miglior livello di assistenza e, quindi, funzionale alla qualità del servizio, il tutto con grave ed irreparabile compromissione anche del rapporto fiduciario che avrebbe dovuto permeare il rapporto tra il dipendente e l'Azienda ospedaliera datrice di lavoro.
8. MOBBING E RESPONSABILITÀ PENALE
Talvolta le condotte mobbizzanti travalicano i confini della responsabilità civile per essere sussumibili, talune o tutte insieme complessivamente considerate, in specifiche fattispecie incriminatrici.
In assenza di un reato ad hoc per reprimere le vessazioni nell'ambiente lavorativo (previsto, invece, in Francia, il
reato di harcèlement moral) [1], la tutela penale dal mobbing è stata operata dalla giurisprudenza, in alcuni casi, limitandosi a punire i singoli episodi di aggressione verbale, di vessazione o di violenza inquadrandoli nei delitti di minacce (art. 612 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), molestie e violenza sessuale (art. 660 e 609-bis c.p., nell'ipotesi di mobbing sessuale), estorsione (art. 629 c.p.). Inoltre, si è cercato di inquadrare le azioni persecutorie, nel rapporto di pubblico impiego, nel delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
[1] La Legge francese del 17 gennaio 2012, n. 73, prevede l'introduzione di una specifica figura di reato relativa al mobbing, tramite l'inserimento nel codice penale di una sezione intitolata all'harcèlement moral e di un art., il 222-33-2, che sanziona «il fatto di molestare gli altri attraverso comportamenti ripetuti aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibili di ledere i suoi diritti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale o di compromettere il suo avvenire professionale». La pena prevista è della reclusione fino ad un anno o la multa di 15.000 euro.
Cassazione penale, sez. II, 12 dicembre 2013, n. 50074
Estorsione
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, per costringere i suoi dipendenti ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, li minacci di licenziamento. L'ingiustizia del profitto è in re ipsa, riferita alle prestazioni non corrisposte, che si traducono anche nella ingiustizia del licenziamento, pervaso da un disvalore giuridico penale che proviene dalla sua ingiusta causa.
Nello stesso senso, Cassazione penale, sez. II, 3 agosto 2012, n. 31535, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena detentiva e quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nei confronti dell'uomo, che invano tentava di giustificare la prassi con la necessità di salvare posti di lavoro in tempo di crisi.
L'imputato, titolare di una azienda, imponeva stipendi più bassi e in generale condizioni contrattuali contrarie alla legge e ai contratti collettivi, sotto minaccia di licenziamento, per la verità non esplicita, bensì "larvata", ma comunque indicativa di un comportamento scorretto di chi si avvale delle attuali condizioni del mercato del lavoro, dove l'offerta prevale sulla domanda.
Non serve addurre a giustificazione della propria condotta l'intento di disapplicare i contratti collettivi per evitare il rischio di chiusura dell'azienda e la conseguente perdita per i dipendenti del posto di lavoro: a maggior ragione integra il reato ex art. 629 c.p. il comportamento del datore perpetrato in presenza di cicli economici di alti tassi di disoccupazione, come quello attuale, e in contesti di grave crisi occupazionale, come sono spesso ampi settori dell'Italia meridionale, luogo in cui si è svolta la vicenda.
Inutile, ancora, invocare una sorta di "complicità" dei lavoratori, i quali sarebbero stati d'accordo con le pratiche scorrette attuate in azienda pur di non essere licenziati.
Per i giudici di legittimità anche questa è una forma, sia pure lieve, di minaccia idonea ad integrare i presupposti del reato di estorsione: l'individuazione degli estremi della estorsione, infatti, sta nella condotta dell'imprenditore che, approfittando della situazione di mercato di lavoro a lui favorevole, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.
La situazione critica del mercato del lavoro confermata dal rischio di chiusura dell'azienda, è indubbiamente una condizione propizia per coartare la volontà dei dipendenti, e di essa il datore di lavoro ha approfittato. Per questi motivi non riesce ad evitare la condanna, anche se parte dei reati risulta prescritta e la Corte d'appello dovrà procedere ad una nuova determinazione della pena.
Ancora, per Cassazione penale, sez. VI, 31 agosto 2010, è punibile per il reato di estorsione l'imprenditore che minacci di licenziamento i propri dipendenti nel caso in cui questi non accettino una retribuzione inferiore a quanto indicato nella busta paga; lo stesso vale per l'imposizione di apporre la propria firma su lettere di dimissioni in bianco onde evitare le disposizioni legislative dettate in tema di preavviso al licenziamento. La Suprema Corte sottolinea, come da giurisprudenza consolidata, che in nessun caso può essere legittimata e ricondotta «alla normale dinamica di rapporti di lavoro» un'attività minatoria, in danno di lavoratori dipendenti, che approfitti delle difficoltà economiche o della situazione precaria del mercato del lavoro per ottenere il loro consenso a subire condizioni di lavoro deteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento giuridico, in attuazione delle garanzie che la Costituzione della Repubblica pone a tutela della libertà, della dignità e dei diritti di chi lavora. Inoltre, la minaccia, intesa quale elemento costitutivo del reato di estorsione, non deve necessariamente essere ricondotta alla prospettazione, a fini di coartazione, di un male irreparabile alle persone o alle cose tale da impedire alla persona offesa di operare una libera scelta; è invece sufficiente che, in considerazione delle circostanze concrete in cui la condotta viene posta in essere, questa sia comunque idonea a far sorgere il timore di subire un concreto pregiudizio.
Cassazione penale, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 1167
Violenza sessuale
Va annullata con rinvio la sentenza d'appello che, ribaltando la pronuncia di condanna di primo grado, nell'assolvere il datore di lavoro per violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. ai danni di una giovanissima commessa che lavorava nel suo negozio di abbigliamento, non ha delineato le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e non ha confutato specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.
La Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale, assolveva un uomo accusato di molestie ai danni di una giovanissima commessa che lavorava nel suo negozio di abbigliamento, non essendo stata raggiunta la prova della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio. Secondo i giudici, infatti, ci si trovava in presenza di un comportamento anomalo della ragazza che, dopo aver subito delle avances sessuali da parte del
suo datore di lavoro, si era volontariamente posta nelle stesse condizioni in cui quelle stesse avances erano avvenute. Tanto più che non vi erano riscontri alle affermazioni della commessa (in particolare, il referto del pronto soccorso).
La Corte territoriale ha basato l'assoluzione dell'uomo sul comportamento anomalo della ragazza che ne avrebbe intaccato l'attendibilità. Il Tribunale, invece, aveva sottolineato che la sua mancata reazione trovava una ragionevole spiegazione nel disorientamento conseguente al comportamento dell'imputato nei confronti del quale ella aveva un evidente timore reverenziale, trattandosi del suo datore di lavoro e essendo stata da poco assunta. Né poteva addursi, a fondamento della pronuncia favorevole all'imputato in secondo grado, la mancanza di riscontri medici (il referto del pronto soccorso) dal momento che le avances erano consistite in baci sul collo e sulla bocca e in sfregamenti che non lasciano tracce repertabili.
Cassazione penale, sez. V, 15 luglio 2013, n. 30502
Ingiuria
Addebitare pubblicamente al dipendente gli insuccessi aziendali e accusarlo pubblicamente senza prove non serve a migliorare l'andamento o il clima aziendale, ma solo ad esasperare i rapporti lavorativi e interpersonali, configurandosi ai suoi danni il delitto di ingiuria.
Il mobbing, viceversa, potrebbe avere forma scriminante qualora eventuali condotte di ingiuria del lavoratore mobbizzato siano il frutto della reazione ad una provocazione ex art. 599 c.p.; in tal senso, per Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2012, n. 4245, va annullata per nuovo esame la sentenza di merito che, al cospetto di una condotta di mobbing compiuta dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, non abbia verificato se la condotta stizzita del dipendente tradottasi nell'ingiuria rubricata sia da ritenere non punibile in quanto reazione ad una provocazione.
Cassazione penale, sez. IV, 9 aprile 2009, n. 23923
Minacce e lesioni
Provocare ansia e stress nel dipendente con comportamenti ingiuriosi e minacciosi è una forma di mobbing che, come tale, va risarcita indipendentemente dalla responsabilità penale per i reati commessi. Va quindi confermato il verdetto d'appello che ha condannato un dirigente di un ufficio giudiziario a risarcire gli stati ansiosi e depressivi provocati dalla sua condotta aggressiva nei confronti di una cancelliera, nonostante i reati di cui era stato accusato - ingiuria, minaccia e lesioni personali colpose - si fossero prescritti.
Tribunale di Monza, 23 aprile 2007 ���
Lesioni e necessità di dolo diretto (e non eventuale)
L'aver continuato nella condotta originariamente posta in essere, dopo la conoscenza della insorgenza di una malattia in capo a dipendente causata da una attività di costante vessazione antisindacale concretizzante il cd. mobbing, impone l'attribuzione in capo al soggetto agente di una responsabilità non già a titolo di colpa o dolo eventuale, bensì di dolo diretto. Deve, infatti, essere ritenuta riferita ad una ipotesi di responsabilità per dolo diretto la condotta assunta dall'agente allorquando la rappresentazione dell'evento lesivo appaia non già possibile ma altamente probabile (fattispecie in tema di sindrome ansioso-depressiva sofferta da dipendente in relazione a situazioni e condotte subite sul posto di lavoro).
Cassazione penale, sez. VI, 7 novembre 2007, n. 4089
1’Abuso d'ufficio
Va confermata la sentenza di condanna al risarcimento del danno, pur essendosi prescritto il reato di abuso d'ufficio, al Sindaco che attribuisce ad una dipendente comunale nuove e diverse mansioni, incurante della qualifica professionale attribuita in relazione a quella precedentemente rivestita e senza badare all'idoneità del soggetto al nuovo lavoro.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'allora primo cittadino di Scorrano che (chiedendo un proscioglimento nel merito) aveva spostato la ragioniera dell'asilo comunale affidandole le mansioni di ausiliario del traffico. Lei lo aveva denunciato per mobbing e aveva vinto tanto in primo quanto in secondo grado. Infatti il Sindaco era stato condannato, oltre che a risarcire il danno alla dipendente (che nel frattempo era caduta in depressione) anche ad un anno di reclusione per abuso d'ufficio, ravvisando nel comportamento del sindaco una evidente tendenza a mobbizzare la dipendente.
Tuttavia, a parte i casi in cui dalla condotta vessatoria derivi una malattia o la morte della vittima, le norme più spesso richiamate dalla giurisprudenza per punire il mobbing sono quelle relative alla violenza privata (art. 610 c.p.), anche tentata (art. 56 c.p.), e ai maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). L'art. 610 c.p. entra in campo in quei casi in cui la condotta vessatoria sia finalizzata ad ottenere uno specifico comportamento da parte del mobbizzato (spesso le dimissioni o il trasferimento).
Cassazione penale, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 31413
Costringere ad accettare il demansionamento è violenza privata
La condotta del datore di lavoro e del dirigente che, al fine di estromettere il lavoratore dal posto di lavoro, pongano in essere nei suoi confronti comportamenti vessatori, con carattere sistematico e duraturo (c.d. mobbing), integra il delitto di violenza privata, quantomeno allo stadio del tentativo.
In particolare, è configurabile il reato di violenza privata, consumata o tentata, a carico di datori di lavoro i quali costringano o cerchino di costringere taluni lavoratori dipendenti ad accettare una novazione del rapporto di lavoro comportante un loro "demansionamento" (nella specie costituito da declassamento dalla qualifica di impiegato a quella di operaio) mediante minaccia di destinarli, altrimenti, a forzata ed umiliante inerzia in ambiente fatiscente ed emarginato dal resto del contesto aziendale, nella prospettiva di un susseguente licenziamento.
La singolare vicenda oggetto del processo si innesta nell'ambito del fenomeno sociale generalmente noto come mobbing, già esaminato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e consistente in atti e comportamenti (violenza, persecuzione psicologica) posti in essere dal datore di lavoro che mira a danneggiare il lavoratore al fine di estrometterlo dal lavoro, atteggiamenti svolti con carattere sistematico e duraturo. Proprio questa giurisprudenza implica chiaramente la possibilità del travalicamento dei confini meramente civilistici o giuslavoristici della condotta di mobbing con l'integrazione di ipotesi di reato.
In realtà la giurisprudenza ha già acquisito che può esservi condotta molesta e vessatoria o, comunque, mobbing anche in presenza di atti di per sé legittimi e che, simmetricamente, non ogni demansionamento così come non ogni altro atto illegittimo da luogo, a cascata, a mobbing. Affinché ciò avvenga, è necessario che quell'atto emerga come l'espressione, o meglio come uno dei tasselli, di un composito disegno vessatorio. In definitiva, per la sussistenza del fenomeno occorre che diverse condotte, alcune o tutte di per sé legittime, si ricompongano in un unicum, essendo complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio
psico-fisico del lavoratore. Ciò non toglie, ovviamente, che tali condotte, esaminate separatamente e distintamente, possano essere illegittime e anche integrare fattispecie di reato.
Cassazione penale, sez. V, 30 aprile 2012, n. 36332 ���
Mobbing strategico (bossing) e marginalizzazione del lavoratore
Integra il delitto di tentata violenza privata, la condotta del datore di lavoro che convochi la dipendente - rientrata al lavoro dopo un periodo di astensione obbligatoria per maternità - in un locale fatiscente e le prospetti di farla lavorare in un luogo degradato ed in condizioni invivibili nel caso di mancata accettazione delle condizioni imposte dalla società preordinate ad ottenere contro la sua volontà le dimissioni o il prolungamento del periodo di allontanamento dal lavoro mediante l'astensione facoltativa post-partum.
Trattasi di un esempio classico in cui la società, a seguito dell'assenza di una donna in stato di gravidanza, provvede alla riorganizzazione aziendale ove non residui più spazio (o residui uno spazio con mansioni di gran lunga inferiori alle precedenti e/o alla sua qualifica). A tale riguardo si parla di mobbing strategico come quell'insieme di attività generanti un terrorismo psicologico di un soggetto o di un gruppo di dirigenti ai danni di un lavoratore (o di un gruppo di lavoratori) tale da indurlo a farlo dimettere. O, peggio, costringere il lavoratore - che concepisce tali atti come ingiusti - a reagire al mobbing, consentendo al datore di lavoro di trovare il pretesto per licenziarlo legittimamente.
Cassazione penale, sez. V, 29 agosto 2007, n. 33624
���Affinità tra mobbing verticale discendente e maltrattamenti in famiglia
Pur mancando di tale fattispecie una precisa figura incriminatrice penale, è approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il c.d. mobbing è quella dei maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione (art. 572 c.p.), per la cui punibilità deve essere verificata la serie complessiva degli episodi lesivi contestati, in ordine alla loro sistematicità e durata dell'azione e nel tempo, le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione della condotta e, per la contestazione dell'aggravante specifica delle procurate lesioni gravi, l'individuazione della conseguenza patologica ad essa riconducibile.
Cassazione penale, sez. VI, 8 maggio 2013, n. 19760
���Mobbing nelle grandi aziende non inquadrabile nei maltrattamenti ...
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. mobbing) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rapporto supremazia-soggezione), dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, e come tale destinatario, quest'ultimo, di obblighi di assistenza verso il primo (nello stesso senso Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 2012, n. 33149; id., 27 aprile 2012, n. 16094; id., 22 novembre 2011, n. 43100; id., 13 gennaio 2011, n. 685; id., 16 giugno 2009, n. 26494).
Cassazione penale, sez. VI, 3 luglio 2013, n. 28603
... perché manca nelle società di grandi dimensioni il rapporto di natura parafamiliare dei maltrattamenti
La modulazione di tale rapporto, dunque, avuto riguardo alla ratio della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p., deve comunque essere caratterizzata dal tratto della "familiarità", poiché è soltanto nel limitato contesto di un tale peculiare rapporto di natura para-familiare che può ipotizzarsi, ove si verifichi l'alterazione della sua funzione attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo, il reato di maltrattamenti: si pensi, in via esemplificativa, al rapporto che lega il collaboratore domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera o a quello che può intercorrere tra il maestro d'arte e l'apprendista.
L'inserimento di tale figura criminosa tra i delitti contro l'assistenza familiare si pone in linea, del resto, con il ruolo che la stessa Costituzione assegna alla «famiglia», quale società intermedia destinata alla formazione e all'affermazione della personalità dei suoi componenti, e nella stessa prospettiva ermeneutica vanno letti ed interpretati soltanto quei rapporti interpersonali che si caratterizzano, al di là delle formali apparenze, per una natura para-familiare.
Siffatta connotazione, tuttavia, deve escludersi nel caso in esame, considerato che la posizione lavorativa del ricorrente, come si è poc'anzi accennato, era inquadrata all'interno di una realtà aziendale complessa (la B.N.L.), la cui articolata organizzazione - attraverso la previsione di «quadri intermedi» - non implicava certo l'instaurarsi di quella stretta ed intensa relazione diretta tra il datore di lavoro ed il dipendente, che appare in grado di determinarne una comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare. Ne discende, inevitabilmente, il manifestarsi di una realtà connotata da una marginalizzazione dell'intensità dei rapporti intersoggettivi, nel senso che non ne viene esaltato quell'aspetto personalistico strettamente connesso alla dinamica relazionale «supremazia- soggezione», individuabile fra soggetti che si trovano ad operare su piani diversi.
Conseguentemente, sulla base di quanto concordemente evidenziato, con congrue ed esaustive argomentazioni, dai giudici di merito, non è in alcun modo apprezzabile, all'interno di tale vicenda storico - fattuale, la riduzione del soggetto più debole in una condizione esistenziale dolorosa ed intollerabile a causa della sopraffazione sistematica di cui egli sarebbe rimasto vittima all'interno di un rapporto quanto meno assimilabile a quello di natura familiare. Se, da un lato, è vero che l'art. 572 c.p. ha "allargato" l'ambito delle condotte che possono configurare il delitto di maltrattamenti anche oltre quello strettamente endo-familiare, è pur vero, dall'altro, che la fattispecie incriminatrice è inserita nel titolo dei delitti in materia familiare ed espressamente indica nella rubrica la limitazione alla famiglia ed ai fanciulli, sicché non può ritenersi idoneo a configurarla il mero contesto di un generico rapporto di subordinazione/sovraordinazione. Da qui la ragione dell'indicazione del requisito della parafamiliarità del rapporto di sovraordinazione, che si caratterizza per la sottoposizione di una persona all'autorità di un'altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita (anche lavorativa) proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per l'affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all'azione di chi ha ed esercita su di lui l'autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità.
Se così non fosse, come peraltro si è già avuto modo di osservare in questa sede, ogni relazione lavorativa caratterizzata da ridotte dimensioni e dal diretto impegno del datore di lavoro dovrebbe, per ciò solo, configurare una sorta di comunità (para)familiare, idonea ad imporre la qualificazione in termini di violazione dell'art. 572 c.p., di condotte che, pur di eguale contenuto ma poste in essere in un contesto più ampio, avrebbero solo rilevanza in ambito civile (il c.d. "mobbing" in una realtà lavorativa, cui fa riferimento, tra le altre, la su citata sentenza della sez. VI, n. 685/2011), con evidente profilo di irragionevolezza del sistema (sez. VI, n. 12517 del 28 marzo 2012, dep. 3 aprile 2012, rv. 252607).
Né, infine, potrebbero trarsi, al riguardo, argomenti in senso contrario dall'analisi della recente interpolazione
del testo normativo attraverso la modifica introdotta dalla novella legislativa n. 172 del 1° ottobre 2012, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno».
L'art. 4, comma 1, lett. d), della legge sopra citata ha sostituito l'art. 572 c.p., novellandone la rubrica, ora denominata «Maltrattamenti contro familiari e conviventi», ed aggiungendo i conviventi nel novero dei soggetti passivi del reato, ma la natura (abituale) e la struttura del reato di maltrattamenti (prima «in famiglia o verso fanciulli», ora «contro familiari e conviventi») sono rimaste sostanzialmente immutate. Le novità, infatti, riguardano essenzialmente la previsione di un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio e l'estensione della tutela nei confronti di persone «comunque conviventi», in una prospettiva orientata, per un verso, a valorizzare l'incidenza della relazione intersoggettiva nell'ambito di operatività della fattispecie, e, per altro verso, ad allargare anche ad un rapporto di mera «convivenza» - non necessariamente qualificato dalla particolare natura del legame che ha portato alla sua instaurazione - la rilevanza del rapporto «familiare», ferme restando le altre relazioni di tipo non propriamente familiare, la cui elencazione è rimasta immutata.
Cassazione penale, sez. VI, 3 luglio 2013, n. 28603 ���
Mancata configurabilità dei maltrattamenti: non esclude risarcimento per altri reati
Laddove condotte mobbizzanti hanno causato lesioni consistite in «disturbo dell'adattamento, reazione depressiva prolungata da problemi sul lavoro», comportante un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni quaranta, il giudice, anche se esclude la sussistenza del reato di maltrattamenti, non può pretermettere la valutazione della rilevanza di condotte - emergenti, peraltro, dalla stessa ricostruzione del compendio storico-fattuale - idonee a configurare altre fattispecie di rilievo penale, pur meno gravi, che come tali dovevano comunque essere prese in considerazione nell'ambito della cognizione di merito».
Nel caso di specie, il dipendente era stato sottoposto ad una serie di comportamenti complessivamente ritenuti idonei a dequalificarne la professionalità, comportandone il passaggio da mansioni contrassegnate da una marcata autonomia decisionale a ruoli caratterizzati, per contro, da «bassa e/o nessuna autonomia», e dunque tali da marginalizzarne, in definitiva, l'attività lavorativa, con un reale svuotamento delle mansioni da lui espletate (giungendo financo alla sua allocazione in un vero e proprio «sgabuzzino», spoglio e sporco, e l'assegnazione a mansioni meramente esecutive e ripetitive).
Tale situazione di fatto è astrattamente riconducibile alla nozione di "mobbing", sia pure in una sua forma di manifestazione attenuata, dai giudici di merito denominata nel caso di specie come "straining".
Infatti le lesioni provocate dalle condotte di mobbing, contestate sotto la veste formale dell'aggravante ex art. 572, comma 2, c.p. («se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»), trattandosi di un nucleo della condotta autonomamente isolabile nei suoi contorni storico-fattuali, non ne determina certo la giuridica irrilevanza, una volta che sia stata esclusa la configurabilità del delitto di maltrattamenti.
Poiché si è più volte affermato in Cassazione che il delitto di lesioni personali volontarie non può ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di illeciti che concorrono materialmente tra loro per la diversa obiettività giuridica, sì da configurare un reato autonomo in concorso materiale con quello di maltrattamenti, per quel che attiene al reato di lesioni personali, l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, con il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., seconda parte, quale statuizione oggettivamente
limitata alle ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venendo "in toto" respinti altri ricorsi rilevanti agli effetti penali. Un epilogo decisorio, quello or ora indicato, ricavabile, oltre che dalla lettera della norma, dalla sua stessa "ratio", che è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale quando non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali.
Cassazione penale, sez. VI, 25 novembre 2010, n. 44803
Come garantire la punizione penale del mobbing verticale discendente nelle imprese di grandi dimensioni
Integra il reato di violenza privata, e non il reato di maltrattamenti in famiglia, la condotta violenta e minacciosa reiteratamente posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico, in modo da costringere il lavoratore, nel contesto di un'azienda organicamente strutturata, a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative.
Nella specie, considerato che dagli atti e dalle convergenti risultanze della prova specifica non sembra potersi riconoscere, pur nella comprovata ripetitività e valenza modale della condotta del ricorrente verso il P., quell'apprezzabile e determinante nesso di vera e propria "supremazia - soggezione" tra il soggetto passivo e quello attivo, tanto da assimilarne i caratteri peculiari alle situazioni tipicamente a carattere familiare (ad esempio tra colf e persone della famiglia, ovvero tra mastro d'arte ed apprendista in un contesto di stabilità e non di occasionalità di rapporto), non è configurabile il reato contestato di maltrattamenti né quello ex art. 612 bis c.p., (c.d. stalking), tanto più che per quest'ultimo, i caratteri tipicizzanti condotta attiva e effetti, passivi assumono connotazioni modali e sostanziali sfuggenti ai reali termini dell'accusa (cfr. in termini Cass. pen. sez, VI, 26 giugno 2009, n. 25594).
Sembra piuttosto correttamente configurabile, proprio attraverso una motivata valutazione ed apprezzamento della richiamata prova specifica, peraltro motivatamente segnalata nell'impugnata sentenza a ribadita conferma di quanto già dedotto in 1° grado nella condotta del B. il reato di violenza privata continuata potendo ricondursi ai puntuali episodi, contestati nell'imputazione, caratteri di una condotta moralmente violenta e psicologicamente minacciosa, idonei a costringere il lavoratore a tollerare uno stato di deprezzamento delle sue qualità lavorative nel contesto di una condotta articolata in più atti consequenziali ad un medesimo disegno criminoso, con l'intuibile aggravante della commissione del fatto con abuso di relazioni di prestazioni d'opera ex art. 61 c.p., n. 2. In tali sensi va opportunamente qualificato il fatto, proprio avuto riguardo alle concludenti emergenze tipicizzanti il rapporto tra un capo officina ed un meccanico nel contesto di un'azienda organicamente strutturata in termini affatto riconducibili a situazioni ancorate ad ambiti familiari come innanzi segnalati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, previa qualificazione del fatto nei termini anzidetti, s'impone l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la determinazione della pena.
Un sentiero interpretativo percorso dalla giurisprudenza penale per garantire la punizione penale del fenomeno mobbing (per lo meno quello verticale nelle imprese di grandi dimensioni, come dimostra la sentenza che precede, è quella di riqualificare le condotte vessatorie nella fattispecie di violenza privata continuata (ex artt. 81 e 610 c.p.) aggravata dall'abuso di relazioni di prestazioni d'opera di cui all'art. 61 n. 2 c.p. In tal modo è possibile superare, nell'ambito del rapporto di lavoro, la presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo, con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura para-familiare (elemento, quest'ultimo, come detto, richiesto dall'art. 572 c.p., per la configurabilità dei maltrattamenti).
Tuttavia, il percorso ermeneutico più idoneo da percorrere per garantire la punibilità di qualunque forma di mobbing (e non solo quello verticale ascendente) è l'inquadramento delle condotte mobbizzanti nel delitto di atti
persecutori descritto nell'art. 612-bis c.p.
Appaiono evidenti le affinità tra mobbing e stalking (entrambi possono realizzarsi attraverso atti in sé leciti; tratto caratterizzante di entrambi sono gli episodi di molestie e presuppongono una reiterazione delle condotte vessatorie). Diversa sarebbe, invece, la finalità in quanto il mobbing è volto a porre fine alla vita lavorativa del collega o del rapporto di lavoro tra l'autore e la vittima mentre lo scopo dello stalker è normalmente quella di entrare in contatto con la vittima o, addirittura, di imporle un rapporto. Tale elemento di differenziazione, tuttavia, oltre che essere più apparente che reale (si riconosce, infatti, che il mobber non agirebbe esclusivamente con la finalità esclusiva di espellere il lavoratore, quanto piuttosto di svilire o ledere la dignità personale o professionale del dipendente), comporta che il mobbing troverà punizione nell'alveo del reato di stalking solo laddove integrerà uno degli eventi alternativi previsti dalla norma. A tale proposito, l'art. 612-bis c.p. recita: «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».
Come si evince dalla lettera della norma, è irrilevante (e rientrano entrambi nell'area di applicazione dell'art. 612-bis c.p.) che ci troviamo di fronte allo stalking occupazionale (ove si perseguita la vittima nell'ambiente lavorativo quale strategia aggiuntiva al mobbing, nelle forme del bossing - che ha come obiettivo quello di esercitare una pressione psicologica sulla vittima per indurla a dare le dimissioni - oppure del mobbing orizzontale, ove l'azione discriminatoria è messa in atto tra individui di pari grado, in genere colleghi, ed ha lo scopo di isolare la vittima e distruggerne l'immagine sia in campo lavorativo che nella sfera privata), o allo stalking comune, ossia quello che non si ferma nei luoghi di lavoro (e che potrebbe aggiungersi alle molestie sessuali fino a giungere al reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.) ma che si consuma oltre siffatti luoghi per invadere la sfera privata della vittima (ad esempio con pedinamenti dal luogo di lavoro a casa della vittima, telefonate moleste, s.m.s., e-mail fuori dell'orario lavorativo) provocandole uno stato di ansia e di paura e/o la costringa a cambiare le proprie abitudini di vita (in questo caso lo scopo dello stalker è quello di avvicinare, e non di allontanare la vittima). In quest'ultimo caso, l'effettiva finalità persecutoria si esercita nella vita privata della vittima, ma la motivazione proviene dall'ambiente di lavoro dove lo stalker ha realizzato, subito o desiderato una situazione di conflitto, persecuzione o mobbing.
La fattispecie di atti persecutori è inoltre idonea a reprimere tutti i fenomeni di mobbing, non solo quello verticale discendente (bossing), ma anche quello verticale ascendente e quello orizzontale, come dimostrano la pronunce che seguono.
Tribunale di Milano, Gip, 4 maggio 2010
Mobbing ascendente e stalking
Va emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter c.p.p., nei confronti del dipendente che si era opposto ad una riorganizzazione aziendale ed era stato messo in cassa integrazione e aveva iniziato a perseguitare il superiore con minacce, rivolte anche alla sua famiglia.
Nel caso di specie, il mobber - stalker era il dipendente e la vittima il superiore, il quale veniva perseguitato con minacce, rivolte anche alla sua famiglia, da uno dei lavoratori coinvolti dalla cessione di un ramo d'azienda nel quadro di una pesante ristrutturazione societaria. Nel caso di specie, il gip presso il Tribunale di Milano, ha emesso nei confronti del lavoratore licenziato, indagato per il delitto di stalking ex art. 612-bis c.p., il divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter c.p.p., prescrivendo allo stalker di non avvicinarsi più all'ufficio del manager, di stare lontano da casa sua, di andar via dai luoghi frequentati nel tempo libero dai suoi familiari
Cassazione civile, sez. unite, 21 marzo 2013, n. 7042
Mobbing orizzontale e stalking
Il procuratore deve ritenersi responsabile degli illeciti di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), in relazione all'art. 612-bis c.p., e di cui al medesimo D.Lgs. n. 109, art. 2, comma 1, lett. d), con relativa inflizione di sanzione disciplinare, per avere molestato la collega del medesimo ufficio assillandola con continue telefonate, messaggi telefonici, richieste di incontri, e ciò nonostante il netto rifiuto opposto dalla vittima, in tal modo arrecandole profondo turbamento alla vita personale e familiare, con lesione del prestigio della magistratura in considerazione della notorietà che dette condotte avevano ricevuto; ed ancora, quanto al secondo illecito, il fatto di avere, con la condotta ossessiva di cui al primo, creato pregiudizio allo svolgimento del lavoro della collega, entrando continuamente nel suo ufficio per sollecitare incontri, trattenendovisi ogni volta a lungo nonostante le chiare manifestazioni di insofferenza oppostegli, nonché di avere inviato alla collega, a seguito del netto rifiuto dalla stessa oppostogli, una lettera con la quale segnalava la situazione di incompatibilità in cui la medesima collega si sarebbe trovata a causa dell'esercizio della professione legale da parte della sorella, e di avere poi segnalato la detta incompatibilità al Consiglio superiore della magistratura.
Allo stesso modo, Cass. civ., sez. unite, 28 maggio 2012, n. 8407, ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che, su richiesta del Procuratore generale presso questa Corte, ha disposto in via cautelare il trasferimento provvisorio dal Tribunale di Trani a quello di Matera, con le stesse funzioni di giudice, di un magistrato donna, che era stata sottoposta a procedimento penale per i reati di atti persecutori, ingiuria, diffamazione, lesione personale, percosse, danneggiamento, commessi in danno del collega, all'epoca dell'esaurimento di una loro travagliata relazione sentimentale.
Cassazione penale, sez. V, 25 luglio 2013, n. 32462 ���
Concorso in responsabilità omissiva del datore di lavoro per condotte mobbizzanti di un dipendente
La circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove il comportamento dell'agente venga consumato all'interno del ritenuto rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2012, n. 27706, chiamata a decidere un caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro poste in essere da un lavoratore in danno di altro lavoratore).
Ricorre, quindi, la responsabilità penale del datore di lavoro, a titolo di reato omissivo improprio (ex art. 40, comma 2, c.p., quale titolare di una specifica posizione di garanzia volta alla tutela dell'obbligo di sicurezza dei lavoratori), per le condotte mobbizzanti commesse dai lavoratori (anche superiori), e che possano essere sussunte in specifiche fattispecie di reato. Anche in sede penale, infatti, la fonte dalla quale trae origine la posizione di garanzia che impone al datore di lavoro l'obbligo giuridico di attivarsi viene individuata nell'art. 2049 cod. civ., pur in presenza dei presupposti richiesti anche dalla giurisprudenza giuslavorista (esistenza del danno; esistenza del rapporto di preposizione tra committente e ausiliario e sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria: cfr. Cass. civ, sez. lav., 25 luglio 2013, n. 18093).
Riferimenti Normativi Codice Civile Art. 2049 Codice Civile Art. 2087
Minella Carmelo – Diritto e Pratica del Lavoro