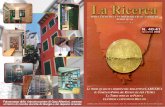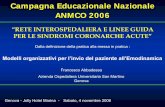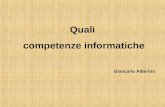Giovanni Albertini - SUPSI · Parkinson. La fattibilità dello svolgimento del lavoro nel contesto...
Transcript of Giovanni Albertini - SUPSI · Parkinson. La fattibilità dello svolgimento del lavoro nel contesto...

1
3
2
Giovanni Albertini Bachelor of Science in Fisioterapia
Indagine sulla percezione soggettiva e sui vissuti indotti dalla terapia di gruppo in pazienti affetti da Morbo di Parkinson
1 Principali tappe metodologiche.
2Raccolta e analisi dei dati.
3Costruzione di una tabella a doppia entrata e relativa sud-divisione delle risposte pervenute dai questionari in ma-crocategorie.
Docente relatore: Francesco Micheloni
Il lavoro ha preso avvio dal seguente quesito: “Qual’ è la percezione soggettiva e i vissuti dei pazienti con Morbo di Parkinson in Ticino nei confronti della terapia di gruppo?”L’elaborato poggia su un iniziale quadro teorico di riferi-mento centrato sulla patologia in questione e sulla valen-za dell’utilità della riabilitazione in pazienti con Mordo di Parkinson.
La fattibilità dello svolgimento del lavoro nel contesto ti-cinese è stata verificata tramite l’invio di un formulario di raccolta dati presso i “Gruppi Parkinson” attivi nel canto-ne. I dati raccolti hanno permesso di identificare il gruppo bersaglio sulla base dei seguenti criteri di inclusione: - appartenenza ai “Gruppi Parkinson-Ticino”(uomini e donne);- età minore di 75 anni; - grado 3 e 4 di radiazione secondo Hoen e Yahr (1967); - esordio della patologia da meno di 10 anni;- nessuna comorbilità presente; - assenza di disturbi cognitivi.
Per la raccolta dati è stato messo a punto e utilizzato un questionario strutturato con domande chiuse e aperte.Un approccio sia di tipo qualitativo che quantitativo ha permesso l’analisi di quanto raccolto.I risultati emersi dai questionari evidenziano che i pazienti partecipanti alla terapia di gruppo in Ticino sono soddi-sfatti da questo tipo di approccio e percepiscono dei bene-fici che si ripercuotono in positivo sul loro stato di salute generale.
Dall’analisi della percezione soggettiva si evidenzia, infatti, che la terapia di gruppo oltre ad essere una terapia coin-volgente dal punto di vista sociale, risulta essere di grande aiuto per mantenere il proprio stato di salute e migliorare la mobilità.

Quali evidenze ha il “Functional Restoration Program”?
Tappa 1: obiettivo, focalizzazione dell’oggetto (lettura di revisioni sul “FRP” e “work hardening” )
• che cos’è il “functional restoration program” e/o “work hardening”?
• A cosa serve? ... Tappa 2: obiettivo, realizzazione della
striscia di ricerca (lettura di abstract)
Tappa 3: obiettivo, delimitare il campo secondo l’acronimo
PICO
Tappa 4: Principali tappe del processo metodologico utilizzato
DOMANDE DI BACK-GROUND
functional restoration OR work hardening OR work conditioning OR
physical conditioning low back pain
clinical trial OR random* clinical trial* return to work OR work reentry OR work resumption
NOT animal NOT surgery
DOMANDE DI FORE-GROUND
24 articoli
• P: Population • I: Intervent • C: Comparison • O: Outcome
24 articoli (lettura degli abstract)
5 articoli
10 articoli (lettura degli articoli)
1
Racha Al Tahan Bachelor of Science in Fisioterapia
Functional Restoration Program: quali evidenze?
1 Principali tappe del processo metodologico utilizzato
Il trattamento “Functional Restoration Program” (FRP) sembra inteso ad affronta-re più le problematiche di disabilità dei pazienti soggetti a lombalgie croniche che il dolore provocato da questa patologia. Scopo primario di questo trattamento, attra-verso la multidisciplinarità, ovvero la collaborazione tra diversi specialisti (fisiote-rapista, ergoterapista, psicologo, medico generico), è quello di riuscire a reintegrare i pazienti nel mondo lavorativo, limitando successive recidive e quindi assenze dal lavoro. Il lavoro si propone di verificare la validità di questo approccio terapeutico attraverso una revisione della letteratura.
Il percorso di revisione della letteratura riguardo il FRP è stato svolto in diverse tappe.Sulla base degli articoli ricavati da una ricerca effettuata su PubMed e dopo aver delimitato il campo di indagine, ho analizzato e ricavato le conclusioni seguenti.Emerge con certezza la validità di questo approccio terapeutico. È possibile affer-mare che attuando il FRP vi è sempre stato un notevole miglioramento delle condi-zioni fisiche dei pazienti e una migliore gestione del dolore. In tutti i casi trattati, il dato più significativo che ne consegue è un massiccio ritorno al lavoro.
Sebbene si possa asserire di aver raccolto sufficienti dati che permettono di dimo-strare l’efficacia del FRP, non è ancora chiaro quanto fattori come: il territorio; la relativa sicurezza sociale; le credenze del paziente; l’economia del paese; l’appar-tenenza socio-culturale, influiscano sui risultati ottenuti. Ulteriori studi e approfondimenti in questa direzione sarebbero auspicabili per meglio comprendere la tematica in questione.
Docente relatore: Francesco Micheloni

1
3
2
Breve descrizioneLa fisioterapia assume un ruolo molto importante per risol-vere i problemi riguardanti la pubalgia negli sportivi. Essa aiuta, tramite esercizi riabilitativi, a recuperare la funziona-lità del cingolo pelvico durante la statica, la deambulazio-ne e soprattutto le attività sportive. Spesso ne sono affetti gli sportivi che praticano sport come il calcio, l’hockey su ghiaccio e il football americano. Queste attività richiedono movimenti ripetuti (come la corsa e il pattinaggio) ad alta intensità che causano un sovraccarico nella zona pubica. I risultati che ne scaturiscono sono dolori a livello inguinale, addominale e pubico.
Con il passare del tempo questi possono divenire cronici recando molto disagio allo sportivo in quanto deve abban-donare il campo da gioco. Oltre al dolore, questa patologia può creare forti problemi a livello intrarticolare e musco-lare causando forti rigidità ed ipostenie severe. L’obiettivo del lavoro è quello di verificare il ruolo che la fisioterapia ha nella riabilitazione in pazienti affetti da pubalgia e di di-mostrarne l’efficacia, e non da ultimo, di creare un proto-collo preventivo in modo tale che tutti gli sportivi possano evitare questa problematica e proseguire nella loro attività senza fermarsi per lunghi periodi.
MetodoPer dimostrare l’efficacia del trattamento fisioterapico in sportivi affetti da pubalgia è stata effettuata una revisio-ne della letteratura. La ricerca degli articoli è avvenuta tra-mite i seguenti motori di ricerca: google, PubMed, Pedro, SPORTmed, Cochrane e Science Direct.Le seguenti parole chiave sono state utilizzate: (“groin pain” OR “groin injury” OR “ostetis pubis” OR “Pubalgia” OR “adductor tendinitis”) AND (“treatment” OR “phy-sical therapy” OR “physiotherapy”) AND (“athletes” OR “sportsmen” OR “soccer” OR “hockey”) AND (“Control-led Clinical Trial” [Publication Type] OR “ Clinical Trials as Topic” . Con questo procedimento 51 articoli sono sta-ti selezionati; tuttavia quelli che possedevano un’evidenza scientifica alta erano solamente 5.
RisultatiTutti gli studi mostrano una certa efficacia dell’applicazio-ne ai pazienti affetti da pubalgia di esercizi di rinforzo mu-scolare a livello del tronco e degli adduttori. Ogni autore però ha modalità e metodi di approccio differenti, senza contare la tempistica di intervento, l’intensità degli esercizi e della posologia. Inoltre, alcuni autori hanno focalizzato l’attenzione sull’importanza della prevenzione in quanto diminuirebbe drasticamente la percentuale di sportivi con pubalgia. In questo contesto infatti alcune ricerche mostra-no degli ottimi risultati.Purtroppo, in questo campo non sono state eseguite suf-ficienti ricerche per affermare con maggiore precisione la validità d’intervento. È necessario quindi approfondire questo tema, in modo da valorizzare con più sicurezza l’ef-ficacia del rinforzo muscolare, senza dimenticare l’impor-tanza e l’efficacia della prevenzione.
Benjamin Rogger Bachelor of Science in Fisioterapia
L’efficacia del trattamento fisioterapico in pazienti sportivi affetti da pubalgiaDocente relatrice: Martina Erni
1 Rinforzo adduttori addominali.
2 Macchina rinforzo adduttori.
3 Stretching adduttori.

1 Elettromiografo utilizzato nello studioAmplificatore per segnale elettromiografico di superficie (EMG-USB) fabbricato dalla OT Bioelettronica©.
2 Schiera lineare asciutta di sedici elettrodi utilizzata in que-sto studio per la rilevazione del segnale elettromiograficoLa schiera è costituita da barre in argento (5 mm x 1 mm) con una distanza interelettrodica di 5 mm.Schiera prodotta dalla OT Bioelettronica©.
3La zona di innervazione muscolare (ZI).
4Acquisizione del segnale elettromiografico sul muscolo trapezio medio.
5Segnale elettromiografico del muscolo trapezio medioLocalizzazione della zona di innervazione nel muscolo tra-pezio medio.
6Localizzazione della zona di innervazione nel muscolo tra-pezio medio.
1 2
3
4
6
5
L’elettromiografia di superficie è una tecnica non invasiva che permette lo studio dell’attività elettrica nella muscola-tura scheletrica. L’elettromiografo amplifica e registra in-fatti il potenziale elettrico generato durante la contrazione grazie all’applicazione sulla cute di appositi elettrodi.L’interesse verso l’elettromiografia di superficie è in aumen-to; questa tendenza è dimostrata dalle applicazioni cliniche in vari ambiti della medicina quali:- la neurologia, con lo studio delle alterazioni neuromusco-lari e delle malattie neurologiche;- la medicina riabilitativa e dello sport, con studi di valu-tazione dell’analisi del movimento e delle manifestazioni mioelettriche di fatica;- l’ergonomia, nella prevenzione delle patologie causate da posture scorrette;- l’anatomia e la fisiologia.
Nonostante ciò, non sono disponibili attualmente proce-dure standardizzate per l’utilizzo delle apparecchiature ed in particolare indicazioni utili al corretto posizionamen-to degli elettrodi bipolari, requisito necessario per ottenere una buona qualità del segnale elettromiografico.
L’obiettivo dello studio è quello di identificare la posizione migliore per il rilevamento del segnale elettromiografico nei seguenti muscoli: bicipite brachiale capo breve, bicipite brachiale capo lungo, grande romboideo, piccolo romboi-deo, trapezio medio e trapezio inferiore.Sulla base di un campione di 10 soggetti sani, per ogni sin-golo muscolo è stato identificato l’intervallo in cui è situata la zona di innervazione rispetto ad un sistema di riferimen-to anatomico. In questa zona l’acquisizione del segnale elet-tromiografico è controindicata.
Sono stati ottenuti buoni risultati per i muscoli bicipite brachiale capo breve, bicipite brachiale capo lungo e trape-zio medio, mentre per i muscoli trapezio inferiore, gran-de romboideo e piccolo romboideo sono necessari ulteriori studi per confermare le indicazioni ottenute nello studio effettuato.Si auspica inoltre la creazione in futuro di un atlante nel quale siano riportate indicazioni riguardanti il corretto po-sizionamento degli elettrodi bipolari. Tale atlante sarebbe un supporto utile per ricercatori e clinici.
Michel Rozzi Bachelor of Science in Fisioterapia
Studio della zona di innervazione muscolare tramite elettromiografia di superficieDocente relatore: Marco Barbero

1 2
4
5
3
2
La fibrosi cistica è una patologia molto diffusa, soprattut-to nell’Europa Occidentale, e una delle sue peculiarità è la cronicità. Proprio per questo, si è posto il quesito di come si possa adempiere in maniera ottimale a questa proble-matica che va ad incidere in modo importante sulla qua-lità di vita di chi ne è affetto.Il fisioterapista si occupa di più aspetti congiunti a questa patologia, al fine di offrire al paziente, con il suo accordo, un trattamento ottimale, concepito in conformità: pre-venzione, cura e riabilitazione, formazione, ricerca e ge-stione.
L’obiettivo del lavoro, perseguito mediante una revisione della letteratura, prevede l’identificazione e l’efficacia di tecniche attualmente in uso inerenti alla “toilette bron-chiale” in bambini e adolescenti con fibrosi cistica stabile e lo scopo è quello di elaborare una “sorta” di linea guida che comprenda le tecniche più conosciute e trattate pro-poste dalla letteratura scientifica negli ultimi 10 anni (più precisamente dal 1998 al 2008).
Particolare attenzione si era posta alla funzionalità respi-ratoria e all’espettorazione del muco. Al fine di compren-dere adeguatamente il contesto, è importante cogliere le peculiarità anatomo – patologiche della fibrosi cistica, correlandole con la sintomatologia.In letteratura c’è molto materiale a riguardo, sia negli stu-di primari (RCT) che in quelli secondari (Review e Linee Guida), ma la maggior parte di questo materiale tratta la problematica in modo globale e non è selettivo per un’uni-ca e precisa fascia d’età.
Oggi si trovano molteplici tecniche proponibili ad un pa-ziente, ma non vi è una miglior tecnica di “toilette bron-chiale” che prevale in modo evidente e che sia sostenuta da evidenze importanti riportate in letteratura. Al contrario, viene molto sottolineata l’importanza della presa a carico del singolo paziente, con rispettivo adatta-mento dei singoli trattamenti. È rilevante quindi la co-noscenza appropriata delle singole tecniche in modo da proporre al paziente un “menu completo” del possibile approccio al fine di ottenere il miglior risultato.
Sara Risi Bachelor of Science in Fisioterapia
Riabilitazione respiratoria: “toilette bronchiale” nei bambini / adolescenti affetti da fibrosi cisticaRevisione della letteratura sui vari approcci terapeutici e sulla loro efficacia
Docente relatrice: Brigitte Erdmann
1 Gli organi e gli apparati più colpiti dalla fibrosi cistica sono: polmoni, pancreas, intestino, apparato epatobiliare e ri-produttivo.(fonte: http://www.liquidarea.com)
2 Lo stetoscopio è uno strumento fondamentale per il fisio-terapista che lavora nella respiratoria.
3 Le radiografie del torace permettono di visualizzare le possibili atelectasie polmonari.(fonte: http://img150.imageshack.us/i/rx1.gif)
4Acapella e coach (per bambini).
5PEP (pressione espiratoria positiva) Mask.

1 Brusca iperestensione seguita da una violenta iperflessione.
2 Spostamento in avanti del tronco con conseguente com-pressione e rotazione verso l’alto della cervicale e della testa.
3Movimento della cervicale inferiore attorno all’asse di ro-tazione (iar).
4Deformazione sigmoidale della colonna cervicale causata da un’eccessiva rotazione del tratto cervicale inferiore.
5Posizione iniziale del cranio-cervical flexion test.
6Esecuzione del CCF.
1
2
3
4
5
6
L’obiettivo del lavoro è quello di verificare la relazione tra dolore, disabilità e deficit dei muscoli profondi del collo in pazienti che hanno subìto colpo di frusta.Il colpo di frusta è una patologia a forte impatto sociale a cui conseguono diversi sintomi clinici.Questo studio è strutturato sull’analisi di 15 pazienti con distorsione cervicale a cui sono stati sottoposti il Cranio Cervical Flexion test (CCF) per la valutazione del deficit dei muscoli profondi, e la scala del dolore e della disabi-lità cervicale per valutare dolore e disabilità. I dati rica-vati dall’applicazione di questi due strumenti sono stati analizzati attraverso istogrammi e grafici a dispersione, al
fine di rappresentare le relazioni tra le variabili in esame (dolore, disabilità e deficit dei muscoli profondi).I risultati emersi dall’analisi dei grafici hanno mostrato la negatività del test in un solo paziente su 15. I pazienti risultati positivi al test hanno valori di dolore e disabilità nettamente maggiori rispetto a chi è risultato negativo al test stesso. I valori delle disabilità, determinate dalla sca-la, hanno denotato, in media, la tendenza ad aumentare proporzionalmente alla riduzione della performance nel CCF. Un risultato interessante è rappresentato dalla pre-senza di valori medi di disabilità maggiori rispetto a quel-li relativi al dolore nei pazienti che non hanno raggiunto
la pressione di 26 mmHg nel CCF, mentre una situazione opposta è presente in quelli che sono riusciti a raggiunge-re o superare tale pressione.L’analisi dei risultati ottenuti ha portato a considerare che effettivamente il colpo di frusta risulta essere una pato-logia a cui conseguono postumi che influiscono negati-vamente sulle condizioni fisiche del paziente, questo pur tenendo conto del numero ridotto dei soggetti interessati allo studio. La presenza infatti di un solo paziente su 15 risultato negativo al test e degli elevati valori medi di disa-bilità e dolore, relativi ai pazienti risultati positivi al test, portano a supporre quanto appena detto.
Il rapporto tra i valori medi di dolore rispetto a quelli rela-tivi alla disabilità precedentemente descritti ha portato ad un’importante conclusione: a differenza di come comu-nemente si tende a pensare, il deficit cervicale, e di conse-guenza la scarsa performance della muscolatura cervica-le, sembra essere associato più alla presenza di disabilità che alla presenza di dolore. Questo lascia supporre che sia l’approccio che il trattamento di un paziente che ha subito un colpo di frusta, non debbano essere incentrati unica-mente sulla cura del dolore ma che questa debba invece essere integrata dalla valutazione e dal trattamento delle disabilità.
Maria Teresa Fico Bachelor of Science in Fisioterapia
Colpo di frusta: correlazione tra dolore, disabilità e deficit dei flessori profondiDocente relatore: Marco Barbero

1
4
5
2
3
6
1 Diagramma di flusso (flow chart) sulla procedu-ra della selezione degli articoli e dei test inclusi nella revisione della letteratura. Tre tipologie principali di valutazioni funzionali sono state iden-tificate per le problematiche dell’instabilità della caviglia:– lo Star Excursion Balance Test (SEBT),– le diverse variazioni degli Hop test (test con
balzi);– il Balance Error Scoring System (BESS).
2 Star Excursion Balance Test (SEBT): test funziona-le che coinvolge un arto inferiore in carico al cen-tro di una griglia con 8 diagonali, cercando di massimizzare la distanza raggiunta tramite l’arto controlaterale. Il SEBT si è dimostrato adatto nel-la valutazione dell’instabilità cronica di caviglia, soprattutto in popolazioni di giovani-sportivi, poiché é un affidabile test che sfida i limiti indi-viduali della stabilità, quantificando la capacità di controllo posturale dinamico personale.
3Multiple Hop Test: test affidabile che dimostra i deficit di performance funzionale nei pazienti con instabilità cronica della caviglia (CAI) rispet-to a soggetti sani. Le caratteristiche che lo dif-ferenziano sono la presenza delle fasi di spinta, volo e atterraggio che richiedono un diverso pattern d’attivazione nella stabilizzazione della caviglia ed un confronto col tentativo di cercare una stabilità nel minor tempo possibile dopo ognuno dei 10 salti.
4A. Figure-of-8 Hop; B. Side Hop; C. Up-Down Hop; D. Single Hop for Distance. Questi 4 test sono stati utilizzati poiché includono movimenti sia sul piano frontale che sagittale, trovando che sussiste una relazione tra sensazioni soggettive d’instabilità e i deficit di performance nel Figure-of-8 Hop test e nel Side-Hop test, ma nessuna relazione è presente durante le attività sul piano sagittale (C e D).
5Single-limb Hopping Test: il test presenta un circuito su piattaforma a basi piane ed inclinate, sul quale è richiesto un percorso a salti ed una stabilizzazione più rapidamente possibile. Con-frontando i risultati con la percezione soggetti-va d’instabilità, i soggetti che hanno riferito sensazioni d’instabilità hanno avuto deficit di performance riscontrabili nel Single-limb Hop-ping Test.
6Balance Error Scoring System (BESS): questa batteria di test consiste in 6 differenti condizio-ni da effettuare a occhi chiusi: 3 su superficie stabile e 3 su superficie instabile; entrambe le situazioni in 3 diverse posizioni (bipodalica a piedi uniti, monopodalica, tandem). Il BESS é stato dimostrato come metodo valido, affidabi-le e alternativo rispetto a l’utilizzo di una peda-na di forza, nel valutare la stabilità posturale, con risultati coerenti con quelli ottenuti prece-dentemente con il SEBT.
Background / Obiettivi Una considerevole percentuale di persone che hanno su-bìto una distorsione acuta della caviglia, sviluppa suc-cessivamente un’instabilità. Altre cause d’insufficien-ze funzionali e/o meccaniche, pongono la problematica dell’instabilità quale tema rilevante nella nostra società. Nella letteratura una definizione unanime d’instabilità funzionale della caviglia non viene riportata. Resta dun-que un’entità difficile da diagnosticare e valutare. Scaturi-sce quindi la necessità di conoscere i migliori test valutativi sull’instabilità, che rendano possibile un’accurata valuta-zione ed esame clinico. L’obiettivo dello studio è quello di ricercare i test diagnostico-funzionali non strumenta-li che valutano l’instabilità della caviglia, richiamando le validità diagnostiche e le basi teorico-pratiche.
DesignRevisione della letteraturaFonte dei datiConsultazione del database PubMed dal 1948 fino al feb-braio 2009, utilizzando i seguenti termini: ankle, test, in-stability e sprain.
Selezione degli studiSono stati inclusi nell’analisi gli studi che rispettavano i seguenti criteri: presenza delle tematiche sull’instabilità funzionale della caviglia (FAI), instabilità cronica della caviglia (CAI), e/o distorsione laterale della caviglia (LAS); presenza di un test clinico-funzionale; assenza di tratta-menti, questionari, fratture e patologie degenerative; studi cross-sectional, epidemiologici, longitudinali.
RisultatiIl principale risultato ottenuto tramite la revisione siste-matica, produce un’esame delle attuali evidenze disponi-bili sull’efficacia di 3 test funzionali: lo Star Excursion Ba-lance Test (SEBT), il Balance Error Scoring System (BESS) e le varianti degli Hop-Tests. Tuttavia, non è stato ancora definito un protocollo standard per l’esecuzione dei test, come anche nelle fasi di preparazione dei partecipanti.Conclusioni / RaccomandazioniI test funzionali possono fornire valutazioni alternative rispetto ai test strumentali. Il SEBT sembra essere il test diagnostico-funzionale non strumentale più adatto ai cli-nici per valutazioni d’instabilità della caviglia. Caratte-ristiche comuni ai test analizzati sono la facile e rapida esecuzione ed interpretazione, ed uno scarso bisogno di equipaggiamento e risorse economiche.
I test funzionali hanno il vantaggio di analizzare la fun-zionalità a livello globale, ma non consentono di detettare anormalità specifiche, ponendo difficoltà nella valutazio-ne in soggetti che risentono di problematiche ad altre ar-ticolazioni non in esame ma coinvolte nei test.
Parole chiavecaviglia, test funzionale, instabilità, distorsione, controllo posturale dinamico,ankle, functional test, instability, sprain, dynamic postu-ral control
Kabiria Donati, Massimo Majocchi Bachelor of Science in Fisioterapia
Test diagnostico-funzionali non strumentali per l’instabilità della caviglia. Una revisione della letteraturaDocente relatore: Luca Scascighini

1
4
5
2
3
6
6
1 Star Excursion Balance Test (SEBT): PM – direzione postero-mediale.
2 Esempio di mancato appoggio sul nastro adesi-vo dell’arto in allungamento, considerato come errore.
3Tracciante “marker” utilizzato come riscontro visivo del risultato raggiunto nella precedente rilevazione (esecuzione della seconda o terza misurazione nella direzione M).
4Livello di significatività nella correlazione tra una storia di distorsione e l’esecuzione del SEBT.La variabile index è definita come la media delle tre esecuzioni per ognuna delle otto direzioni, normalizzata con la lunghezza dell’arto inferiore.
5Questo scatterplot dimostra l’associazione tra SEBT (sinistra) e variabile sport, evidenziando una performance mediamente migliore esegui-ta dal soggetto sportivo, indipendentemente dalla variabile instabilità.
6Differenze d’esecuzione del SEBT nel gruppo caviglie instabili e nel gruppo caviglie stabili.
Background / ObiettiviDiversi sono i metodi presenti nella letteratura per l’analisi dell’instabilità del-la caviglia. Tuttavia viene raccomandato l’utilizzo delle valutazioni non stru-mentali, come ad esempio lo Star Excursion Balance Test (SEBT).Lo SEBT è un test funzionale affidabile che sfida i limiti individuali della sta-bilità, quantificando la capacità di controllo posturale dinamico personale, dimostratosi adatto nella valutazione dell’instabilità cronica di caviglia, so-prattutto in popolazioni di giovani sportivi.Tuttavia, non è ancora nota la correlazione tra distorsione e instabilità, e tra sensazione soggettiva d’instabilità (rilevata mediante il questionario Ankle In-stability Instrument – AII) e SEBT.Gli obiettivi dello studio sono: paragonare attraverso il SEBT il gruppo avente una storia di almeno una distorsione con il gruppo di controllo sano; valutare la possibile correlazione tra AII e SEBT; ricercare l’influenza di altri parametri e le relazioni che potrebbero avere con il test.
Design Studio comparativo, trasversale.
Materiali e metodiQuarantadue studenti (n=42) universitari, docenti e collaboratori (n=27 ma-schi, n=15 femmine; 26.4 ± 5.7 anni; 173.7 ± 8.0 cm altezza; 89.4 ± 4.5 lun-ghezza arto inferiore) provenienti dalla Scuola Universitaria Professionale del-la Svizzera Italiana (SUPSI), con età compresa tra i 16 e i 40 anni, sono stati arruolati per questo studio. Il livello di attività sportiva, l’arto dominante, gli errori effettuati nelle 8 direzioni e l’età, sono stati studiati e comparati.
RisultatiLa correlazione tra distorsione e SEBT non ha mostrato nessuna rilevanza sta-tisticamente significativa. Le analisi tra SEBT e: soggetti sportivi, arto domi-nate, e caviglie stabili e instabili (selezionate tramite l’AII), sono risultate tutte estremamente significative (p = .000).
Conclusioni / RaccomandazioniNon esiste una stretta relazione tra una storia di distorsione/i, e l’esecuzione del SEBT, dimostrando dunque che, siccome una distorsione non è una “conditio sine qua non” per sviluppare un’instabilità della caviglia, altri fattori sono re-sponsabili della riduzione di controllo posturale e quindi dell’instabilità.In ambiti riabilitativi ed in analisi trasversali si consiglia una differenziazione tra soggetti sportivi e non, e tra arto dominante destro o sinistro.Ulteriori risultati suggeriscono che il questionario AII potrebbe potenzialmen-te entrare nella pratica clinica accanto alla valutazione del SEBT, disponendo così di due parametri oggettivi rivalutabili sui quali fare affidamento.
Parole chiaveCaviglia, instabilità, distorsione, controllo posturale dinamico, ankle, instabi-lity, sprain, dynamic postural control, SEBTs
Kabiria Donati, Massimo Majocchi Bachelor of Science in Fisioterapia
Valutazione funzionale degli arti inferiori con lo Star Excursion Balance Test (SEBT) in soggetti con una distorsione della caviglia e soggetti sani – Un’analisi Cross-sectionalDocente relatore: Luca Scascighini

Laura Foletti Bachelor of Science in Fisioterapia
Che metodi esistono per quantificare oggettivamente un edema? Una revisione della letteraturaDocente relatore: Luca Scascighini
Nell’ambito fisioterapico ci si trova spesso a confronto con pazienti che presentano edemi, dovuti ad episodi traumati-ci, post-operatorio, radioterapia, infezioni, congeniti o altre cause. Il primo passo che l’operatore deve compiere consiste nell’identificare il tipo d’edema attraverso l’osservazio-ne. Una volta che l’origine o la causa dell’edema sono stati identificati (tipo linfatico, venoso, arterioso o lipido) si può agire in modo adeguato per risolvere il problema. Per con-fermare l’efficace dell’intervento sull’edema bisogna avere un indicatore d’efficacia che permetta di dare una valuta-zione dell’andamento del trattamento e quindi del gonfiore. Questo indicatore d’efficacia è per esempio la misurazione in centimetri della circonferenza del volume dell’arto ede-matoso. Purtroppo il metodo non è molto preciso per vari motivi. Molte volte il nastro viene stretto troppo o i punti reperiti non sono più gli stessi e la misurazione risulta poco veritiera.
Da queste considerazioni è scaturita la domanda di ricer-ca che prevede l’identificazione di altri metodi oggettivabili per misurare un edema linfatico, venoso o arterioso e l’in-dividuazione della tecnica più attendibile e valida per mi-surarli. Per rispondere a questi obiettivi è stata svolta una revisione della letteratura, utilizzando PubMed come banca dati. In letteratura è evidente che, oltre alla misurazione in cen-timetri, altri quattro metodi sono utulizzati:- leg-o-meter- tronco di cono e disco modello- figura dell’otto- misurazione con acqua-spostamento e le sue varianti
Il “Leg-o-Meter” ha come caratteristica peculiare che il na-stro utilizzato viene sempre posizionato alla stessa altezza: 13 cm dal pavimento. Inseguito si misura la circonferenza della caviglia e si ottiene il volume dell’arto, immettendo i dati in una formula matematica.Il “Tronco di Cono e il Disco Modello” si basano su delle formule che misurano il volume dell’arto. La “Figura dell’Otto” utilizza la misurazione in centimetri con un nastro che passa su dei punti predefiniti e standard della superficie dorsale dove il gonfiore é più concentrato, disegnando un otto. La “Misurazione con l’Acqua-Sposta-mento” utilizza un serbatoio pieno d’acqua dove l’arto vie-ne lentamente messo all’interno. L’acqua che aumenta e si innalza sopra il rubinetto viene poi misurata.
Tutti questi test descritti precedentemente presentano dei vantaggi e degli svantaggi, non sono sempre applicabili e la letteratura in questo campo presenta delle contraddizioni. Di conseguenza, non è stato possibile affermare l’attendi-bilità e la validità dell’una o dell’altra tecnica per la mi-surazione di un edema. L’elemento importante rilevato è comunque che l’operatore deve conoscere i vari metodi ed essere in grado di valutare quale tecnica sia più adeguata nella situazione sotto osservazione.
1
2
3
1 Foto figura dell’otto per la mano.
2Foto figura dell’otto per il piede.
3 Foto figura dell’otto per la mano.