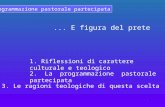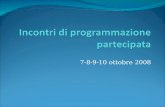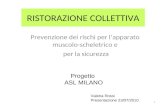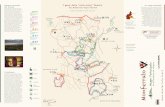CONVEGNO NAZIONALE “Leadership partecipata: la dirigenza … · La scuola come mente collettiva...
Transcript of CONVEGNO NAZIONALE “Leadership partecipata: la dirigenza … · La scuola come mente collettiva...
www.flcgil.it 1
CONVEGNO NAZIONALE
“Leadership partecipata: la dirigenza scolastica tra didattica ed organizzazione”
Bologna, 25 e 26 febbraio 2014
Hotel Europa
Relazione
Paolo Cortigiani, dirigente scolastico
La scuola come mente collettiva ovvero “le armi di collaborazione di massa” - la
ricerca organizzativa della “don Milani” di Genova
“il punto di caduta determinante della qualità formativa è nella organizzazione segmentaria delle
scuole… in cui non esiste un curricolo di scuola ma tanti curricoli quanti sono i docenti”
(Piero Romei, 1986)
Il potere dipende dalla capacità di costituire reti
e dalla capacità di connettere le diverse reti
(Manuel Castells, 2009)
Vi parlerò di una esperienza di cooperazione professionale, di organizzazione a rete e direzione distribuita, di democrazia in un luogo di lavoro. Ho intestato il mio intervento con due frasi che, pur proveniendo da anni e studiosi molto diversi, esprimono la duplice motivazione e valore aggiunto del discorso cooperativo e democratico. Nella frase di Romei c’è una motivazione economica-funzionale, di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia di una organizzazione (già nel 1986 richiamava l’attenzione sulla necessità di superare una organizzazione del lavoro docente in cui ognuno viaggia per suo conto (il curricolo come sommatoria di curricoli individuali). Nella frase di Castells è chiara una motivazione politica: la forma organizzativa “a rete” è sì funzionale alla generazione della conoscenza (per Castells la rete è LA forma organizzativa della conoscenza), ma è anche strategica sul piano del Potere, potere costruire significati nelle menti delle persone e di influenzarne quindi i comportamenti. E visto che l’era scolastica moderna è inaugurata dall’Autonomia scolastica (in principio è l’Autonomia…), che almeno nelle intenzioni voleva trasferire potere alle scuole, il tema del potere delle reti (delle organizzazioni a rete) è di grande interesse e attualità. Sull’articolo 46 della nostra Costituzione agisce la spirale del silenzio e dell’autocensura determinata dal totalitarismo ideologico liberale, per cui idee considerate eretiche, come la partecipazione dei lavoratori alla direzione delle aziende e l’idea della democrazia nei luoghi di lavoro, sono oggetto di tale disapprovazione se non irrisione sociale da spingere al silenzio le persone che osano pensarle. Anzi non sono più pensate, è scattata l’inibizione a immaginarle. Quindi partecipazione, cooperazione e democrazia come strategie allo stesso tempo utili (funzionano per l’efficacia) e giuste.
www.flcgil.it 2
La questione organizzativa (“quaestio”: interrogazione, ricerca) – come organizzare e dirigere il lavoro nelle scuole? – domanda doppiamente cruciale Più di 40 anni fa il sociologo Bernstein aveva rilevato come le modalità di organizzazione del lavoro docente rappresentino una variabile significativamente correlata all’efficacia delle scuole, sia sul versante degli apprendimenti degli studenti (pensiamo alla pionieristica ricerca di Bernstein) sia sul versante dell’apprendimento professionale e organizzativo e della capacità di innovazione sostenibile delle scuole. Negli anni successivi alle stesse conclusioni pervennero numerosi studi, come quelli di Romei. Nonostante ciò persiste una notevole difficoltà a “mettere a tema” la questione organizzativa, che è affrontata saltuariamente e debolmente. Le scuole continuarono a rappresentarsi come sommatoria di docenti che episodicamente si riuniscono, prevalentemente per valutare (enorme forza di inerzia di questa rappresentazione, quasi “naturale”); intorno e sopra la moltitudine dei docenti sta l’organizzazione amministrativa di tipo burocratico. Poi arrivò il ciclone New Pubblic Management, il paradigma di gestione del settore pubblico affermatosi negli ultimi due decenni che, integrando diritto amministrativo e diritto privato, punta sulla competizione e mercatizzazione dei servizi pubblici, sulla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro, sulla managerializzazione della direzione, sulla “governante” degli interessi. Il NPM ha tre comandamenti: “let manager manage”, “market driven management”, “management is management”. Il NPM ha ispirato la costruzione della DS, sul piano normativo (fliera dei d.lgs. 29, 59, 165, 150), contrattuale (Ccnl dal 2000 ad oggi) e culturale (corsi di preparazione ai concorsi edi formazione) Il NPM rappresenta l’unico modo di pensare l’organizzazione e la direzione di una ISA o sono pensabili e praticabili altre possibilità ? Insomma se nella fase di costruzione della dirigenza scolastica la questione organizzativa è stata monopolizzata dai ds e dalle loro associazioni, quindi funzionale alla catena di comando-esecuzione-controllo nelle scuole (staff, figure intermedie o alte professionalità che dir si voglia), oggi occorre ribaltare la prospettiva e il punto di approccio alla questione organizzativa; occorre ripartire dal lavoro della conoscenza e da lì porre interrogarsi: quale organizzazione serve alle scuole, quindi quale direzione, quindi quale dirigente ? E’quello che stiamo tentando di fare alla “don Milani” di Genova, che da tempo ha preso un’altra strada. Procederò intrecciando la descrizione dei fenomeni empirici con alcune riflessioni teoriche. L’ESPERIENZA DON MILANI – 2004-2014 La “don Milani” di Genova non ha mai rinnegato la strada della collegialità. Non siamo “conservatori” o “veterocollegialisti” ma riteniamo che le idee di partecipazione e democrazia che ispiravano le riforme del 1974, se opportunamente estese e sviluppate, assumano oggi, nella società della conoscenza, un valore formidabile per consentire alle scuole e al sistema scolastico di generare conoscenza professionale e organizzativa, quindi apprendimento/innovazione diffusi. Insomma la don Milani si considera figlia, o meglio nipote, della collegialità e nemmeno lontana parente del NPM e della sua genia. in da tempo ha preso un’altra strada impegnandosi ad approfondire e rinnovare la strada della “collegialità” e costruire una organizzazione cooperativa “a rete” e a direzione distribuita che negli ultimi dieci anni si è
• Un assetti organizzativi interni delle scuole come RETE DI COMUNITA’ DI PRATICA. • TIC 2.0 utilizzate per supportare il lavoro ordinario delle comunità di pratica • una direzione distribuita e democratica
2004 – come spesso succede, anche questa discontinuità (innovazione) è nata dall’incontro, un po’ casuale, tra una soluzione e un problema. 7 docenti e il ds devono redigere un progetto di “ricerca e innovazione” ai sensi art 11 dpr 275 – tempi stretti – bisogno di confronto nel merito, scambio di materiali e progressive stesure – l’ITD-
www.flcgil.it 3
CNR ci propone di utilizzare una tecnologia telematica: un software open source “Moodle”, nato per gestire la FaD. Fin dall’inizio la tecnologia è approcciata come risposta a bisogno lavorativo circoscritto e a termine. Questa filosofia (cucire l’abito telematico è cucito sui bisogni via via emergenti dell’organizzare) sarà adottata anche negli anni successivi. Il gruppo di redazione del progetto, sperimentato il potenziale della tecnologia adottata in termini di supporto del lavoro cognitivo collaborativo, decide di proporla al Collegio, uno dei “luoghi di crisi” dell’organizzazione scolastica. Così nacque la “piattaforma”. 2005/06 – si aprono tre forum del collegio e una serie di cartelle; nel corso dell’anno si aprono gradualmente anche gli ambienti di lavoro virtuale dei singoli Dipartimenti. Oltre alla comunicazione tra direzione e collegio e agli scambi nel forum organizzativo, nel forum “Discutiamone”, pensato per gli argomenti di ampio respiro, parte una discussione sulla coerenza tra il Profilo Formativo in Uscita (PFU) dello studente, descritto per competenze, e il reale percorso formativo offerto, il “curricolo reale”. Nel corso della riflessione e in seguito alla mappatura del curricolo reale, si prende coscienza della pluralità e diversità dei curricoli reali e si decide di avviare l’operazione, durata tre anni scolastici, del “curriculum comune”. Prende forma l’alternanza, che diventa intreccio inestricabile, di lavoro in presenza e lavoro a distanza: dal thread iniziale, ad una riunione del Collegio, a ulteriori thread nei forum dei Dipartimenti e del collegio, ad un seminario interno, riunioni integrate con la comunicazione e riflessione a distanza… Di questa faticosa operazione sono stati protagonisti i Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari. La forma discorsiva prevalente è quella argomentativa, in cui i significati sono costruiti attraverso il confronto delle abitudini e delle preferenze, sono state esplicitate premesse prima implicite, si è attivato il pensiero divergente e quindi individuate soluzioni non considerate inizialmente. L’esito è il “curricolo comune”, che successivamente sarà chiamato curricolo esplicito comune per distinguerlo dal curricolo sommerso/implicito che poi diventerà “curricolo educativo”. La scuola si fa “laboratorio riflessivo” in cui il senso comune professionale è oggetto di un lavorio critico diffuso e diventa fare sensato, pratica densa di significati negoziati insieme. 2006/07 – irrompono i Consigli di classe e con questi l’emergenza degli eventi che accadono in classe e a cui i gruppi devono dare risposte tempestive [slide con frase di Mortari] – i Consigli sono esposti ai continui imprevisti, gli “attesi imprevisti”, sono “il fronte” di cui il Quartier generale deve sempre tenere conto ascoltando e valorizzandone i segnali – i Consigli spesso evidenziano impietosamente la “fallacia della predeterminazione”, il difetto illuministico della Progettazione curricolare dei Dipartimenti e delle buone intenzioni del POF (grande documento retorico) – i Consigli sono condizionati dal fattore tempo, dall’urgenza dei problemi e dalla tempestività nell’individuare strategie di soluzione. Le esigenze di coordinamento quotidiano delle azioni portano ad un uso massiccio di wiki e calendari on line (verifiche, uscite, osservazioni relative alla classe, richieste di soldi…) Nei forum dei consigli di classe le forme del discorso sono prevalentemente narrative perché raccontare, collocare in un ordine temporale, è la modalità più immediata per rappresentare un evento imprevisto e provare ad interpretare le azioni dei protagonisti. Si sviluppano grappoli di narrazioni in cui i docenti si scambiano informazioni, costruiscono insieme spiegazioni di quanto avvenuto e negoziano strategie di intervento. È molto interessante osservare il passaggio dalle iniziale forme di discorso narrative a quelle argomentative, in cui gli eventi vengono progressivamente collocati dentro quadri concettuali, magari modificati rispetto a quelli attesi.
a) In nessun altro ambiente come i Consigli di classe si può osservare l’unità dialettica di
azione e conoscenza e la natura del sapere professionale come sapere pratico, in cui la pratica non è meramente azione, ma azione-cognizione/riflessione-interazione sociale. Le pratiche sono i luoghi dove si costruisce il senso/significato, quindi dove si produce nuova conoscenza: in parole povere, dove si apprende e si innova.
b) E come i Consigli di classe siano il vero “fronte”, la “prima linea” della scuola in cui si
costruisce e si misura l’affidabilità della scuola stessa, affidabilità intesa come capacità
www.flcgil.it 4
sistemica di gestire le criticità evitando “disastri” didattici ed educativi, risultato di disattenzione, mancanza o scarsa comunicazione, interventi scoordinati o disomogenei. Capacità sistemica di gestione degli eventi critici. L’evento didattico è per sua natura denso di criticità e imprevisti che mettono continuamente in crisi aspettative, routine, procedure e programmazioni. Secondo Weick un’organizzazione affidabile deve avere alcune proprietà: valorizzare le persone che lavorano in prima linea perché è in una posizione favorevole per individuare e segnalare eventi inattesi dai Piani e dalle Procedure – darsi reciproco ascolto e coordinare le diverse prospettive per decidere in modo appropriato alla situazione – decentrare la decisione rendendola mobile (decidere dove serve) – clima aperto e collaborativo che incoraggi ad esplicitare tempestivamente eventuali errori (approccio non punitivo e sanzionatorio all’errore, che favorisce occultamento delle criticità e individuazione del capro espiatorio)
Nel 2009/10 dopo un seminario interno intitolato “curricolo comune esplicito e curricolo implicito” prende il via il filone di lavoro chiamato “i consigli educativi” che ha l’obiettivo di esplicitare il curricolo sommerso e gestirne orientarne le variabili in modo intenzionale e sistematico. Dal curriculum al quotidiano,alle variabili psico-sociali del curricolo – si tematizza il curricolo sommerso Assetto attuale (sempre in movimento) la piattaforma realizzata con applicativo open source Moodle, si articola in 55/60 partecipanti: docenti in servizio + ds + dsga 34 ambienti/gruppi di lavoro virtuali – sostanziale isomorfismo tra org in presenza e org a distanza Ogni ambiente ha un arredo-tipo formato da uno o più forum, cartelle variamente annidate, calendario/i, wiki, sondaggi 79 forum 163 cartelle di archiviazione: la documentazione accessibile: utili al lavoro del gruppo (verbali, diari di bordo, progetti, piano di lavoro annuale,), al lavoro d’aula (programmazioni, UdA, materiali didattici, verifiche, griglie di osservazione e valutazione…) 291 wiki per la scrittura collaborativa di UdA, materiali didattici (vedi curricolo comune), diari di bordo, questionari, Progetti, documenti vari – radicamento della pratica documentativa la cui utilità è motivata internamente nel gruppo Circa 50 msg al giorno nell’arco da settembre a metà luglio (con picchi di 70/80 msg giornalieri) Sondaggi: attraverso questionari on line si raccoglie, in modo capillare e omogeneo, il parere della CP su temi di interesse rilevante – indagine sui climi di classe che nel 2010 inaugura il lavoro sul curricolo sommerso e sugli aspetti educativi che ha portato nel 2012 alla costituzione del coordinamento dei “CdCl educativi”, pratiche informali di valutazione, questionario sulle Indicazioni Nazionali proposto in seguito alla richiesta di parere del Miur, questionari vari su uso delle TIC in classe e sull’uso della piattaforma, Deliberazioni elettroniche: formalizzate nel regolamento del Collegio [copiare testo]
Tabelle con dati In sintesi cosa abbiamo fatto ? la scuola si è andata organizzando come RETE DI
COMUNITA’ DI PRATICA, e ha dato una RISPOSTA COOPERATIVA E
DEMOCRATICA (non lassista né dirigista/autoritaria) al problema dei “legami deboli”,
valorizzando una doppia specificità
1. del lavoro docente (spesso rappresentate e vissute come “difetti”): la separatezza
(barriere fisiche), l’asincronia (barriere temporali), l’immaterialità (la sua natura
cognitiva e discorsiva), l’emergenza (sollecitato da eventi critici)
1. della risorsa invisibile, la conoscenza (professionale), il sapere pratico, che è una
risorsa anomala perché moltiplicabile (non si consuma con l’uso), creativa (risultato di
esplorazione, interpretazione, immaginazione), sociale (si alimenta di confronto e
www.flcgil.it 5
interazioni), aperta (gli esiti non sono prederminabili). La conoscenza richiede autonomia di ricerca, presuppone processi di validazione discorsivi e dialogici. Un contesto organizzativo è pertanto epistemologicamente affidabile se caratterizzato da interazioni discorsive libere, pubbliche, paritarie, non strumentali.
Conflitto con le risposte main stream, “dominanti”: [vedi parte alla fine] sottolineo il conflitto
tra prospettive diverse perché la rimozione di una visione conflittuale ha causato abbastanza
danni nel Paese e nella scuola.
CONSIDERAZIONE GENERALE: Abbiamo ritenuto che si potessero “rafforzare i legami”, migliorare il coordinamento, la cooperazione e quindi il livello di integrazione del lavoro didattico potenziando la collaborazione, ovvero, come dice Sennett, la partecipazione attiva e la reciprocità, indispensabili elementi per costituire una struttura collettiva organizzata. Non è necessario che le persone concordino sugli obiettivi per agire in modo organizzato ma è indispensabile che condividano un impegno reciproco. [PATTO PROFESSIONALE]. L’accesso alle informazioni, la visibilità del proprio e altrui lavoro e la possibilità di comunicare e interagire è la condizione per partecipare. La condivisione degli obiettivi è un risultato della reciprocità, non una premessa. Ma la pertacipazione è l’azione cruciale per l’apprendimento e lo sviluppo professionale, perché l’apprendimento negli ambienti di lavoro nasce dalla partecipazione alle pratiche di una comunità professionale. Considerazioni PARTICOLARI, anche frutto di indagini strutturate, alcune pubblicate,
svolte in collaborazione con l’ITD-CNR di Genova: Mutata percezione dell’ambiente di lavoro: con la piattaforma non c’è più solo l’ambiente fisico ma si crea un campo di percezioni e di interazioni sociali più vasto che ha confini invisibili. Tutti i gruppi e le risorse di lavoro risultano simultaneamente presenti e disponibili (non esistono barriere e divisioni spaziali e temporali) e “in azione” (l’organizzazione emerge dalle azioni situate non è l’organigramma statico e astratto, ma le azioni dell’organizzare, dinamiche e concrete)– discontinuità con abitudini e vissuti, tempi di orientamento e adattamento personali tra gli estremi dell’agorafobia telematica e dell’astensione diffidente e il presenzialismo invadente. Visibilità e accessibilità delle pratiche alimentano la partecipazione e questa alimenta la riflessione e rielaborazione delle pratiche, quindi apprendimento e innovazione Il lavoro collaborativo, le
azioni-chiave dell’organizzare, diventano visibili e osservabili: La piattaforma consente un cambiamento di approccio importante, dato che l’organizzazione diventa un evento osservabile nelle interazioni discorsive; anzi, non vediamo “l’organizzazione”, bensì le pratiche delle persone che comunicano-organizzano-riflettono-apprendono quotidianamente. A questo proposito Weick osserva che «la parola organizzazione è un sostantivo, ed è anche un mito. Se cercate un’organizzazione non la troverete. Quello che troverete è che ci sono degli eventi, legati assieme, che accadono entro certi confini, e queste sequenze sono le forme cui noi attribuiamo una sostanza quando parliamo di organizzazione» [Weick, 1993, p. 126]. Weick propone di usare il verbo “organizzare” al posto del sostantivo “organizzazione” per focalizzare l’attenzione sulle interazioni e i processi. La comunicazione diffusa e l’intensificazione delle interazioni (in una parola: la partecipazione) sono le condizioni della cooperazione e della generazione di conoscenza nel luogo di lavoro. Non riconosciute per lungo tempo e tuttora da chi ritiene punta sulla catena di comando-esecuzione-controllo e sui manuali delle procedure Organizzazione blended ribaltata:- Passaggio da Funzione periferica che espande le potenzialità della SCUOLA REALE A un rapporto invertito LA SCUOLA REALE funziona da terminale di iniziative generate e
sviluppate in RETE
www.flcgil.it 6
Integrazione tra lavoro in presenza e lavoro in rete: dal 2006 ad oggi il rapporto si è ribaltato: se nel 2007 era vissuto come complemento del lavoro in presenza, ora le riunioni formali rappresentano un momento di sintesi o di deliberazione formale di complemento al lavoro in rete – l’85% dei docenti sostiene che il lavoro in rete facilita “molto” il lavoro in presenza nelle riunioni Ambiente di apprendimento e sviluppo professionale: scarsa efficacia se non fallimento dei modelli di formazione individuali e separati dai contesti di lavoro. La formazione separata dalla quotidianità e dai contesti reali di lavoro è spesso un luogo di disconnessione tra le biografie e i bisogni professionali dei docenti e le offerte formative proposte dall’Amministrazione; disconnessione che non consente di generare senso e significato alle cose che si fanno. Le competenze sono proprietà emergenti in situazione, dentro l’ambiente di lavoro. Ma un ambiente di lavoro non è di per sé un ambiente di apprendimento professionale. Per diventarlo occorre rendere disponibili e far interagire le risorse formative presenti nel contesto: il sapere dei documenti e soprattutto il sapere “incorporato” delle persone e “metterle al lavoro”, valorizzarle (letteralmente: far sì che producano valore professionale). Ciò significa intensificare le interazioni cognitive, moltiplicare le opportunità di apprendimento tra pari e tra docenti più esperti e docenti apprendisti; scegliere l’apprendimento contestualizzato, prossimale alle pratiche, tra pari, è anche un modo per rispondere all’inadeguatezza dei modelli di “formazione in servizio” tradizionali (di tipo individuale e decontestualizzato). L’ambiente di lavoro funziona come laboratorio riflessivo e ciò è facilitato dalla stessa natura della comunicazione on line, che in quanto differita e scritta incrementa la riflessività dell’ambiente e produce vantaggi in termini di chiarezza espositiva, spessore argomentativo, memoria delle riflessioni e discussioni; d’altra parte l’assenza fisica degli interlocutori riduce le possibilità e la tempestività di autocorrezione in caso di criticità relazionale. Socializzazione professionale e organizzativa dei docenti neo-trasferiti o precari: nell’indagine del …. Uno dei dati più netti dei questionari del 2008 e del 2013 è … La precarizzazione del lavoro rappresenta una delle ragioni principali dello scadimento di qualità delle scuole perché il lavoro non è solo funzione, rapporto tra la persona e il compito, individuale e decontestualizzato, ma è anche partecipazione non periferica alla vita dell’organizzazione e alla costruzione sociale del senso delle azioni professionali. Il precario è mutilato di queste dimensioni e mutila, priva, impoverisce le scuole. La piattaforma, come testimoniano i precari passati dalla don Milani, è un formidabile strumento di facilitazione dell’inserimento attivo nelle comunità professionali della scuola
Decisionalità plurale, migrante e incorporata nelle azioni – Le decisioni solo in rari casi sono processi lineari-razionali che precedono e determinano le azioni; nella realtà il rapporto tra azione e decisione è molto più problematico e multiforme. Non solo esistono diverse logiche decisionali dovute ai limiti della razionalità, alla conformità alle Norme, alle appartenenze partigiane, alla mutevolezza delle preferenze, all’incertezza delle tecniche alla fluidità della partecipazione, ai fattori ambientali, all’expertise artigianale, alla negoziazione dei significati…. Nel lavoro e in particolare nel mondo della scuola, è difficile distinguere il momento della decisione dalle altre azioni professionali. C’è poi chi sostiene (Brunsson) che azioni e decisioni hanno logiche diverse e incommensurabili; le motivazioni etiche ed ideali, i “valori”, ispirano le azioni con maggiore vigore del calcolo razionale di costi e benefici tipico di una decisione razionale. Le esperienze più significative della scuola italiana sono nate da convinzioni pedagogiche, religiose e politiche (pensiamo alle scuole attive o al personalismo cristiano), non da decisioni razionali prese a tavolino.
Innovazione incrementale, radicata dentro i processi lavorativi, prossimale ai bisogni e alle possibilità, endogena quindi sostenibile. fallacia dei modelli di innovazione ingegneristici: l’innovazione è sempre più pensata e progettata altrove, lontano dalle scuole, sempre più spesso in think thank economico-finanziari; quanta innovazione scolastica è stata ideata in FMI, BM, OCSE,
www.flcgil.it 7
BCE ?, . La delega dell’innovazione a tecno-strutture esterne ed estranee alle scuole sta producendo l’afasia dei deleganti (i lavoratori della scuola) Valutazione generata all’interno dei processi professionali situati e sociali: pratiche di auto ed etero valutazione alternative ai modelli premiali e selettivi volti a innescare processi di emulazione e competizione individuale. La procedura di “gradimento” non è finalizzata a selezionare i docenti “migliori” (fotografia statica dell’esito della gara) ma di rendere tutti i docenti migliori valutando gli aspetti situati/contestualizzati e dinamici della professionalità: 1) verificarne la volontà pattizia (di impegno reciproco) 2) valutare a fine anno la partecipazione e la capacità di cooperazione ovvero di integrare le competenze di ciascuno nell’azione comune all’interno dei vari gruppi di lavoro di appartenenza (consigli, dipartimenti etc in presenza e on line ai coordinatori dei quali è affidato il compito di formulare un report sulla base di una traccia strutturata coerente con il Patto professionale di ingresso) in quanto l’efficacia del lavoro scolastico è correlata con la qualità del lavoro dei gruppi (in termini di capacità di comunicare, coordinarsi, riflettere, condividere sapere) più che con individualità professionali (i solisti). Alle osservazioni dei coordinatori dei gruppi di lavoro di appartenenza si affianca la auto-valutazione del singolo docente che si esplica nella presentazione di un report personale centrato sugli aspetti riflessivi ed euristici della propria esperienza cui è allegato il diario di bordo realizzato nell’arco dell’anno con il tutor. Ciò consente di esplicitare preventivamente i comportamenti attesi che saranno oggetto di osservazione/valutazione, di utilizzare una pluralità di punti di vista nella osservazione e di ancorare a elementi concreti le osservazioni proposte al dirigente che formula la valutazione formale. A questo scopo la piattaforma è uno strumento formidabile perché mantiene traccia scritta dei contributi di ognuno, materializzando il alvoro discorsivo e cognitivo collegiale dei docenti. Come già detto: lo scopo di questa esperienza di valutazione dei processi professionali non è quello di premiare i docenti migliori, ma di rendere tutti i docenti migliori.
La tecnologia telematica – le TIC hanno consentito di strutturare e rendere sistematici i
processi discorsivi e cognitivi superando le barriere spaziali e temporali tipiche del lavoro
docente. Processo poco governato dall’alto: la tecnologia segue i bisogni e i tempi di ogni gruppo – maturità e velocità variabili – diffusione delle competenze tecnologiche e delle responsabilità gestionali della piattaforma (apprendimento molecolare di prossimità)- pregi e difetti di una lievitazione naturale – indubbiamente rischio di caos e disordine sempre presente, ma rischio che vale la pena correre (sono fecondi, l’ordine è sempre una traccia provvisoria del disordine originario. Con De Andrè: “dal diamante non nasce niente, dal letame nascono i fiori…”) Adozione graduale assistita Abito telematico cucito su misura:condizioni per replicare l’esperienza, tentativo di modellizzazione di uso delle TIC e nel lavoro ordinario di una scuola – situare l’intervento sul terreno prossimale del lavoro di un gruppo e “coltivare con cura la piantina” fino a che non ha messo radici, allora si può togliere il tutore e vederla crescere liberamente. Le TIC hanno fornito il sistema nervoso, l’innervamento, l’infrastruttura tecnica – l’uso delle TIC a sostegno della cooperazione e dell’autonomia professionale dei lavoratori della scuola – un pensiero maligno (a pensar male non si sbaglia mai…): perché finora si è promossa la diffusione delle TIC in tanti ambiti, nelle classi (Lim, classi 2.0, registri elettronici) o nel lavoro amministrativo (Sidi, Amm Trasparente, iscrizioni on line), ma NON all’interno del lavoro docente e nell’organizzazione delle scuole ? se ne teme forse il potenziale di autonomia e di democrazia e i processi di non allineamento che ciò può innescare ? WIKISCHOOL: Da almeno un decennio i teorici della wikinomics hanno evidenziato l’importanza di sviluppare forme di collaborazione di massa con i consumatori e sfruttare la peer production che si sviluppa spontaneamente e gratuitamente in rete. Come succede in Wikipedia, l’enciclopedia co-costruita on line. Il Miur dovrebbe porsi il problema di intercettare e valorizzare il “surplus cognitivo” delle I.S.A. Magari anche di promuoverlo e strutturarlo. “Là fuori” (fuori dalla
www.flcgil.it 8
filiera OEFI-Governo-Miur) ci sono migliaia di comunità professionali che possono mettere a disposizione il loro sapere, la loro creatività professionale. Perché non inserire nel Piano Scuola Digitale una “azione” dedicata a supportare il lavoro collaborativo e mettere a frutto la cooperazione dei lavoratori della conoscenza ? Perché non attivare un sistema di WIKISCHOOLS ? correndo il rischio delle possibili tensioni tra la RETE e la PIRAMIDE, ma anche di una nuova stagione di innovazione dal basso, generata L’organizzazione a rete cambia la funzione di direzione e il ruolo del dirigente La direzione è la capacità cognitiva e sociale di modellare il compito e l’ambiente lavorativo e si esercita attraverso un complesso di azioni che possono essere svolte da una persona, da un gruppo di persone o collettivamente. Rompere la spirale del silenzio e Riattivare una critica (pensiero e azione) del paradigma della direzione manageriale imposto dal NPM: il New Pubblic Management, il nuovo paradigma di gestione del settore pubblico che integra diritto amministrativo e diritto privato punta sulla competizione e sulla mercatizzazione dei servizi pubblici, sulla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro e dei rapporti con l’utenza, sulla managerializzazione della direzione, sulla “governante” degli interessi. I tre comandamenti del NPM: “let manager manage”, “market driven management”, “management is management”. La DS, così come è stata costruita normativamente dalla filiera
legislativa e contrattuale (d.lga. 29, 59, 165, 150 e cccnl) e culturalmente dai corsi di preparazione ai concorsi e dagli anni di formazione, rappresenta l’unico modo di rappresentarsi (“pensiero unico”) la direzione di una ISA o sono pensabili e praticabili altre possibilità ? è importante perché l’ideologia managerialista ha condizionato pesantemente la questione organizzativa. Dagli anni ’90 “è andata così”, ma non è un destino ineluttabile, si può cambiare rotta, la ds e l’organizzazione delle scuole possono essere diverse e migliori. a) la direzione manageriale è una risposta cognitivamente seduttiva perché semplifica drasticamente i problemi complessi posti da organizzazioni professionali ‘a legamideboli’ quali sono le scuole. In quanto tale ha prodotto un effetto di verità che ha assunto una forza apparentemente irresistibile; b) la direzione manageriale è però disfunzionale alla generazione di innovazione, a una decisionalità ‘accurata’, alla capacità di gestire l’incertezza e gli eventi imprevisti di cui le scuole hanno bisogno per operare efficacemente nella società della conoscenza; Se ci riferiamo agli studi sulla leadership l’esperienza della don Milani è collocabile all’interno di una concezione collaborativa, distribuita e democratica della direzione, cercando di recuperare in termini aggiornati il principio della “gestione collegiale” introdotto nella scuola italiana nel 1974 e tenerlo insieme con le pratiche di democrazia deliberativa che si sviluppano nella negoziazione diffusa all’interno dei forum della piattaforma. ORGANIZZAZIONE A RETE E LEADERSHIP DEMOCRATICA c) la direzione distribuita e democratica è più efficace perché organica all’organizzazione a rete, caratterizzata da comunicazione aperta e orizzontale, densità delle interazioni cognitive, migrazione ad hoc del potere decisionale, che massimizzano la generazione di apprendimento e di innovazione; d) la direzione distribuita e democratica sposta il focus dell’attenzione e dell’impegno sul
contesto di lavoro come rete di pratiche (approccio contestuale), piuttosto che sugli stili di leadership del singolo dirigente (approcci focalizzati sulla persona del dirigente) o sui climi e la manipolazione delle relazioni (approcci psico-sociali). Direzione distribuita e democratica organica all’organizzazione a rete: il dirigente coltiva, supporta, facilita, coordina le interazioni discorsive e cognitive e connette la costellazione di comunità di pratica (organizzazione a rete come costellazione di comunità di pratica)
Il dirigente “irretito” – quale ruolo dei DS all’interno di una direzione distribuita di una
organizzazione a rete ?
www.flcgil.it 9
Nella scuola organizzata a rete conta la reputazione che ogni persona riesce a conquistarsi con la capacità di offrire supporto, argomentare in modo persuasivo, proporre soluzioni ai problemi emergenti e significativi per il gruppo. Nella rete il dirigente non può affidarsi all’asimmetria del proprio ruolo formalmente ‘superiore’, perché la rete rompe le linee d’azione top-down, de-formalizza i ruoli, scompagina le pratiche dirigiste. La rete, fisica o virtuale, per sua natura (paritaria, orizzontale, interattiva) minaccia gli assetti gerarchici e piramidali. In rete il dirigente deve esercitare un ruolo di promozione della partecipazione, di facilitazione della comunicazione, di sostegno ai processi decisionali, di connessione di expertise; un ruolo quindi contrario alla visione individualista e decisionista, ingenuamente onnipotente, che ha accompagnato la nascita della dirigenza scolastica italiana e che i recenti provvedimenti legislativi mirano a rafforzare ulteriormente; ma un ruolo anche diverso dai modelli ‘relazionali’ e ‘climatici’ (centrati sulle dinamiche psicologiche interpersonali), perché focalizzato:
- concettualmente sulla transizione dalla leadership alla followership (Serpieri, 2008), intesa come abilitazione dei ‘subordinati’ ad autogestire il proprio lavoro;
- operativamente sull’attivazione e cura di concreti dispositivi organizzativi, anche telematici, in grado di facilitare la costruzione sociale e democratica del compito.
dimensioni che si nutrono di bisogni e motivazioni di fiducia, parità, reciprocità, gratuità, espressione creativa, responsabilità sociale. Tengo a sottolineare il duplice valore aggiunto di pratiche collaborative e distribuite di
direzione: il valore etico/politico, per la maggiore partecipazione ed equità nella distribuzione del potere interno, ed il valore economico/funzionale, per la maggiore efficacia nel raggiungimento dei risultati istituzionali, laddove autorevoli studi internazionali evidenziano una significativa correlazione tra direzione collaborativa e scuole di successo [Serpieri, 2000]. Che fare come dirigenti? I dirigenti scolastici possono dare un contributo importante alla prospettiva riflessiva e comunitaria se si impegnano a: 1. riprendere una riflessione critica sul proprio ruolo all’interno dei processi di direzione delle
scuole, nella consapevolezza che il discorso sulla dirigenza si intreccia e correla con i discorsi e le politiche scolastiche più generali. Ciò significa interrogarsi su quale scuola, quale organizzazione del lavoro e quale distribuzione dei poteri riteniamo utili e giusti nella società della conoscenza e dell’incertezza; significa sottoporre a critica i quadri concettuali e normativi (legislativi e contrattuali) dentro i quali ci siamo mossi in questi ultimi due decenni; significa vagliare il lessico “managerialese” che ci hanno abituati a usare; 2. contrastare la deriva che ha allontanato i dirigenti dal nucleo tecnico- didattico delle scuole, deriva che determina non soltanto la dis-trazione del focus dell’attenzione sui versanti amministrativo, giuridico, di marketing, ma anche un’intensificazione sempre meno sostenibile dei carichi di lavoro e dei carichi emotivi, risultato di una visione individuale,solitaria, eroica della direzione; principale fattore di caduta della qualità del nostro lavoro, precipitata in questi anni 3. coltivare forme di direzione distribuita ovvero supportare i dispositivi riflessivi, la costruzione negoziata dei significati, la partecipazione ai processi decisionali. Il dirigente assume un ruolo di manutentore e facilitatore della connessione di rete (per dirla con Wenger, se le scuole sono ‘reti di comunità di pratica’, i dirigenti ne sono i primi ‘coltivatori’) e la funzione di direzione emerge dalle interazioni cognitive orizzontali delle comunità di pratica; 4. costruire climi di scuola connotati da fiducia reciproca, comunicazione aperta e libera, senso di parità e di mutua responsabilità in quanto ‘ingredienti’ psico-sociali essenziali a organizzazioni cooperative e democratiche; 5. sollecitare i decisori politici a una maggiore umiltà, ottenere rispetto per la cultura delle scuole e fiducia nei professionisti delle scuole, renderli consapevoli che il sapere professionale delle scuole è la principale risorsa su cui investire per il miglioramento complessivo del sistema. Porre al centro della prossima tornata contrattuale (coordinando i testi proposti per i CCNL del personale docente ed ata e dell’Area V) la questione organizzativa delle scuole,
www.flcgil.it 10
- sancire la dimensione cooperativa del lavoro docente, non solo in presenza (tradizionale collegialità) ma anche a distanza, quindi il lavoro telematico
- i ruoli di coordinamento dei gruppi di lavoro strutturali: consigli di classe e dipartimenti - l’uso delle TIC 2.0 (la dimensione telematica) nel lavoro cooperativo dei docenti - l’assegnazione nell’organico di diritto delle scuole di risorse umane che assistano,
supportino e consentano l’utilizzo massivo e stabile delle TIC nel lavoro cooperativo (docenti con particolari titoli, ITP, assistenti tecnici…)
le soluzioni contrattuali spettano alle parti negoziali, l’importante è che questa materia non abbia più una natura “aggiuntiva” o affidata alla “disponilità” dei singoli (leggi: residuale ed eventuale), ma che sia compresa strutturalmente nei profili professionali del personale. È ovvio che occorre un riconoscimento economico adeguato e questo presuppone un investimento importante. Legame debole – è stato Weick ad approfondire l’intuizione di Glassman facendone uno dei cardini della sua riflessione sui fenomeni organizzativi. In una situazione di legame debole gli elementi in gioco sono collegati da nessi non lineari (non se A allora B, ma se A allora B oppure C oppure D…. in altri termini gli elementi si influenzano reciprocamente ma occasionalmente (invece che costantemente), indirettamente (invece che direttamente), successivamente (invece che immediatamente). Causa dei legami deboli: incertezza delle tecnologie didattiche, mutevolezza delle preferenze, fluidità della partecipazione (precariato e trasferimenti ma anche composizione a geometria variabile di alcuni organi collegiali)… Connotazione negativa del termine: funzionano male, difetto… pre-giudizi dela cultura burocratica e manageriale che, per loro natura, tendono a vedere male i legami deboli, considerarli cattiva organizzazione, un difetto da eliminare. I legami deboli non sono un fallimento dell’organizzare, ma forme organizzative diverse da mettere a tema e da valorizzare in quanto formidabili opportunità di generazione di conoscenza professionale (quindi apprendimento e innovazione). DS “coltivatore” delle Comunità di Pratica – …non nel senso di “braccia rubate all’agricoltura” – l’idea di coltivazione rinvia a una relazione con un soggetto vivente/vitale (a prescindere che il seme sia stato piantato o portato dal vento), dotato di autonomia di crescita (al contrario dell’idea di “progettazione”, molto ingegneresca) – rimanda a pratiche di cura, sostegno, nutrimento (stimolo), protezione: buona terra, concime, attenzione a parassiti ed erbacce, soleggia mento, freddo… (non possiamo tirare verso l’alto il suo gambo, le sue foglie e i suoi fiori, possiamo aiutarli a crescere rigogliosi…)- il lavoro di coltivazione della CdP agisce sulle tre dimensioni della CdP: il campo tematico, gli aspetti comunitari (fiducia, rispetto, ascolto impegno reciproci) , la pratica (azione cognitiva e non situata in un contesto fatto di persone, tecnologie, oggetti) – le strategie della coltivazione delle CdP: progettare per l’evoluzione (in primis potenziare la partecipazione e intensificare le interazioni sociali e cognitive, rendere disponibili le conoscenze incorporate e materializzate, negoziare i significati…), creare dialogo tra prospettive interne ed esterne (integrare le CdP nell’organizzazione), muovere i livelli di partecipazione, attenzione agli aspetti pubblici e privati – la col Surplus cognitivo – è una idea, e il titolo di un libro, di Clay Shirky: grazie alle tecnologie digitali è aumentata esponenzialmente l’opportunità di produrre contenuti e condividerli in rete. Alle persone piace creare gratuitamente, per il piacere di farlo, in modo disinteressato. Perché non sfruttare il tempo libero, la generosità, la creatività che c’è in rete per produrre valore civico ? tra l’altro la partecipazione gratuita e disinteressata è connaturata al mondo della scuola (chiamata volontariato, spirito missionario…). Invece nell’ultimo quindicennio si è andati in direzione opposta a quanto ci suggerisce la rete e le scuole, invece che essere “prosumers”, sono state consumatrici passive (come nell’era della TV, non del Web 2.0) di innovazioni pensate e create altrove. Anche alle scuole piace creare, il Miur dovrebbe rendersene conto e offrire questa possibilità, anche tecnologica.
CONVEGNO NAZIONALECONVEGNO NAZIONALEDIRIGENTI SCOLASTICIDIRIGENTI SCOLASTICI
La scuola come mente collettivaLa scuola come mente collettivaLa scuola come mente collettivaLa scuola come mente collettivaLa scuola come mente collettivaLa scuola come mente collettivaLa scuola come mente collettivaLa scuola come mente collettivaLa scuola come mente collettivaovvero
le armi di collaborazione di massadella scuola “don Milani” di Genova
La scuola come mente collettiva
Paolo Cortigianid.s. Istituto Onnicomprensivo
annesso al Convitto “C. Colombo”
“il punto di caduta determinante della qualità formativa è nella organizzazione segmentaria delle scuole… in cui non esiste un curricolo di scuola ma tanti curricoli quanti sono i docenti”
(Piero Romei, 1986)
Il potere dipende dalla capacità di costituire reti e dalla capacità di connettere le diverse reti
(Manuel Castells, 2009)
La partecipazione è emancipativa
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
(articolo 46 della Costituzione)
La questione organizzativa
• I modi di organizzare il lavoro docente condizionano l’efficacia di due apprendimenti
• La forza di inerzia della rappresentazione naturale delle scuole
• il New Public Management è ineluttabile ?
• ribaltare la prospettiva: quale organizzazione del lavoro ? - quale direzione ? – quale dirigente ?
la RICERCA della don MILANI (2004-2014): la collegialità sposa le tecnologie 2.0
Robusta tradizione di “collegialità”, approfondita e rinnovata nel tempo
Vetero-collegialisti ? le idee di partecipazione e democrazia che ispiravano
le riforme del 1974, se opportunamente approfondite, aggiornate e sviluppate, assumono oggi, nella società della conoscenza, un valore strategico per consentire alle scuole e al sistema scolastico di generare conoscenza professionale e organizzativa, ovvero…
apprendimento, innovazione, apprendimento, innovazione, affidabilitàaffidabilità.
• “…le prestazioni coscienziose e affidabili sono possibili soltanto come frutto di menti collettive. Innanzitutto significa che per fare bene un lavoro che esige cura e attenzione non bastano persone diligenti, se poi vengono lasciate sole… Stare attento, fare con cura le cose non è un atto solitario, è un atto sociale… la superiorità di una mente collettiva rispetto a una pluralità di menti individuali sta nella capacità di affrontare eventi inattesi con molta maggiore efficacia. Nella mente collettiva, sebbene le attività restino individuali, il referente diventa un campo socialmente strutturato e la coscienziosità delle azioni dei singoli dipende dall’interazione tra i know-how individuali.” (Karl Weick, 1998)
Le organizzazioni AFFIDABILI
2004: l’incontro con una tecnologia
• 7 docenti e il ds redigono un progetto
• Un ricercatore ITD ci presenta “Moodle”
• Dalla FaD al lavoro quotidiano ordinario
• L’abito telematico cucito sui bisogni di una comunità al lavoro
• Sorpresi dalle potenzialità di supporto alla cooperazione si decide il “gran passo”
2005/06: il Collegio e poi i Dipartimenti
• L’ambiente “Collegio” e il suo arredo• Nel forum “Discutiamone” parte una riflessione su PFU e
curricolo• Seminario in presenza e lavoro on line di mappatura del
curricolo “reale” svolto dai Dipartimenti, che entrano sulla scena virtuale.
• Matura la consapevolezza della frammentazione del curricolo, che rende retorico il PFU
• I Dipartimenti iniziano il lavoro di costruzione del curricolo “comune” tuttora in atto
• Intreccio tra lavoro a distanza e lavoro in presenza• Forma discorsiva di tipo argomentativo• Inizia a emergere il curricolo sommerso….
2006/07: irrompono i Consigli• la natura “eventuale” del lavoro docente• Le forme del discorso sono prevalentemente
narrative• Il fronte e il quartier generale• Nitida emerge la natura pratica e sociale del sapere
professionale e l’unità dialettica di azione-conoscenza-azione
• È in prima linea che si misura e si co-costruisce l’affidabilità della scuola
• Le esigenze pressanti di coordinamento delle azioni portano a introdurre calendari e wiki
I consigli presidio di affidabilità• L’affidabilità è la capacità sistemica di gestire con successo
eventi imprevisti evitando che questi, inascoltati od occultati, provochino “disastri”
• L’evento didattico-educativo è per sua natura denso di imprevisti, ambiguità, incertezze, rischi.
Le proprietà di una organizzazione affidabile secondo Weick:• sensibilità al contesto e valorizzazione del personale in “prima
linea”• decisioni competenti e accurate: ascolto reciproco, integrazione
delle prospettive, coordinamento delle azioni, potere “migrante”• Una organizzazione affidabile non si lascia fuorviare dalle proprie
procedure e routine (cd “fallacia della predeterminazione”)• approccio non punitivo all’errore: dove vige un rapporto stretto
tra errore e sanzione [dlgs 150 ?] si sviluppa da un lato un atteggiamento di occultamento dell'errore dall'altro di individuazione del capro espiatorio cui addossare le colpe del fallimento
2011- le mani sul curricolo sommerso
• DAL confronto sulle modalità di condurre le classi e di gestire le criticità di tipo psico-sociale che “condizionano” la realizzazione del curricolo esplicito (curricolo sommerso spontaneo)
• Discussioni blended, questionario on line, seminari…
• AL percorso, tuttora in atto, di progettare un curricolo esplicito educativo
• L’esperienza dei “consigli educativi”
Il matrimonio tra tecnologia e cooperazioneaiuta sulle specificità problematiche del lavoro
docentevalorizza la risorsa principe delle scuole, la natura
cognitiva e discorsiva del lavoro docenteLa comunicazione on line facilita, per sua natura,
la riflessività sulle praticheLa percezione dell’ambiente di lavoro cambia
L’ “organizzazione blended” si ribalta nel tempo
È possibile alleggerire il carico deliberativo “in presenza” con la deliberazione elettronica
La tecnologia “sartoriale”
Si comunica in modo tempestivo e interattivoSi accede alla documentazione (conoscenza
“materializzata”)Si coordinano le azioni dei singoli nei gruppiSi gestiscono eventi inattesiSi costruiscono interpretazioni Si negoziano le azioni da attivareSi apprende tra colleghi riflettendo sulle praticheSi generano innovazioni prossimaliSi decide nel corso delle azioni
la cooperazione in piattaforma
Mappa (turbolenta) della piattaforma
39 ambienti / gruppi di lavoro virtuali arredo-tipo: forum, cartelle variamente
annidate, calendari, wiki, sondaggi 79 forum di comunicazione e discussione 163 cartelle di condivisione di documenti 291 wiki per la scrittura collaborativa Circa 40 msg al giorno (con picchi di 70/80
nei primi mesi dell’a.s.) Strumento “Sondaggi” (questionari on line) Deliberazione elettronica
la partecipazione azione chiave dell’organizzare “a rete”
Abbiamo lavorato sulle condizioni della partecipazione intensificando la comunicazione, la cooperazione, la riflessività sulle pratiche, la decisionalità diffusa.
…ovvero abbiamo lavorato sui “legami deboli” e sfruttato le anomalie della risorsa-conoscenza.
RISPOSTA COOPERATIVA E DEMOCRATICA alla questione organizzativa
in aperto conflitto con le risposte main streamLa scuola si è andata organizzando come RETE DI
COMUNITA’ DI PRATICA al cui interno ha preso forma una direzione partecipata e democratica, “organica” all’organizzazione a rete e alle comunità di pratica.
Legami deboli: difetto o risorsa ?
Due approcci “non lassisti” al problema:• Dirigista (burocratico o manageriale): usa le
risorse del comando gerarchico e del controllo su obiettivi dati per allineare le azioni del nucleo professionale a quelle della direzione.
• democratica: punta a valorizzare le logiche professionali del nucleo tecnico, quindi a intensificare la comunicazione e la riflessione sulle pratiche, la produzione e negoziazione dei significati, la generazione di sapere endogeno e di innovazione incrementale
Managerialismo: risposta seduttiva, ma sbagliata
considera la partecipazione come un fattore di disturbo da limitare o liquidare.
disconosce e svaluta la specificità professionale e le proprietà dei contesti lavorativi scolastici causando:
Il rafforzamento della frattura tra gerarchia e nucleo tecnico
L’abbandono delle tematiche didattiche (perdita del “centro” del servizio scolastico)
I guadagni della cooperazione• Si incrementa la riflessività sulle pratiche
quindi l’apprendimento• Si facilita la socializzazione organizzativa dei
“novizi”
• Si diffonde una decisionalità “situata” e quindi accurata
• Si alimenta l’innovazione endogena e si migliora la “traduzione” dell’innovazione esogena
• Si supporta la valutazione interna dei processi professionali
Il dirigente “irretito” L’organizzazione a rete cambia la funzione di direzione e
il ruolo del dirigente La spirale del silenzio - riprendere una riflessione critica -
cambiare rotta
Il DS “coltivatore” di Comunità di Pratica e manutentore della Rete
Nella nuova tornata contrattuale coordinare le proposte del Ccnl “Area V” e del Ccnl del personale docente e ata
• sancire la dimensione cooperativa del lavoro docente• Istituzionalizzare i ruoli di coordinamento dei gruppi di lavoro
strutturali• il telelavoro (art 139 Ccnl) esteso ai docenti • figure che supportino l’utilizzo massivo e stabile delle TIC non
solo nel lavoro d’aula
Il focus del DS nella direzione democratica
• SE la conoscenza professionale cresce riflettendo insieme sulle pratiche più che applicando teorie elaborate altrove
• SE la razionalità “al lavoro” è una razionalità euristica, “sporcata” da convinzioni e valori e da processi decisionali “imperfetti” perché frutto dell’expertise e di negoziazioni
• ALLORA PER LA DIREZIONE il problema diventa come allestire contesti che consentano e intensifichino comunicazione, riflessione, cooperazione, problem solving, intelligenza collettiva.
dalla scuola “a rete” alla Rete delle scuole
Il MIUR dovrebbe porsi il problema di attingere alla conoscenza generata nelle scuole, alla creatività del “cervello sociale” di 8000 organizzazioni scolastiche
Nell’era della Rete e della Wikinomics è un’esigenza vitale
Il MIUR non può continuare a pensare che il sapere e l’innovazione si generino solo nei think thanks degli O.E.F.I.
La piramide genera poca conoscenza e non sfrutta le armi di collaborazione di massa
O.E.F.I.
MIUR
SCUOLE
Wikinomics SI’ - WIKISCHOOLS perché no?
• L’economia sfrutta le forme di collaborazione di massa con i consumatori e la peer production
• Il Miur NO ! “surplus cognitivo” inutilizzato. Che spreco...
• Piano Scuola Digitale: perché non attivare una “azione” dedicata a supportare la cooperazione e la generazione di conoscenza dei lavoratori nelle singole scuole e tra le scuole ?
Perché non puntare sulle WIKISCHOOLS ?