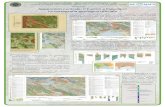Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e...
Transcript of Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e...
Azienda modello o latifondo?D Fucino dal prosciugamento alla riforma
Costantino Felice
Il Fucino è un ‘luogo’ che, per pregnanza storica, difficilmente trova eguali nel Mezzogiorno e nell’Italia intera. La sua secolare vicenda ha interessato la letteratura, l’economia, la politica, la tecnica. In questo saggio vengono analizzati prevalentemente comportamenti e scelte dei soggetti coinvolti sulla base della loro coerenza rispetto a finalità di crescita e di sviluppo.Sotto questo profilo, infatti, il Fucino ha funzionato da laboratorio. Per il modo stesso in cui è sorto — vasta estensione di vergini terre sottratte ad un lago —- il ‘latifondo’ Torlonia si prestava ad insolite sperimentazioni agronomiche e produttive. Nelle sue forme di produzione e di organizzazione si esprimevano strategie imprenditoriali il cui significato andava ben oltre l’orizzonte familiare di un pur importante casato romano. Vi si riflettevano, con forte impatto, equilibri del mercato interno ed estero, indirizzi governativi, umori ed orientamenti di classi e ceti. Lo stesso è accaduto all’indomani della riforma agraria. Di qui la rilevanza dell’ampio e contrastato dibattito che ha accompagnato le tappe fondamentali della storia fu- cense, giudicata molto diversamente.Ed anche ad osservarlo con l’occhio disincantato della prospettiva storica, avendo presente ogni possibile variante e concausa, una valutazione sicura ed univoca — moderna azienda capitalistica o antico latifondo? Modello nobi- liar-feudale o lucida imprenditorialità capitalistica? — risulta tutt’altro che facile.Il Fucino si presenta, dunque, come un osservatorio privilegiato anche per verificare una serie di nodi tematici — logica nobiliare/logica borghese, economia/contesto, centro/periferia, Stato/mercato — che da qualche tempo sono al centro della più aggiornata storiografia.
The Fucino plain is a "place” that hardly finds its equal, as to historical pregnance, in today’s South or even in Italy as a whole, its remarkable record spanning from literature to technical improvement, from economy to politics. The A . ’s analysis concerns behaviours and options which have much to do with agricoltural growth and economic development.It is indeed under this respect that the Fucino acted literally as a laboratory. Because o f the very way in which it was born — large virgin lands recovered from a lake — the Torlonia’s “latifondo ” was an ideal test stand fo r agronomic and cultural experiments, becoming ipso facto a valuable term o f reference fo r technical and managerial innovation.Its peculiar form s o f production and organization o f labour reflected market strategies and economic policies that went well far beyond the private interests o f an outstanding Roman family, however important they might be. Hence the relevance o f the harsh debate that marked every single chapter o f the Fucino story.And the matter o f fact that, even in the light o f a disenchanted historical approach, a clear and distinct assessment appears still to be anything but an easy task.For its emblematic character and national relevance, the Fucino represents, therefore, a privileged viewpoint from one can usefully check a series o f topical joints — such as bourgeois vs. nobiliary approach, economy vs. its context, centre vs. periphery, State vs. the market — that have fo r sometime captured the attention o f the most sensible historiography concerning the South or, better, the whole o f Italy.
Italia contemporanea”, dicembre 1992, n. 189
636 Costantino Felice
II quadro di partenza
Pensare al passato del Fucino vuol dire evocare molteplici significati: quasi non c’è versante dell’attività umana che non ne sia stato in qualche modo coinvolto. È difficile trovare un luogo — nel Mezzogiorno in particolare, ma anche nell’Italia intera — altrettanto carico di pregnanza storica. Immancabile meta dei voyageur sette-ottocenteschi (ed anche di età successiva), esso ha ispirato suggestive pagine della narrativa diaristica; ma soprattutto è diventato poi, come tutti sanno, lo scenario grandioso e palpitante della migliore letteratura silonia- na. Altrettanto di rilievo le vette che vi ha toccato il sapere tecnico: al centro di progettazioni ardite ed avveniristiche già in epoche passate, l’ingegneria del diciannovesimo secolo lo ha fatto, infine, oggetto di una gigantesca e discussa opera di manomissione, alterandone radicalmente i preesistenti quadri ambientali. Per secoli in balia dei vincoli e delle forze naturali, la conca fucense doveva diventare ad un certo punto, con i suoi numerosi manufatti e le sue squadrature geometriche, uno dei luoghi maggiormente “costruiti” ed “artificiali”1.
Il Fucino è stato anche terreno fecondo per la germinazione di forme della socialità e della politica. Intorno alla sua secolare vicenda sono andati consolidandosi interessi ed aspettative, si sono aggregati ceti e costruite corporazioni, è cresciuto un associazionismo contadino e padronale dai tratti talora originali, oltre che insolitamente vigoroso e continuo nel tempo. I suoi problemi sono stati al centro di conflitti e dibattiti che, particolarmente nei momenti di maggiore tensione, hanno fatto maturare le coscienze e dato vita a movimenti di notevole portata. Lo scontro di classe, la contesa tra
capitale e lavoro, tanto nelle forme del suo svolgimento che nella soggettività dei protagonisti, vi ha assunto spesso profili molto marcati, toccando punte di asprezza e di esemplarità che in alcune fasi sono state di riferimento, se non addirittura di modello, per il complesso delle forze e degli schiera- menti in campo a livello nazionale. Ma è soprattutto sul piano delle dinamiche economiche che il Fucino ha funzionato da laboratorio. Per il modo stesso in cui era sorto — vasta estensione di vergini terre sottratte ad un lago — il “latifondo” Torlonia si prestava ad insolite sperimentazioni agronomiche e produttive. Diventava ipso facto novità e centro di attenzione: per tecniche colturali, ordinamenti agrari, assetti gestionali. Nelle sue forme di produzione e di organizzazione si esprimevano strategie imprenditoriali il cui significato andava ben oltre l’orizzonte familiare di un pur importante casato romano. Vi si riflettevano, con forte impatto, equilibri del mercato interno ed estero, indirizzi governativi, umori ed orientamenti di classi e ceti. Di qui la rilevanza dell’ampio e contrastato dibattito che ha accompagnato le tappe fondamentali della sua storia. I giudizi ovviamente sono andati di volta in volta differenziandosi a seconda dei punti di vista e degli interessi in gioco: di solito positivi, com’era naturale, per la proprietà e gli apparati istituzionali; negativi per quanti — forze del lavoro, agrari ed amministratori locali, settori della politica e del mondo scientifico — nelle scelte di Casa Torlonia hanno visto soprattutto miopia economica e volontà di dominio. Per gli uni il Fucino è stato esempio di oculatezza imprenditoriale e di progresso, per gli altri un mostruoso impasto di oppressione e di arretratezza. Ed anche ad osservarlo con l’occhio disincantato della pro
1 Sul tema della “costruzione” del territorio esiste ormai una discreta letteratura. Basti qui citare, anche per gli ulteriori rimandi bibliografici, oltre che per la maggiore attinenza al nostro tema, Lorenzo Bellicini, La costruzione del territorio meridionale, “Meridiana”, 1990, n. 10, pp. 11-44.
Azienda modello o latifondo? 637
spettiva storica, avendo presente ogni possibile variante e concausa, una valutazione sicura ed univoca risulta tutt’altro che facile.
NelPormai ampio panorama di studi prodotti dalla ‘nuova storia’ va consolidandosi un’immagine del Sud d’Italia molto diversa da quella consegnataci dal meridionalismo classico: non più realtà uniformemente immobile ed arretrata, schiacciata tra l’assenteismo agrario e la disgregazione del “contadiname”, ma segmento pienamente inserito, sebbene da condizioni di debolezza, nei processi di modernizzazione che negli ultimi due, tre secoli hanno investito l’insieme dell’ “economia-mondo”. Elementi di dinamismo, se non proprio strategie di sviluppo, vengono individuati persino nel deprecato sistema latifondistico2, tradizionale nodo della persistente questione meridionale. Il Fucino, d’altra parte, difficilmente può essere tout court assimilato al latifondo. A parte la sua notevole ampiezza, tanto sotto l’aspetto giuridico che dal lato tecnico-produttivo esso aveva ben poco dei caratteri tipici di quell’ordinamento. La sua stessa origine s’ispirava a tutt’altri principi. La colossale opera di prosciugamento e bonifica dell’alveo non fu il frutto di una illuminata munificenza patrizia, il gratuito prodotto di un nobile casato smanioso di grandezza, come da tanta agiografia si è tentato di far credere. Più prosaicamente, e con maggiore senso della modernità, essa rispondeva anzitutto a finalità economiche e finanziarie. L’impresa s’inseriva nel sistema delle “con
cessioni”, cui da tempo nelle aree più avanzate d’Europa si faceva ricorso per realizzare infrastrutture e servizi. In mancanza di risorse pubbliche, la concessione era per lo Stato — soprattutto in Italia, dove il ruolo del potere pubblico è stato storicamente decisivo anche in economia — il modo più efficace di attivare gli investimenti privati in direzione del capitale fisso sociale (strade, ferrovie, bonifica). Compiuta l’opera, a determinate condizioni (col supporto però di laute sovvenzioni), se ne affidava la gestione al concessionario perché potesse recuperare i capitali spesi. Con questo meccanismo l’Italia, come si sa, divenne terra di conquista per la grande finanza d’Oltralpe. Ma in tale ottica cominciavano a muoversi anche alcuni ambienti del nascente capitalismo italiano.
Un’iniziativa analoga a quella del Fucino Alessandro Torlonia l’aveva tentata negli ultimi anni trenta in Calabria. Formata un’apposita società, egli aveva proposto al governo borbonico di costruire un canale navigabile tra i golfi di S. Eufemia e di Squillace, con eventuale porto annesso, chiedendo in cambio di goderne le proprietà per novantanove anni. L’idea era piaciuta personalmente al sovrano, che incaricò il ministro dell’Interno di studiarne fattibilità e condizioni. Ad un certo punto però, non è chiaro perché, Torlonia si fece indietro3. Il proposito riuscì invece nel Fucino. Qui, del resto, le prospettive di profitto si presentavano ben più sicure ed allettanti. Acquisire e mettere a
2 Si veda, ad esempio, Marta Petrusewicz, Latifondo. Economia, morale e vita materiale in una periferia dell’Ottocento, Venezia, Marsilio, 1989; Piero Bevilacqua, Forme de!paesaggio e evoluzioni dell’habitat. Alcune ipotesi, “Meridiana”, 1990, n. 10, pp. 77-80. Quanto agli sviluppi più aggiornati della storiografia meridionalistica, si vedano Carmine Donzelli, Mezzogiorno tra “questione” e purgatorio. Opinione comune, immagine scientifica, strategie di ricerca, “Meridiana”, 1990, n. 9, pp. 13-53, e, sebbene ormai un po’ datati, i miei Verso una “nuova storia" del Mezzogiorno, “Italia contemporanea”, 1987, n. 168, pp. 119-132, e Orientamenti e problemi della storiografia contemporanea. Di nuovo la “questione meridionale”, “Cultura e scuola”, 1988, n. 106, pp. 101-109.3 Giuseppe Carelli, Ragguaglio di alcuni principali porti, fari e lazzaretti de’ reali domimi di qua dal Faro, “Annali civili”, 1857, f. CXX, p. 118. Sempre sugli “Annali civili” (1854, f. CI, pp. 39-69), riguardo al Fucino, si veda la Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del secolo XVIII, con introduzione di Ferdinando De Luca.
638 Costantino Felice
coltura una vasta e fertile pianura, a ridosso dei mercati di Roma e Napoli, in un periodo di prevalente ottimismo per le sorti dell’economia e di importanti realizzazioni viarie, non poteva non costituire una ghiotta occasione per chiunque avesse avuto un minimo di fiuto per gli affari; e pare che Torlonia ne fosse tutt’altro che sprovvisto4. Ciò non significa, naturalmente, che questo nucleo di fredda razionalità capitalistica non venisse circonfuso da motivazioni extraeconomiche, come quella del prestigio o anche della magnanimità. Realizzare un progetto del genere voleva dire, d’altra parte, portare a compimento un disegno che era stato nelle aspirazioni di alcuni “grandi” della storia, da Cesare agli ultimi sovrani del regno di Napoli. La possibilità di aggiungere il proprio medaglione, perdippiù con l’alone del probabile successo, ad una galleria di simili personaggi certo non doveva lasciare indifferente un patriziato romano che considerava il proprio destino storico tutt’altro che esaurito. Ma si tratta di cornice. Nella sostanza l’operazione s’inquadrava perfettamente — pur nei limiti che vedremo — nella logica del grande capitale ottocentesco.
Era stato Afan de Rivera a produrre la progettazione più avanzata sul Fucino: i suoi dettagliati piani, oltre a raccogliere il meglio delle precedenti elaborazioni (si pensi a Ignazio Stile), anticipavano elementi di tale modernità da configurarsi, nell’insieme,
quasi come una “bonifica integrale”5. Quand’egli era ancora in vita, però, difficoltà d’ogni genere ne avevano bloccato i tentativi di realizzazione. La sua improvvisa morte, poi, faceva cadere ogni residua speranza di trovare all’interno dell’amministrazione napoletana le risorse finanziarie e tecniche necessarie all’impresa. Nei primi anni cinquanta si decideva pertanto di far ricorso all’intervento privato. Venne costituita una società con prevalente capitale inglese e francese. Il deliberato della concessione prevedeva che essa si accollasse tutti gli oneri del prosciugamento in cambio della proprietà dei terreni “sottostanti al lago”, senza alcun limite di tempo. Nel giro di qualche anno, ritiratisi uno dopo l’altro i partner esteri, Torlonia s’impossessa dell’intero capitale sociale, assumendo personalmente la direzione dell’opera.
Dal lato tecnico, tanto per l’ideazione che per l’esecuzione, il prosciugamento del Fucino rappresentò quanto di più avanzato a quel tempo si potesse immaginare. Il progetto fu redatto da Frantz Montricher, ingegnere di Marsiglia, uscito datt’École polytechnique. Suoi più stretti collaboratori, subentratigli poi a tutti gli effetti nei massimi ruoli direzionali, erano due personaggi ugualmente di notevole levatura scientifica: Henri Bermont, quale ingegnere capo, e Alexandre Brisse, quale direttore dei lavori6. Questa provenienza estera dei quadri tecnici di più
4 Per un sintetico profilo del personaggio cfr. VIntroduzione di Anna Maria Giraldi, in Archivio centrale dello Stato, L ’archivio dell'amministrazione Torlonia. Inventario, Roma, 1984, pp. XX-XX1V.5 L’opera principale che Carlo Afan de Rivera dedica al Fucino è Progetto della restaurazione dell’emissario di Claudio e dello scolo del Fucino, Napoli, 1836. Ma nel 1823 era uscito anche Considerazioni sul progetto di prosciugare il lago di Fucino. Su de Rivera, con riferimento ai progetti di bonifica del Fucino, cfr. John Davis, Società e imprenditori nel Regno borbonico. 1815-1860, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 182 e 250. Sull’attività di bonifica nel regno di Napoli, fondamentale resta P. Bevilacqua, Acque e bonifiche nel Mezzogiorno nella prima metà dell ’Ottocento, “Studi storici”, 1986, n. 2, pp. 335-357.6 Quest’ultimo è coautore, insieme con Léon De Rotrou, capo dell’amministrazione Torlonia, della monumentale opera Prosciugamento del Lago Fucino fatto eseguire da Sua Eccellenza il Principe Alessandro Torlonia. Descrizione storica e tecnica, Roma, 1883, 2 voli. De Rotrou usa in genere toni di smaccata adulazione, presentandoci un Torlonia principe della Chiesa e vessillifero della fede, che avrebbe interpretato la colossale impresa per spirito di magnanimità verso le comunità locali minacciate dal lago. Dello stesso autore si veda, più o meno con analoga im-
Azienda modello o latifondo? 639
alto livello (ma lo stesso vale, come si dirà fra poco, anche per le maestranze) non era tanto dovuta — o comunque non soltanto — all’ottica internazionale con cui si muovevano i Torlonia, o alla loro pregiudiziale ostilità — essendo essi intimamente legati agli ambienti pontifici — verso lo stato unitario: assai più verosimilmente la prima Italia liberale scontava qui la propria carenza di professionalità elevate, dovuta forse anche al fatto che i governi nazionali — come è stato scritto a proposito del Tavoliere — “trascurarono ed anzi spazzarono via i lasciti, legislativi e culturali, delPesperienza bo- nificatrice borbonica”7. Non che sia mancata del tutto la sensibilità a questi problemi: il nuovo Stato anzi — come si sa — assunse subito tra i suoi compiti fondamentali proprio il “governo politico” del mercato e dell’intervento sul territorio8, soprattutto attraverso le grandi opere pubbliche. Ma è probabile che tale orientamento si sia risolto prevalentemente in una cooptazione, all’interno degli apparati ministeriali, delle professionalità tecnico-scientifiche esistenti, relegando in secondo piano l’impegno a crearne di nuove e più elevate. O comunque gli sforzi in questa direzione — almeno fino a Nitti — dovettero risultare quanto meno insufficienti.
Il Fucino era il terzo lago d’Italia, dopo il Garda e il Maggiore. Chiuso in una corona di monti, con un’elevazione che mediamente superava i 600 metri, esso registrava un’ampiezza, pur tra continue oscillazioni, di oltre 150 kmq. Il primo a studiare la possibilità di prosciugare questo immenso specchio d’acqua, per farne il “granaio di Roma”, fu Giulio Cesare. Il proposito venne però tradotto in pratica dall’imperatore Claudio. Tramite una galleria sotterranea — il celebre emissario Claudio, appunto — le acque lacustri furono incanalate nel fiume Liri. Stando alle testimonianze del tempo, ed anche al giudizio dei posteri (particolarmente severi quelli di Afan de Rivera e di Brisse), il manufatto risultò alla fine alquanto difettoso ed approssimativo. È solo nel II secolo, infatti, che la colonizzazione della conca tocca il suo apice, come dimostra lo sviluppo di Alba Fucens, il centro amministrativo allora più importante della regione marsica- na. Successivamente, però, i canali di deflusso e l’emissario restarono per secoli senza alcuna manutenzione. La gigantesca opera, meraviglia di molte generazioni di tecnici, era andata in tal modo progressivamente deperendo, fino a diventare del tutto inservibile. Un tentativo di restauro venne promosso da Federico II per riparare ai danni di
postazione, Prosciugamento del Lago Fucino eseguito dal principe D. Alessandro Torlonia. Confronto tra l ’Emissario di Claudio e l ’Emissario Torlonia, Firenze, Le Monnier, 1871. Del Brisse, molto più sobrio, è anche Dessèchement du Lac Fucino. Rapport à son Excellence Le Prence A. Torlonia, Neaples, 1874. Occorre considerare, comunque, che la quasi totalità dello sterminato opuscolame sul Fucino, traendo di solito origine da occasioni di difesa per questa o quella parte nelle innumerevoli controversie giudiziarie o politico-sociali che si sono succedute nel tempo, risente di una certa parzialità. Sugli aspetti tecnici del progetto di prosciugamento del Fucino, cfr. Roberto Parisi e Adriana Pica, L ’impresa del Fucino tra storia e progetto, tesi di laurea, Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli, a.a. 1989-1990.7 P. Bevilacqua, Introduzione ad Antonio Checco-Leandra D ’Antone-Franco Mercurio-Valeria Pizzini, Il Tavoliere di Puglia. Bonifica e trasformazione tra XIX e X X secolo, a cura di P. Bevilacqua, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 18. Sull’argomento cfr. anche Paolo Morachiello, Ingegneri e tecnici nell’età della Destra (1860-1875). Dal Canale Cavour all’Agro romano, Roma, Officina, 1976.8 Le analisi e le informazioni più approfondite, in merito, si trovano in Leandra D ’Antone, Tecnici e progetti. Il governo del territorio, “Meridiana, 1990, n. 10, soprattutto pp. 125-127. Della D’Antone, sempre su questi temi, si veda anche Scienze e governo del territorio. Medici, ingegneri, agronomi e urbanisti nel tavoliere di Puglia (1865- 1965), Milano, Angeli, 1990.
640 Costantino Felice
un’ennesima piena. Ma certamente i risultati non furono eccellenti, né duraturi9. Senza effetto dovevano risultare, come accennato, anche i propositi nutriti dai sovrani napoletani tra la fine del Settecento e il primo Ottocento. Col tempo il lago s’era compieta- mente ricostituito. È vero che esso con le sue acque, oltre a temperare il clima e favorire la coltivazione di piante mediterranee (olivi, viti, mandorli), consentiva anche, grazie alla presenza di volatili e pesci lacustri, una certa attività di pesca e caccia; ma queste modeste risorse — in un’economia a prevalente impianto agricolo, profondamente segnata da precarietà ed arretratezze — difficilmente compensavano i permanenti rischi di distruzione e di morte che il bacino, con i suoi periodici innalzamenti di livello, comportava per le popolazioni ripuarie.Il Fucino — scriveva Afan de Rivera nei primi anni trenta dell’Ottocento — come al presente in un periodo più o meno lungo soleva ritirarsi in più angusti confini e dilatarsi poscia inondando le terre men elevate. Durante il periodo di decrescimento i Marsi allettati dalla fertilità delle terre concimate per le scomposizioni animali e vegetali che si operavano sott’acqua, vi stabilivano industriose abitazioni, e per la presente prosperità obliando le passate irruzioni delle acque, vi edificavano case rurali e comode abitazioni. Ma allorché il Fucino nelle sue furiose escrescenze stendeva il suo dominio tutto all’intorno, quella ridente posizione di cose cangiavasi in lutto e desolazione. A un tratto perdevasi la proprietà delle terre e degli edifizi che passavano sotto il dominio delle acque10.
Spinte dunque da vitali ragioni di sicurezza, erano le stesse comunità locali, molto spesso, a sollecitare interventi bonificatori. Le pressioni dal basso senz’altro pesarono nel riprodurre il problema anche a metà Ottocento. Occorreva ormai iniziare tutto daccapo. Per la strumentazione tecnico-scientifica del tempo si trattava di lavori colossali, che richiedevano non solo altissime competenze progettuali e direzionali, ma anche maestranze qualificate ed ampia manovalanza. Nonostante la diffusissima sottoccupazione agricola, non era facile trovare sul posto tante forze. Soprattutto per la manodopera specializzata si dovette procedere ad una massiccia importazione. In particolare vennero fatti venire dal circondario di Marsiglia, dove già si erano acquisite esperienze del genere, circa 500 minatori e tagliapietra che, insieme al personale di direzione e vigilanza, formavano un gruppo francese molto omogeneo: certamente il nucleo principale cui si deve la realizzazione dell’opera. Ad essi col tempo si aggiunsero altri lavoratori — carrettieri, artigiani, commercianti — difficilmente reperibili in loco. È stato calcolato — non è chiaro in base a quali criteri — che l’immigrazione avrebbe superato le quindici- mila unità nel periodo 1850-1880, mentre gli operai occupati sarebbero stati mediamente quattromila11.
È facile immaginare quali sconvolgimenti economici e sociali abbiano potuto produrre le attività di prosciugamento sul contesto preesistente. Anzitutto nel circondario —
9 Ernst Kantorowicz, Federico II imperatore, Milano, Garzanti, 1976, p. 35; Luigi Gatto, Terre e vicende dei Fucino nell’età medievale, e, per una specifica rassegna della storiografia latina sul Fucino, Gaetano Messineo, L ’emissario di Claudio, in Aa.Vv., Fucino cento anni. 1877-1977, L’Aquila, s.d. [ma 1978], rispettivamente pp. 227-228 e 139-167.10 Progetto della restaurazione, cit., p. 35. Quanto alle economie lacustri preesistenti al prosciugamento, si veda soprattutto Adriana Giarrizzo, La piana del Fucino dopo il prosciugamento. Note antropologiche, “Bollettino Società Geografica Italiana”, 1971, f. 10-12, pp. 620-622. Sul commercio del pesce fucense, cfr. anche Luigi Lopez, Pesca di mare e di Fucino nell’Aquila fra il Trecento e l ’Ottocento, “Rivista abruzzese”, 1992, n. 1, pp. 6-8 e 20.11 Marcello Vittorini, Il prosciugamento del Fucino: evoluzione del tessuto insediativo e della organizzazione del territorio, in Fucino cento anni, cit., pp. 264, 268 e 272.
Azienda modello o latifondo? 641
pare anzi nell’intera provincia aquilana, stando alle testimonianze raccolte da Fran- chetti nell’ottobre 187312 — non si colgono più segni di disoccupazione, nonostante la contemporanea crisi della pastorizia e dell’agricoltura di sussistenza (con l’inizio della ‘grande depressione’, anche di quella proiettata sui mercati). La crescita demografica nella zona subisce una brusca accelerazione: nel ventennio 1861-1881 la popolazione residente dei comuni ripuari, in base alle circo- scrizioni dell’epoca, passa da 32.669 abitanti a 42.250, con un incremento di quasi il 30 per cento. L’aumento è particolarmente vistoso in alcuni centri: a Ortucchio del 64,4 per cento, a Pescina del 55,5 per cento (soprattutto per l’exploit di S. Benedetto, che allora faceva parte dello stesso comune), a Celano del 41,8 per cento, ad Avezzano del 39,4 per cento, a Trasacco del 35,6 per cento, a Luco del 32,7 per cento. Che tali dati — sebbene inferiori a quanto si è di solito scritto13 — fossero dovuti all’afflusso di manodopera per i lavori del Fucino trova indiretta conferma in due altre stime, anch’esse desumibili dalla statistica ufficiale. Anzitutto la crescita ancora superiore (37,6 per cento) della popolazione presente: una differenza — questa tra presenti e residenti — che evidentemente sta a denotare 1’aggirarsi nella zona di molta gente arrivata da fuori, che non aveva ancora regolarizzata — e forse non aveva intenzione o possibilità di farlo
— la propria posizione anagrafica. L’altro aspetto da rilevare è che nel successivo ventennio 1881-1901 l’incremento demografico— sempre nella stessa area fucense — scende al 25,5 per cento per la popolazione residente e addirittura al 16,1 per cento per quella presente: un calo relativo abbastanza netto, di cui è difficile negare lo stretto legame col venir meno della favorevole congiuntura che col prosciugamento si era creata nel mercato del lavoro.
Naturalmente il nuovo quadro demografico ed occupazionale — il cui peso dovette essere certamente decisivo nella complessiva tenuta della montagna abruzzese e molisana— crea tutta una serie di problemi: sul piano abitativo, igienico-sanitario e persino antropologico. Negli anni ottanta a Pescina, per esempio, risultano 425 nuovi fabbricati, ad Avezzano 328, a Luco 300, a Celano 297. Il possidente Nicola Marcone a proposito di S. Benedetto notava che “tutto il caseggiato del paese ogni giorno più si abbellisce e si estende” . In qualche modo migliorano anche le condizioni materiali e morali della gente comune. Annotava Franchetti nel suo Diario di viaggio:Condizione dei contadini. Buona dopo che Tor- lonia ebbe sterrato il lago; i contadini non vogliono più lavorare gli altri terreni se non a condizioni migliori di prima. Se prima avevano metà dei prodotti, ora vogliono i due terzi e li ottengono; Torlonia è molto amato dai contadini e odiato dai signori. Miseria. Nessuna14.
12 Condizioni economiche e amministrative delle provincie napoletane. Appunti di viaggio. Diario del viaggio, a cura di A. Jannazzo, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 133 e 142.13 I dati qui riportati — riferiti ai comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pescina, Trasacco — sono elaborati, per quanto riguarda la popolazione residente, da Istat, Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 1861 al 1951, Roma, 1961, pp. 225-228, e, per la popolazione presente, da Id., Popolazione residente e presente dei comuni ai censimenti dal 1861 al 1961. Circoscrizioni territoriali al 15 ottobre 1961, Roma, 1962, pp. 280-285. In genere sovrastimate le cifre di Lorenzo Botti, Per la storia. Documenti sul Fucino, Angelini, Avezzano, 1893, pp. XXX-XXXIII, riprese da M. Vittorini, Il prosciugamento del Fucino, cit., p. 272, e da Raffaele Colapietra, Fucino ieri. 1878-1951, L’Aquila, 1989 (ed. orig. 1977), pp. 18 e 26. Si tenga anche conto che contemporaneamente un forte incremento demografico si riscontrava anche in altre aree di pianura, come ad esempio il Tavoliere (Leandra D ’Antone, Medici, ingegneri, agronomi nella bonifica del Tavoliere, in II Tavoliere di Puglia, cit., pp. 109-110).14 Leopoldo Franchetti, Condizioni economiche e amministrative delle provincie napoletane. Appunti di viaggio -
642 Costantino Felice
L’introduzione del pagamento mensile, al posto di quello a giornata (spesso in natura), pur nella tenuità delle remunerazioni e nelle differenze di trattamento tra i locali e i forestieri, rappresentò un indubbio elemento di novità e di avanzamento rispetto alla staticità di una tipica economia preindustriale, caratterizzata da arcaici rapporti di lavoro. Il positivo impatto dell’opera di prosciugamento sulla vita delle comunità ripuarie trovava del resto riscontro in un’accentuata divaricazione tra l’area fucense, che mostrava segni di crescente miglioramento, e i comuni depressi deH’interno, i quali viceversa arretravano15. Ma le cose andavano man mano mettendosi bene soprattutto per i Torlonia. Con lo Stato unitario i nuovi governanti avevano benevolmente acconsentito di rivedere ed ammorbidire le clausole della convenzione borbonica. I tempi di realizzazione dell’opera, precedentemente fissati in otto anni, vennero dilazionati fino al 1878, le ipotesi di rescissione del contratto sostituite con quella più blanda di un risarcimento degli eventuali danni. Restava invece immutato il disposto che scaricava sui comuni l’onere della prova circa la demanialità dell’alveo: sarà il cuore della questione fucense, concernendo essa la legittimità o meno della proprietà da parte del casato romano. Inizialmente la tensione intorno a questo nodo si accentrava sul problema dei confini. Con
un decreto governativo del maggio 1862 erano stati fissati i criteri per la loro definizione in base all’“attuale linea di sommersione”, pur facendo salvi — si aggiungeva con formula ambigua — i “diritti della compagnia e dei terzi” . Ma al momento dell’apposizione dei termini, un mese dopo, l’acqua sover
chiava di oltre 5 metri il livello registrato nell’anno della concessione. In alcune zone erano ricoperte piantagioni orticole e persino case. Il picchettamento venne peraltro effettuato pochi giorni prima che si cominciasse a far defluire le acque nell’emissario. Questo insieme di circostanze provocò i primi tumulti popolari. Non era chiaro, in verità, se la delimitazione del lago dovesse intendersi come atto meramente tecnico oppure come una vincolante prefigurazione dei diritti di possesso. Sta di fatto che i Torlonia procedevano all’occupazione delle terre man mano prosciugate proprio a partire da quella perimetrazione. Vi furono opposizioni solo da parte delle municipalità di Luco e di Ortucchio, che alla fine si videro sostanzialmente riconosciuti i loro diritti. Quando nell’autunno del 1872 la controversia giungeva a trovare finalmente una soluzione — col riconoscimento del viale di circonvallazione appena costruito attorno al lago quale confine — la superficie del ‘latifondo’ risultava di poco superiore ai 14.000 ettari.
L’“Eccellentissima Casa” esce vincitrice
diario di viaggio, a cura di Antonio Jannazzo, Roma-Bari, Laterza, 1985, p. 169 (corsivi nel testo). I precedenti dati sulle abitazioni sono ripresi da “Risveglio” (L’Aquila), 11 marzo 1988. Il Marcone poco prima citato nel testo (// lago de’ Marsi e sui dintorni, Roma, 1986, p. 53) a questo proposito così si esprimeva: “È spettacolo assai commovente quello d’un popolo che, mercé l’industria e l’operosità, risorge dalle proprie ceneri. L’agiatezza ha le sue simpatie e il suo profumo. Si rivela dovunque, dai volti, dalle case, dalle praterie, perfino dalla vigoria delle bestie”.15 Al riguardo Colapietra opportunamente nota come il collegio elettorale di Pescina, che comprendeva tutti i comuni ripuari, ed era quarto per popolazione tra i collegi abruzzesi (52.252 abitanti), nel 1876 fosse salito al terzo posto per indice di censo degli elettori, mentre quello di Avezzano, nel quale maggiormente rientravano i comuni dell’entroterra e che aveva una popolazione di poco inferiore, precipitava al tredicesimo (Problemi politici e sociali dell’Abruzzo a fine Ottocento, I, “Nuovi quaderni del Meridione”, 1967, n. 18, p. 158-161). Su uno “straordinario rincaro” dei prezzi e dei salari nell’area del Fucino in questo periodo, cfr. L. Franchetti, Condizioni economiche, cit., p. 142, e Carmine Letta, Memoria sulle condizioni dell’agricoltura e della classe agricola riflettente il Circondario di Avezzano, Milano, 1984, p. 129. Basti pensare, peraltro, che il dazio sui consumi ad Avezzano passa da 13.257 subito dopo l’Unità a 44.595 nel 1882 (R. Colapietra, Fucino ieri, cit., p. 36).
Azienda modello o latifondo? 643
anche nel contenzioso sulle alterazioni climatiche conseguenti al prosciugamento. Una prima polemica su questo tema si ebbe nella primavera del 1874, allorquando freddi eccezionali distrussero completamente gli oliveti del circondario. Da taluni si giunse a chiedere la ricostituzione pura e semplice del lago. In seguito ci si attestò sulla più ragionevole rivendicazione di un suo ripristino quanto meno parziale. Su questa linea si collocavano i proprietari terrieri delle zone cir- confucensi, i quali vedevano minacciati i loro tradizionali interessi non tanto — o comunque non solo — dagli eventuali squilibri ambientali, quanto piuttosto dall’emergere dei Torlonia come potenza economica in un’area troppo contigua ai propri possedimenti ed affari. Franchetti rilevò — lo abbiamo visto — come Torlonia fosse amato dai contadini e odiato dai proprietari. Persino il marchese Dragonetti si lamentò con lui del “dissesto economico portato dal subitaneo accrescere delle terre coltivabili coll’essiccamento del Fucino.’’16. Mentre miglioravano gli “operai agricoli”, accadeva l’opposto per i grandi e medi possidenti, “i quali se una volta si lasciavano pregare per concedere in fitto i loro terreni” , ora dovevano essi
pregare i contadini “lasciandosi addirittura imporre le condizioni, con sensibile diminuzione della rendita” . Emerge qui uno scontro evidente tra possidenza agraria tradizionale e grande capitale (soprattutto finanziario), il cui intervento in agricoltura, com’è stato ipotizzato anche sul piano generale17, appariva — ed in effetti era — un fattore di perturbamento dei vecchi equilibri economici e sociali.
Attacchi sul fronte del deterioramento ambientale venivano peraltro da settori delle libere professioni. Discussioni vi erano state — anche in sede progettuale — sulla conservazione o meno del “bacinetto”, una sorta di serbatoio al centro della conca, la cui funzione avrebbe dovuto essere di moderazione climatica e di contenimento del deflusso nelle fasi di forte rialzo delle acque. Ma soprattutto, a sostanziare la tesi secondo cui la totale scomparsa del lago, rompendo irrimediabilmente l’ecosistema, si sarebbe alla fine risolta in grave danno per le comunità locali, sopraggiungeva il rincrudimento delle “febbri palustri” nella zona18. Anche su tale versante i contrasti furono molto aspri, specie per i ritardi con cui in effetti si procedeva alla bonifica. Nonostante questo groviglio
16 L. Franchetti, Condizioni economiche, cit., p. 173, mentre le successive frasi virgolettate sono riprese da C. Letta, Memoria, cit., p. 191. La voce degli agrari marsicani trovava autorevole espressione, oltre che in vari organi di stampa locali, nel consiglio provinciale dell’Aquila, in molte amministrazioni comunali e in enti economici (Comizio agrario, Camera di commercio, ecc.), del cui controllo essi, quale ceto dominante, facilmente disponevano. Da taluni si paventava il rischio, tra l’altro, che i futuri vantaggi del prosciugamento e della messa a coltura del bacino, per quanto si potessero prevedere consistenti, non avrebbero compensato le perdite subite con la distruzione delle preesistenti economie lacustri (pesca, caccia, viticoltura, ecc.). Naturalmente si trattava di un’argomentazione assai poco sostenibile: se davvero il Fucino fosse stato un tempo quel “giardino degli Abruzzi” di cui si favoleggiava, non si spiegherebbe, tanto per cominciare, la concorde richiesta avanzata nel corso dei secoli — anche da parte delle popolazioni rivierasche, come abbiamo visto — di prosciugare quella massa liquida per sfruttarne le terre sottostanti con criteri più consoni e razionali. Raffronti statistici tra il prima e il dopo sono naturalmente difficili in un campo del genere; ma nel 1893 verrà calcolato che se prima un ettaro di lago dava un reddito lordo annuo di cinque lire, ora se ne ricavava sessanta volte di più (Enrico Celani, La bonifica del Fucino e la nostra agricoltura, estr. dalla “Nuova Rassegna”, 1893, n. 46, p. 16).11 P. Bevilacqua, Introduzione, cit., p. 21.18 Cfr., anche per i rimandi bibliografici, Costantino Felice, Il disagio di vivere. Il cibo, la casa, le malattie in Abruzzo e Molise dall’Unità al secondo dopoguerra, Milano, Angeli, 1989, p. 151. Per un’ampia analisi tecnica sui problemi del bacinetto, Carlo Possenti, Sul prosciugamento del lago Fucino, Roma, 1972 (estr. dal “Giornale del Genio civile”).
644 Costantino Felice
di problemi, spesso inestricabili e di tanto in tanto sul punto di esplodere, i lavori procedettero con ritmi abbastanza intensi. Aperti riconoscimenti da parte delle autorità regie e governative sancivano ufficialmente i successi dei Torlonia, fregiati tra l’altro del titolo di “principi del Fucino”. Quando nel 1875 l’opera è sostanzialmente compiuta, a ventidue anni dall’inizio, i risultati si presentano di tutto rispetto: oltre all’emissario (ultimato nel 1869) e all’incile, 210 km di strade, 100 di canali, 648 di fossi. Il tutto con una spesa, stando alle stime di Brisse e De Rotrou, di poco superiore ai 43 milioni, circa dieci volte l’originario capitale sociale.
Ordinamenti produttivi e forme di conduzione
Nella logica del profitto l’impresa era apparsa subito fruttuosa. Già nel 1864 — riferisce De Rotrou19 — la domanda di acquisto dei terreni superava ogni possibile offerta. Per l’imprenditore Torlonia il rischio dell’inve- stimento si riduceva a zero. Ma si rivelarono subito allettanti anche gli indici della produzione: di vendere lotti per ammortizzare i costi, come si prevedeva inizialmente, non c’era dunque alcun bisogno. Nel 1863, all’indomani del primo deflusso, da una superficialissima aratura si ottennero fino a 70
quintali per ettaro di granturco, 50-60 di grano, 40 di fagioli e 400 di patate. Negli anni seguenti questa altissima feracità va ovviamente scemando, ma resta sempre al di sopra della media, suscitando la meraviglia di osservatori locali ed esterni20. L’indirizzo prevalente era quello cerealicolo: nel 1872 il 40 per cento (oltre 2.000 ettari) della superficie disseccata risultava a grano, con avvicendamenti di mais, fave e fagioli. La resa del frumento era allora di oltre 17 quintali ad ettaro, un dato sempre eccezionale. Parte del terreno veniva coltivata a prato e a vite, anche qui con buoni risultati. Ma la prospettiva su cui decisamente si puntava, nell’ottica illusoria del “granaio di Roma”, era la cerealicoltura, tanto che si prevedeva di sestuplicarne la produzione e quintuplicare gli addetti.
È difficile accertare con sicurezza se l’alta redditività delle colture tradizionali e il loro smercio sui mercati romani relativamente agevole, grazie anche ai miglioramenti stradali lungo la Tiburtina-Valeria e all’apertura negli anni ottanta della ferrovia Avezzano- Roma, abbiano pesato come forza inerziale sui comportamenti imprenditoriali della proprietà. La rigidità del sistema commerciale e distributivo, come per il resto del Mezzogiorno21, senz’altro dovette influire negativamente. Resta il fatto, comunque, che scelte coraggiose ed innovative, nell’organizzazione produttiva e gestionale del ‘la-
19 L. De Rotron, Dessèchement, cit., pp. 128-129.20 “Grande ammirazione” per la “straordinaria feracità del suolo fucense” espresse, ad esempio, Giustino Fortunato durante un’escursione compiuta nell’estate del 1886 (“Umbrone”, 24 agosto 1886). Da parte di Nicola Marcone, dopo aver parlato di un “piano liquido” trasformato in “campo fertilissimo, donde traggono tutti il pane e una relativa agiatezza”, si auspica la possibilità di fare del Fucino “un vero e meraviglioso angolo dell’Olanda” (Il lago de’ Morsi, cit., pp. 50 e 97). I dati sulla produttività sono ripresi da Luigi Clemente Jacobini, Il disseccamento del Fucino, Memoria estratta dagli Atti dell’Accademia dei Lincei nella tornata del 9 giugno 1872, pp. 5-6; Carmelo Mancini, Il Fucino agrologicamente considerato, Città di Castello, 1890, p. 32; L. Botti, Per la storia, cit., p. XXX; Eugenio Paradisi, Il Fucino proprietà dei principi Torlonia, Avezzano, 1903, p. 11, dove tra l’altro si legge che queste rese “si ottenevano graffiando la terra con un aratro adamitico”, donde poi “un poco di scoraggiamento” quando questa altissima fertilità naturale andò esaurendosi.21 Cfr. Aldo Cormio, Note sulla crisi agraria e sulla svolta del 1887 nel Mezzogiorno, in Angelo Massafra (a cura di), Problemi di storia delle campagne meridionali nell’età moderna e contemporanea, Bari, Dedalo, 1981, pp. 553- 554.
Azienda modello o latifondo? 645
tifondo’, in questo primo periodo non ve ne furono, nonostante la crisi agraria compromettesse del tutto la prospettiva di rappresentare il “granaio di Roma”. Già dagli osservatori contemporanei più attenti vennero fondati rilievi in tal senso. L’agronomo Letta, ad esempio, denunciava esplicitamente l’assenza di un indirizzo “agricolo-industria- le” : non soltanto erano scarsamente sviluppate le piante industriali come la barbabietola, il lino e la canapa, ma la stessa coltivazione dei cereali (per non dire della vite) veniva praticata con sistemi arretrati e depauperanti. Andava affermandosi la vecchia agricoltura estensiva, senza specializzazione né agganci con le industrie alimentari. Mancavano “volontà” e “concorso fattivo”, insomma, per fare del Fucino “l’emporio agri- colo-industriale degli Abruzzi”22. Ma è soprattutto sul piano dei rapporti socio-produttivi che i nodi cominciano subito ad aggrovigliarsi. Inizialmente i propositi sembravano rispondere a criteri di razionalità: costruire unità poderali di 20-25 ettari, sull’esempio della mezzadria classica, in modo da evitare tanto i rischi della solita frammentazione quanto quelli dell’eccessivo accentramento. In realtà le cose andarono del tutto diversamente. Sulla base di quali logiche? A che tipo di spinte hanno sottostato i processi reali? Sono questi gli interrogativi storiograficamente cruciali cui occorre dare risposta. Se le intenzioni erano altre, appare difficile pensare che a certi esiti, da tutti deprecati, si sia giunti per deliberata volontà. Non è neppure immaginabile, d’altro canto, che tutto si sia svolto per effetto di meccanismi spontanei ed ingovernabili. Il cosiddetto “partito Torlonia” , compreso l’establishment gover
nativo ed istituzionale, ha sempre additato nella “follia rossa” del 1919-1921 la causa della dispersione e del frazionamento. Da parte della pubblicistica di sinistra, oltre che della storiografia più avvertita23, a questa versione si è imputato invece un radicale stravolgimento dei fatti, teso a nascondere proprie responsabilità e negligenze. Ma, tolto l’involucro ideologico, una parte di verità sta forse in entrambe le posizioni.
Dare seguito aH’originario piano di appoderamento avrebbe richiesto investimenti di notevole portata, oltre a non comuni capacità di gestione. Per la piena funzionalità dei previsti 4-500 poderi occorreva costruire case, strade, canali, silos: un insieme di strutture fondiarie, insomma, dai costi tutt’altro che marginali. Impegni altrettanto considerevoli — forse anche superiori — avrebbe comportato la conduzione in economia dell’intero bacino o di gran parte di esso. È difficile pensare — sebbene non manchino indizi in questo senso24 — che scelte del genere non rientrassero nelle possibilità finanziarie dei Torlonia. Probabilmente furono decisivi, o comunque condizionanti, anche i dati del contesto in cui il complesso aziendale s’inseriva. Fatto sta che il risultato alla fine sarà il minuto frazionamento — l’esatto contrario delle intenzioni dichiarate — con conseguenze deleterie sotto ogni profilo: economico, sociale e politico. Nel 1890 i circa 13.000 ettari di terreno allora coltivabili risultavano suddivisi in un fondo a conduzione diretta (2.800 ettari), in una porzione molto minore (900 ettari destinata a mezzadrie e nella rimanente, di gran lunga la più estesa (9.300 ettari), ad affittanze. In confronto alla preesistente realtà della provincia
22 C. Letta, Memoria, cit., p. 6.23 In particolare R. Colapietra, Fucino ieri cit., pp. 31-32, 73, 175.24 È significativo, ad esempio, che vi fosse chi esortava il governo ad esonerare i Torlonia dal pagamento della fondiaria, affinché con la corrispondente somma — 165.000 lire nei primi anni ottanta — si potessero costruire le case coloniche (R. Colapietra, Fucino ieri, cit., p. 55, nota 42).
646 Costantino Felice
aquilana, dominata dal grande possesso ce- realicolo-pastorale da un lato e dal frazionamento contadino dall’altro, il parziale assetto mezzadrile introdotto nel Fucino, per quanto modesto, rappresentava senz’altro un passo avanti. Ma a parte i pur legittimi dubbi sulla razionalità del modello, erano tante e tali le carenze che l’accompagnavano da renderlo nei fatti scarsamente efficace rispetto alla sua stessa logica. L’ordinamento colonico, inoltre, era il meno adatto per rispondere alla forte domanda di terra e di lavoro che proveniva dal contadiname marsi- cano. Esso richiedeva un tipo di personale difficilmente reperibile in loco, tanto che nella quasi totalità — come già accaduto per il prosciugamento — lo si dovette far venire da fuori. Analogo discorso valeva per l’azienda in economia. La scarsa elasticità del mercato del lavoro, come per altre realtà del Mezzogiorno, fu dunque tra i motivi che imposero una conduzione mista del latifondo: accanto all’azienda-madre, gestita capitalisticamente, la mezzadria e soprattutto l’affitto.
Ai primi del Novecento, quando l’appoderamento era ormai giunto a conclusione, si contavano appena una cinquantina di mezzadrie, affidate in prevalenza a famiglie marchigiane, romagnole e teramane: una sorta di “aristocrazia contadina” che fungeva da “cintura di sicurezza” verso le pressioni della società locale. La massima parte delle terre, oltre i due terzi (8.769 ettari), era finita in affittanze (circa 8.000 allora i concessionari), il vero punctum dolens del regime fucense. Inizialmente anche per esse si prevedeva la misura di 20-25 ettari. Tutt’altra però fu la strada effettivamente seguita. L’area del bacinetto (2.000 ettari) venne affittata ai Tittoni, grossi mercanti romani.
Per i Torlonia si trattò del modo più facile di introitare denaro fresco senza sottoporsi direttamente ad impegni e spese di gestione. Ed altrettanto, sotto di loro, fecero i Tittoni: pagavano 80 lire ad ettaro e subaffittavano a 28025. Una linea di condotta, dunque, speculativa e finanziaria. Ma giocano un ruolo anche altre motivazioni. L’iniziale pri- vilegiamento degli estranei nel grande affitto fu tra le cause che alimentarono l’ostilità dell’oligarchia proprietaria del posto contro l’Eccellentissima Casa. Ben presto però, accortamente, il meccanismo venne esteso anche ai possidenti marsicani. Un motivo di malcontento si tramutava così in collante di stabilità ed alleanza. Le famiglie prescelte dai Torlonia, oltre a poter offrire le necessarie garanzie di solvibilità, erano quelle maggiormente influenti, di solito detentrici del potere quanto meno a livello locale, di cui essi volevano evidentemente assicurarsi il favore. Vengono in tal modo a stringersi rapporti sempre più stretti, in termini di cointeressenze e intermediazioni, tra il ‘principe’ e i maggiorenti della zona: una sorta di ‘società d’interessi’, che funge, anche in questo caso, da cuscinetto e da controllo rispetto alle istanze della gente comune. I grandi affittuari del Fucino, non diversamente dai classici gabellotti meridionali, si danno an- ch’essi alla pratica del subaffitto, con conseguente rapida frammentazione dei fondi. L’unità di riferimento nei contratti diventa la coppa, una misura locale corrispondente ad un ventesimo di ettaro. Il fenomeno investe, a partire dai secondi anni ottanta, persino le aree esterne al bacinetto, nelle quali per un certo tempo il criterio dell’ampiezza media, sia pure tra fortissimi sbalzi da luogo a luogo, era stato in qualche modo rispettato. Nel 1888-1889 le ditte intestatarie, stan
25 C. Letta, Memoria, cit., pp. 193-194. La giustificazione addotta dai sostenitori dei Torlonia per la mancata costruzione del mezzo migliaio di case coloniche — è interessante notarlo — era che il suolo non fosse “abbastanza assodato” (Gioacchino Lampani, Il lago Fucino e l ’Agro romano, Roma, 1881, p. 9).
Azienda modello o latifondo? 647
do ai registri padronali, sono poco più di 300; nel quinquennio 1905-1910 esse superano le 1.60026. Ma sotto questo gruppo si dipanavano poi le svariate migliaia di subconcessionari — piccoli contadini, mezzadri, pastori, ecc. — che formavano l’ampia base della piramide sociale. Nei contratti si faceva formalmente divieto di subaffittare, nei fatti però nessuno rispettava la norma. Già nei primi anni ottanta erano oltre 4.000 i fittavoli del Fucino; all’inizio del nuovo secolo — lo abbiamo visto — essi risultano raddoppiati.
A monte di queste perverse dinamiche vi era, con ogni evidenza, la condotta assentei- stica dei Torlonia. Il rapporto d’affitto già di per sé, tolta la contabilità del canone, denotava scarso impegno. Lasciarlo poi tranquillamente proliferare nei mille rivoli delle subconcessioni — una ‘negligenza’ di frequente denunciata dai loro stessi collaboratori — voleva dire di fatto (anche a prescindere dalle intenzioni) totale abbandono e disinteresse: un atteggiamento alla lunga nefasto per la stessa proprietà. Con riferimento soprattutto alla gestione e ai rapporti socioproduttivi, siamo di fronte ad un capitalismo agrario di vecchio stampo, la cui logica è ben lontana dal modello schumpeteriano dell’investimento a rischio per la valorizza
zione massima dei fattori di produzione. Più che alle moderne borghesie dell’Ottocento, i cui profili emergono sempre più nettamente grazie a recenti studi27, è all’antico patriziato romano, redditiero e gaudente, che per molti tratti appare ispirato il comportamento dei Torlonia. È sintomatico, d’altro canto, che una delle principali magagne che ad essi di continuo si rimprovera — non solo da coloro che ne subivano le dirette conseguenze, ma anche da osservatori qualunque — consistesse nella insufficiente manutenzione delle opere infrastrutturali: strade, canali di scolo, bonifiche e così via.
Il vertiginoso ingrossarsi del subaffitto — avviato, come si vede, molto prima del “biennio rosso” — era però anche il risultato di spinte difficilmente contenibili provenienti dal basso. Per un contadino della Marsica, il quale di solito non possedeva che minuscoli pezzi di terra sparsi qua e là, ottenere un lotto della conca fucense, quali che fossero le condizioni, costituiva comunque un passo avanti. Soprattutto nei primi anni, l’eccezionale fertilità del suolo, alimentando la speranza di “un grande guadagno con poco sforzo”, rende l’affitto una specie di gioco al lotto intorno al quale s’affollano in numero crescente i “contadini azzardosi”28. Ma la ressa continua, sotto la pressione de-
26 Salvatore De Filippis, Il Fucino e il suo prosciugamento, Città di Castello, 1893, p. 66; Adriano Pizzuti, Le affittanze agrarie nel Fucino prima della riforma agraria, Avezzano, 1953, p. 37; Guido Astuti, Vicende giurìdiche del Fucino, in Fucino cento anni, cit., p. 301. Dettagliate notizie sugli affitti, come su altri aspetti del Fucino, si trovano naturalmente in A tti della Giunta per la Inchiesta agraria sulle condizioni della classe agricola, Roma, 1884 (d’ora in avanti Inchiesta agraria), vol. XII, fase. I, pp. 299-306, e fase. II, pp. 375-379.27 Se ne può avere un quadro abbastanza rappresentativo, in riferimento soprattutto alla Neue Sozialgeschichte, dal volume collettaneo Borghesie europee dell’Ottocento, a cura di Jurgen Kocka, Venezia, Marsilio, 1989. Con riguardo ad alcuni scenari dell’Italia borghese tra Otto e Novecento, significativi anche i contributi di Paolo Macry, Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli, Torino, Einaudi, 1988, e di Alberto M. Banti, Terra e denaro. Una borghesia padana dell’Ottocento, Venezia, Marsilio, 1989, su cui si veda uno stimolante dibattito tra A. Lyttelton, P. Pezzino, B. Salvemini e L. Scariffa, in “Meridiana”, 1989, n. 6, pp. 231-259. Utili spunti di riflessione sullo stesso tema si ricavano anche dai contributi (per gli argomenti qui trattati, specialmente da quello di Barone) raccolti nel numero monografico che questa stessa rivista (“Meridiana”, 1991, n. 11-12) ha dedicato alle Imprese. Un resoconto sullo stato del dibattito storiografico (all’epoca), in merito appunto a Borghesie, ceti medi, professioni, si ricava anche dagli interventi di Jurgen Kocka, Paolo Macry, Raffaele Romanelli e Mariuccia Salvati, in “Passato e presente”, 1990, n. 22, pp. 21-48.28 Inchiesta agraria, p. 299.
648 Costantino Felice
mografica e la disoccupazione di ritorno (conclusa l’opera di prosciugamento), anche in seguito, nonostante la caduta di rendimento e l’inasprirsi delle clausole contrattuali. In effetti le terre del Fucino rappresentavano per molti 1’“unico mezzo di lavoro e di esistenza”29. È vero che in genere, accanto all’agognata coppa dell’alveo, continuavano a sussistere i tradizionali supporti dell’autoconsumo contadino: qualche piccolo possesso nell’area circonfucense, il minuto bestiame d’uso familiare, saltuari lavoretti nei boschi (fasciname, legnatico, ecc.). Ma si trattava pur sempre di forme integrative molto esili e precarie, che peraltro l’avanzare di moderne dinamiche produttive metteva inesorabilmente fuori gioco. Il frazionamento pulviscolare — come le migrazioni periodiche e i nuovi dissodamenti — era dunque un modo di sfuggire alla “trappola malthu- siana”. Che fosse questo il nodo principale della questione fucense già Franchetti lo constatava durante il viaggio dell’autunno 1873:[...] dalla divisione della proprietà — egli scriveva — mi pare di poter concludere che non è la gran proprietà, non l’inerzia dei contadini, non il cattivo regime delle acque, ma bensì l’eccesso del numero della popolazione in confronto della quantità delle terre coltivabili, che cagiona la miseria dei contadini [...]. E ciò mi è stato confermato dal vedere nell’Avezzanese migliorate le condizioni per i contadini dei contratti di fitto, dopo l’essiccamento del Fucino30.
Solo di fronte ad un allargamento della forbice popolazione-risorse, si poteva spie
gare il fatto sconcertante — rilevato da Letta al tempo dell’Inchiesta agraria — di masse contadine le quali di continuo si lamentavano dei “patti gravosi” cui dovevano sottostare, ma che poi, al momento del rinnovo degli affitti, “si gitta[va]no a corpo perduto, facendo offerte sempre maggiori, pur di dirsi affittuari del Fucino”31. L’abnorme moltiplicarsi dei subaffitti però, anziché risolvere o attenuare i problemi da cui nasceva, li esaspera ulteriormente. Sul piano sociale si dilata il disagio. Il costo dei fitti aumenta, mentre diminuisce la produttività dei suoli. Gli effetti di questa divaricazione si scaricano — è ovvio — sull’ultimo anello, il più debole, della catena di concessioni e subconcessioni. Inevitabilmente migliaia di affittuari finiscono sommersi dai debiti32. Quanto mai pesanti, come evidenziato da un po’ tutta la letteratura sul Fucino (non solo di sinistra), erano peraltro le condizioni contrattuali e le forme di riscossione: brevità del rapporto, pagamento dell’estaglio prima del raccolto (pena il divieto di esportare i prodotti), obbligo di corrisponderlo in moneta o con l’aggio del 5-8 per cento, oltre ad una serie di altre soffocanti clausole sull’uso delle infrastrutture viarie e delle macchine agricole.
I problemi si complicano anche sotto l’aspetto giuridico. Già dagli anni ottanta, infatti, inizia l’abitudine di ‘vendere’ ed ‘acquistare’ i fitti, o anche di trasmetterseli in eredità. Della “buonuscita” si faceva regolare pattuizione di compravendita a prezzi equivalenti al valore d’acquisto. Le terre del
29 Così scrisse il giornale locale “Umbrone” (21 aprile 1886) commentando una sassaiola tra pescinesi e sambene- dettesi che si contendevano l’affitto del bacinetto.30 L. Franchetti, Condizioni economiche, cit., p. 173.31 C. Letta, Memoria, cit., p. 193.32 Negli anni settanta il debito dei subaffittuari dei Tittoni ammontava ad oltre un milione, mentre a Luco, per esempio, la rendita di un ettaro di terreno fucense scendeva da 500 a 200 lire (C. Letta, Memoria, cit., p. 122). In seguito l’indebitamento crescerà sia verso i Torlonia che i grandi affittuari, tanto che nel triennio 1883-1885 si registrano nel Fucino 974 condanne di esproprio per una somma complessiva di 581.652 lire. Vincenzo Cerri, Una risposta, s.d. (ma 1886), p. 9, in replica al direttore dell’ “Umbrone” .
Azienda modello o latifondo? 649
Fucino diventano di fatto commerciabili come normali possedimenti. A seguito di questa prassi insorge nella coscienza comune — per dirla con le caute parole di un giurista — la tendenza ad assimilare la “alienazione dei poteri di godimento” , spettanti all’affittuario, alla “alienazione della proprietà”33. È uno dei motivi che da parte delle popolazioni ripuarie — ma anche in sede politica e parlamentare — verrà accampato per dare fondamento all’esproprio. Ma gli effetti di questo sistema dovevano risentirsi soprattutto sul piano produttivo. Nella prospettiva del massimo guadagno col minimo di capitali e di lavoro, il rapporto d’affitto per sua natura induceva ad un atteggiamento predatorio verso la terra. Né il concedente né il concessionario erano interessati ad investire in capitale fisso per migliorare e valorizzare il bene fondiario. L’indirizzo meglio confacente a tale logica era ovviamente quello cerealicolo. Produrre grano richiedeva minori spese e fatica che avventurarsi in colture nuove ed impegnative. Anche dal lato del reddito per un certo tempo, almeno fino a crisi agraria inoltrata, ci si sentiva più sicuri ed avvantaggiati. Di qui l’insistenza su questa strada, anche quando l’antico obiettivo del “granaio di Roma” è del tutto sfumato. Per fare largo alla cerealicoltura, ancora negli anni ottanta, i Torlonia non disdegnano di abbattere vigneti e mandorleti34. Contro un simile regime agrario, che sottoutilizza i terreni impoverendone la fertilità, si esprimono i commissari dell’Inchiesta agraria, per i quali sarebbe stato invece necessario, oltre al completamento della bonifica, “trasformare il sistema di coltura e di conduzione, mediante l’accrescimento del bestiame,
la costruzione di case coloniche, il prolungamento dei periodi locativi, e l’impianto di nuove coltivazioni”35. Consigli poco ascoltati però, tanto che nel 1893 risultano destinati a frumento oltre 10.000 ettari.
La svolta tra Ottocento e Novecento
Una prima virata, dalla tradizionale impostazione preminentemente redditiera ad una logica più attenta alle ragioni dell’imprenditorialità, con propensione ad innesti di tipo industriale, si verifica dietro la spinta della grande recessione. Ne sono protagonisti l’amministratore Lorenzo Botti, che a metà anni ottanta introduce forti elementi di razionalizzazione e dinamismo, e un altro personaggio, Ludovico Fusco, il quale sulla base di precedenti esperienze in Campania e nel Lazio giunge ad Avezzano con grandi progetti di bieticoltura e distillerie. I guadagni che i Torlonia traevano dal Fucino, in confronto al periodo anteriore alla crisi, stavano registrando un vero e proprio tracollo, giungendo a ridursi — secondo alcuni calcoli36 — di quasi due terzi. Partendo da questi dati negativi, Botti costruisce un piano di rilancio che si muove su più versanti. Suoi, anzitutto, sono l’introduzione e il perfezionamento della mezzadria, cui destina una superficie agronomicamente tra le meno felici, suddividendola in 36 poderi tra i 25 e i 50 ettari, che cerca di dotare di tutti i requisiti fondiari (casa, bestiame, attrezzi) con cui il modello si era affermato in Toscana e nelle Marche. Ma soprattutto interviene sugli ordinamenti colturali, secondo linee in fondo comuni ad altre zone d’Italia, modifi-
33 G. Astuti, Vicende giuridiche del Fucino, cit., p. 302; A. Pizzuti, Le affittanze, cit., p. 38.34 Vincenzo Cerri, Il dissidio tra il principe Torlonia e la Morsica, Avezzano, 1882, p. 16. Per i dati sull’incremento della produzione granaria, L. Botti, Per la storia, cit., p. XXXIV.35 Inchiesta agraria, fase. I, p. 303.36 V. Cerri, Una risposta, cit., p. 9.
650 Costantino Felice
cando le tradizionali rotazioni con un massiccio uso delle foraggere37. Ciò gli consente anche di sviluppare notevolmente la zootecnia, tanto in direzione dell’allevamento che della concimazione. Nei comuni ripuari dal 1866 al 1889 il patrimonio zootecnico si raddoppia: i bovini passano da 2.482 a 4.423, le pecore da 15.077 a 23.638 e i suini da 1.509 a 2.631. Viene intensificata la coltivazione delle patate, in buona quantità esportate a Roma, mentre in ambienti illuminati si discute sull’impianto di cartiere e di silos per stoppie e pioppi. Ancora non siamo, certo, all’affermazione di un indirizzo specialistico ben definito: se tramonta il mito del “granaio di Roma”, si continuano a chiedere sgravi fiscali e tariffe doganali per la grani- coltura; ma i segnali di un ammodernamento in senso capitalistico, per quanto impastato di vecchio spirito paternalistico, appaiono già netti. Il Fucino viene fatto oggetto di particolare attenzione da parte degli economisti, assurgendo ad esempio di “redenzione agricola” per l’intero paese. Senz’altro positivi, in ogni caso, sono i riflessi di questa situazione sulla complessiva economia della zona, se sono attendibili i calcoli secondo cui, dei quasi quattro milioni e mezzo netti che ogni anno fruttavano i possedimenti del Fucino, solo uno finiva ai proprietari, mentre il resto andava ad incrementare i redditi di quanti in un modo o nell’altro — mezzadri, affittuari, braccianti, ecc. — vi lavoravano sopra38.
Più vivaci dinamismi, d’altro canto, investivano in quegli anni un po’ tutti gli ambienti sociali ed economici della zona. Lo attestava, tra l’altro, il sorgere di istituti bancari. Nell’autunno del 1883 era stata fondata la Banca popolare marsicana, la quale,
nonostante le difficoltà iniziali, andava man mano consolidandosi. E a fine 1887 veniva attivata, a Gioia dei Marsi, una Banca popolare mandamentale il cui scopo dichiarato era di “agevolare e diffondere [...] il prestito a condizioni possibili” , oltre che di “educare al risparmio e alla previdenza”39. Anch’essa ben presto si attestava su un giro d’affari di tutto rispetto, che nel 1894 toccava i 12 milioni di lire. Naturalmente a promuovere e controllare tali organismi erano sempre i notabili del posto; non mancavano tuttavia aperture tanto verso gli strati popolari (le azioni della Banca marsicana, per esempio, si potevano acquistare a rate) che in direzione dell’entourage torloniano, sebbene quest’ultimo operasse soprattutto attraverso la Banca romana, cui significativamente era stata appaltata la riscossione delle imposte su tutto il Fucino.
La vera svolta nel senso dell’industrializzazione, in sintonia con il ciclo espansivo dell’economia nazionale, si registra ai primi del Novecento. Nel 1895, deceduto immaturamente Botti, rimasto pur sempre legato ad una prospettiva agricola, i nuovi agenti Eugenio Paradisi e Angelo De Rossi cominciano a prestare maggiore attenzione a settori — sfruttamento dei minerali e produzione idroelettrica — che potrebbero connotare in modo nuovo l’economia della zona. Ma soprattutto sono significative le modernizzazioni fondiarie. Nel 1903, oltre alla circonvallazione, 337 km di strade rotabili dividono geometricamente il bacino. I canali irrigatori raggiungono una percorrenza di 300 km circa. Tra prati artificiali e naturali il Fucino produce oltre 170.000 quintali di foraggio all’anno. Il bestiame, nella sola azienda gestita in proprio, risulta costituito
37 L. Botti, Per la storia cit., pp. VI e XXXVIII. Per il quadro nazionale, A. Cormio, Note sulla crisi agraria, cit., pp. 554-555; Gianni Toniolo, Storia economica dell’Italia liberale. 1850-1918, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 121, e, con specifico riferimento al Tavoliere pugliese, L. D ’Antone, Medici, ingegneri, agronomi, cit., pp. 107 sgg.38 E. Celani, La bonifica del Fucino, cit., pp. 7 e 16.39 R. Colapietra, Fucino ieri, cit., pp. 45-46 e 67.
Azienda modello o latifondo? 651
di 605 bovini, 209 equini, 388 suini, 4.400 ovini, tutti di buona qualità. Si fabbricano i formaggi grana e gorgonzola. Il personale occupato stabilmente (fattori, caporali, ver- gari, guardie, ecc.) raggiunge le 136 unità, mentre i contadini con un “lavoro remunerativo” sarebbero non meno di 7.000. La stessa cerealicoltura, sempre in funzione preminente, tende ora a specializzarsi verso un grano da semente molto qualificato — il grano fucense — la cui commercializzazione si presenta altamente remunerativa. Sulla base di questi dati, c’era allora chi — in sottesa polemica tanto con l’inerzia dello stato che con l’assenteismo degli agrari — giudicava il Fucino “la più grande azienda agraria italiana”40. La maggiore novità è tuttavia rappresentata dalla barbabietola: non tanto quella da foraggio, che pure rendeva 800-1.000 quintali ad ettaro, quanto soprattutto quella da zucchero, la cui resa (350-500 quintali ad ettaro) risultava anch’essa assai promettente. Il definitivo privilegiamento accordato a questa pianta (rispetto alla stessa patata), in quanto prodotto più costante e sicuro nel rendimento, segna finalmente l’inizio di quell’integrazione tra agricoltura e industria che da sempre era negli auspici di quanti guardavano con intelligenza alle sorti del Fucino. Ancora una volta, però, protagonista dell’importante passaggio è il capitale esterno alla regione. L’espansione della bietola avviene infatti su intervento della Società italo-tedesca che ne contratta, a condizioni spesso vessatorie ma di sicura impronta industriale (con personale e macchinari tedeschi), quantitativi e modalità di consegna. Essa ottiene dai Torlonia l’intero bacinetto per impiantare in loco fabbriche e raf
finerie, che vengono attivate nell’estate 1903 (in precedenza la barbabietola veniva inviata, per la lavorazione, negli zuccherifici di Rieti e Monterotondo); ed in conformità a questa nuova realtà, dai forti agganci romani, modifica il nome in Società romana zuccheri.
Effetti di dinamismo si registrano anche dal lato politico e sociale. Le amministrazioni comunali, specialmente ad Avezzano e negli altri centri maggiori, intervengono con maggiore fattività nei settori dei servizi e dell’arredo urbano: si sistemano strade, le piazze vengono abbellite con fontane e giardini, arriva l’illuminazione elettrica, si costruiscono acquedotti, nascono iniziative nel campo della sanità e dell’igiene. Si sviluppano i primi conflitti sindacali tra la Romana Zuccheri e i bieticoltori. Si consolida la rete dell’associazionismo, che nella zona già in passato aveva dato segni di vitalità (nel 1888 si potevano contare quattro società operaie sulle sponde dell’ex lago). Il movimento socialista, alimentandosi del nuovo “soffio di vita industriale” (per dirla con le parole di un suo organo di stampa), va assumendo le prime forme organizzate: in leghe, cooperative di consumo, circoli, sezioni di partito. Un quadro, insomma, alquanto mosso e ricco di fermenti: molto distante, in ogni caso, da quello statico ed uniforme che emerge dalle desolate pagine di Silone41. Man mano che passa il tempo la prospettiva industriale segna nuove tappe. A Lecce nei Marsi nel 1905, su iniziativa della Società italiana per la fabbricazione dell’alluminio, viene attivata una miniera di bauxite, collegata a valle con la teleferica. Tre anni dopo, con sullo sfondo sempre Torlonia e la Banca popolare, sorge la Società marsicana per la fabbri-
40 Così suonava il titolo di un articolo, a firma di C. Mancini, pubblicato su “Il Messaggero”, 15 aprile 1903, da cui sono riprese le notizie riportate nel testo.41 Per un approccio a Silone, da quest’ottica, C. Felice, Una regione in “idea”: miti e stereotipi dell’Abruzzo, in “Cultura e scuola”, 1991, n. 118, pp. 102-103. Il periodico socialista cui poco prima si fa riferimento nel testo è “Avvenire”, 18 ottobre 1903.
652 Costantino Felice
cazione di prodotti chimici, colori e concimi. Come in altre aree dell’Abruzzo e Molise, è operante tutta quella serie di esercizi — pastifici, segherie, fornaci, ecc. — attraverso i quali continua ad esprimersi il vivace e fervido universo dell’artigianato e delle manifatture locali; ma non manca neppure qualche opificio che dalla fase protoindustriale, sfruttando l’energia elettrica e dotandosi di adeguati macchinari, tenta di proiettarsi nel sistema di fabbrica42. Comincia intanto a prendere corpo l’indirizzo turistico. La carovana di gitanti che nell’agosto 1909, con grande lancio pubblicitario e folta partecipazione di giornalisti ed uomini politici, muove da Roma “alla scoperta dell’Abruzzo”, al di là dei suoi aspetti pittoreschi e tardodecadenti, rappresenta anche per il Fucino — sua tappa fondamentale — un momento importante di valorizzazione. Il principale promotore di quella kermesse, il pubblicista e pedagogista d’orientamento socialista Emidio Agostinone, l’anno prima aveva pubblicato un volume, Il Fucino, incentrato proprio sulla illustrazione ed esaltazione dei “tesori” archeologici, paesaggistici ed escursionistici della zona.
Persistevano, tuttavia, molteplici fattori di ritardo. Se si osserva l’andamento economico del Principato tra il 1910 e il 1914 — primo periodo per il quale disponiamo di un dettagliato resoconto43 —, il quadro molto differenziato per forme di conduzione e livelli produttivi, rilevato finora, emerge assai nettamente. Per un prospetto dell’indicatore maggiormente significativo da questo punto di vista si veda la tabella 1.
La parte del ‘latifondo’ che rendeva meglio era quella condotta in proprio. Se si considera che nello stesso periodo la rendita lorda passa qui da 938.592 lire a 1.010.843, con un incremento del 7,7 per cento, mentre quella netta, come si vede, cresce del 58,5 per cento, appare evidente l’altissimo profitto. Esso era dovuto al forte aumento degli introiti (essenzialmente per la rapida crescita dei prezzi agricoli), di contro ad una diminuzione delle spese, sia pure di poco. Il periodo d’oro — come per l’agricoltura nazionale — è il biennio 1911-1912, quando l’utile giunge a superare le 300.000 lire. Meno buono, ma pur sempre positivo, l’andamento del settore a colonia, dove le 142 lire ad ettaro del 1910 diventano 188 nel 1914, con un incremento del 32,4 per cento. In coda figura il sistema dell’affittanza, sempre di gran lunga il più esteso (quasi 10.000 ettari), la cui rendita unitaria aumenta da 132 a 150 lire (13,6 per cento). L’affitto dunque continuava ad essere il tallone d’Achille del Principato, anche a volerlo considerare freddamente dal solo lato contabile.
Questi dati rimandavano, però, a questioni ben più complesse e sostanziali. I risultati economici del Fucino, compresi quelli delle iniziative più moderne, erano in realtà di molto inferiori alle aspettative. Lo zuccherificio nel 1912 occupava 850 persone, assai meno delle quasi 2.000 preventivate (peraltro molte erano giunte da fuori, soprattutto per i lavori a più alto contenuto tecnologico). Produceva 60.000 quintali di zucchero, esportato in gran parte nell’Italia meridionale per la fornitura dell’esercito. L’annesso
42 R. Colapietra, Fucino ieri, cit., pp. 86-87 e 90. Per un quadro complessivo, C. Felice, Protoindustria o pluriatti- vità rurale? La "deindustrializzazione” dei secondo Ottocento in Abruzzo e Molise, “Trimestre”, 1990, nn. 3-4, pp. 273-309, e Id., Dinamiche di sviluppo e gerarchie territoriali: i censimenti industriali del primo Novecento, “Abruzzo contemporaneo”, 1991, n. 1, pp. 13-46.43 Si tratta del dattiloscritto La gestione del principato del Fucino nei due periodi quinquennali: l ’uno precedente al terremoto (anni 1910-1914) e l ’altro posteriore al terremoto (anni 1915-1919) dell’amministratore Bernardo Vincenti (in seguito Relazione Vincenti), che si trova in Archivio centrale dello Stato (d’ora in poi Acs), Archivio Torlo- nia, b. 203.
Azienda modello o latifondo? 653
opificio per l’alcol ne impiegava appena una quarantina. Lo smercio dei prodotti chimici quasi non superava, per quantità e volume d’affari, quello effettuato verso Roma dalle classiche fornaci di laterizi funzionanti a Tagliacozzo e a Magliano44. Un “soffio industriale” , quindi, alla fin fine piuttosto flebile. Le difficoltà ovviamente si ripercuotevano soprattutto sui ceti subalterni, provocando tensioni sul piano socio-politico ed ulteriori contraddizioni su quello economico. Nel febbraio del 1910, in vista del progetto governativo di aumento della tassa di fabbricazione sullo zucchero, la Romana zuccheri chiede una corrispondente diminuzione del prezzo delle bietole, già “non ancora abbastanza remunerativo” per i produttori, a meno di non dover decurtare — minaccia — le mercedi degli operai45. Di fronte dunque a probabili riduzioni del profitto, se ne rovesciano i costi sugli strati più deboli, i lavoratori della fabbrica e i contadini. È in tale contesto che nel Fucino si sviluppano le forme più avanzate, quanto meno in ambito abruzzese-molisano, di lotta sindacale e politica. Il movimento socialista, nonostante i contrasti interni, si consolida sul piano delle organizzazioni economiche, come accennato, grazie al proliferare di cooperative e leghe. Su questo terreno, e naturalmente in competizione con i “sovversivi”, vistosi risultati consegue anche il
cooperativismo di matrice cattolica46. E soprattutto prendono corpo le prime grandi vertenze. Negli anni 1910-1911 i bieticoltori diventano principali protagonisti di una serie di agitazioni contro la Romana zuccheri. Si chiede anzitutto l’aumento del prezzo delle bietole, ma vi sono anche altri obiettivi: contratto unico, eliminazione dei gabellotti, forme di pesa e di consegna meno sfavorevoli, trasferimento della direzione aziendale ad Avezzano, impianto di altri zuccherifici. Per le incertezze delle sue espressioni politiche, il movimento alla fine rifluisce, senza ottenere apprezzabili risultati; esso tuttavia aveva mostrato inediti livelli di consapevolezza e mobilitazione.
Neppure l’azienda gestita in proprio se la passava granché bene. Pare che la rendita proprietaria, per le tasse e gli effetti dell’emigrazione, si fosse ridotta del 4 per cento in questo periodo47. Anche qui il peso del fisco — l’imposta di ricchezza mobile e persino la tassa della Camera di commercio — veniva scaricato sui lavoratori. I Torlonia, inoltre, pagavano salari dimezzati rispetto a quelli normalmente praticati altrove. Per tali circostanze i braccianti di Ortucchio, nel marzo 1913, scendono in sciopero chiedendo una “più equa mercede” . L’agitazione, prolungatasi per oltre due mesi, si conclude questa volta con un sostanziale successo. Il controllo complessivo sui meccanismi dell’e-
44 “Gazzetta Commerciale”, 31 ottobre 1912.45 Così si disse in un comizio di protesta organizzato il 24 febbraio 1910 da elementi del “partito Torlonia” (“Il Piccolo Marsicano”, 28 febbraio 1910).46 In un articolo su “La Nuova Marsica” (15 aprile 1911), dal significativo titolo Un uomo di volontà. Democratici, imparate da lui, si ricordavano le seguenti realizzazioni del parroco di Tagliacozzo Alessandro Paoluzi: una cassa rurale, un asilo infantile e diversi rami dell’Azione cattolica. In pochi mesi poi, stando alle informazioni di un giornale locale, “Il Popolo Marso” (15 gennaio 1914), quest’attività diventa assai più consistente: 7 casse rurali, 11 circoli giovanili e il Credito Marso. Lo stesso giornale nell’estate di quell’anno (15 luglio 1914) forniva un quadro complessivo dell’organizzazione cattolica nella Marsica: 10 casse rurali, 9 società cattoliche di Mutuo soccorso, le unioni professionali di Pescina e di Magliano', l’Unione agricola di Corcumello, l’assicurazione bovini e la cooperativa di consumo a Tagliacozzo, 3 asili infantili, 40 circoli giovanili maschili e 3 femminili per complessivi 11.000 organizzati. Ma, per una puntuale ricostruzione degli aspetti sociali, sindacali e politici di questo periodo, cfr. ancora R. Colapietra, Fucino ieri, cit., pp. 81-116.47 “Il Popolo Marso”, 15 aprile 1914.
654 Costantino Felice
conomia, e quindi anche l’egemonia sulla società civile, in età giolittiana restano comunque saldamente in mano ai Torlonia e al notabilato locale, come dimostrano i risultati delle elezioni generali nell’ottobre 1913, che vedono trionfare proprio un giovane rampollo del casato, Giovanni Torlonia, e l’ingegnere ed armentario Erminio Sipari, a scapito dei socialisti Ernesto Trapanese e Luigi Vidimari. Il devastante terremoto che il 13 gennaio 1915 si abbatte sulla Marsica arreca ingenti danni anche alle strutture fondiarie del Fucino: strade e ponti in buona parte distrutti, fabbricati rasi al suolo, il sistema di canalizzazione assai compromesso, gli impianti idroelettrici resi inservibili. Per la sola riparazione parziale di questi ultimi e la riattivazione del congegno idrovoro del bacinetto occorsero — secondo calcoli al 31 dicembre 1919 — oltre tre milioni di lire. Nel contesto della ricostruzione, la forbice tra azienda in conduzione diretta e colonie da una parte e le affittanze dall’altra continua a divaricarsi. Si veda, per un confronto con il quinquennio precedente, l’andamento della rendita netta, per i tre comparti, negli anni fino al 1919 (tabella 2).
I forti incrementi dell’azienda in proprio e delle colonie sono dovuti — ripete più volte lo stesso Vincenti — soprattutto ai buoni raccolti e all’innalzamento dei prezzi agricoli; nel primo caso anche al consistente abbassamento dei costi di manodopera per il massiccio impiego dei prigionieri di guerra. Ma la causa della sproporzione rispetto all’affitto rimane pur sempre la persistente arretratezza di quest’ultimo, che anzi col tempo si va aggravando. Le dinamiche economiche del Principato, con le loro forti differenziazioni interne, appaiono evidenti anche da un raffronto tra i due quinquenni presi complessivamente. Nel primo la rendita media per ettaro dell’azienda in economia risul
ta di 195 lire, nel secondo di 467; per le colonie si passa da 175 a 404 lire; per gli affitti, invece, si registra addirittura una diminuzione: da 144 lire a 132. Tale settore peggiora dunque non solo in termini relativi, ma anche in assoluto. Nell’insieme tuttavia i guadagni netti del Principato sono crescenti, come si può desumere dalla tabella 3.
All’indomani della guerra, stando alle notizie fornite da un giornale locale48, il Fucino complessivamente produce circa 200.000 quintali di grano, 600.000 di barbabietole,300.000 di patate, 100.000 di legumi e300.000 di fieno: una pluralità di indirizzi, come si vede, che denota il persistere di un netto predominio dell’attività agricola, il cui sviluppo in senso industriale e capitalistico stentava a prendere forme definitive. Un mezzo migliaio di lavoratori venivano occupati in impianti di segherie, mattoni e forni: “esercizi” , cioè, altamente impregnati di ruralità. La stessa Romana zuccheri coltivava in proprio 150 ettari, mentre subaffittava i2.000 del bacinetto, mostrando in tal modo di essersi pienamente adagiata sulle perverse logiche fucensi. Un piano di ammodernamento degli impianti e di valorizzazione delle risorse (tanto agrarie che idriche), organico e molto ambizioso, in questo periodo venne per la verità elaborato. Ne fu redattore l’ingegnere Angelo Omodeo, uno dei tecnici allora più prestigiosi. Partendo da alcune contestazioni di fatto circa l’inadeguatezza delle vecchie strutture, egli proponeva di costruire un altro emissario su terreni sicuri e a quota più bassa che consentisse, grazie ad un salto di 100 metri, di produrre energia elettrica per una potenza annua di circa11.000 Hp, creando anche le condizioni per irrigare la valle del Liri. Si sarebbe raggiunto in tal modo il “duplice scopo di assicurare stabilmente la bonifica e di utilizzare le acque per l’elettro-produzione, moderando i
48 « Il Domani”, 31 luglio e 18 agosto 1919.
Azienda modello o latifondo? 655
deflussi con serbatoi di stagione e garantendo la regolarità agli utenti inferiori con un serbatoio di reintegrazione”49. Una visione tipica, insomma, di quell’entourage nittiano che nei primi decenni del secolo, col favore di settori del socialismo riformista, si era andato coagulando attorno all’idea di poter sfruttare le risorse idroelettriche dei bacini appenninici per uno sviluppo combinato di agricoltura e industria nel Mezzogiorno50. Il disegno incontrò, però, forti opposizioni (oltre alle tiepidezze degli stessi Torlonia): da parte del Genio civile dell’Aquila, da parte di altri tecnici che pure presentarono delle proposte e soprattutto di società tecnico-finanziarie, la Sme in particolare, direttamente o indirettamente interessate al controllo delle acque in quella zona. Problemi insorsero anche per la classifica dell’opera nei gradi della bonifica: i Torlonia avrebbero voluto la prima categoria per ottenere il massimo di sovvenzioni dallo stato. Alla fine venne concessa la seconda, che per essi comportava oneri assai più gravosi. Le resistenze sostanziali, come al solito, si trasformarono in cavilli burocratici. Così il progetto finì con l’arenarsi in un continuo andirivieni tra le varie commissioni ministeriali e tra una proroga e l’altra dell’inizio dei lavori. Di esso si continuerà a parlare, come avremo modo di constatare, fino agli anni trenta; di fatto però non vedrà mai la luce.
A causa delle perduranti arretratezze, negli anni del dopoguerra la situazione, dato il generale inasprirsi dello scontro sociale e politico, diventa a più riprese esplosiva, con invasioni di terre, picchettamenti, conflitti a fuoco. Per la prima volta nella storia del Fucino i rapporti di forza sembrano sbilanciar
si a favore dei fittavoli e degli altri lavoratori della terra. Per i Torlonia sono tempi duri. “Il tenimento del Fucino — scriveva Vincenti nel citato rendiconto — nelle attuali condizioni è, purtroppo, quanto di meno redditizio e di più pericoloso si possa immaginare nei riguardi della tutela e difesa del diritto di proprietà.” La gran parte di esso, quella gestita sotto forma di piccolo affitto, produceva ormai — lo abbiamo visto — scarsissimo profitto. Nonostante le affittanze rappresentassero per i Torlonia il fattore di reddito che maggiormente andava modificato, recenti disposizioni legislative rendevano invariabile, o comunque suscettibile solo di aumenti lievissimi, il canone di locazione. A giudizio dello zelante Vincenti, il valore medio unitario degli estagli, per essere almeno in parte aggiornato sull’andamento congiunturale, avrebbe dovuto essere triplicato. Ma non era la caduta degli introiti il guaio peggiore. La minaccia più grave proveniva dall’attacco al diritto di proprietà. L’inveterata abitudine di ‘vendere’ il subaffitto, ingenerando la convinzione di poter disporre liberamente delle terre, aveva creato forti resistenze ad ogni incremento del canone, mentre si era disposti a pagare qualunque cifra (fino a 4.000 lire ad ettaro!) pur di entrare in possesso di una subconcessione. “Per la propaganda sovversiva e per la insipienza dei governanti”, si andava generalizzando la convinzione — continuava allarmato Vincenti — che prima o poi ai contadini sarebbe stato “assegnato il terreno singolarmente posseduto” . L’opposizione agli aumenti, anche a quelli consentiti per legge (15 per cento), veniva quindi vista dalla proprietà come “preludio di ben più gravi conseguenze future” .
49 Angelo Omodeo-Francesco Pacelli, La bonifica del Fucino e l’utilizzazione dell’alto Liti. Memoria per i Principi Giovanni e Carlo Torlonia, Roma, 1921, p. 32. Se ne può vedere copia in Acs, Archivio Torlonia, b. 203.50 Cfr. soprattutto Giuseppe Barone, Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica nell’Italia contemporanea, Torino, Einaudi, 1986; L. D ’Antone, Tecnici e progetti, cit., p. 133. Quanto ai rapporti tra industriali elettrici, stato ed uso delle acque, sempre interessanti restano anche le notazioni di Teresa Isenburg, Acque e Stato. Energia, bonifiche, irrigazioni in Italia fra 1930 e 1950, Milano, Angeli, 1981.
656 Costantino Felice
L’indebitamento dei fittavoli, cresciuto a dismisura negli anni prebellici, nel dopoguerra era andato progressivamente riducendosi, per una “maggiore cura e disciplina” nelle riscossioni, ma forse anche per questo alleggerimento dell’estaglio dovuto al mutato rapporto di forze. Esso tuttavia restava ancora consistente (997.000 lire nel 1918); negli ultimi tempi tendeva anzi di nuovo a crescere. Contro gli affittuari morosi l’amministrazione cercava di difendersi a colpi di disdette: se ne contavano 6.700 al 31 maggio 1921, per non dire delle espulsioni senza alcun preavviso. Nello stesso tempo, mentre lo smantellamento dei gabellotti restava lettera morta, essa procedeva di fatto a nuove concessioni particellari, tanto che gli affittuari in poco tempo quasi si raddoppiano (da 8.000 a 15.000). Anche nel clima infuocato del “biennio rosso” , d’altro canto, le condizioni contrattuali conservano pressoché intatta la loro durezza a scapito dei concessionari. Dalla proprietà si guardava all’ammontare del loro indebitamento quasi con impotenza. Non avrebbe dato frutti, per l’altissimo numero di casi e per le lentezze giudiziarie, neppure il ricorso massiccio a vie legali.
Posto — si chiedeva sgomento Vincenti — che gli affittuari si rendano in gran parte morosi, o che diventino tali nella loro totalità, o quasi, come si farà a perseguire, praticamente, a via di uscieri, di citazioni, di liti e di sentenze, tante persone oggi protette dall’abusato manto del lavoratore e favorite dai lunghi notori riposi della magistratura durante le more degli interminabili rispettivi giudizi?
Ma ormai venivano consumati — egli incalzava ancora — “soprusi, abusi e reati” che per le loro implicazioni giuridiche e politiche costituivano fatti ben più gravi di un
mancato pagamento di estaglio. Se finora il diritto di proprietà nel Fucino non era stato intaccato lo si doveva, secondo questo solerte amministratore, ad una “certa energica resistenza” opposta alle invasioni e alla previdente distribuzione di terre ad una cooperativa di combattenti, guardati con benevolenza in funzione antisocialista e antipopolare. Ma chi poteva garantire per il futuro? Il Principato del Fucino, costretto per ora dalla pressione popolare e da vincoli legislativi a doversi accontentare di un basso reddito, “domani forse [sarebbe stato] soggetto ad usurpazioni illegali per atti d’imperio delle numerose masse lavoratrici locali” .
Vincenti concludeva il suo fosco quadro con pennellate negative anche sulla mezzadria e l’azienda in proprio. Nel primo caso, “salvo qualche opportuno ritocco del patto colonico”, le cose andavano abbastanza bene, ma occorrevano ancora ulteriori ingenti spese per il ripristino completo delle unità poderali dopo le distruzioni del terremoto. Per l’azienda in economia, lavorata con “squadre di operai lautamente retribuiti e di scarsa potenzialità produttiva” , si lamentava il progressivo e rapido assottigliarsi dei guadagni, non più in grado di garantire l’aumento di quelli medi globali. Persino il bestiame, cresciuto nei poderi colonici dove continuava ad essere di grande utilità, qui risultava in passivo e forte diminuzione. Per uscire da questa situazione già grave, ma che si prospettava ancora più tetra per il futuro, Vincenti suggeriva due possibili vie: la concessione in enfiteusi di piccoli lotti onde “pacificare gli animi dei lavoratori” ; la trasformazione della proprietà in “Società anonima [...] per una conduzione diretta, sociale e collettiva”51. Con questa seconda ipotesi i Torlonia, oltre a compiere “opera saggia e previdente”, avrebbe potuto con più decisio
51 In un documento non firmato, ma che sembra uscito anch’esso dalla penna di Vincenti, si suggerisce di rinunciare alla conduzione diretta delle aziende di Via Nova e di Strada 30 per darle in “affitto di piccole quote direttamente agli agricoltori sprovvisti di terre o a cooperative ben disciplinate”, oppure per affittarle integralmente ad “una
Azienda modello o latifondo? 657
ne incamminarsi sulla strada di una “moderna industrializzazione agricola” .
In realtà, quando Vincenti forniva queste indicazioni, nell’ottobre del 1920, il movimento socialista, dal quale si riteneva provenissero i pericoli paventati, era già in pieno riflusso. All’interno dello schieramento anti- torlonia vi erano differenze di posizione difficilmente conciliabili. Solo in un convegno del febbraio 1921, ad Avezzano, si converge unitariamente sulla richiesta di affitto alle cooperative come “sola forma” per risolvere la questione fucense. Troppo tardi ormai. Grazie al compiacente sostegno del fascismo, i Torlonia tornavano a rinsaldare, come forse mai in passato, la loro “onnipotenza” sulla Marsica.
La “morsa a tre ganasce” tra crisi ed autarchia
Con l’avvento della dittatura cade qualsiasi prospettiva di esproprio, come pure di un diverso assetto proprietario. Le forze d’ispirazione fascista, ormai vincenti, dichiarano di perseguire l’obiettivo della piccola proprietà: per ragioni non soltanto agrarie ed economiche — come si espresse Acerbo in un discorso del 6 maggio 1922 alla Camera52 —, ma anche d’ordine politico e persino sentimentale, “purché però la piccola proprietà si produca da condizioni di ambiente effettivamente esistenti in atto o in formazione, e non sia il prodotto artificioso di compiacenti leggi o, peggio, di abusi e di violenze”. Nella condotta dei Torlonia questo cauto orientamento filocontadino, in cui maldestramente riecheggiavano vecchie
ascendenze della democrazia rurale, assume le forme caricaturali, come sappiamo, della parcellizzazione in affitti da un ettaro a testa; di fatto però tale pratica, con il “mercimonio” delle subconcessioni che ne seguiva, mette fuori gioco le ultime speranze suscitate dal decreto Visocchi, come pure i sempre più rari tentativi di invasione da parte delle leghe socialiste, le quali man mano vengono smantellate, insieme alle amministrazioni comunali dello stesso colore.
Il discorso viene spostato — o almeno si tenta — su un terreno esclusivamente produttivistico ed aziendalista. La piaga delle affittanze, tuttavia, difficilmente può essere elusa. Nelle loro annuali relazioni gli amministratori dei Torlonia continuano a denunciare la scarsità della rendita rispetto “al valore grandissimo della terra ed alla sua fertilità”53. Il nodo è sempre lì, nelle insufficienti entrate per i bassi estagli e gli alti debiti dei fittavoli. Dall’altra sponda, neppure i sindacati fascisti, per quanto subalterni e concilianti verso la proprietà, possono sottrarsi — proprio su questo punto — ad aspre frizioni e contrapposizioni. Nel febbraio 1923 essi approvano una piattaforma rivendicativa che, per molti versi, sembra collocarsi su una linea di capitalismo illuminato: no agli appezzamenti inferiori all’ettaro, durata almeno novennale delle concessioni, ricostituzione delle medie aziende, eliminazione dei non agricoltori, estaglio proporzionato al costo del grano. Lo scontro però si gioca, in concreto, sul rinnovo degli affitti, scaduti da mesi. Le trattative si svolgono soprattutto in sede nazionale. Nell’accordo che viene stipulato a fine maggio, tolta una generica affermazione sulla durata novennale dei con-
Società che si prendesse la bega di sistemare tutti gli agricoltori dei comuni ripuari, Società che potrebbe formarsi da persone ligie ai Signori Principi, che ne rimarrebbero ispiratori” (Acs, Archivio Torlonia, b. 204).52 Cit. in R. Colapietra, Fucino ieri, cit., p. 150.53 Così si legge in un documento intitolato Brevi osservazioni sul bilancio 1928, a firma di Caio Sallustio Crispo, uno dei più ascoltati collaboratori dei Torlonia, sempre presente nei consigli di amministrazione delle Società che ad essi facevano capo, in Acs, Archivio Torlonia, b. 205.
658 Costantino Felice
tratti, non c’è però alcuna novità in favore degli affittuari. Il vero problema, quello del canone, resta aperto e gravido di tensioni. I fattavoli continuano ad indebitarsi: ad ottobre un migliaio risultano sfrattati. Nell’estate intanto, per meglio controllare i meccanismi dell’accumulazione, i Torlonia danno vita ad un’altra importante istituzione: la Banca del Fucino. Nello stesso tempo la loro insistente richiesta di un aumento dell’esta- glio provoca pericolose agitazioni, con scioperi e minacce di occupazioni. Mussolini in persona deve incaricare Serpieri, sottosegretario all’Economia, di tentare una composizione tra le parti. L’annuncio di un lodo, il 18 ottobre 1923, fa tornare tutti al lavoro; ma in realtà l’intervento ministeriale si limita a prorogare di un anno i contratti.
Il “concordato generale d’affitto” stilato nel 1924 non fa compiere sostanziali passi avanti; per certi versi, anzi, segna un arretramento. Non si parla più di durata novennale dell’affitto, ma soltanto quinquennale. Il canone viene innalzato da 400 a 460 lire, con “sacrificio economico e finanziario” del casato romano, che chiedeva molto di più. Per il resto si ripetono i soliti assunti, tra cui spicca quello di una “collaborazione sincera e duratura” degli agricoltori con la proprietà. Nessun seguito veniva dato ai propositi di ammodernamento produttivistico ed infrastrutturale, su cui particolarmente insisteva il direttore della Cattedra ambulante di
agricoltura, Rocco D’Alessandro, non senza conseguenze sul piano personale: di un riassetto poderale non si vedono tracce, del secondo emissario non si parla più, la manutenzione di strade e canali lascia sempre a desiderare. Tuttavia le polemiche di tanto in tanto riprendono quota anche in periodo di stabilizzazione fascista54. Alle accuse da parte dei Torlonia si obietta talora con argomenti non del tutto infondati. In una Memoria che nel 1926 venne presentata formalmente alla controparte sindacale, come risposta ad un ordine del giorno che riproponeva tutte le questioni55, si faceva presente, ad esempio, che l’affitto era altrove di 1.000 lire ad ettaro per terreni di analoga fertilità, ed inoltre che mediamente in Abruzzo e Molise la dimensione di questo tipo di poderi era di un quarto di ettaro, molto inferiore dunque a quella del Fucino. In effetti le terre dell’ex alveo, a paragone della circostante Marsica, per restare all’ambiente più vicino, presentavano senz’altro caratteri meno sconfortanti56. Forse non a caso nel successivo accordo stipulato il 31 marzo, sempre a Roma, le posizioni padronali risultano ancora vincenti. In concreto vengono decisi solo l’innalzamento delle categorie di terreni da 6 a 11 e un aumento del 30 per cento del canone: tutto il resto è libro di sogni.
Il punto d’arrivo di questo asimmetrico procedere vertenziale — per Torlonia ogni volta sostanziosi aumenti dell’estaglio, per
54 Nel Fucino, d’altro canto, un’infinità di episodi segnala il tenace perdurare di un’opposizione sempre viva. Non a caso è proprio qui che si forgia il nucleo più maturo e combattivo di comunisti abruzzesi (Corbi, Spallone, Amicone, ecc.), destinati in futuro ad assumere ruoli importanti; ed è ad Avezzano che l’Ovra fissa la sede della IV sezione, comprendente oltre l’Abruzzo anche l’Umbria. Cfr. C. Felice, Società rurale e “grande crisi”: il potere, la “cospirazione”, le rivolte in Abruzzo e Molise, in Marinella Chiodo (a cura di), Geografia e forme del dissenso sociale in Italia durante il fascismo (1928-1934), Cosenza, Pellegrini, 1990, pp. 132 e 134.55 Venne approvato in un’assemblea sindacale che si tenne ad Avezzano a metà febbraio (“Il Risorgimento d’Abruzzo e Molise”, 18 febbraio 1926). La Memoria si trova in Acs, Archivio Torlonia, b. 205, dove si può vedere anche il testo dell’accordo sindacale del 31 marzo, di cui si dice in seguito.56 Nella Memoria citata alla nota 55 veniva riportato un parere della Commissione censuaria dell’Aquila in cui tra l’altro si poteva leggere di “particolari feracità”, “alto reddito unitario”, “freschezza del terreno, ricchissimo di humus”, “suolo profondo e di giusto impasto”, “viabilità perfetta”: un insieme di favorevoli circostanze, insomma, che davano “l’illusione di essere trasportati d’un tratto in piena pianura padana”.
Azienda modello o latifondo? 659
la controparte solo promesse — è dato dal cosiddetto lodo Bottai, del 10 agosto 1929, un provvedimento che segna in modo decisivo la storia del Fucino57. Ad esso si giunge, ancora una volta, dopo che tra le parti erano state condotte lunghe ed estenuanti trattative, tanto in sede locale che nazionale, senza approdare ad alcunché. L’atto deliberativo è preceduto da una lunga premessa in cui, oltre a ricordare gli esiti dei due precedenti accordi, vengono espressi “pareri” sulla situazione del momento. Il maggiore inconveniente dell’agricoltura fucense è visto sempre nell’eccessivo frazionamento, il quale — vi si ribadisce con estrema brutalità — “non può imputarsi a colpa dei proprietari, essendo stato determinato dalle illegali, inconsulte e scomposte invasioni dei terreni, avvenute all’epoca della maggiore follia rossa, dal 1919 al 1921”. Da allora la grande e media azienda sarebbero state distrutte, provocando un’antieconomica dispersione e frammentazione dei lotti.La stragrande maggioranza di questi piccoli affittuari — si legge ad un certo punto — sono braccianti e nullatenenti, privi di animali propri, per modo che non concimano e non coltivano convenientemente le proprie terre e ritraggano una quantità di prodotti non proporzionata alla loro fertilità.
Teoricamente il ragionamento doveva servire a contenere la pretesa dei Torlonia di un incremento del 50 per cento sulle corrisposte d’affitto, da 600 a 900 lire ad ettaro per i terreni di prima qualità, mentre i sindacati opponevano una richiesta di diminuzione. Alla fine però, sebbene non così consistente, l’aumento si ebbe lo stesso (20 per cento). Ma il punto centrale del lodo questa volta non era tanto il prezzo del canone, quanto il fatto che se ne sanciva il pagamento in natu
ra, con la bietola, divenuta ormai il principale prodotto del Fucino. Sulla base di una produzione media stimata, nelle aree migliori, in 300 quintali ad ettaro, se ne fissava in 60 la quota da corrispondere in estaglio. Per le altre dieci categorie di terreni i calcoli venivano proporzionati ai loro valori produttivi. Deroghe a questa forma di corresponsione erano previste solo nel caso di parcelle non confacenti alla coltura delle bietole. Si trattava però di eccezioni, soggette peraltro a precise regole. Per il resto il lodo Bottai, pur riconoscendo che il problema del Fucino “trascende [va] gli interessi privati dei proprietari e degli affittuari, per investire direttamente gli interessi dell’economia nazionale” , non faceva che riproporre i soliti suggerimenti: accorpamento delle quote; eliminazione degli affittuari non agricoltori, come pure all’opposto di quelli piccoli; completamento della bonifica; costruzione di ricoveri per animali e persone. Non più che petizioni di principio, come si vede, senza alcuna indicazione o vincolo — che pure il governo avrebbe potuto imporre — per passare ai fatti. Nei contratti privati che sulla base del loro vennero stipulati, il locatore peraltro si riservava, “in relazione all’andamento dell’industria saccarifera, di limitare la quantità di terreno da coltivarsi, con separato atto contenente anche le condizioni relative alla coltivazione (consegna, trasporti, ecc.)” . Gli affittuari che per un motivo o per un altro non avessero potuto ottemperare agli impegni sottoscritti dovevano “corrispondere per ogni quintale prodotto in meno L. 10,80”. Quest’ultimo prezzo, inferiore a quello di 12- 13 lire previsto dal lodo, sembrava venire incontro ai piccoli coltivatori costretti a versare denaro al posto delle bietole. Senonchè — rileva ancora Pizzuti58 — in tale misura, pre
57 Anche di questo importante documento si trova copia in Acs, Archivio Torlonia, b. 205. Ma venne pubblicato anche da “Il Giornale d’Abruzzo e Molise”, 3 ottobre 1929, e dieci giorni dopo da “Il Popolo d’Abruzzo” .58 A. Pizzuti, Le affittanze agrarie, cit., pp. 51-52.
660 Costantino Felice
stabilita all’atto della locazione, si liquidava poi anche il prodotto normalmente consegnato fuori dall’estaglio. A chi acquistava le bietole, cioè agli stessi Torlonia, veniva così assicurato un convenientissimo affare.
Per cogliere la specificità della questione fucense occorre considerare un altro aspetto. Nell’Italia settentrionale veniva adottato il contratto cosiddetto “a riferimento”, consistente nel pagamento delle bietole in base al loro grado polarimetrico. Con tale criterio di solito finiva all’agricoltore la metà circa del ricavo dello zucchero prodotto dalle sue bietole. Nel Fucino vigeva invece, come abbiamo visto, il contratto “a prezzo fisso”, per effetto del quale si determinava a priori, all’atto delle semine, il prezzo da pagare. È vero che questo sistema garantiva il produttore dall’alea del mercato (il che induceva spesso anche i contadini a preferirlo), ma poiché era sempre l’acquirente ad imporre le condizioni, esso inevitabilmente avvantaggiava quest’ultimo. Per tutto il periodo fascista, ed anche nell’immediato dopoguerra, continuò ad esserci questa differenza: mentre i contratti nazionali facevano riferimento al titolo zuccherino, nel Fucino valeva il pagamento a peso, sempre inferiore alla media, oltre che soggetto a tutti quei soprusi connessi alle modalità di consegna e pesatura che già conosciamo59. I maggiori guadagni insomma, tanto sugli estagli che sui normali conferimenti, li facevano comunque i Torlonia.
Permanevano inoltre, ed anzi, col pretesto di più rigidi controlli sulla produzione, tendevano ad aggravarsi, quelle odiose clausole contrattuali che facevano del coltivatore fucense una riedizione del medievale ser
vo della gleba: divieto di libera uscita dei prodotti se non tramite salvacondotto del principe, obbligo di accedere al fondo solo per una determinata strada, e via dicendo. Tramite lo zuccherificio e tramite la terra veniva a configurarsi — entro il nuovo ‘ordine’ costruito dal regime — un duplice rapporto di sfruttamento tra Torlonia e i contadini: quello del proprietario col fittavolo e quello dell’industriale col bieticoltore. Tramite la Banca del Fucino, poi, l’Eccellentissima Casa controllava anche buona parte dei movimenti del credito e del risparmio, con tutto ciò che ne conseguiva non solo per la fornitura dei mezzi di produzione (macchinari, sementi, concimi), ma anche più in generale per le condizioni di vita nella zona. Terra, zuccherificio, banca: sulle comunità fucensi si chiudeva quella “morsa a tre ganasce”, come allora si diceva in gergo popolare, i cui tentacolari meccanismi di dominio sono stati evidenziati da tanta letteratura60. Ma non è questo l’aspetto — pur gravido di conseguenze sul piano sociale e politico — che qui preme rilevare. Può anche darsi che la strada seguita dai Torlonia — essere insieme agricoltori, banchieri, industriali e mercanti — fosse la più idonea, in quel contesto, ad assicurare la piena valorizzazione dei prodotti. Resta comunque il fatto che gli effetti di un tale sistema — indubbiamente un misto di moderno capitalismo e di residui feudali — sono risultati alla fine deleteri persino sul versante della mera logica economica.
Il lodo Bottai veniva confermato, nelle sue grandi linee, dai successivi capitolati provinciali del 1933 e del 1939, cui dovevano attenersi i singoli contratti d’affitto, ora redatti non più per appezzamenti (una ventina
59 Ancora Pizzuti denuncia per gli anni quaranta uno stato di cose sostanzialmente identico a quello dell’età giolit- tiana (Le affittanze agrarie, cit., pp. 139-149).60 Si veda per tutti Romolo Liberale, Il movimento contadino del Fucino. Da! prosciugamento del lago alla cacciata dei Torlonia, Roma, Edizioni dell’Urbe, 1977, pp. 26-34.
Azienda modello o latifondo? 661
di affittuari per ognuno) ma individualmente, cioè con tanti atti separati quanti erano gli intestatari di locazione. Unica novità l’inserimento negli estagli, accanto alla bietola, di una piccola quota di grano: 125 kg per le sarchiate di prima categoria. Con tali dispositivi i Torlonia si assicuravano il monopolio non soltanto sulla materia prima, fissandone quantità, prezzo e modalità di consegna, ma anche su ogni momento del ciclo economico, dalla scelta delle colture alla trasformazione e commercializzazione dei raccolti. Veniva così sancito il primato dell’attività industriale su quella agricola.
Nel 1927 i Torlonia avevano rilevato lo zuccherificio e le distillerie: il primo — Società anonima zuccherificio Avezzano (Saza)— con una spesa di 10 milioni; le seconde — Società anonima distillerie Avezzano (Sada)— di due milioni61. Per circostanze legate alla congiuntura (rivalutazione della lira, ribasso dei prezzi, oscillazioni nel tasso di sconto), le cose nei primi anni andarono meno bene del previsto. Il prezzo dello zucchero passò da 266 lire a quintale nel 1927 a meno di 211 nella successiva campagna bieticola, la prima gestita dalla Saza, per poi continuare man mano a scendere fin sotto le 200 lire dei primi anni trenta: una crisi di vaste proporzioni per l’intero settore saccarifero (nel Fucino la superficie a bietole si contrasse del 30 per cento), solo in parte attenuata dal considerevole sostegno dello stato62. Anche i ricavi dell’alcol scesero da 272 lire nel 1928 a meno di 174 a edro nel 1931, a causa del forte calo dei consumi, che peraltro comportò un eccezionale stoccaggio, con conseguente immobilizzo di capitali.
Negli stessi anni, però, si abbassavano anche i costi di produzione. Le spese di imballaggio si erano ridotte di quasi la metà dal 1927 al 1932, il prezzo del carbone era sceso da 205 lire a quintale a 115, quello della manodopera a sua volta risultava diminuito del 63 per cento su ogni quintale di zucchero. A queste economie andavano aggiunti i risparmi effettuati con le ristrutturazioni introdotte dalla nuova gestione. In particolare si ebbe una contrazione del personale: gli impiegati scesero da 37 a 26 e gli operai da 860 a 794, con un recupero sul monte-salari di circa il 30 per cento. Nonostante dunque la discesa dei prezzi di ricavo, altre favorevoli condizioni di mercato consentivano di realizzare buoni utili: considerando insieme zuccherificio e distillerie, nell’intero quinquennio 1928-1932 ben 15.690.736 di lire, pari ad oltre tre milioni all’anno. Per un periodo di crisi, erano risultati più che soddisfacenti.
Tuttavia, a comprimere le possibilità espansive deH’industria fucense erano soprattutto le linee di politica economica seguite dal fascismo. Dal 1925 lo zuccherificio di Avezzano faceva parte del Consorzio nazionale produttori di zucchero (Cnpz), da cui ogni anno riceveva disposizioni sulle quantità da produrre. Il contingente ad esso assegnato, di solito non più di 90.000 quintali, era molto inferiore a quanto si sarebbe potuto ottenere nel Fucino. Nelle relazioni di accompagnamento ai bilanci, il Consiglio di amministrazione della Saza esprimeva quasi sempre rammarico per questo trattamento ingiustamente punitivo. Nel 1935, quanto lo zucchero comincia a riprendere
61 Queste e le altre notizie che seguono sullo zuccherificio e le distillerie, a meno di diverse indicazioni, sono tratte da una Relazione sull’andamento della Società Anonima Zuccherificio di Avezzano nei quinquennio 1927-1932, a firma del direttore Fabio Friggeri, che si trova in Acs, Archivio Torlonia, b. 206. Nello stesso fondo archivistico, in massima parte però nella b. 202, si possono consultare anche i successivi bilanci annuali e le annesse relazioni di accompagnamento, oltre agli statuti di fondazione tanto della Saza che della Sada.62 Ester Fano, Problemi e vicende dell’agricoltura italiana tra le due guerre, “Quaderni storici”, 1975, nn. 29-30, pp. 488-489.
662 Costantino Felice
quota sui mercati, la società avezzanese, avendo minacciato contromisure, ottenne un aumento del proprio contingente di10.000 quintali, oltre alla possibilità di smaltire gli stocks di magazzino. Anche con questo provvedimento, tuttavia, la situazione non migliorava di molto. Gli impianti del Fucino continuavano ad essere sottoutilizzati, con danni non soltanto per l’economia di quell’area ma per l’Italia intera che, nonostante l’autarchia, per coprire il consumo interno era costretta ad importare dall’estero. Anche la produzione dell’alcol veniva sottoposta a rigidi controlli attraverso la Sipa (Società italiana produttori di alcol), con conseguente sottoutilizzo delle distillerie fu- censi. Allorquando, “nel quadro dell’economia e della difesa nazionale” , fu deciso di mescolare l’alcol puro alla benzina per produrre maggiori quantitativi di carburante, sembrava che al settore fosse “consentito più ampio respiro”, come si legge nella relazione di bilancio 1935. Ma a conti fatti i vantaggi della riconversione, a parte i suoi alti costi, risultarono piuttosto modesti. “Con la creazione degli impianti per l’alcool assoluto — si ammetteva infatti nella relazione del 1936 — la nostra industria si è ispirata ad un interesse nazionale più che a considerazioni di tornaconto economico, poiché minimi sono i margini di utile nella produzione dell’alcool assoluto.” Il regime consortile dunque, se da un lato garantiva le fabbriche del Fucino dagli imprevisti del mercato, dall’altro ne comprimeva le potenzialità. Era l’intera economia della zona, il cui fulcro più moderno consisteva proprio nell’industria saccarifera ed etilica, a risultarne fortemente condizionata, se non del tutto bloccata.
Le forzate limitazioni dell’attività industriale si sommavano alle inerzie nel comparto agricolo. Protetta dalla normativa del
lodo Bottai e dei successivi capitolati, che di fatto precludeva ogni concorrenza e sollecitazione di mercato, l’amministrazione Torlonia non aveva stimoli a funzionalizza- re al meglio i fattori della produzione. Nella gestione degli affitti, a parte la riscossione dell’estaglio e la consegna dei previsti quantitativi di bietola, tutto il resto — subaffitti, avvicendamenti, manutenzione — veniva ignorato, o comunque trascurato. Di questa “menomazione di funzionalità padronale” — come eufemisticamente la definisce Pizzuti63 — la gente del Fulcino era ben consapevole e ne approfittava per consolidare la coscienza del “buon diritto” a non essere “disturbata” nell’uso e nella disponibilità delle parcelle possedute. I piccoli affittuari, da parte loro, non erano certo in grado di ottemperare alle disposizioni contrattuali che impegnavano ad una maggiore razionalità nell’attività agricola. In tale contesto, di fronte al crescente indebitamento contadino, restavano precarie le condizioni più generali della produttività, tanto del lavoro che dei terreni. Già il frazionamento pulviscolare, non consentendo l’uso di macchinari e l’applicazione di moderne tecniche colturali, come di continuo denunciavano gli agronomi, costituiva un insormontabile freno ad ogni proposito di più congruo sfruttamento delle risorse. Ma pesava anche — su questi persistenti elementi di arretratezza — il disimpegno dei Torlonia quanto ad investimenti in opere infrastrutturali e fondiarie. Neppure le chance offerte dalla legge di bonifica integrale scuotono la passività dell’illustre casato. Vengono progressivamente diminuite persino le spese di normale manutenzione (impianti elettrici, strade, ponti, canali e fossi, fabbricati), che scendono da 901.308 lire nel 1930 a 713.375 nel 1934. È vero che siamo negli anni della ‘grande crisi’, ma il fat-
63 A. Pizzuti, Le affittanze agrarie, cit., p. 53.
Azienda modello o latifondo? 663
to che tagli vengano effettuati su una voce la cui eseguità da sempre si rimproverava ai Tor- lonia, e che certamente incideva sull’andamento produttivo, la diceva lunga sulla cultura imprenditoriale deH’Eccellentissima Casa.
La realizzazione di un piano completo di bonifica, con le annesse centrali elettriche, veniva considerata un indispensabile presupposto per il compimento di quel “programma agricolo-industriale” che era nei sogni di tecnici e politici avveduti fin dai tempi dell’Inchiesta agraria, come sappiamo. Data la rilevanza dell’economia fucense, ben oltre le dimensioni provinciali e regionali, iniziative organiche di questo genere, che ne avrebbero messo in discussione le sorti complessive, coinvolgevano ovviamente le massime istanze dello stato, sollecitandone — almeno all’apparenza — le premure. Ma inutilmente da questi ambienti si richiamavano i Torlo- nia — nei cui confronti, del resto, persino le più alte autorità del regime (Tassinari, Mussolini) mostravano particolare deferenza — alla “comprensione delle necessità del momento” e ai doveri verso la nazione64. Inascoltati, d’altro canto, restavano anche i suggerimenti che venivano dal loro stesso entourage tecnico ed amministrativo. I consiglieri più accorti non mancavano di sollecitare una maggiore “modernità di vedute” . Anziché attardarsi in scelte e gesti d’ancien regime (beneficenza, elargizioni, contributi assistenziali) — essi facevano notare — occorreva dar vita ad un’amministrazione efficiente e dinamica, capace di guardare ai problemi sociali e politici senza perdere di vista gli interessi economici. Specificamente si indicava la necessità che l’Eccellentissima Ca
sa difendesse meglio il proprio ruolo nazionale attraverso una più capillare penetrazione negli organismi associativi e nei mezzi d’informazione65. Ma non pare che questi inviti abbiano prodotto effetti.
La carenza d’investimenti, insieme al carattere prevalentemente antiquato delle forme contrattuali, costringe all’immobilismo anche dal lato produttivo. Il regime di conduzione non subisce sostanziali modifiche: i circa 14.000 ettari di terreni coltivati continuano ad essere ripartiti tra gli 11.000 dati in fitto, i 1.200 dati a colonia e gli 800 gestiti in proprio (due aziende: quella di Via Nuova, di 500 ettari, e quella di Strada 30, di 300). Nonostante tutto, però, il Fucino viene éonsiderato dal fascismo una specie di fiore all’occhiello: c’è chi lo definisce “il più grandioso e il più bel tenimento d’Italia e forse d’Europa”66. E in effetti i guadagni, stando alla contabilità aziendale, sembrano tutt’altro che trascurabili, come si può desumere dalla tabella 4.
In uno sguardo di più lungo periodo si constata che in provincia dell’Aquila la produzione bieticola media del decennio 1914- 1923 era stata di 564.000 quintali all’anno: rapportata alla superficie coltivata nel 1924 (2.800 ettari), essa dava poco più di 200 quintali ad ettaro. Successivamente si registra un notevole incremento, connesso al sorgere della Saza e della Sida, come sappiamo. Nel sessennio 1923-1928 abbiamo una produzione media annuale di oltre 800.000 quintali, corrispondenti ad una resa di 262 per ettaro. Nel 1929 il raccolto è particolarmente buono, tanto che il rendimento unitario sale a 282 quintali. Nella seconda metà
64 Per esempio, si veda un articolo a firma di Luigi Rossetti, Realizzazioni di problemi nazionali nella Morsica, “Il Giornale d’Italia”, 9 luglio 1932. D ’altro canto, anche nelle aree in questo periodo ben più dinamiche, come il Tavoliere, al “fervore sperimentale e progettuale” fanno seguito in concreto modesti risultati (L. D ’Antone, Tecnici e progetti, cit., pp. 134-137).65 Esplicita in questo senso una nota, intitolata Brevi osservazioni sul bilancio 1928, redatta da Caio Sallustio Cri- spo (Acs, Archivio Torlonia, b. 205).66 “Annuario dell’agricoltura italiana”, 1930, p. 530.
664 Costantino Felice
del successivo decennio il trend si mantiene stabile o addirittura, contrariamente all’andamento della media nazionale, scende di qualche punto67. Negli anni della guerra — è naturale — la situazione precipita ulteriormente: 235 quintali ad ettaro nel 1941, 208 nel 1942, 133 nel 1943, 124 nel 1945. La produttività della principale coltivazione del Fucino, dopo lo sviluppo del primo ventennio del secolo, restava dunque stazionaria. Questi dati riguardavano ovviamente l’intero tenimento. Nelle due aziende gestite in proprio le cose andavano invece molto meglio, come si può ricavare dalla tabella 5.
Tra il primo e il secondo quinquennio, nonostante la ‘grande crisi’, l’incremento delle rese appare in questo caso considerevole. È vero che la gestione in proprio comprendeva le terre agronomicamente più favorevoli; ma è anche probabile che in essa continuassero a consolidarsi criteri di maggiore razionalità e modernità. Dalle aziende in economia si traevano infatti i più alti redditi unitari: nel 1936 circa 1.230 lire ad ettaro, di contro a poco più di 900 ricavate dalle colonie e poco più di 600 dagli affitti. La coltura principale qui era sempre il grano, che dava complessivamente i maggiori guadagni, grazie ai favori di cui godeva con la “battaglia del grano” e poi col sistema degli ammassi. Anche l’utile della patata, sia pure fortemente oscillante di anno in anno, risultava molto elevato, anzi il migliore in assoluto se rapportato alla superficie coltivata: 2.941 lire ad ettaro nel 1936 (ben 5.625 l’anno prima!), mentre per il grano si erano avute 1.379 lire nel 1935 e 1.820 l’anno pre
cedente, e per la bietola rispettivamente 1.077 e 1.661.
Le terre a mezzadria nel complesso rendevano ovviamente più di quelle in economia (1.122.572 lire nel 1936); ma i maggiori proventi venivano dagli affitti: oltre 6 milioni e mezzo l’anno. A segnare profondamente l’andamento economico del Principato, l’essenza stessa della sua logica imprenditoriale, era dunque questa predominante forma di conduzione: una sorta di tara storica che ab origine esso si portava dietro, con un aggrovigliarsi sempre più fitto di problemi e difficoltà. Su tale comparto si scarivava la contraddizione che costituiva il cuore stesso della questione fucen- se: lo sproporzionato rapporto tra abitanti e risorse. I circa 15.000 piccoli coltivatori sparpagliati tra Avezzano e i comuni ripua- ri, per quanto occupati anche in altre saltuarie attività, non avrebbero mai potuto trarre un reddito sufficiente da quote di terreno mediamente inferiori all’ettaro. Negli anni trenta la pressione demografica non si attenua, sebbene la ruralizzazione tenti di nasconderla. Una via d’uscita si sarebbe potuta forse creare — come accenna Pizzuti68 — solo con un “piano di industrializzazione” che il ministero delle Corporazioni (peraltro chiamato in causa col lodo Bottai), essendo investito di funzioni di sintesi e coordinamento tra i vari settori della produzione, senz’altro avrebbe potuto approntare e proporre. Ma di un impegno del genere, come sappiamo, non c’è traccia. Di anno in anno cresce la massa dei disoccupati: nell’estate del 1938 in provincia dell’Aquila se ne contano 3.000 nell’industria e al-
67 “Annuario statistico dell’agricoltura italiana”, 1936-38 e 1939-42.1 precedenti dati sono ripresi, per il 1914-23 da “Notizie periodiche di statistica agraria”, 1924, p. 375, e per il 1923-28 e 1929, da Catasto agrario 1929, fase. 62, Roma, 1936, p. 7. Essi si riferiscono all’intera provincia aquilana, ma, eccettuati piccoli appezzamenti nel medio Aterno, nell’altopiano di Montereale e nella valle amiternina, si tratta solo del Fucino. Quanto alla produzione di barbabietola a livello nazionale, cfr. Gabriella Corona-Gino Massullo, La terra e le tecniche, in Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, I. Spazi e paesaggi, a cura di P. Bevilacqua, Marsilio, Venezia, 1989, p. 401.68 A. Pizzuti, Le affittanze agrarie, cit., p. 49.
Azienda modello o latifondo? 665
frettanti in agricoltura. Unico sbocco per l’eccedenza di manodopera, teorizzato ad un certo punto dalle stesse autorità di regime69, non resta che l’emigrazione. Ed infatti a scaglioni — decine di famiglie ogni volta — vengono spediti ‘volontari’ tanto verso la Germania, per coltivare anche lì patate e barbabietole, quanto verso le colonie dell’Africa, per bonificare nuove terre.
Negli anni della guerra, nonostante la disoccupazione fosse alleggerita dalle partenze per il fronte, i tradizionali problemi del Fucino si aggravano pesantemente. Soprattutto diventa sempre più insostenibile l’indebitamento degli affittuari. Dal bilancio del 1936 esso risultava, alla fine di quell’anno, di ben 9 milioni. Ma negli anni seguenti — come dimostra con chiarezza il Pizzuti — esso cresce con progressione quasi geometrica: nel 1949 i morosi risulteranno gravati globalmente da debiti, risalenti anche al periodo fascista, per oltre 200 milioni di lire70. Alla base del fenomeno c’è la crisi della bietola. Nel triennio 1936-1938 il suo prezzo corrispondeva a circa 1/10 di quello del grano; nel 1945 il rapporto è di 3/4. Di conseguenza chi versava l’estaglio in bietole, o nel suo contro- valore monetario, finiva col pagare molto più di chi lo versava in grano: nel 1945 per uno stesso appezzamento la maggiorazione era di otto volte. Facevano le spese di questo andamento dei prezzi particolarmente i piccoli affittuari, i quali avevano minori possibilità di prevedere l’andamento dei mercati. In seguito il disorientamento cresce ancora. E non pochi di essi, confidando sulla passata esperienza, tornano a seminare molte bietole. Senonchè nel 1946, mentre
il prezzo di questo prodotto cresce da 350 a 397 lire il quintale, quello del grano quasi si quadruplica, sbalzando da 463 lire a 1.614 circa. L’anno successivo è di nuovo la bietola a più che raddoppiare, portandosi a quasi 840 lire il quintale.
Le rovine della guerra, intanto, sono ingenti. Il comune di Avezzano, classificato tra i sinistrati di prima categoria, si presenta illeso solo per un quinto del suo abitato. Anche le strutture produttive del Fucino, soprattutto quelle industriali, compresi lo zuccherificio e la malteria, risultano in gran parte distrutte o gravemente danneggiate. Passato il fronte, comunque, è soprattutto il possesso della terra — terra da seminare per sfamarsi — il bisogno che scuote la gente del Fucino. Neppure i programmi e i tempi della politica riescono a ritmarsi, pur nel nuovo clima di libertà, sulle esigenze della vita quotidiana. Il partito che maggiormente riesce a “polarizzare” la massa verso di sé — come si esprime il prefetto dell’Aquila71 — è quello comunista; ma esso sostiene ora la proprietà individuale della terra, a differenza dei socialisti che insistono sulle affittanze collettive, o dei cattolici che puntano sulle cooperative e su meccanismi di assegnazione delle terre analoghi a quelli previsti dal decreto Visocchi. E tuttavia neanche i comunisti, pur esprimendo allora la linea meglio sintonizzata sulle aspirazioni popolari, dovendo ricondurre i movimenti entro il quadro di legalità che si va definendo col nuovo stato, possono completamente adeguarsi alle istanze che premono dal basso. È in questo contesto che le tensioni del Fucino, il 16 ottobre 1944, sfociano nel tragico episodio di Ortucchio. Su alcune centinaia di contadini,
69 “Corriere d’Abruzzo”, 18 giugno 1938. I dati sulla disoccupazione sono presi da un rapporto di questura del maggio 1938, in ACS, Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati (d’ora in poi Agr), 1920-45, b. 48.7(1 A. Pizzuti, Le affittanze agrarie, cit., pp. 74-78 e 131.71 Acs, Agr, 1931-49, b. 58 A.
666 Costantino Felice
che “armati scuri, zappe, badili ed altri arnesi al canto inno lavoratori”, tentano di occupare i terreni ancora incolti dell’azienda Torlonia, un nucleo di carabinieri e guardie campestri risponde col fuoco: un contadino muore e altri restano feriti72.
La riforma tra istanze economiche e condizionamenti partitici della politica
L’eccidio di Ortucchio — il primo dell’Italia liberata — dà il senso di quanto infuocato fosse il clima sociale e politico nel Fucino dell’immediato dopoguerra. Come all’indomani del primo conflitto mondiale, i Torlonia vengono a trovarsi in condizioni di debolezza. Ora anzi, nel nuovo contesto di riorganizzazione democratica e di rinnovate speranze per le riforme, l’isolamento si fa ancora più netto e rischioso. La posizione delle forze politiche — nella cui analisi, in sede regionale e talora nazionale, l’argomento Fucino torna ad occupare un posto di primo piano — viene espressa con maggiore chiarezza ed incisività che nel passato. I socialisti ribadiscono la loro tradizionale linea che vedeva nelle affittanze collet
tive la strada maestra per giungere alla socializzazione del latifondo. Anche i comunisti, pur tra approssimazioni ed astrattezze, continuano a tenere come punti fermi della loro lotta — nella prospettiva ultima di “cacciare” i Torlonia73 — il canone enfi- teutico e la demanialità dell’ex alveo. La novità è adesso rappresentata dalla De. Un suo autorevole esponente, Vincenzo Rivera, presidente della provincia e dell’Associazione aricoltori, si espresse in sostanza a favore delPesproprio74. La presa di posizione non piacque ad alcuni settori della De, né alla Confida, dal cui esecutivo nazionale Rivera dovette dimettersi. Ma intanto il dibattito, anche tra le forze moderata, si avviava su binari dai quali tale prospettiva quanto meno non veniva esclusa. L’atteggiamento della De — e dello stesso Rivera — andrà poi sempre più definendosi nel senso di un aziendalismo privatistico — il vecchio motivo del riappoderamento in funzione direttocoltivatrice — che di frequente porrà il partito in contrapposizione alle sinistre.
Sul piano economico-sociale, alla base del magmatico ribollire di fermenti e tensioni stanno due fenomeni che già conosciamo,
72 Per una ricostruzione dettagliata dell’accaduto, C. Felice, Alle origini della restaurazione post-bellica nel Mezzogiorno: società, partiti e Stato in Abruzzo e Molise (II), “Rivista abruzzese” , 1986, n. 4, pp. 212-213.73 Vale la pena riferire la notizia — riportata da Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, p. 401 — secondo cui erano i massimi dirigenti del partito, in questo caso Giorgio Amendola, a spingere i reticenti compagni di Avezzano a porre al centro della lotta la parola d’ordine “Torlonia deve essere espropriato” e magari arrestato.74 “11 Risveglio d’Abruzzo”, 25 maggio 1945. Nell’articolo, dal secco titolo II Principato del Fucino (riassunto su “Il Popolo” del 2 giugno), Rivera poneva il problema di una “revisione del titolo di possesso” del Fucino (erroneamente inteso come classico latifondo) più che dal lato storico e giuridico, che pure lo vedeva sostanzialmente schierato in difesa della demanialità, soprattutto da quello economico e sociale. Le “cospicue rendite” riscosse in un set- tantennio avevano, a suo parere, ormai ampiamente compensato i Torlonia degli sforzi compiuti e dei rischi corsi col prosciugamento e la bonifica del lago. Considerato che il latifondo valeva ora più di cento volte l’investimento iniziale, egli proponeva dunque che ai principi romani venisse offerta, come indennità per lo “scioglimento o annullamento della convenzione”, una cifra pari a quella da essi a suo tempo sborsata. Suddivisa in medi e piccoli poderi, la terra avrebbe dovuto essere data “a chi la coltiva”, mentre alla comune manutenzione dell’alveo si sarebbe dovuto provvedere tramite un consorzio degli stessi assegnatari. In aperta polemica con tale visione (avallata in un comizio a Peterno anche da Giuseppe Spataro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio) “L’Avvenire”, organo della Federazione socialista dell’Aquila, pubblicava il 9 giugno 1945 un articolo di Claudio Caiola, Sul problema economico e sociale del Fucino, lucido e ben argomentato.
Azienda modello o latifondo? 667
ma che ora diventano esplosivi: l’esasperata polverizzazione del subaffitto e la disoccupazione crescente. Entrambi riconducono allo squilibrio popolazione-risorse. La situazione dei fittavoli si fa sempre più pesante non solo per l’accumulo dei debiti, ma anche per il più generale deterioramento delle condizioni di vita. I provvedimenti emanati dai governi di unità nazionale, in particolare i due decreti Gullo del 5 aprile 1945, che formalmente individuavano nel “coltivatore diretto” il solo soggetto avente diritto all’affitto, tanto nei casi di proroga che di nuovi contratti, creano una serie inestricabile di conflitti e contestazioni protrattisi per vari anni.
Nel Fucino infatti questa figura, dai contorni tutt’altro che netti anche altrove, difficilmente coincideva con l’affittuario. Pizzuti calcola che dal 1945 al 1950 più di8.000 coltivatori diretti, o sedicenti tali, abbiano inviato al proprietario le domande per l’applicazione in proprio favore dei disposti luogotenenziali. Alla fine, però, solo una metà avrebbe ottenuto il perfezionamento dei patti secondo le nuove norme. Non cessò neppure quel “traffico” dei contratti in cui certo trovava parziale sfogo la persistente fame di terra, ma che continuava anche ad essere fonte di “immancabili speculazioni”. I decreti Gullo relativi ai contratti d’affitto, insomma, registravano nel Fucino un sostanziale fallimento. Seppure vi fosse stata una remota possibilità che essi avessero un’incidenza, il comportamento della proprietà — sottolinea ancora Pizzuti — fu tale da vanificarla, contribuendo a rafforzare la “generale convinzione secondo la quale il Fucino si sottraeva a
qualsiasi esperimento di normalizzazione giuridica”75.
I contenziosi sulla proroga dei fitti e l’eliminazione dei non coltivatori investivano soprattutto la sfera amministrativa e legale. Ma intanto si sviluppavano anche le lotte sul piano più propriamente sindacale. Il punto di attacco erano le “pattuizioni vessatorie” imposte dal lodo Bottai, soprattutto riguardo al costo del canone, alla sua corresponsione in natura e all’obbligo di coltivare bietole. Un ampio movimento — protagonista la Federterra — monta nel febbraio del 1948.
Tra i suoi obiettivi vi sono il blocco degli sfratti, la riduzione dell’estaglio e il ratizzo degli arretrati. Su ciascuno di essi, alla fine, si riesce a strappare dei risultati. Le rivendicazioni della Federterra non costituivano — è ovvio — un “piano completo ed organico”, capace di rispondere tanto ai requisiti della giustizia sociale che ai principi della razionalità economica e della fattibilità. Per muoversi su questo terreno complessivo occorrevano competenze tecniche, politiche e giuridiche che solo un intervento dello stato, come poi di fatto avverrà, poteva garantire. Lo stesso nodo degli affitti tornerà di nuovo alla ribalta due anni dopo, con l’ampia mobilitazione che porterà alla cacciata dei Torlonia. Ma nell’immediato dopoguerra, assai più che dai rinnovi contrattuali, le tensioni sono alimentate dalle lotte dei disoccupati e sottoccupati che aspirano al possesso fondiario. Materia del contendere in questo caso diventano i decreti sull’assegnazione delle terre incolte. È il campo su cui maggiormente si misura lo scarto tra apparati istituzionali e comportamenti
75 A. Pizzuti, Le affittanze agrarie, cit., pp. 83-84, 88 e 93. Naturalmente assai dura, in questo contesto, era la polemica delle risorgenti forze politiche contro Torlonia e la sua amministrazione, accusati — per dirla con le parole di “Risorgere” (15 aprile 1945) — periodico che si qualificava come organo del Cln provinciale — di “fare capo a tutte le camorre locali” e di servirsi di “tutti i mezzi leciti ed illeciti” per tenere assoggettata la gran massa degli affittuari.
668 Costantino Felice
degli strati subalterni76. Le forze politiche e sindacali s’impegnano ad organizzare le cooperative. Ma i risultati stentano a venire: alla fine del 1944 in provincia dell’Aquila — stando ad una nota del prefetto — ancora non ne risultava nessuna. Nel contempo i limiti della legalità venivano di continuo forzati da invasioni, picchettamenti, semine abusive, che in genere vedevano gli occupanti procedere — anziché alle attribuzioni collettive — di fatto alla suddivisione delle terre in lotti singoli77. Ancora una volta, insomma, il tradizionale individualismo contadino, nonostante l’atmosfera fortemente impregnata di miti egualitari e solidaristici78, aveva il sopravvento sui velleitarismi della cooperazione. L’operato delle sinistre sul versante economico veniva, nella realtà, svuotato dalla loro incapacità di dar vita a ‘strutture’ stabili ed efficienti (cooperative, banche, enti di assistenza). Nell’estate del 1945, secondo un autorevole esponente comunista, in provincia dell’Aquila si registrava il minimo nazionale nell’applicazione dei
decreti Gullo sulle terre incolte: appena 500 ettari, contro gli oltre 16.000 della Calabria, della Sicilia e dell’Agro romano. Col passare dei mesi la graduatoria non cambia. Al 31 dicembre 1946, stando questa volta a fonti ministeriali79, sempre nella stessa area risultavano assegnati, per amichevole componimento, 1.760 ettari a due cooperative: per quest’ultimo dato il compartimento regionale si collocava di gran lunga all’ultimo posto in Italia, mentre per la superficie veniva superato solo dalla Basilicata.
In questo contesto, piccoli affittuari e contadini nullatenenti, la grande massa cioè dei disoccupati e sottoccupati, come in altri momenti cruciali del passato, costituiscono la forza d’urto delle lotte che si sviluppano nella primavera del 1950, l’anno dei massimi sconvolgimenti nella storia del Fucino, almeno per quanto concerne gli assetti proprietari. La novità ora è data dall’ampiezza del fronte che i conflitti coinvolgono. Le terre del Fucino, insieme al Vomano per le centrali idroelettriche, diventano il princi-
76 Al riguardo, C. Felice, Sociale e politico nell’Abruzzo dell’immediato dopoguerra, in L ’Altro dopoguerra. Roma e il Sud 1943-1945, a cura di Nicola Gallerano, Milano, Angeli, 1985, pp. 171-180.77 Acs, Agr, 1935-55, b. 193, e serie 1931-49, b. 58A. Sulle iniziative e le lotte promosse dai partiti, notizie si trovano ovviamente anche sui loro organi di stampa. Per i comunisti “Voce d’Abruzzo”, particolarmente del 26 maggio, del 2 e 16 giugno e del 28 luglio 1945. Quanto ai socialisti, sul loro periodico “L’Avvenire” significativo soprattutto l’articolo, a firma di Claudio Caiola, che annunciava la costituzione (tra i promotori anche Silone) di una “Cooperativa agricola del Fucino”. Ma in un precedente intervento, dal titolo I socialisti e il Fucino, nel quale veniva enunciata con la massima chiarezza la linea socialista, si prendeva atto in qualche modo delle difficoltà che si frapponevano su questa strada, data la “innata riottosità nei contadini d’Abruzzo, per difetto di preparazione, a partecipare ad una cooperativa”. D ’altro canto i limiti della prospettiva cooperativistica erano ben presenti agli osservatori più competenti fin d’allora. Si pensi a Manlio Rossi Doria, il cui articolo, Le assegnazioni di Terre alle cooperative, apparve il 23 dicembre 1945 su “Risorgere”, e a Gino Luzzatto che su “Critica politica” del gennaio-marzo 1945 definiva “semplicistica” la formula della terra ai contadini attraverso le cooperative, “sprovviste di ogni preparazione tecnica e dei più elementari sussidi finanziari” . Cfr. anche R. Colapie- tra, Fucino ieri, cit., pp. 265 e 321, nota 88.78 Seppure specificamente riguardanti altri contesti — ma certamente estensibili, nella sostanza, all’intera realtà meridionale — si vedano in proposito le considerazioni di Paul Ginsborg, Storia d ’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, I. Dalla guerra alla fine degli anni ’50, Torino, Einaudi, 1989, pp. 166-168, dove si fa riferimento soprattutto al lavoro di Gabriella Gribaudi, Mito dell’eguaglianza e individualismo: un comune del Mezzogiorno, in Aa.Vv., Italia 1945-1950, Milano, Angeli, 1985, pp. 461-462 e 496-497.79 “Annuario statistico delTagricoltura italiana”, 1943-46, p. 79. L’articolo dell’esponente comunista cui si è fatto poco prima riferimento è Ruggero Grieco, Il latifondo e la concessione delle terre incolte ai contadini, “Rinascita”, luglio-agosto 1945. Istanze per l’assegnazione di terre incolte erano state avanzate anche da 3 cooperative della provincia di Pescara e da 2 del Molise, ma senza successo.
Azienda modello o latifondo? 669
pale laboratorio nazionale dove si attua con successo la strategia delle alleanze — messa a punto soprattutto dai comunisti — sulla riforma agraria. È qui infatti che lo “sciopero alla rovescia” , già sperimentato in Calabria, raggiunge la sua massima efficacia e risonanza. La piattaforma rivendicativa, elaborata in sede politica ma sostanzialmente coincidente con gli obiettivi sindacali della Federterra80, toccava tutti i nodi della questione fucense: nuovo capitolato d’affitto, lavori di manutenzione, esproprio. Essa era tale da coinvolgere unitariamente — per la prima volta — le tre componenti tradizionali dello schieramento antitorlonia: i comuni, perché interessati a rivendicare la demanialità dell’ex alveo; gli affittuari, protesi al superamento del lodo Bottai: i braccianti, i quali puntavano ad essere occupati nelle opere di sistemazione idraulica e stradale. Quest’ultimo costituiva il motivo più trascinante. Con lo sciopero a rovescio si eseguivano lavori non tanto — ha notato acutamente Colapietra — “per far vivere la terra, come s’era detto fino ad allora dai tecnici e dai ‘dottrinari’, ma per far vivere i lavoratori della terra, con una finalità non agronomica ma schiettamente sociale”81. Ancora una volta, insomma, erano i più elementari bisogni della sussistenza, su cui ora si mostravano ben sintonizzate le forze politiche e sindacali, a fungere da detonatore nella mobilitazione di uomini e coscienze. Indurre i Torlonia a “pagare”’, come recitava uno slogan, significava dar da mangiare — nel senso letterale del termine — a strati non piccoli di popolazione, le cui già grame con
dizioni di vita si vedevano quell’anno aggravate da un inverno particolarmente rigido e lungo. La chiarezza del programma era supportata, questa volta, da un’organizzazione ben concertata e capillare: una serie di Comitati per la rinascita su base comunale facevano capo ad un Comitato centrale, con sede nel municipio di Avezzano, cui partecipavano personaggi di vari orientamenti, sebbene sotto un’indubbia egemonia comunista. I lavoratori vennero suddivisi in squadre di 7 membri ciascuna, con un caposquadra e un affittuario come dirigente tecnico; da ogni cinque squadre si formavano i gruppi, i cui responsabili formavano il comitato locale. La sera i capisquadra si riunivano in assemblea per fare il bilancio della situazione, indicendo di tanto in tanto lo sciopero di tutta la popolazione. Fornai e commercianti aprirono crediti per il rifornimento dei generi di prima necessità.
L’agitazione ebbe inizio la mattina del 6 febbraio 1950, “allorché i disoccupati di Luco e di Celano, di Pescina e di Trasacco, di Avezzano, di Cerchio, S. Benedetto, Aielli, Ortucchio, Paterno e Gioia, imboccarono le strade del comprensorio, badili in spalla, carri al seguito, la ‘Internazionale’ sulle labbra e le donne a salutare e incitare”82. Giunti sul latifondo, si misero a sistemare strade e canali. Stessa scena nei giorni e nelle settimane seguenti. Quando la polizia e i custodi del fondo cercavano di respingerli, le squadre si riformavano in altri punti e riprendevano i lavori. Un primo sciopero generale venne proclamato il 15 febbraio. Il secondo si svolse esattamente una settimana
80 La sua formulazione più chiara ed argomentata si aveva con l’opuscolo di Renato Vidimari, II Fucino, Torlonia e i contadini, a cura dell’Associazione Nazionale Coltivatori Diretti, Roma, 1949.81 R. Colapietra, Fucino ieri, cit., p. 282.82 A. Pizzuti, Le affittanze agrarie, cit., p. 111. Cfr. anche P. Ginsborg, Storia d ’Italia, cit., pp. 169-170, e per una ricostruzione più dettagliata (sebbene quasi esclusivamente su fonti giornalistiche e pubblicazioni di sinistra), oltre naturalmente a R. Colapietra, Fucino ieri, cit., pp. 285 sgg., Gianni Melilla, Piano del lavoro e Cgil in Abruzzo, in Aa.Vv., Anni cinquanta: il Piano del Lavoro in Abruzzo, a cura della redazione di “Cronaca e Storia”, Edicrones, Sulmona, 1980, pp. 22-27.
670 Costantino Felice
dopo. Fu il culmine della lotta, con una ampiezza di mobilitazione ed un apparato scenografico — negozi e uffici chiusi, scuole deserte, stazioni occupate, treni addobbati con festoni rossi e bandiere tricolori, donne a distribuire volantini, blocchi stradali e così via — che hanno fatto di quella giornata uno dei momenti più ‘leggendari’ della storia fucense. Nel complesso si calcola che allo sciopero a rovescio, prolungatosi per due mesi, abbiano partecipato attivamente oltre 2.000 braccianti e 3.000 piccoli affittuari, mentre almeno altre 12.000 persone avrebbero solidarizzato in forme concrete.
Due giorni dopo la grande manifestazione del 22 febbraio, il prefetto dell’Aquila ricevette l’ordine dal governo di firmare il decreto sull’imponibile. Dovettero passare ancora alcune settimane perché Torlonia si decidesse a pagare gli scioperanti, ma alla fine fu costretto a cedere, sebbene con l’escamotage di versamenti effettuati in forma di “elargizioni per soccorsi invernali” . Risultati si conseguirono anche sulle condizioni d’affitto, fino all’accordo — il 28 maggio — di un nuovo capitolato che in sostanza seppelliva il “famigerato” lodo Bottai. Nonostante i successi, le lotte, estesesi nel frattempo ad altre aree del Mezzogiorno non si attenuavano. Ed ancora una volta l’ottusità padronale rispose ad un certo punto con uccisioni e ferimenti. Il 30 aprile a Celano le guardie private di Torlonia sparano in mezzo alla folla lasciando sul lastrico due morti83.
Ormai la questione Fucino si avviava verso una “soluzione radicale” nell’ambito del la riforma agraria. Alla Camera dei deputati entrava formalmente alla fine di febbraio grazie ad una mozione di cui era primo firmatario il comunista Fernando Amiconi. Ai
primi di marzo si parlava già di legge stralcio per la costituzione di speciali enti nel Fucino, nella Maremma, nella Sabina e in Sicilia.
Il 19 di quel mese ne dava conferma ad Avezzano lo stesso ministro dell’Agricoltura, Antonio Segni. Le Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini — la cosiddetta legge stralcio appunto — portano la data del 21 ottobre 1950, n. 841. Un decreto del presidente della Repubblica, in data 7 febbraio 1951, n. 66, costituiva ufficialmente l’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di cui poco dopo verrà nominato presidente Giuseppe Medici. Nel settembre di quell’anno una serie di altri provvedimenti disponeva che il nuovo Ente procedesse all’esproprio e all’occupazione delle terre.
L’appaiamento del comprensorio del Fucino (poco più di 44.000 ettari) con la Maremma, data la sua scarsa connotazione la- tifondistica, trovava giustificazione solo nella prospettiva di dover organizzare flussi migratori, come poi in parte accadrà, dall’area abruzzese verso quella toscana. Nei primi anni la discussione si accentrò sul problema del “fuori Fucino” , vale a dire sull’allargamento del territorio da sottoporre alla giurisdizione dell’Ente, oltre i circo- scritti confini dell’ex alveo. Tra le forze locali c’era la piena consapevolezza che solo un intervento dello stato avrebbe potuto aprire la via allo sviluppo. Per le comunità la rincorsa a stare dentro il comprensorio costituiva il modo più realistico di difendere i propri interessi. Un’intesa tra i partiti di sinistra e settori della De portò alla legge 9 agosto 1954, n. 639, con la quale si istituiva — del tutto staccato da quello della
83 Paolo Cinanni, Lotte per la terra nel Mezzogiorno. 1943-1953, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 91 sgg.; Giovanni Russo, Baroni e contadini, Bari, Laterza, 1979, pp. 7 sgg.; P. Ginsborg, Storia d ’Italia, cit., p. 170.
Azienda modello o latifondo? 671
Maremma — l’Ente Fucino, alla cui competenza venne affidato un territorio più che triplicato rispetto al precedente: ben 155.000 ettari distribuiti in dieci comuni. L’Ente Fucino si ritrova infatti due classici problemi: la parcellizzazione fondiaria e il sovrappo- polamento. Sul cosiddetto accorpamento la letteratura meridionalistica aveva speso fiumi di parole senza alcun esito. Negli anni del dopoguerra l’argomento continuava ad essere al centro del dibattito. Nel Fucino occorreva fare i conti con una situazione intricatissima, specie per gli affitti. Ufficialmente risultavano 9.918 intestatari, ma coloro che direttamente o indirettamente avevano a che fare con quel rapporto — chiarisce Pizzuti84 — ammontavano almeno a 15.800. Ad ogni contratto corrispondevano di solito più corpi fondiari: talora oltre 10 quote, distinte tra loro per ubicazione, qualità e giurisdizione comunale. Le quote potevano a loro volta comporsi di più parcelle. Queste ultime erano 28.853, di cui il 73 per cento non superiore al mezzo ettaro, mentre il 93 per cento copriva appena il 17 per cento della superficie.
Un quadro pertanto assai complicato, dai risvolti non soltanto economici e sociali, co- m’è facile intuire, ma anche psicologici. Per metterci mano nel modo più indolore possibile — e dunque senza rischiare un ennesimo fallimento — l’Ente ritenne di dover confermare il possesso della terra a tutti gli affittuari che già ne beneficiavano al momento
della riforma. Grazie a tale criterio l’accor- pamento, col consenso pressoché unanime, potè finalmente realizzarsi: un risultato che per certi versi aveva del miracoloso, ma purtroppo anche dei limiti. Le quote ricostituite (nel Fucino non si ebbero “poderi”) furono in effetti ben 9.146, oscillanti per dimensione da uno a quattro ettari85. In quest’opera di ricomposizione fondiaria il Fucino divenne una sorta di laboratorio nazionale: il modello era l’azienda coltivatrice autosufficiente, capace di garantire un normale livello di vita e di occupare la forza lavoro di una famiglia media. Neppure tale obiettivo, però, venne del tutto raggiunto. Il risultato fu piuttosto di livellare verso il basso la struttura aziendale, ponendo la maggior parte dei coltivatori nell’impossibilità di proiettarsi sul mercato. Quando infatti si passò alle assegnazioni, ci si trovò di fronte a circa 11.600 domande, di cui 1.900 avanzate da braccianti e il resto da ex affittuari. I primi vennero quasi tutti esclusi. Dei secondi, una buona parte (3.725), trovandosi nei limiti prescritti, si vide confermata la propria quota; un nucleo ristretto (263) se la vide ridurre ad un massimo di quattro ettari; ma tutti gli altri — circa 4.900 — dovettero accontentarsi della misura minima (appena un ettaro), certamente non sufficiente ad assicurare neppure l’autosostentamento. Ancora una volta, dunque, ragioni d’ordine sociale avevano finito con l’imporsi sulla razionalità
84 A. Pizzuti, Le affittanze agrarie, cit., 12. È documentato peraltro che il 42 per cento delle aziende era ubicato esclusivamente o parzialmente in comune diverso da quello di residenza dell’affittuario; non mancavano neppure casi di ubicazione in cinque comuni (Antonio Castracaro, La riforma agraria neI Fucino, 1954).85 R. Colapietra, La Riforma nel Fucino, “Nord e Sud”, 1957, n. 31, pp. 77-108, cui si rimanda anche per gli altri dati che seguono, a meno di diversa indicazione. Sugli esiti complessivi della riforma nel fucino si vedano Russel King, Land Reform: the Italian Experience, London, 1973, pp. 86-87; Michele Bonaduce, Costi e risultati economici della riforma agraria in Puglia, Lucania e Molise, Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 182-187; Istituto nazionale di sociologia rurale, La riforma fondiaria: trent’anni dopo, Milano, Angeli 1979, 2 voli.; Franco Mercurio, Saverio Russo, L ’organizzazione spaziale della grande azienda, “Meridiana”, 1990, n. 10, pp. 115-120 (anche per una sintesi dei criteri economici e sociali che ispiravano la riforma); Sara Follacchio, Trasformazioni della società rurale nel Fucino dall’applicazione dell riforma agraria, in Aa.Vv., Contributi per una storia dell’Abruzzo contemporaneo, Milano, Angeli, 1992, pp. 187-218. Un quadro critico sugli effetti della riforma nel Mezzogiorno d’Italia, con gli indispensabili rimandi bibliografici, si trova anche in P. Ginsborg, Storia d ’Italia, cit., pp. 173-187.
672 Costantino Felice
economica delle scelte, pur nel quadro di indirizzi che nel dopoguerra, come nel resto d’Italia86, si rifacevano al classico modello cerealicolo-pastorale.
Nel 1955 la dimensione media delle quote risultava inferiore all’ettaro e mezzo, mentre ad ogni addetto ne toccava 1,25: i valori più bassi tra tutte le aree interessate alla riforma. Gran parte degli assegnatari del Fucino — è vero — continuava a possedere nelle zone montane piccoli fondi che arrotondavano l’azienda, tanto che mediamente questa risultava di 2,19 ettari87. A parte però la modestia anche di tale dato, si trattava in genere di appezzamenti frammentati e di scarsa consistenza. L’auspicio del Pizzuti — espresso a conclusione del suo utilissimo studio — che gli affittuari di un tempo si trasformassero con la riforma in “liberi imprenditori agricoli”, era ancora lontano dal- l’avverarsi. Inoltre non pochi contadini, constatando di non potercela fare con le quote ottenute, dovettero ad un certo punto cederle, per emigrare o cambiare lavoro. Veniva così a ricrearsi un mercato semiclandestino della terra, analogo a quello dei subaffitti al tempo dei Torlonia, che a stento l’Ente, tramite un’apposita commissione di “dinamica agraria” , riuscì a controllare, limitando l’ulteriore spezzettamento. L’esiguità di gran parte dei nuovi possedimenti, insieme allo sviluppo della meccanizzazione, costituiva naturalmente un ostacolo anche per l’incremento del patrimonio zootecnico, da più parti auspicato. Un’altra conseguenza — forse non del tutto negativa, se vista
col senno del poi — fu l’impossibilità di costruire case coloniche sparse, al cui posto si preferirono i “borghi residenziali” .
A compromettere il buon esito della riforma era ancora una volta il sovrappeso demografico. Stando ai dati del censimento 1951, due terzi della popolazione del comprensorio (66.316 residenti) erano dediti all’agricoltura: in alcuni centri (Aielli, Ortuc- chio, Trasacco) il grado di ruralità raggiungeva l’80 per cento, mentre solo ad Avezza- no scendeva al 40 per cento. L’addensamento era di 148 abitanti per kmq; considerando però che la popolazione gravitava economicamente quasi tutta sulla piana dell’ex alveo, esso saliva in effetti ad oltre 300: un valore di gran lunga superiore alla media nazionale (156 abitanti per kmq) e persino a quello di aree, come il Lodigiano (250), ben altrimenti sviluppate tanto dal lato industriale che agricolo88. Sul fatto che fosse questo il problema principale da affrontare — lo sfoltimento della popolazione rurale — c’era piena consapevolezza nei massimi dirigenti dell’Ente, a cominciare dallo stesso Medici89. Ma divergenti risultavano le soluzioni prospettate, tanto da far precipitare l’Ente in una difficile crisi. Alcuni puntavano, ispirandosi al modello agronomico tradizionale, sulla piena valorizzazione delle potenzialità agrarie e zootecniche della zona; altri viceversa — le sinistre in particolare (ma anche settori democristiani) — indicavano nell’industrializzazione la via più sicura per l’impiego della forza lavoro eccedente; altri ancora non vedevano altro sbocco
86 L. D ’Antone, Tecnici e progetti, cit., pp. 137-139.87 Giuseppe Barbero, Riforma agraria italiana. Risultati e prospettive, Milano, Feltrinelli, 1960, pp. 73, 78-80 e 115. Gli altri comprensori della riforma cui qui si fa riferimento sono quelli del Delta padano (32.336 ettari), della Maremma (132.132), della Campania (12.720), di Puglia-Lucania-Molise (166.278), della Calabria (73.571) e della Sardegna (74.496). Complessivamente le aziende agrarie del Fucino nel 1955 erano 9.085, di cui la massima parte (8.564) non superava i cinque ettari e solo 521 si collocavano per ampiezza tra i 5 e 20 ettari.88 Ente Fucino, La riforma fondiaria nel Fucino. I dati fondamentali, Avezzano, 1953, p. 8.89 In un discorso tenuto ad Avezzano il 27 febbraio 1952 egli aveva affermato: “Il problema dei problemi di questa contrada sta in un eccesso di popolazione che non può trovare adeguata sistemazione senza che si promuova un
Azienda modello o latifondo? 673
che un massiccio esodo migratorio. Naturalmente vi erano sfumature. Che in ogni caso dovesse esservi un deflusso di manodopera, quasi nessuno dubitava. I poteri differivano su modalità e quantità. Alla fine comunque, in parte organizzato in parte spontaneo, l’esodo ci fu anche dal Fucino: contingenti di lavoratori finirono in Maremma, diversi andarono a fare i bieticoltori in Francia o i minatori in Belgio, altri ancora presero la via tradizionale degli oceani.
Ma il Fucino continuava ad essere, anche terra di controtendenze; esso restava infatti un’area relativamente avanzata rispetto al resto della provincia, tanto da diventare meta — almeno il capoluogo Avezzano — di sia pur limitate correnti immigratorie. D’altro canto il complesso di opere realizzate, o comunque messe in cantiere già nei primi anni, nonostante il notevole ritardo con cui venne approntato un piano organico, fu di non poco conto. All’indomani della costituzione dell’Ente Fucino, un miliardo di lire risultava destinato alla viabilità; un altro alle attività agrarie, soprattutto per la fornitura di attrezzi e concimi; una somma di poco superiore riguardava i progetti di economia montana; mezzo miliardo i lavori di sistemazione agraria; analoga somma un piano d’irrigazione; 700 milioni l’edilizia e circa 300 le attività sociali90. Per quanto utilizzati tra mille lungaggini e spesso in base a logiche clientelari, questi finanziamenti non poteva
no non ripercuotersi sulla crescita economica e sul tenore di vita delle popolazioni. Le infrastrutture agrarie registravano un consistente irrobustimento: nel 1959, allorquando su quasi 16.000 ettari espropriati ne erano stati assegnati 13.475 suddivisi in 9.146 quote (solo 170 finite a braccianti), risultavano realizzati 356 km di strade interpoderali e 182 poderali (a parte le centinaia riattate), 62 fabbricati rurali e 6 borghi residenziali, oltre ad una trentina di stalle e alcune decine di pozzi91. Nell’insieme degli investimenti fondiari — una voce piuttosto modesta sul complesso dei capitali — di rilievo quelli effettuati dai proprietari conduttori: al 31 dicembre 1955 quasi P87 per cento, su un totale di oltre 50.000 lire ad ettaro. Significativi erano anche gli incrementi di produttività. In poco tempo, dall’inizio della riforma a metà anni cinquanta, la resa del grano passava da 24 a 43 quintali per ettaro, quella della barbabietola da 250 a 340, quella delle patate da 140 a 200. La terra nel Fucino continuava ad essere la principale fonte di ricchezza: si è calcolato che nel 1954 su707.000 lire di capitali complessivi per ogni ettaro di superficie (il valore più alto tra tutte le aree investite dalla riforma), ad essa erano da attribuirsi 492.000 (ancora il valore più alto), contro solo 50.000 di investimenti fondiari e 165.000 di capitale agrario92. A tali risultati, comunque, si perveniva anche grazie all’introduzione di avanzate tecniche
forte sviluppo delle industrie e dei commerci, senza che si creino occasioni di lavoro che non siano rappresentate soltanto dalla pulitura dei fossi, dalla manutenzione delle strade e da tutti gli altri consueti e tradizionali lavori”. Lo stesso concetto ribadì nello scritto II problema fondamentale della riforma nel Fucino, in “Agricoltura”, 1953, n. 3, poi sostanzialmente rifuso, con l’aggiunta di documenti, nella citata opera ufficiale dell’Ente Fucino. Cfr. R. Colapietra, La Riforma nel Fucino, cit., pp. 94-101.90 R. Colapietra, La Riforma nel Fucino, cit., pp. 93-96. I circa 12 miliardi spesi a tutto il 1956 dall’Ente di riforma vennero impiegati senza alcun piano preordinato, ma secondo logiche spesso clientelari ed elettoralistiche. In altri termini tra l’Ente e gli assegnatari — nota ancora Colapietra — si erano andati intessendo i medesimi rapporti di assoggettamento che i Torlonia avevano avuto a suo tempo con gli affittuari: l’unica differenza — per molti versi un’aggravante — consisteva nel fatto che mentre questi ultimi rappresentavano, “agli occhi dei devoti, la più vasta somma di poteri”, l’Ente doveva sottostare a mille pressioni e condizionamenti.91 Franco Mercurio-Saverio Russo, L ’organizzazione spaziale, cit., pp. 118-119.92 G. Barbero, Riforma agraria, cit., pp. 45-59, 91 e 113, anche per i successivi valori della produzione lorda.
674 Costantino Felice
irrigatorie. Dopo la perforazione di decine di pozzi artesiani, constatatane l’insufficienza, venne adottato il sistema della pluvirrigazione a bassa pressione — uno dei primissimi esempi in Italia — con grande beneficio delle colture e degli erbai93. Non a caso del resto, tra tutte le aree di riforma, il Fucino offriva la più alta produzione lorda vendibile, con notevole percentuale, nella sua composizione, della zootecnia (20 per cento). Essa in verità era già consistente dall’inizio, tanto che per un certo tempo si mantenne stabile e qualche anno persino diminuì. Ma dal 1958 di nuovo tornava a crescere, raggiungendo la cifra record di 385.000 per ettaro di superficie agraria.
È probabile che i progressi in campo tecnico e produttivo, come allora si obiettava da settori della sinistra, non si traducessero immediatamente in aumenti di reddito; ma se ai finanziamenti in capitale costante e alla più intensa circolazione di beni si aggiunge la maggiore disponibilità monetaria dovuta a stipendi, salari, pensioni, prestiti, ecc., diventa impensabile che tutti questi meccanismi di attivazione economica (ad oltre 300 ammontavano i soli funzionari dell’Ente) non abbiano comportato, almeno in parte, un miglioramento complessivo delle condizioni di vita. L’aumento dell’occupazione fu determinato non tanto all’intensificazione dei processi produttivi sulle terre assegnate, quanto soprattutto all’attività di bonifica e trasformazione fondiaria, alle opere pubbliche e all’incremento del settore terziario. Nella composizione del reddito familiare degli assegnatari — prescindendo quindi da altre categorie che si avvantaggiarono della riforma, — oltre l’80 per cento nel 1955 risultava di provenienza
agricola; ma quel rimanente quasi 20 per cento di origine extraziendale — una percentuale che pure, in confronto alle altre aree della riforma, era di gran lunga la più bassa — costituiva un dato tutt’altro che trascurabile, soprattutto se si considera che esso si componeva per un 30 per cento circa di pensioni e rendite varie, aveva cioè una provenienza diversa tanto dal lavoro dipendente (50 per cento) che da quello indipendente (20 per cento)94. Accanto a sicuri elementi di sviluppo, cominciavano a manifestarsi, in altri termini, anche i primi sintomi dell’assistenzialismo. L’intervento massiccio dello Stato produceva anche le distorsioni partitiche e clientelati tipiche delle forme assunte dal welfare state nell’Italia meridionale.
Il fenomeno appare particolarmente vistoso in relazione alla nascita e allo sviluppo della cooperazione. Le leggi di riforma prevedevano che i compiti di “assistenza tecnica ed economico-finanziaria” alle nuove piccole proprietà coltivatrici passassero ad un certo punto dall’Ente alle cooperative, delle quali gli assegnatari avevano l’obbligo giuridico di far parte.
Si trattava del cosiddetto terzo momento, molto importante e delicato, dopo i primi due dell’esproprio e della trasformazione delle terre. Le cooperative potevano essere di due tipi: di “servizio”, per la gestione delle macchine agricole e la vendita di concimi, sementi, ecc., e “specializzate”, addette alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Le cose però, anche in questo caso, andarono in modo alquanto diverso da come fissato nei testi legislativi. Al 31 dicembre 1955, delle 35 cooperative allora previste ne risultavano formate solo 29, con 2.616 soci che rappresentano
93 Enrico Romano-Giorgio Pagliuca, La sperimentazione pluvirrigua a bassa pressione nel Fucino (i risultati dell ’anno 1958), Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, s.n.t.94 G. Barbero, Riforma agraria, cit., pp. 59 e 188-189.
Azienda modello o latifondo? 675
poco più di un quarto del totale degli assegnatari95.
A risultati così modesti contribuivano vari fattori. È probabile che ancora una volta pesasse la psicologia individualistica e diffidente dei contadini. Ma decisivo fu anche l’ambiguo e distorto comportamento dei partiti. Le sinistre, accusando l’Ente e le cooperative di scarsa democraticità, sconsigliarono i loro iscritti e simpatizzanti dall’a- derirvi. Da parte sua l’Ente, “solida nicchia” del potere democristiano, temendo una prevalenza di assegnatari comunisti e socialisti, si guardò bene dal sollecitarli al rispetto degli obblighi di legge. Le forze di opposizione finirono in tal modo col ritrovarsi all’esterno, o comunque ai margini, dei centri vitali attraverso cui si distribuivano risorse: per deliberata volontà della De, ma anche per loro incertezze ed errori. Come al solito, quando dalla fase della lotta e delle rivendicazioni si passava a quella deliberativa ed attuativa, le sinistre assumevano un atteggiamento ostruzionistico e difensivo che di fatto le collocava in una posizione di debolezza. Ed infatti, non diversamente da quanto accadeva in altre realtà meridionali, man mano che si andava avanti nel processo gestionale, coinvolgendo aspettative ed
interessi concreti, progressivamente esse perdevano adesioni, con vistosi riflessi sul piano elettorale96. I consensi, in altri termini, si accentravano sul partito che, disponendo del potere, consentiva di fare della politica una risorsa anche dal lato economico.
Col tempo, comunque, le cooperative crescono e si rafforzano. Nel 1958 esse diventano 43, di cui due “specializzate”, tutte riunite in un consorzio e con 3.762 associati. L’attività di servizio si riassumeva nei seguenti dati: 463 milioni di lire per dotazione macchine, 466 per distribuzione concimi, sementi, ecc., 827 per vendita di prodotti97. Cifre non esaltanti, ma neppure trascurabili. Anche se nel Fucino stentava a decollare uno “sviluppo autocentrato” , i fattori di crescita continuavano a consolidarsi. Sul complesso degli assegnatari andava selezionandosi un’élite di agricoltori che — magari già favoriti in partenza per qualità e dimensioni delle quote ottenute — più di altri si mostravano dotati di senso dell’impresa. Prendeva consistenza, insomma, quella piccola borghesia rurale che era tra gli obiettivi politici e sociali della riforma agraria, almeno nella sua ispirazione moderata.
Costantino Felice
95 R. Colapietra, La Riforma nel Fucino, cit., pp. 98-99.96 R. Colapietra, La Riforma nel Fucino, cit., pp. 101-108. Sui comportamenti e gli sviluppi politici connessi all’attuazione della riforma, con riferimento alla Calabria — una realtà in questo molto analoga a quella abruzzese — si vedano le considerazioni di Giuseppe Galasso, La riforma agraria in Sila e nei territori jonici contermini, “Nord e Sud” 1957, pp. 30-46, oltre a Paolo Pezzino, La riforma agraria in Calabria. Intervento pubblico e dinamica sociale in un’area del Mezzogiorno. 1950/1970, Milano, Feltrinelli, 1977.97 G. Barbero, Riforma agraria, cit., pp. 63-64.
Costantino Felice (1945) lavora presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università “D’Annunzio” a Pescara. I suoi studi riguardano prevalentemente la storia economica e sociale del Mezzogiorno, con attenzione particolare all’Abruzzo e al Molise. Tra l’altro ha pubblicato II disagio di vivere. Il cibo, la casa, le malattie in Abruzzo e Molise dall’Unità al secondo dopoguerra (Milano, Angeli, 1989).
676 Costantino Felice
Tabella 1. - Principato de!Fucino: rendita netta (lire)
Azienda in economia Mezzadria Affittanza(1.341 ettari) (1.248) (9.576)
1909-10 187.816 177.673 1.265.0311910-11 230.276 214.876 1.460.3011911-12 300.839 204.223 1.412.0441912-13 287.243 262.862 1.412.8301913-14 297.773 234.270 1.435.704
Fonte: R e la z io n e V in cen ti, cit.
Tabella 2. - Principato del Fucino: rendita netta (lire)
Azienda in economia Mezzadria Affittanze
1915 95.600 163.118 942.7191916 251.037 292.588 1.272.2741917 540.789 335.786 1.363.0841918 1.186.727 884.587 1.357.7341919 1.055.502 842.162 1.395.367
Fonte: R e la z io n e V in ce n ti, cit.
Tabella 3. - Medie percentuali delle rendite e delle spese per ettaro (lire)
1910-1914 1915-1919 Incremento (%)
Rendita lorda 161 210 30,4Rendita netta 108 141 31,7Spese 54 69 27,8
Fonte: R e la z io n e V in cen ti, cit.
Tabella 4. - Principato del Fucino: utile netto (lire)
1931 6.545.185 1934 5.240.1641932 6.051.401 1935 7.557.5431933 5.715.467 1936 7.168.733
Fonte: B ila n c i 1 931-1937 .
Tabella 5. - Produzione unitaria: medie annuali (quintali)
1926-30 1931-35 1936
Grano 20,46 24,93 23,22Bietola 317,20 330,65 359,83Patate 172,02 221,81 220,75
Fonte: B ila n c io 1936.
![Page 1: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Azienda modello o latifondo? - italia-resistenza.it · Relazione del lago Fucino e dell’emmissario di Claudio dell’architetto I. S. [Ignazio Stile] scritta verso il cadere del](https://reader042.fdocumenti.com/reader042/viewer/2022022510/5c6782e009d3f28e058bd6fb/html5/thumbnails/42.jpg)