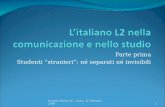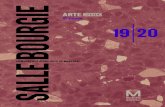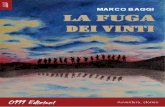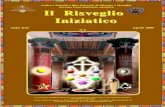VADEMECUM DEL MEDIATORE - Genitori Ancora...“E quando arriva la notte e resto sola con me La testa...
Transcript of VADEMECUM DEL MEDIATORE - Genitori Ancora...“E quando arriva la notte e resto sola con me La testa...
VADEMECUM DEL MEDIATORE a cura dell’avv. Laura Raveglia (2015)
“E quando arriva la notte e resto sola con me La testa parte e va in giro in cerca dei suoi perchè
Né vincitori né vinti si esce sconfitti a metà L’amore può allontanarci la vita continuerà”
da “La notte” di Arisa
Indice
1. Matrimonio
1.1. Doveri tra i coniugi
1.2. Doveri verso i figli
1.3. Scioglimento del matrimonio
1.3.1. Separazione consensuale
1.3.2. Separazione giudiziale
2. Regime patrimoniale della famiglia
2.1. Regime patrimoniale primario
2.2. Regime patrimoniale secondario
2.2.1. Comunione legale
2.2.2. Separazione dei beni
3. Legge 10 dicembre 2012 n. 219 3.1. Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali 4. Legge 10 novembre 2014 n. 162 e Legge 6 maggio 2015 n. 55
4.1. Premessa
4.2. L. 162/2014
4.1.1. Negoziazione assistita da avvocati
4.1.2. Separazione o divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato
Civile.
4.3. L.55/15 - Divorzio breve - in vigore da 26 Maggio 2015
1. Matrimonio
1.1. DOVERI TRA I CONIUGI
Art.143 c.c.
(Doveri che discendono dal matrimonio)
→ obbligo reciproco alla fedeltà;
→ all’assistenza morale e materiale;
→ alla collaborazione nell’interesse
della famiglia;
→ alla coabitazione;
Entrambi i coniugi sono tenuti in
relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o
casalingo a contribuire ai bisogni della
1.2. DOVERI VERSO I FIGLI
Art. 147 c.c.
(Doveri verso i figli)
Il matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l’obbligo di mantenere, istruire
educare e assistere moralmente i figli nel
rispetto delle loro capacità, inclinazioni
naturali e aspirazioni secondo quanto
previsto dall’art. 315 bis c.c..
Art. 148 c.c.
(Concorso negli oneri)
I coniugi devono adempiere l’obbligo di
famiglia.
Art. 151 c.c.
(Addebito della separazione)
Il giudice, se richiesto, nel pronunciare la
separazione dichiara a quale dei coniugi
sia addebitabile la separazione in
considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio (art. 143 c.c.).
cui all’art. 147 c.c. secondo quanto
previsto dall’art. 316 bis c.c., vale a dire in
proporzione alle rispettive sostanze, e
secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi
sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine
di prossimità, sono tenuti a fornire ai
genitori stessi i mezzi necessari affinchè
possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli.
Conseguenze
1.3. SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Il matrimonio si scioglie per richiesta esclusivamente di uno dei coniugi o di
entrambi.
La separazione si propone innanzi al Tribunale ordinario e può essere
consensuale o giudiziale. Con la L. 162/2014, emessa nell’ambito del
riassetto del procedimento civile finalizzato alla riduzione dell’arretrato
giudiziario, le coppie che vogliano consensualmente separarsi o divorziare
possono ricorrere a due nuove opzioni alternative al ricorso congiunto al
Tribunale. Sono state infatti previste la negoziazione assistita da avvocati
oppure, al ricorrere di determinate condizioni, l’accordo presso l’Ufficio di
Stato Civile. (vedi infra)
1.3.1. Separazione consensuale avanti il Tribunale (art. 158 c.c.)
La separazione consensuale è fondata sul solo consenso dei coniugi
(consenso alla separazione e consenso sulle condizioni di separazione) e non
ha effetto senza l’omologazione del giudice, infatti la separazione
consensuale acquista efficacia con la omologazione del Tribunale.
Possiamo distinguere nella separazione consensuale avanti il Tribunale le
seguenti fasi:
I° Fase: Determinazione del contenuto dell'accordo
In questa fase (anche con l'assistenza di un professionista, es. avvocato e/o
mediatore familiare) i coniugi predispongono il contenuto dell'accordo di
separazione.
In linea di massima l’oggetto dell’accordo sarà:
→ il diritto di visita: del genitore presso il quale i figli minori non saranno
stabilmente collocati (es. per esigenze connesse alle relazioni già
sviluppate, per salvaguardare gli equilibri psicofisici già consolidati ecc.).
In questo senso la previsione dei giorni in cui gli incontri avverranno, la
regolamentazione dei periodi di frequentazione durante le vacanze
estive e invernali e così via, assume la valenza di determinazione del
contenuto minimo nel senso che, proprio in ragione dell'applicazione
della disciplina dell'affidamento condiviso il genitore che non avrà
stabilmente i figli presso la propria dimora dovrebbe poterli incontrare
nei tempi concordati (salvo le ovvie esigenze di coordinamento);
→ l'assegno di mantenimento del/dei figlio/figli: assegno cosiddetto
perequativo. Sul punto si impone una precisazione: al mantenimento
dei figli (minori o maggiorenni non economicamente indipendenti)
concorrono entrambi i genitori proporzionalmente alla loro capacità di
lavoro professionale o casalingo, di conseguenza quanto dovuto, ad
esempio dal padre, non deve essere inteso come fonte esclusiva del
sostentamento del figlio per il quale l'importo è versato ma, al
contrario, come quota concorrente (proporzionata al reddito
dell'obbligato) perequativa rispetto a quanto impiegato anche dall'altro
genitore. Ancora rispetto all'ammontare dell'importo dovuto a titolo di
mantenimento (imprescindibile ed irrinunciabile) verrà anche previsto
l'adeguamento automatico agli indici ISTAT e la partecipazione alle
spese scolastiche, mediche, sportive e/o straordinarie, normalmente
nell'ordine del 50% ma che può prevedere percentuali diverse;
→ determinazione dell'eventuale assegno in favore del coniuge
economicamente svantaggiato (coniuge debole) ed eventuale previsione
di modifica o adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT o
modificabile in ragione del verificarsi di particolari situazioni (es.
cessazione di uno stato transitorio di disoccupazione);
→ assegnazione della casa coniugale, generalmente al coniuge collocatario
dei figli minori. Si tenga conto che l’assegnazione della casa coniugale
ha una valenza economica ( es. equivalente del canone di locazione di
un immobile della medesima natura);
→ ulteriori regolamenti patrimoniali attraverso i quali i coniugi
disciplinano la sorte, ad esempio, di beni in proprietà comune ed
indivisa, della vettura di famiglia (e delle relative spese), pagamento rate
di mutui contratti in costanza di matrimonio, sorte di rapporti bancari
cointestati ecc..
Al fine della sua piena validità il contenuto dell'accordo di separazione deve
essere assoggettato al vaglio del Giudice ovvero, essere sottoposto a giudizio
di omologazione del tribunale. Per ottenere questo (la c.d."omologa" della
separazione) il contenuto dell'accordo raggiunto dai coniugi deve essere
riportato all'interno di uno specifico atto: il ricorso. Questo, indirizzato al
Presidente del Tribunale (scelto in base a criteri di competenza territoriale
vale a dire ultima residenza comune dei coniugi), oltre quanto detto prima,
dovrà contenere la richiesta della fissazione di udienza di comparizione delle
parti (c.d. udienza presidenziale) ed essere accompagnato dalla
documentazione richiesta (certificati anagrafici ed eventuale
documentazione fiscale afferente gli ultimi tre anni).
II° Fase: Fissazione dell'udienza di comparizione delle parti(c.d. udienza presidenziale)
All'esito di una sommaria valutazione del contenuto del ricorso, viene fissata
l'udienza di comparizione delle parti (c.d. udienza presidenziale) alla quale i
coniugi devono presenziare personalmente. In questa udienza viene esperito
da parte del Presidente del Tribunale, in primo luogo, il tentativo di
conciliazione e, successivamente in caso di esito negativo, viene redatto il
verbale d'udienza che conterrà l'indicazione dell'accordo raggiunto e del suo
contenuto. Il verbale verrà sottoscritto di pungo dai due coniugi.
III° Fase: Omologazione dell'accordo e visto del Pubblico ministero
Successivamente alla "fase presidenziale" l'accordo di separazione viene
sottoposto al giudizio di omologazione (fase collegiale) ed al visto del
Pubblico ministero (in caso di presenza di figli minori) sino a che non vi
sarà la pronuncia definitiva (omologazione della separazione) debitamente
comunicata alle parti. La separazione consensuale acquista efficacia con la
omologazione del Tribunale il quale provvede in camera di consiglio su
relazione del presidente. E' possibile giungere a questa fase anche nel caso di
conversione di una separazione giudiziale in consensuale all'interno della
quale i coniugi riescano a raggiungere un accordo che rende inutile la
prosecuzione del giudizio contenzioso.
Con l'omologazione, in sintesi, si avranno i seguenti effetti:
→ autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l’obbligo del mutuo
rispetto (parziale cessazione degli obblighi nascenti dal matrimonio;
viene meno l’obbligo reciproco di fedeltà e di coabitazione);
→ efficacia esecutiva dell'accordo di separazione;
→ il termine di 6 mesi per la presentazione del ricorso per la richiesta di
cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) decorreranno
dalla data dell’udienza presidenziale ma nel giudizio si impone la
produzione dell’ omologa del tribunale;
→ il contenuto degli accordi (specie di natura economica) può essere
sottoposto a modifica o revisione anche dopo l'avvenuta omologazione,
sempreché intervengano fatti nuovi, mediante la proposizione di
apposita istanza di modifica;
→ in ogni momento, anche successivo all'omologazione della separazione
consensuale, è possibile la riconciliazione dei coniugi con il ripristino
dello status quo ante. La riconciliazione può avvenire sia per espressa
volontà delle parti, sia in ragione di comportamenti (es. ripristino della
convivenza e della comunione materiale e spirituale) incompatibili con
lo status di coniugi separati.
1.3.2. Separazione giudiziale (art. 151 c.c.)
In mancanza di accordo, può essere richiesta la separazione giudiziale anche
da uno solo dei coniugi quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile
la prosecuzione delle convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole.
Possiamo distinguere nella separazione giudiziale le seguenti fasi:
I° Fase: Conferimento dell’incarico all’avvocato
A differenza della separazione consensuale dove la presenza dell'avvocato (o
degli avvocati) è facoltativa, (salvo che il singolo Tribunale non imponga
diversamente), nella separazione giudiziale le parti devono essere
necessariamente assistite da un avvocato. Con il conferimento del mandato
(delega) all'avvocato inizia la fase di valutazione del professionista al fine di
raccogliere ogni informazione utile alla corretta istruzione del ricorso. Nello
stesso tempo è corretta prassi contattare l'altro coniuge (la "famosa" lettera)
al fine di poter valutare congiuntamente l'ipotesi che la separazione avvenga
in modo consensuale piuttosto che all'esito di un contenzioso. In questa
fase, è senz'altro utile il tentativo dell’avvocato di ridurre l'eventuale
conflittualità evitando l’accesso ad altri strumenti di tutela di portata ben più
ampia (es. presentazione di querele con tutte le conseguenze che ne
derivano in ipotesi di procedibilità d’ufficio non potendo essere rimesse).
Ancora, spesso con la collaborazione del collega di controparte, è possibile
tentare un percorso di negoziazione assistita (vedi infra) o di mediazione
familiare.
Tuttavia, in ipotesi di insuccesso dei tentativi di negoziazione dell’avvocato e
mediazione del mediatore famigliare specie quando la conflittualità della
coppia si è già ripetutamente manifestata nel ricorso alla giustizia penale
(presentazione reciproca di querele), l'unica alternativa è quella di proseguire
con la redazione e il deposito della separazione giudiziale.
II° Fase: Redazione e presentazione del ricorso
Sia la separazione giudiziale che la consensuale si propongono con ricorso al
Tribunale ordinario del luogo dell’ultima residenza comune ovvero, in
mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza. Nel ricorso
deve essere indicata l’esistenza di figli.
La separazione giudiziale, prevede lo svolgersi di una vera e propria fase
contenziosa.
Si ricorre, dunque, alla separazione giudiziale quando l'istanza di separazione
consensuale non può essere perfezionata atteso che i coniugi non riescono a
raggiungere un accordo di separazione, o quando, ipotesi non infrequente, si
vuole che la "colpa" della separazione (addebito) sia addebitata
esclusivamente ad uno dei coniugi in ragione di specifici comportamenti
tenuti in costanza di matrimonio contrari ai doveri che discendono dal
matrimonio medesimo. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo
di separazione deve essere ricompreso anche il caso, non infrequente, in cui
solo uno dei due coniugi voglia separarsi mentre l'altro rifiuti di
sottoscrivere una separazione consensuale.
Come per la separazione consensuale, la separazione giudiziale ha inizio con
la presentazione del ricorso il cui contenuto sarà tuttavia ben diverso dalla
semplice esigenza di sottoporre al giudizio di omologazione l'accordo
congiunto di separazione.
Il ricorso, infatti, come anticipato, potrà contenere anche una specifica
domanda di addebito quando il ricorrente ritenga che la causa della
separazione sia da attribuire esclusivamente all'altro coniuge.
Una volta effettuato il deposito, verrà comunicata la data dell'udienza di
comparizione personale delle parti (fase presidenziale) ed il tutto sarà
notificato, a cura dell’avvocato alla controparte la quale, potrà costituirsi nei
termini concessi dal presidente (es. in caso con la proposizione di domanda
riconvenzionale es. addebito reciproco).
III° Fase: Udienza di comparizione,provvedimenti urgenti adottati dal presidente nell’interesse dei coniugi e della prole
Come nella separazione consensuale, all'udienza presidenziale verrà esperito
il tentativo di conciliazione. All’udienza Presidenziale il Presidente deve
sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente e deve tentare la
conciliazione. Se la conciliazione non riesce il presidente sentiti i coniugi e i
rispettivi difensori dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti
che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il
giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. I provvedimenti temporanei e urgenti che il presidente adotta
riguardano: Affidamento dei figli (art. 337 ter) ad entrambi i genitori;
assegno di mantenimento dei figli (art. 316 bis); assegnazione della casa
familiare (art. 337 sexies); eventuale assegno di mantenimento in favore del
coniuge che non gode di adeguati redditi propri e cui prima facie non è
addebitabile la separazione.
Il Presidente determina, dunque, l'assetto della coppia tenendo conto della
necessità immediata di far cessare la convivenza, dando possibilità alle parti
di porre in essere uno scambio di memorie integrative rispetto al contenuto
del ricorso che, in teoria, potrebbe essere stato limitato solo alla richiesta di
instaurazione del giudizio.
Deve poi rilevarsi come ex art. 337 octies c.c. prima dell’emanazione dei
provvedimenti temporanei e urgenti riguardo ai figli ex art. 337 ter c.c.,
qualora ne ravvisi l’opportunità il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro
consenso può rinviare l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli per
consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti,- i mediatori appunto
– tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare
riferimento alla tutela dell’interesse materiale e morale dei figli.
Sempre ex art. 337 octies il Giudice dispone l’ascolto del figlio minore che
abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di
discernimento. Tuttavia, nei procedimento in cui si prende atto di un
accordo dei genitori o si omologa un accordo relativo alle condizioni di
affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con
l’interesse del minore o manifestamente superfluo.
L’ascolto del minore è in linea con quanto sancito dall’art. 315 bis c.c.
secondo cui il figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età
inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte
le questioni e le procedure che lo riguardano.
IV° Fase: Istruzione della causa e sentenza parziale
In questa fase, il Giudice istruttore designato dal Presidente del Tribunale
all’esito dell’udienza presidenziale, se richiesto opera sostanzialmente una
scissione rispetto al contenuto dell'intero giudizio attraverso la c.d. sentenza
parziale. In effetti, può essere anticipato, su richiesta dell’avvocato, il
momento in cui i coniugi (che restano tali sino al divorzio)
acquisiscono"ufficialmente" lo stato di separati (con le necessarie
conseguenze) appunto con la sentenza parziale resa in corso di giudizio. Le
restanti questioni (es. addebito della separazione) saranno poi decise in sede
di sentenza definitiva.
Si noti che con le modifiche non saranno più necessari 3 anni dall’udienza
presidenziale per presentare la domanda di divorzio bensì basteranno sei
mesi in ipotesi di separazione consensuale, e un anno in caso di separazione
giudiziale.
Durante tutto lo svolgimento della fase contenziosa è possibile, mediante la
presentazione di idonee istanze, chiedere la modifica dei provvedimenti
assunti in fase presidenziale (es. sopraggiunta e non temporanea difficoltà
economica dell'eventuale obbligato al mantenimento ecc..) Ancora, sino alla
pronuncia della sentenza definitiva è possibile sia la riconciliazione dei
coniugi con il conseguente abbandono del contenzioso come è pure
possibile la conversione della separazione giudiziale in separazione
consensuale in conseguenza, ad esempio, del positivo esito di un percorso di
mediazione familiare o in ogni caso per sopravvenuto accordo.
V° Fase: Decisione e sentenza definitiva.
Successivamente all'emanazione della sentenza parziale, la causa prosegue
fino alla sentenza definitiva che costituisce l'esaurimento della fase di primo
grado del giudizio. Il contenuto della sentenza riguarda l'intero giudizio
e"risponderà" in modo più o meno soddisfacente alle istanze delle parti
portate all'attenzione del tribunale con i rispettivi atti introduttivi. La
sentenza è, ovviamente, appellabile e le statuizioni in essa contenute
possono dunque essere modificate. Sino al momento della sentenza
definitiva è ancora possibile la conversione della separazione giudiziale in
separazione consensuale. E, ancora, anche dopo l'emanazione della sentenza
(come in ogni fase in corso di giudizio) è possibile la riconciliazione dei
coniugi con il ripristino delle status quo ante. La riconciliazione può avvenire
sia per espressa volontà delle parti, sia in ragione di comportamenti (es.
ripristino della convivenza e della comunione materiale e spirituale)
incompatibile con lo status di coniugi separati. Il Giudice pronunciando la
separazione dichiara ove ne sia richiesto a quale dei coniugi sia addebitabile
la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio.
2. Il regime patrimoniale della famiglia
2.1. REGIME PATRIMONIALE PRIMARIO (ART. 143 C.C., 147
C.C., 148 C.C.)
Si rinvia ai paragrafi “1.1. Doveri che discendono dal matrimonio” e “1.2. Doveri
verso i figli” del presente vademecum.
2.2. REGIME PATRIMONIALE SECONDARIO
Art. 159 c.c. "[...] il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa
convenzione stipulata a norma dell'art. 162 cod. civ., è costituito dalla comunione dei
beni".
2.2.1. Comunione legale
E’ opportuno fin da ora precisare che la comunione legale non è comunione
universale, cioè non ricade su tutto quanto appartiene a ciascun coniuge.
Secondo quanto previsto dall'art. 177 c.c., costituiscono oggetto della
comunione:
(i) Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio (es. mobili di casa, auto, appartamento), ad esclusione di
quelli relativi ai beni personali. Non vi fanno parte i redditi, ma i
risparmi se residuano (de residuo) allo scioglimento della comunione.
(ii) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
(impresa familiare art.230 bis);
(iii) Gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma
appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio.
Sono esclusi i "beni personali" di ciascun coniuge (art. 179 c.c.):
(i) I beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
(ii) I beni acquisiti successivamente il matrimonio per effetto di donazione
o successione, salvo che siano espressamente attribuiti alla comunione;
(iii) I beni di uso strettamente personale;
(iv) I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
(v) I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione
attinente alla perdita totale e/o parziale della capacità lavorativa;
(vi) I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o
col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto
dell'acquisto.
L'amministrazione dei beni della comunione (art. 180 c.c.) spetta
disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Tuttavia, il compimento degli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, spetta congiuntamente ad entrambi i
coniugi.
Se ha ad oggetto
beni immobili o
mobili registrati
sono annullabili
entro un anno.
Atti compiuti da un coniuge
senza il necessario consenso
Se hanno ad oggetto beni mobili, il
coniuge è obbligato a ricostituire la
comunione ovvero, qualora non sia
possibile, a pagare alla comunione
l'equivalente.
Lo scioglimento della comunione (art.191 c.c. novellato L. 55/15) si verifica
(i) nella separazione giudiziale nel momento in cui il Presidente del
tribunale autorizza i coniugi a vivere separati;
(ii) nella separazione consensuale alla data di sottoscrizione del processo
verbale di separazione consensuale.
2.2.2. Separazione dei beni
Art. 215 c.c. "[...] convenire che ciascuno di essi (coniuge) conservi la titolarità esclusiva
dei beni acquistati durante il matrimonio".
In sostanza, è il regime in forza del quale ciascun coniuge rimane esclusivo
titolare dei beni di sua pertinenza e di ogni acquisto che abbia ad effettuare,
con diritto ad amministrare il suo patrimonio senza ingerenze dell'altro
coniuge.
E’ necessario un accordo stipulato con atto pubblico o anche mediante una
semplice dichiarazione inserita nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Rimane, tuttavia, fermo quanto stabilito dall'art.143,3° comma, c.c. e cioè:
“Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in base alle proprie sostanze ed alla propria
capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia” e ciò
non solo in quanto ex art. 315 bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle
sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” ma anche perché ex art. 316 bis
c.c.: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle
rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
3. Legge 10 dicembre 2012 n. 219
3.1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI
FIGLI NATURALI
Fin dalle prime discussioni fu evidente che la legge 10 dicembre 2012 n.219
avrebbe segnato una svolta nell’ordinamento giuridico italiano in materia di
filiazione, realizzando finalmente quello che da tempo in molti chiedevano:
l’uguaglianza tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di
fuori del matrimonio o adottivi.
Se l’art. 74 del codice civile definiva, infatti, la parentela come “il vincolo tra
persone che discendono da uno stesso stipite”, il nuovo testo dello stesso articolo,
introdotto con l’art.1 della L. 10 dicembre 2012 n. 219, sottolineerà che tale
vincolo non sorge solo nel caso di figli nati all’interno del matrimonio ma
anche se la filiazione sia avvenuta al di fuori del matrimonio o in caso di figli
adottivi.
Si tratta di una innovazione nell’ordinamento giuridico italiano in quanto fino
ad allora i figli nati al di fuori del matrimonio non erano legati da alcun
vincolo ai parenti paterni (es.zii,nonni).
Viene introdotta una ulteriore innovazione con la modifica del testo
dell’art.315 c.c. dove viene riconosciuto a tutti i figli lo stesso stato giuridico.
Il figlio ha il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti
significativi con i parenti. A tale scopo la legge attribuisce ai nonni la
possibilità di agire in giudizio per far valere il diritto dei nipoti alla continuità
del rapporto con i nonni.
Una riforma quindi che va ad interessare la materia della filiazione andando
ad abbattere le disuguaglianze esistenti nell’ordinamento giuridico. Non si
farà più riferimento a figli legittimi e figli naturali ma a figli nati all’interno del
matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio. Con il riconoscimento a
tutti i figli dello stesso stato giuridico, lo Stato riconosce a tutti i figli
gli stessi diritti, soprattutto in materia di successioni. La mancanza di un
riconoscimento della parentela collaterale si ripercuoteva infatti sui diritti
ereditari. I figli legittimi e naturali succedevano in parti uguali al genitore
premorto. Solo i figli naturali del defunto però potevano ereditare, mentre
esclusi erano gli ascendenti naturali e i fratelli e le sorelle naturali del defunto,
i quali ereditavano solo in assenza di parenti legittimi fino al 6° grado e prima
dello Stato (art.565 cc). Bastava quindi la presenza di un cugino per escludere
la successione di un fratello naturale.
La nozione di “potestà genitoriale” viene sostituita con quella di
“responsabilità genitoriale”.
Viene abbassato da 16 a 14 anni il limite di età entro cui occorre il consenso
del minore per il riconoscimento e viene riformato anche il procedimento di
riconoscimento del figlio in caso di opposizione dell’altro genitore. La nuova
formulazione della norma prevede una procedura più snella e veloce. Viene
inoltre riconosciuta anche ai genitori con età inferiore ai 16 anni, e previo
consenso del giudice, di riconoscere i propri figli
Il legislatore ha inoltre riconosciuto al minore il diritto ad essere
ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. Il minore non sarà più un
mero oggetto delle decisioni dell’autorità giudiziaria ma rivestirà un ruolo
attivo.
La novità più rilevante però è stata introdotta dall’art.3 della legge in oggetto,
il quale riconosce la competenza per tutte le questioni inerenti
l’affidamento ed il mantenimento dei figli minori al Tribunale
ordinario, anche quando i genitori non siano uniti in matrimonio.
Una ulteriore innovazione apportata da questa riforma è la previsione che
possano essere riconosciuti dai genitori anche i c.d. “figli incestuosi”, ossia
figli nati da genitori legati da vincoli di parentela, mentre anteriormente i figli
incestuosi non potevano essere riconosciuti dai genitori salvo che questi
fossero in buona fede, ossia ignorassero il vincolo di parentela.
Sull’argomento vi fu da subito polemica poiché secondo alcuni esponenti
politici questa norma andrebbe a legittimare l’incesto.
Sulla questione era già intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza
50/2006, riconoscendo al figlio incestuoso la possibilità di agire per far
dichiarare giudizialmente la paternità o maternità naturale anche nei casi in cui
il riconoscimento non era ammesso ai sensi dell’art.251 cc. Il riconoscimento
spontaneo da parte della madre o del padre rimaneva ugualmente precluso.
La Corte Costituzionale aveva inoltre sottolineato come le vigenti norme che
impediscono il riconoscimento rappresentino una “capitis deminutio
perpetua e irrimediabile” per il figlio, conseguente ad un comportamento
altrui, che è in contrasto con l’art.2 della Costituzione per violazione del
diritto all’identità personale, riconosciuto anche dalla Convenzione dell’ONU
sui diritti del fanciullo (art.8), stipulata a New York il 20 novembre 1989 e
ratificata con L.176/1991
Le innovazioni più salienti della legge comportano:
1) Pari diritti ereditari tra figli nati fuori dal matrimonio. Questo, uno
degli obbiettivi principali della modifica – già apportata dalla legge n. 219/12,
all’articolo 74 c.c. – che aveva esteso il vincolo di “parentela” a tutti i soggetti
appartenenti allo stesso stipite, a prescindere dal fatto che la nascita della
prole fosse avvenuta tra genitori coniugati o conviventi. I figli nati fuori dal
matrimonio, con il riconoscimento da parte del genitore, acquistano un
legame giuridico non solo con chi li ha riconosciuti, ma anche con i relativi
familiari, di cui saranno “parenti” a tutti gli effetti, con conseguente
partecipazione al loro asse ereditario.
2) Più tutela e garanzie per i nonni, che, grazie alla riforma, potranno
vantare – e far valere in giudizio – il diritto di mantenere rapporti significativi
con i nipoti, ferma la valutazione sulla compatibilità delle loro richieste, con il
superiore interesse del minore, ai sensi del nuovo articolo 317 bis del codice
civile. Inoltre il nonno, paterno o materno, cui sia impedito l’esercizio di tale
diritto, potrà ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del nipote, al
fine di ottenere l’emissione dei provvedimenti più idonei per soddisfare le
esigenze dei minori, quali il diritto a conservare e mantenere rapporti
significativi con gli ascendenti.
3) Cambia, con la riforma, la nozione di “potestà genitoriale” (nel codice
civile ancor definita “patria potestà”), che viene più correttamente definita
“responsabilità genitoriale”. Muta, così, la concezione tradizionale del
rapporto genitori-figli, non più centrata sul potere che l’adulto (il genitore) – e
sul corrispondente stato di soggezione del figlio – ma focalizzata sull’impegno
che i genitori devono assumersi nei confronti della prole. In sintesi, il
rapporto genitori-figli sarà letto, non più dalla prospettiva del papà o della
mamma, ma da quella del figlio, le cui esigenze determinanti al fine di
determinare il contenuto delle scelte, che sarà intrapresa alla luce del suo
preminente interesse. Il nuovo articolo 316 del codice civile disegna una più
chiara e profonda responsabilità del genitore, tenuto a vigilare su istruzione,
educazione e condizioni di vita del figlio, fino alla sua raggiunta indipendenza
economica, anche in tutti quei casi in cui non eserciti direttamente tale
responsabilità genitoriale (ad esempio perché divorziato o genitore naturale
che non vive con il proprio discendente diretto).
4) Introdotta nel codice civile, anche una norma specifica (l’articolo 336 bis)
che prevede e disciplina le modalità dell’ascolto dei minori che abbiano
compiuto i dodici anni, o di età inferiore se capaci di discernimento.
Essi saranno ascoltati, nell’ambito dei procedimenti nei quali dovranno
adottarsi provvedimenti che li riguardino, dal presidente del tribunale o dal
giudice delegato. L’ascolto avviene sotto la direzione del giudice, talora con
l’ausilio di esperti, anche quando vi partecipino i genitori, i difensori delle
parti, il curatore speciale del minore, e il pubblico ministero, ove autorizzati
dal giudice stesso. La riforma, in questo senso, recepisce le indicazioni della
Cassazione, che più volte ha sottolineato come il mancato ascolto del minore
costituisca violazione del principio del contraddittorio e dei criteri del giusto
processo, purché, è ovvio, non gli arrechi alcun danno.
5) Presunzione di paternità del marito più estesa, grazie alla modifica
dell’articolo 230 del codice civile, che presume l’esistenza di un vincolo di
sangue, non solo in relazione al figlio concepito – ma anche a quello “nato” –
durante il coniugio. In particolare, si presumerà concepito durante il
matrimonio il figlio nato entro trecento giorni dalla data dell’annullamento,
dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio
(articolo 232 c.c.), a prescindere dal fatto che la nascita sia successiva o
precedente ai centottanta giorni dalla celebrazione. Ciò che fa presumere la
paternità del coniuge, in sostanza, è il collocarsi del parto durante il corso del
matrimonio.
6) Ai sensi del modificato terzo comma dell’articolo 234 del codice civile., in
ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il
matrimonio. La prova della filiazione inoltre – secondo la nuova versione
dell’articolo 241 c.c. – potrà essere data (non solo tramite testimoni,
come prevedeva la vecchia formulazione del testo) ma con “ogni
mezzo”. Eliminato, dunque, ogni limite agli strumenti cui ricorrere per
dimostrare il legame di sangue, ove manchino l’atto di nascita e il possesso di
stato che restano, ancor oggi, le principali prove della filiazione. Posto che è
possibile provare in modo scientifico la paternità, erano divenute
anacronistiche e paradossali le limitazioni ai mezzi di prova della paternità.
7) Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio può essere
effettuato sia dal padre sia dalla madre, congiuntamente o separatamente,
anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del
concepimento (nuovo articolo 250 del codice civile modificato dalla legge n.
219/12) abbassa da sedici a quattordici anni, l’età dalla quale il
riconoscimento del figlio non produce effetto senza il suo assenso. Ampliate
anche le possibilità di riconoscimento della prole “incestuosa” (termine
oggi cancellato), i cui genitori – ai sensi del riscritto articolo 251 c.c. – non
dovranno più dimostrare l’inconsapevolezza, al momento del concepimento,
del loro vincolo di parentela. Più semplicemente, il figlio nato tra parenti,
potrà essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice, valutatone
l’interesse, e la necessità di evitargli un pregiudizio.
8) In materia di disconoscimento di paternità del figlio nato in costanza di
matrimonio, il nuovo articolo 243 bis del codice civile prevede che l’azione
possa essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio stesso. Chi la
promuova, sarà ammesso a provare l’inesistenza del rapporto di filiazione; la
sola dichiarazione della madre, tuttavia, non escluderà la paternità. L’azione,
improponibile decorsi cinque anni dalla nascita, sarà, però,
imprescrittibile per il figlio. Riscritto anche l’articolo 246 c.c.: se il presunto
padre o la madre (titolari dell’azione) siano deceduti senza averla promossa,
ma entro il termine previsto, potranno esperirla discendenti o ascendenti. Il
nuovo termine decorrerà dalla morte del presunto genitore, dalla nascita del
figlio postumo, o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascun
discendente. Diversamente, in caso di decesso del figlio titolare dell’azione,
avvenuto anteriormente al suo esercizio, coniuge o discendenti potranno
avanzare l’istanza entro un anno dal decesso del figlio o dalla maggiore età di
ciascun discendente.
9) In attuazione della delega, il nuovo articolo 79 bis della legge n. 184/83
(disciplinante le adozioni) impone al giudice – di fronte a casi di minori a
rischio abbandono, stanti le gravi difficoltà economiche familiari – di
fare il possibile affinché possano crescere nella loro famiglia. Egli,
pertanto, sarà tenuto a segnalare ai Comuni, le situazioni di indigenza dei
nuclei che abbiano richiesto interventi di sostegno. Si consentirà, così, ai
competenti servizi territoriali, di attivarsi – compatibilmente con le risorse
finanziarie e le sfere di competenza – per fornire aiuto concreto alle famiglie
fortemente disagiate, impossibilitate, altrimenti, ad occuparsi dei propri figli.
4. L. 10 novembre 2014 n. 162 e L. 6 maggio 2015 n.55
4.1. PREMESSA
La L. n. 162/2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10.11.2014), ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Per quanto rileva, con il d.l. 132/14 convertito in L. 162/14 e con la successiva L. 55/15 i procedimenti previsti per le separazioni personali dei coniugi e lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno subito un radicale mutamento sia nelle modalità che nei tempi. 4.2. LEGGE 162/2014
Con il primo decreto e la successiva legge di conversione, emessi nell’ambito del riassetto del procedimento civile finalizzato alla riduzione dell’arretrato giudiziario, le coppie che vogliano consensualmente separarsi o divorziare possono ricorrere a due nuove opzioni alternative al ricorso congiunto al Tribunale. Sono state infatti previste la negoziazione assistita da avvocati oppure, al ricorrere di determinate condizioni, l’accordo presso l’Ufficio di Stato Civile.
4.2.1. Negoziazione assistita da avvocati
Quanto alla negoziazione assistita, il procedimento ha inizio con la sottoscrizione di una convenzione o con l’invito alla negoziazione assistita rivolto da una parte all’altra in ragione degli artt. 2,3,4 della Legge. La convenzione consiste in un accordo attraverso il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere una controversia. L’Avvocato certifica l’autografia delle firme delle parti che partecipano alla convenzione e la data in cui sono state apposte. E’ prevista la forma scritta a pena di nullità e deve essere incluso un termine superiore a 30 giorni ed inferiore a 3 mesi entro cui concludere l’accordo. Sempre per volontà delle parti, il termine può essere prorogato di altri 30 giorni. Successivamente alla convenzione si procede alla stesura dell’accordo vero e proprio, che contiene le condizioni di separazione o di divorzio. A differenza di quanto previsto nel decreto, la Legge di conversione ha disposto la necessaria presenza di un Avvocato per parte, nonché il passaggio obbligatorio dell’accordo entro 10 giorni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, che, in caso non vi siano figli minorenni o maggiorenni incapaci o economicamente non indipendenti sarà un controllo di regolarità (nulla osta), mentre nell’altro caso il P.M. (autorizzazione) autorizzerà l’accordo solo se risponde all’interesse dei figli. Qualora, invece, non vi siano gli estremi per autorizzare, il P.M. trasmetterà il tutto al Presidente del Tribunale che fisserà l’udienza di comparizione delle parti entro 5 giorni. Ottenuta l’autorizzazione o il nulla osta l’Avvocato ha il dovere di trasmetterne copia entro 10 giorni all’Ufficiale di Stato Civile, che, in caso contrario provvederà a sanzionare il professionista che non abbia adempiuto, con sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 €. Con le nuove procedure il ruolo dell’Avvocato, che già di per sé obbliga ad un’attenzione particolare data la delicatezza delle situazioni che gli si presentano, diventa ancor più pregnante. L’Avvocato deve infatti avvisare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e deve tentare la conciliazione tra i coniugi oltre che informarli dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. Infatti, in presenza di figli minori deve ricordare ai coniugi l’importanza che gli stessi trascorrano tempi adeguati con entrambi i genitori e ne deve dare atto nell’accordo. Sotto la propria responsabilità, poi, l’Avvocato deve dichiarare che gli accordi non siano
contrari all’ordine pubblico o a norme imperative di legge ossia che non ricorrano condizioni che ledano i diritti considerati indisponibili. A ciò si aggiunga, come visto, l’obbligo sanzionabile di trasmissione del nulla osta o dell’autorizzazione all’Ufficiale di Stato Civile perché provveda con le opportune annotazioni. 4.1.2. Separazione o divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Per quanto attiene, invece, alla separazione consensuale ed al divorzio congiunto innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, questa costituisce la procedura più rapida, ma non possono accedervi le coppie con figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali ai sensi dell’art. 12, comma 2, e non è previsto il successivo controllo del P.M. I coniugi possono recarsi personalmente o anche assistiti da un Avvocato, presso il Comune di residenza di uno dei coniugi o il Comune in cui il matrimonio è stato trascritto e, innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile, concludere un accordo di separazione o divorzio sulla base delle condizioni da loro stessi determinate. L’Ufficiale riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volontà di separarsi o divorziare alle condizioni concordate e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla procedura. Le parti vengono quindi invitate a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile per la conferma dell’accordo per una data successiva stabilita non prima di 30 giorni. La mancata comparizione a detta data equivale a mancata conferma dell’accordo. In caso di successiva comparizione, invece, l’Ufficiale di Stato Civile redige la conferma dell’accordo. 4.3. LEGGE 55/15 - DIVORZIO BREVE - IN VIGORE DAL 26
MAGGIO 2015
Quanto poi alle previsioni di cui alla L.55/15 - Divorzio breve- in vigore da 26 Maggio 2015, queste hanno radicalmente modificato i tempi che intercorrono tra la separazione dei coniugi ed il deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio. Nel caso di separazione giudiziale, infatti, il ricorso per lo scioglimento del matrimonio può essere depositato dopo un anno dall’udienza presidenziale e non più dopo tre anni.
In caso di separazione consensuale lo scioglimento può essere proposto decorsi 6 mesi dall’udienza presidenziale e ciò vale anche in caso di separazioni giudiziali che si trasformino nel corso del giudizio in consensuali. Del pari, in ipotesi di negoziazione assistita i sei mesi decorrono dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. Mentre, in ipotesi di separazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, i sei mesi decorrono dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile. La nuova disciplina si estende anche ai processi ancora in corso all’entrata in vigore della legge e prescinde dalla presenza di figli minori degli anni 18 o maggiorenni non autosufficienti. Un’ulteriore modifica è, altresì, stata prevista per lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi. Fino ad oggi la comunione si riteneva sciolta una volta passata in giudicato la sentenza di separazione o dall’omologa delle condizioni di separazione, senza efficacia retroattiva. Con la riforma, invece, la comunione si scioglie al momento in cui il Presidente autorizza i coniugi a vivere separatamente, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale davanti al Presidente. L’ordinanza viene comunicata all’Ufficiale di Stato civile per la relativa annotazione. “ Ma c’è il dolore che sale che sale e fa male… Vorrebbe una risposta ma in fondo risposta non c’è E quando arriva la notte e resto sola con me La testa parte e va in giro in cerca dei suoi perchè Né vincitori né vinti si esce sconfitti a metà La vita può allontanarci l’amore continuerà” da “La notte” di Arisa