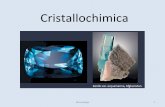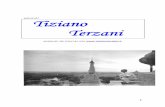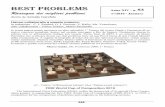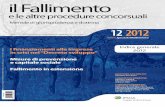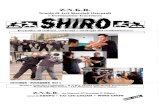Tiziano Agostini - units.it
Transcript of Tiziano Agostini - units.it
2
LEPsicologiE
In psicologia, in quanto disciplina scientifica,non es i s te un approcc io un i ta r io ouniversalmenteaccettato.
Esistono invece sia diversi livelli di analisi siadiversemetodologiedistudioediverselogiched’interpretazionedeifenomeni.
3
Laquestionemetodologicaovvero,acosaservelametodologia?
Come possiamo fare per conoscere la "realtà"? Quando possiamoessere sicuri che i nostri approcci a tale “realtà” ci aiutanoeffettivamenteasoddisfareinostriobiettiviconoscitivi?
Metodologia indica l’insieme delle riflessioni sul metodo esulletecnicheutilizzateinunadatadisciplinaaccademicaperconoscerel’oggettodelladisciplinastessa(Marradi,1998).
4
Lascienzasidifferenziadallealtreattivitàumaneperisuoiobiettivi:! descrizione! scopertadiregolaritàLoscopoprincipaleèlosviluppodi-teorie: insieme di asserzioni che organizzano un largo corpo di fatti[leggi]inunsingolosistemadispiegazionechepossanospiegare-fatti – leggi: asserzioni secondo cui certi eventi sono regolarmenteassociati- leggestatistica:larelazionetralevariabilièregolaremanonperfetta
[vedi legge della frustrazione/aggressività (la teoria di Dollard eMiller prende in considerazione il rapporto tra frustrazione eaggressività. Secondo gli autori infatti, la frustrazione determinasempre aggressività e l'aggressività è sempre conseguenza dellafrustrazione).
NB: le legginonindicanonecessariamenterapportidicausa-effettofraglieventi.La psicologia è una scienza come le altre, le differenze sono ovvie, inquantovièunamaggiorecomplicazioneemaggiorevariabilità,percuilapsicologiausamoltolastatistica.
5
Metodidiconoscenza
MetodiNONempirici(nonbasatisull’esperienza)
Metodiempirici(basatisull’esperienza)
AUTORITÀDio
governogenitori
LOGICA
ragionamentodeduzione
Intuizione
SENSOCOMUNEaccordotraideeedesperienzedi
ungruppo
MISTICISMOinstatoalteratodi
coscienza
SCIENZA
6
Metodidiconoscenza
MetodiNONempirici(nonbasatisull’esperienza)
AUTORITÀDio
governogenitori
Crediamochequalcosasiaveroseunapersonacherispettiamocidicecheècosì.Leautoritàspessosonoindisaccordotraloro.L’autorità è gravemente limitata come mezzo diconoscenza.Leautoritàspessosisbagliano(vediGalileo).
7
Metodidiconoscenza
MetodiNONempirici(nonbasatisull’esperienza)
Èunmezzoimportanteperconoscereilcomportamento.Riguardaproposizioniconcatenatetraloroinmodocheleconclusioniderivanoconcertezzadallepremesse(vedisillogismi).
LOGICAragionamentodeduzione
Premessamaggiore TuttelepersonehannodeipensieriPremessaminore CartesioeraunapersonaConclusionevalida CartesioavevadeipensieriConclusionenonvalidaTuttelepersonesonoCartesio
Premessamaggiore TuttelepersonehannodeipensieriPremessaminore TuttiipensierisonointelligentiConclusionevalidamanonvera Tuttelepersonesonointelligenti
Selaconclusionederivadalleregoledellalogicaèvalida,puòperòesserenonvera.Èquindipossibileunadivergenzatraveritàevalidità.La logica è importante per la scienza, ma non può sostituire l’evidenzaempirica,cioèl’osservazionedeifatti(vedilafantascienza).
8
Metodidiconoscenza
Metodiempirici(basatisull’esperienza)
Intuizione
Spessolenostrevalutazionisonofatteinpochisecondi,perintuizione.È un processo di conoscenza basato su processi “istintivi”, spontanei, non sulla logica o sulragionamento.L’intuizionehaspessounforteeffettosuinostriconvincimenti.Per prendere tutte le decisioni necessarie durante la nostra vita di ogni giorno usiamocontinuamentel’intuizione.Talvolta ciò che sembra intuizione in realtà è basato su fattori oggettivi, che prendiamo inconsiderazione“inunqualchemodo”.
9
Metodidiconoscenza
Metodiempirici(basatisull’esperienza)
Intuizione
SENSOCOMUNEaccordotraideeedesperienzedi
ungruppo
Evidenzial’accordotral’opinionediunapersonaeleideeeesperienzecomunidiunampiogruppodipersone.Haduelimitazionifondamentali.1.Varianeltempoenelleculture.2.Ilsolocriteriochericonoscepergiudicarelaveritàdiunacredenzaopraticaèvederesefunzionaomeno.Questononpermettelacomprensioneelaprevisione,nonportaanuoveconoscenze.
10
Metodidiconoscenza
MetodiNONempirici(nonbasatisull’esperienza)
Metodiempirici(basatisull’esperienza)
AUTORITÀDio
governogenitori
LOGICA
ragionamentodeduzione
Intuizione
SENSOCOMUNEaccordotraideeedesperienzedi
ungruppo
MISTICISMOinstatoalteratodi
coscienza
SCIENZA
11
NonvièunmetodoscientificomadeimetodiscientificiStadi(semplificati–eideali-)delmetodoscientifico:
! definizionedelproblema! formulazionediunaipotesi! raccoltadeidati! elaborazionedelleconclusioni
NB: Le scienze del comportamento seguono le stesse regole dellealtrescienze,anchesetrattanodieventimentali
12
• Èempirica• Èoggettiva• Siautocorregge• Faprogressi• Èpossibilista
• È“parsimoniosa”
• Èinteressataallateoria
!
Lascienza
13
• Èempirica
!
Fonteprincipalediconoscenzaèl’esperienza;sibasasuifatti.L’atteggiamentoscientificofaaffidamentopiùsull’esperienzachesullealtrefontidiconoscenza(autorità,sensocomune,logica…)
• ÈoggettivaPersone con percezione normale nello stesso tempo e nello stessoluogofarebberotuttelastessaosservazione.Diconseguenza,èREPLICABILE:osservazionidescritte inmodopreciso(oggettive e fedeli) permettono in altri tempi e luoghi di ottenere glistessirisultati.È quindi cruciale utilizzare registrazioni accurate e descrizioni chiare eprecise.!Èciòchedistinguelascienzadaciòchenonloè;studiafenomeniosservabilidatutti.Non implica il trattare le persone come oggetti: significa semplicemente che sequalcunoosservassedadietroloscienziato,vedrebbelestessecose.
14
• SiautocorreggeÈapertaalcambiamento:dicontinuonuovidatiempiricicontraddiconole conoscenze precedenti (vedi dibattito negli anni ’50 sul ruolo diambienteegenisulcomportamento).
• FaprogressiCorreggendosi,progredisce;aumentasiainquantitàsiainqualità.Le altre attività umane cambiano, ma non necessariamenteprogrediscono(vedimodaearte).
• ÈpossibilistaNon afferma mai di conoscere la verità completa; nuove evidenzepossonosemprerendereobsoleteleconoscenzecorrenti.
15
• È“parsimoniosa”
Prediligelaspiegazionepiùsemplicepossibileperdarecontodiundatofenomeno(vedicomportamentodellagattadopoilparto).
• ÈinteressataallateoriaDeve mettere in relazione i fatti tra loro, quindi ricerca teorie chespieghinoifatti.Lascienzacercateoriechespieghinocomelecosefunzionino,evuolecapireilperché(nonsolofarlefunzionare,comelatecnologia).
16
DifferenzeconlanonscienzaPer quanto gli scienziati comincino le loro ricerche basandosi sulleconvinzioni che possiedono in quel momento, influenzati anchedall’autorità, dal senso comune e dalla logica, poi però sono guidatidallavolontàdicambiarequelleconvinzionisullabasedelleprovechederivanodall’applicazionedimetodid’indaginerigorosi.Chiunque, se mette in dubbio una teoria, anche dello scienziato piùillustre, basandosi su metodi di ricerca validi, può rimpiazzare con leproprieideequellechevengonodimostratesbagliate.
17
! Realismo(realtàdelmondo)! Razionalità! Regolarità! Scopribilità! CausalitàCausalitàstatistica
L’approccioscientificoèbasatosuiseguentiassuntifondamentali:
Assunti fondamentali della scienza
18
! Realismo(realtàdelmondo)Gli oggetti dello studio scientifico esistono indipendentemente dal fatto di esserepercepitidaunosservatore.Èmoltodiversodalrealismoingenuo(odelsensocomune),cheinveceaffermachelecosesonocomeappaiono.Il fallimentodel senso comune inmolte situazioni ha contribuito allo sviluppodellascienzaeinparticolaredellapsicologia(vedicolorenero).Uomo comune e scienziato credono entrambi nell’esistenza di unmondo reale,masonorealtàdiverse.Adesempio,dovel’uomocomunevedeunmondodipersonebuoneecattive,laborioseepigre,etc.lopsicologovedepersoneinfluenzatedastimoli,eventi,pulsioni,etc.
! RazionalitàIlmondopuòesserecompresotramiteilpensierologico.Se il mondo fosse irrazionale, cioè non comprensibile con i principi della logica,sarebbeinutilecercaredicomprenderloconqualsiasimezzo.
Assunti fondamentali della scienza
19
! ScopribilitàÈ possibile scoprire il funzionamento delmondo, non viene rivelato(vedidifferenzatrarompicapoemistero).Ifenomenisonoinattesadiesserescoperti.
! RegolaritàIlmondoseguelestesseleggiinognitempoeluogo.Lecausedeglieventipossonoesserecomplesseepossiamononessereinpossessodituttiifattinecessariaspiegarliindettaglio,malascienzaassume che il comportamento umano rientri nelle leggi della naturadovunqueeinqualsiasitempo.
Assunti fondamentali della scienza
20
Causalitàstatistica:alcunieventipossonoessereconsiderati causadialtrieventianchese la relazione traquestinonècostante (vedifumo-tumore;povertà-crimine).
! CausalitàPer fare scienza è necessario supporre che gli eventi non siverifichinosenzaragione;ciascuneventoha(almeno)unacausa.La scienza è stata anche definita come la ricerca delle cause e deglieffetti.Relazioni causa-effetto (determinismo) come ipotesi di lavoro:conoscendotutteleleggidelcomportamentoèpossibileprevederlo.
Assunti fondamentali della scienza
21
Teoria[sensolato]Asserzioneoinsiemediasserzioniriguardantirelazionitravariabili.Se le asserzioni riguardano unasingola relazione tra variabili siparla di LEGGE; se le leggi sonocollegate tra loro in un insiemepiùgeneralediasserzionisiparladiTEORIA.
Duedefinizionidelconcettoditeoria:Teoria[sensostretto]Asserzione o insieme di asserzionisulle relazioni tra variabili cheincluda almeno un concetto nond i re t tamente osservato manecessarioperspiegarerelazionitravariabili.
Unateoriaèuninsiemediasserzionicheorganizzanounlargocorpodifatti(leggi)inunsingolosistemadispiegazione.Insostanza,unateoriaèunaspiegazioneperunaseriedifatti.
22
Esempio:
IDATIriguardanouninsiemespecificodiosservazionieseguitesuunapersonain un determinato tempo e in condizioni particolari. Queste asserzioni NONhannovaliditàgenerale.LaLEGGEèun’asserzionegeneralecheèveraognivoltachesirealizzanocertecondizioni.La TEORIA introduce nuovi concetti (es. memoria di lavoro) che non sonopresentia livellodella leggeesonoconcetti teoricipoichésonoutilizzatiperspiegarelarelazionetravariabilichesitrovanellalegge.Iconcettiteoricinonsiosservanonémisuranodirettamente,possonoesseredefiniti solo indirettamente in riferimento ad eventi osservati e/o misuratidirettamente. Sono invenzioni dello scienziato per spiegare le leggi deifenomeni(es.elettrone).
Teoria:
Legge:
Dati:
Memoriadilavoro MemoriaalungotermineInformazione Elaborazione
Lepersonepossonoricordare7unitàdiinformazionipresentateperbrevetempo.
InmediaElenariuscivaaricordareper10s.unaseriedi7numeriquando levenivanomostratiper1s.il12aprile2006.
23
Unabuonateoriadevepoteresseremessachiaramenteallaprova;lascienzasibasa sull’evidenzaempirica,quindi le sue teoriedevonoesseremesseallaprova empiricamente (deve fare una predizione precisa che possa essereprovataveraofalsa):
!leteoriedevonopoteresserefalsificabili.
Laprovapiùfruttuosadiunateoriaèquelladicostruireunasituazioneincuinonpuòfunzionare(vedicastagnaeraffreddore).
Popperaffermacheuna teoria scientificanonpuòmaiessereprovata comevera, perché ci sono molte false teorie che possono predire ogni risultatoottenuto.
Quandocisonoevidenzesperimentalicontrarie(NB:leunicheinformative),lateoriaèerrata.La teoria sarà temporaneamente accettata quando resisterà a tentativi difalsificazione.Aquantepiùprovesopravvive,tantopiùlediamofiducia.
Sitentadifalsificarel’ipotesi‘nulla’alfinedisostenerel’ipotesisostantiva.
24
• Organizzareleconoscenze• Spiegareleleggi
• Prevederenuoveleggi• Guidarelaricerca
Scopi delle teorie
25
• Organizzareleconoscenze• Spiegareleleggi
Inassenzadi teoriaabbiamouna raccoltadidescrizioniequalche legge, lateoriacollegailtuttoinuncontestounificato.-Ilfattosingoloèspiegatocomeistanzadiunaleggegenerale.-Laleggesispiegaconlasuarelazioneconlateoria.-Lateoriaserveaspiegareleleggitrovate.La spiegazione è un collegamento tra concetti particolari e concetti piùgenerali.La bontà di una teoria è correlata al numero di eventi e di leggi che puòspiegare.Più specifica, precisa e semplice è la spiegazione,migliore è la teoria; perquesto, in generale, sono considerate migliori le teorie formulatematematicamenterispettoaquelleespresseinterminigenerali(NB:convantaggiesvantaggidiversi:un’ampiateoriageneralepuòspiegarepiùleggiefatti,maconminoreprecisione).
26
• Prevederenuoveleggi• Guidarelaricerca
Una teoria feconda spiegamolte leggi diverse che in precedenza nonerano collegate fra loro e suggerisce dove cercare nuove leggi,comprese quelle che prevedono eventi controintuitivi (vediesperimento di Lepper, Greene e Nisbett, 1973 sull’autopercezione:incentiviestrinseci-motivazioneintrinseca).
Unabuona teoria suggerirànuovi esperimenti e aiuterà i ricercatori ascegliereviealternativeperrealizzarli.
Questo ruolo di guida della teoria va assieme al suo ruolo di predirenuoveleggi.
27
Laspiegazioneteoricaèilfineultimodellascienza.
Scopidellapsicologiacomescienzasonoladescrizione,laprevisioneeilcontrollo:
-Seladescrizioneèstatafattacorrettamente,sistabilisconodelleleggidelcomportamento.
-La conoscenza di queste leggi permette di prevedere qualicomportamentisiverificheranno.
-Sesipuòprevedereilcomportamento,losipuòcontrollare,sesiriesceadagiresuglieventichelocausano.
28
Asserzioneritenutaveraalfinedivagliarnelavalidità.Un’ipotesipuòessereformulatasottoformadiaffermazione“se...allora...”.SeèveroA,neconsegueB.L’affermazionepuòessereoveraofalsa.Se facciamo certe osservazioni in condizioni particolari, e una data teoria èesatta,allorasidovrebberootteneredeterminatirisultati.L’ipotesipuòriguardareunaleggeprevistadallateoria,oppurelateoriastessapuòesserecentrodell’ipotesi.Un’ipotesisuunaleggeimplicacertiassuntisullateoriadietrolalegge.È impossibile esaminare una teoria senza esaminare anche alcuneprevisionisistematichedellateoriastessa.Quandosifannoaffermazionichecontengonoipotesiriguardantisialateoriacheunalegge,e laprevisionenonèconfermata,puòesserefalsala legge, lateoriaoppureentrambe.Un’ipotesi scientifica devepoter essere esaminataempiricamente inmododapoteressereconfutata.Tuttalaricercascientificaèprogettataperesaminarealmenoun’ipotesi.
Ipotesinellascienza
29
La scienza cerca di elaborare spiegazioni teoriche dei fenomeni che siosservanonelmondo. Si puòpartiredalla teoria e cercare i fenomenichedovrebberoverificarsiselateoriafossevera,oppurepartiredaunfenomenoecercareunateoriachelospieghiinmanierasoddisfacente.La scienza tratta conoscenze oggettive, per cui i concetti per esserescientificidevonoessereoggettivicomeidati.Per Bridgman, un concetto teorico deve essere legato ad operazioniosservabilidachiunque,altrimentinonèscientifico(vedivolontàdiDio,percezioneextrasensoriale).L’operazionismoquindidelimitaiconcettichelascienzapuòusare.
Definizionediconcettiteorici(operazionismo)
30
Quindiiconcettiteoricidevonoaveresignificatooperativo,cioèesserelegati ad operazioni che chiunque può esaminare ed eseguire(Bridgman).Senonvièmododidefinire ilconcettotramiteoperazioniosservabili,taleconcettodevevenireesclusodallascienza.Unadefinizionepiùristrettaprevedeche:iconcettiscientificivengonodefinititramiteleoperazioniconcuisonomisurati.NB:attenzioneaicattiviusidelledefinizionioperazionali.L’ottenimento di risultati uguali a partire da definizioni operazionalidiversedellostessoconcetto(operazioniconvergenti)rafforzalateoriasottostante.Iterminicheusiamodevonoesseredefinitiaccuratamente,inmodocheil loro significato sia chiaro rispetto a eventi della realtà osservabilioggettivamenteerispettoalleteoriesviluppateperspiegaretalieventi.
Definizionediconcettiteorici(operazionismo)
31
Lanaturadelprogressoscientifico
Ogni branca della scienza si organizza in paradigmi (Kuhn): tutti gliassuntieleteorieaccettatecomeveredaungruppodiscienziati.La scienza non procede in linea retta ma evolve per rivoluzioni dipassaggioanuoviparadigmi:scienzanormale(accettazionediunparadigma)" problemiecrisidelparadigma" nuoviparadigmichecompetonoconquelloattuale" accettazionedelnuovoparadigmachespiegaidatiempiricinelmodomigliore
Solo i dati empirici possono essere usati per valutare le teorie,preferenzepersonalisonoirrazionali.
32
«Serendipity»
Arrivareascoperteutilicuinonsimirava.Spessonellascienzalasoluzionediunproblemasiraggiungeperchésinotaqualcheeventopeculiarecuicisiinteressa,tralasciandoillavoroprecedente.Quindi, quando scoprite qualcosa di interessante, mollate tutto ededicateviaquello!Scienzacomesoluzionediproblemi
Molte teorie nascono a seguito della necessità di risolvere problemipraticispecifici.
33
LimitidellascienzaCisonolimitichesonointrinseciallanaturadellascienza,altrisonopratici.-LimitiintrinseciLascienzaèagnostica,siariguardoaDiosiasullequestionidivalore.Haunavaliditàchedipendedallacultura,neèprofondamenteinfluenzata(vedisessualità).È incompleta: sappiamomolto poco, specie in psicologia, che è una disciplinagiovaneetrattafenomeniestremamentecomplessi.Ècorreggibile:vienecontinuamentesottopostaarevisione,manoamanochesiacquisiscononuoveinformazioni(vedifrenologia).-LimitipraticiLa scienza è opportunistica, in quanto progredisce dove i problemi sono piùfacili, dove sono disponibili tecniche e tecnologie, dove ci sono le risorseeconomiche.Ilcostodellaricercaèungravelimitepratico(vedifisicasubatomica).Molti problemi sonoestremamente complessi, già èunproblema trattareduevariabilipervolta.
34
Gliscienziatielaboranoleggieteorieperspiegareifenomenicheosservano.Per fare ciò bisogna passare da affermazioni generiche sulle grandi categorie delcomportamentoagliesempispecificiditalecomportamento.Ilfenomenodastudiarepuòesserequalsiasievento.Per studiare sperimentalmente tale evento dobbiamo eliminare parte della sua complessità,cioèdobbiamoprendereilfenomenoetrasformarloinunaopiùvariabili.VARIABILEèqualcheproprietàdiuneventorealechevienemisurata.Levariabilisonoattributideifenomeniepertantoappartengonoallarealtà.Levariabilivariano.Lariduzionedelfenomenoavariabilifocalizzal’attenzionedellosperimentatoresualcunieventispecificitraimoltichesonolegatialfenomeno.
Variabili
35
Poiché le variabili appartengono alla realtà, e la teoria è un prodottodell’immaginazione dello scienziato, il collegamento tra variabili e teoriarichiededegliassunti,cheleghinolateoriaallarealtà.Le variabili sono tangibili: ad esempio, durata, frequenza, intensità diazionamentodiunaleva;risposteadunquestionario;numerodilibriscritti;etc.I concetti teorici sono immateriali: ad esempio, fame; motivazione; ansia;etc.Le variabili sono collegate ai concetti teorici per mezzo delle definizionioperazionaliusatepermisurareiconcetti.Esempio:lateoriadicechel’ansiaaumentalamotivazioneadaffiliarsi.Per vagliare la teoria, devo prendere i concetti di ansia e motivazioneall’affiliazioneecollegarliavariabilinellarealtà.Leduemisurecostituisconolevariabili.Lamisuradella correlazione tra levariabilipermettedi vagliare l’ipotesi: lapresenzaoassenzadicorrelazioneèprova,rispettivamente,proecontrolateoriachehaoriginatol’esperimento.
Variabili
37
Terminiriguardantilavariabileindipendente:• FattoriSinonimoperdefinirelevariabiliindipendenti.Ogniesperimentohaalmeno1fattorealtrimentinonsarebbeunesperimento!• LivelliParticolarevalorediunavariabileindipendente.Unavariabileindipendentehasemprealmeno2livelli,altrimentinonsarebbeunavariabile!• CondizioniParticolaremodo incui sono trattati i soggetti.È il terminepiùampiousatoperparlarediVI.Cisonotantecondizioniquantisonoimodiincuiisoggettisonotrattati.InunesperimentoTRAisoggetti,lecondizionicoincidonoconigruppi.InunesperimentoENTROisoggetti, lostessogruppovienesottopostoatuttelediversecondizioni(quindinonsiparladigruppi).• TrattamentiSinonimodicondizione.Instatistica,indicaunteststatisticosull’effettodellevariecondizionidell’esperimento.
38
Il CONTROLLO (l’altra faccia della medaglia della validità) consiste inqualsiasimetodopereliminarelepossibiliminacceallavaliditàdiunaricerca.
2significati(distinti,mastrettamentelegatitraloro):
1. Punto di paragone fisso con cui confrontare gli effetti di una VI(Esperimentodicontrollo)
2.Lacapacitàdilimitareoguidarelesorgentidivariabilitànellaricerca,finoalpunto incui ilcomportamentodivieneprevedibile inaltogrado(Controllosperimentale)
Controllo
Entrambi i significati del termine CONTROLLO sono in rapporto conl’usodellastatistica.
39
1. Punto di paragone fisso con cui confrontare gli effetti di una VI(Esperimentodicontrollo)Se2condizionisperimentalidifferisconoper1solaVI,qualsiasidifferenzatraessepuòessereattribuitaall’azionediquellaVI.Sipossonoutilizzare:-gruppodicontrollo:terminediconfrontoperilgrupposperimentale-> ai gruppi di soggetti diversi (esperimenti TRA i soggetti o BETWEEN)somministro un trattamento diverso - o diversi valori dello stesso - (ciascungruppo fa da controllo per l’altro gruppo) [vedi anche questione del cieco edoppiocieco]Se ho gruppi uguali prima del trattamento, qualsiasi differenza dopo iltrattamentoèadessoattribuibile.-condizionedicontrollo:terminediconfrontoperlacondizionesperimentale-> agli stessi soggetti (soggetto come controllo di se stesso - esperimentiENTROisoggettioWITHIN),somministrotrattamentidiversi-odiversivaloridellostesso-intempidiversi.
Controllo
40
Trattamento2gruppidissdiversi
Grupposperimentale
Gruppodicontrollo
Presente
Assente
Esperimento
TRAisoggetti
TrattamentoSempreglistessiss
Condizionesperimentale
Condizionedicontrollo
Presente
Assente
Esperimento
ENTROisoggetti
Controllo
41
2.Controllosperimentale
Capacitàdilimitareoguidarelesorgentidivariabilitànellaricerca.Quando si sono limitate le fonti di variabilità in un esperimento tanto dapermettereunaprevisionedelcomportamento,sipuòdirediaverottenutoilcontrollosperimentale(vedicondizionamentooperante).
Controllo
42
• Usodellasituazionedilaboratorio
• Lasituazionedellaricercacomepreparato
• Misurastrumentaledellarisposta
Ulteriorimetodiperottenereilcontrollo
43
• UsodellasituazionedilaboratorioIl laboratorio scientifico è un luogo organizzato per permettere ilcontrollo più adeguato delle variabili di interesse in quella particolarericerca.Laricercadilaboratorioèidealeperchéèidealeavereilmassimogradodicontrollopossibile.La ricerca sul campo è giustificata quando problemi etici o praticiimpedisconodicontrollarelevariabilicomeingeneresifainlaboratoriooquandosivuoledaremaggiorrisaltoagliaspettiecologicidellaricerca.Laqualitàdei risultatidipendedalgradoe tipodicontrollochesipuòesercitare.
44
• LasituazionedellaricercacomepreparatoPerpreparato, terminemutuatodallabiologia (vedi assonegigantedicalamaro), si intende la situazione sperimentale prodotta nellaboratoriochepermettedimettereinrelazionelevariabilidiinteresse.Ilpreparatomiglioreèquellocheprodurrà larelazionepiùfortetra levariabili studiate (es. Skinner box – rispetto ai labirinti usati inprecedenza, permetteva di studiare la frequenza della risposta invecedel numero di risposte corrette, rivoluzionando gli studisull’apprendimento).Un buon preparato è frutto di una accurata progettazione: è crucialescegliereo creare le condizionimigliori per studiare ciò che interessa,cercando di produrre la relazione più forte possibile tra le variabilid’interesse.
45
• MisurastrumentaledellarispostaÈlamisurazionedelcomportamentoinesameeaumentalasensibilitàdella ricerca: la VD (la risposta) deve essere accuratamentemisurata,utilizzandostrumentiadeguati,doveperstrumentodimisurasiintendeunmezzopertrasformareilcomportamentoinnumerioformeadatteall’analisideidati(es.psicofisica).Tanto più la strumentazione è adeguata, tanto più precisa sarà larelazionetraquantitàdellostimoloedellarisposta.Un buon strumento di misura estrae la risposta dall’insieme delleosservazionicasualirendendoquindilamisuraattendibile.Si può quindi definire oggettiva la misura di un comportamento, maanche di uno stato soggettivo, se la strumentazione di misura dellarispostaèadeguata (es.ansiaerispostapsicogalvanica,maanchetestsull’ansiadistato).Unabuonamisurapermetteprecisione,ripetibilitàedoggettività.
46
Soggetticomecontrollodilorostessi
Ogni soggetto è sottoposto a tutte le condizioni per ridurre lavariabilitàdovutaalledifferenzetraisoggetti.È un metodo spesso usato negli studi sulla sensazione e sullapercezione.Siapplicaquando:-l’usodellostessosoggettoèpossibile-èimprobabilecheilsoggettocapiscagliscopidell’esperimento- non ci sono seri effetti di contrasto tra le condizioni (precedentiinfluenzanolesuccessive)
Controllo Strategiespecifiche
47
Stimolo
ENTROisoggetti
Leggero
Soggetticomecontrollodilorostessi
Ordine
Leggero->PesantePesante
Pesante->LeggeroEffettomedio
645
1089
Stimolo
TRAisoggetti
LeggeroOrdine
PesanteEffetto“vero” 6 86 8
6 8
6 8 6 10
6 8 8 4
Teoriadeilivellidiadattamento(Helson,1964)
Controllo Strategiespecifiche
48
Assegnazioneacaso(randomizzazione)Ciascun soggetto ha la stessa possibilità di essere assegnato ad ognicondizione.Se l’assegnazione è veramente casuale, la confusione tra le variabililegatealsoggettoelavariabilesperimentalepuòesseresolocasuale:solo il caso, cioè, potrebbe generare delle differenze tra i gruppirispettoaunavariabilediversadaquellasperimentale.Inoltre, i metodi statistici per essere validi richiedono l’assegnazionecasuale dei soggetti ai gruppi o alle condizioni, stimano cioè laprobabilità che sia stata l’assegnazione casuale a produrre i risultatiottenuti.Un buon metodo prevede l’utilizzo delle tavole dei numeri casuali(random).
Controllo Strategiespecifiche
49
Parteditabelladinumerirandom059335704551050647
966160799524995611
802634436680750641
357927605685882712
531203681574345880
877742709324958762
020194167828186202
660866560462094785
960549347514829527
Controllo Strategiespecifiche
50
Pareggiamento(1)Bilanciamentodeisoggettirispettoauncriteriopreliminare.
Puòmigliorare la precisione dell’esperimento quando i soggetti differisconotralororispettoaunaVIchepuòinfluenzarelaVDinesame.
Ilprimorequisitopereffettuareilpareggiamentoèilfortesospettochevisiaunavariabileimportanterispettoacuiisoggettidifferisconoechesiapossibilecontrollarlaconquestometodo(es.pesodipartenzaedieta).
Se non si trova correlazione tra la variabile pareggiata e l’effetto (VD),indipendentemente dal trattamento (VI), il pareggiamento è inutile, anzi,indebolisce l’esperimento perché l’analisi statistica che si applica a datiottenutiinquestomodo(gruppiappaiatioacoppie)èmenopotentediquellachesiapplicapergruppirandomizzati(soggettisingoli),inquantosiapplicaaunnumerodisoggetticheèlametà(menogradidilibertà).
Controllo Strategiespecifiche
51
Pareggiamento(2)Il pareggiamento deve essere eseguito prima che i soggetti venganoassegnati alle condizioni e si deve possedere una misura dellacaratteristicadapareggiareperognisoggetto.
Si cerca di pareggiare i soggetti rispetto a una variabile che abbia lamassimaprobabilitàdiesserecorrelataconlaVD.
Dopoilpareggiamento,siassegnanocasualmenteimembridiciascunacoppiaallecondizionisperimentali.
Controllo Strategiespecifiche
52
ControllostatisticoTutti i metodi di controllo mirano a ridurre la variabilità; siccome in genere questo non ècompletamenteottenibileènecessarioutilizzareilcontrollostatistico.
In senso lato è sinonimo di statistica inferenziale, cioè le decisioni da prendere in caso diincertezza.
Riguarda domande come: l’effetto ottenuto è reale o casuale? Sono sufficienti i soggetti?Quante prove si devono fare? È possibile analizzare i dati ottenuti tramite il disegnosperimentaleutilizzato?
Insensostrettoriguardaimetodiutilizzati inpraticaperstabilirelaprobabilitàcheuncertoeventosisiaverificatopercaso(vedistrategiespecifiche).
ControlloStrategiespecifiche
53
• RipetizioneSibasasulprincipiodellareplicabilità.Unesperimento isolato,speciese i risultati sonosorprendenti,nonhavalore assoluto. Se la ripetizionenonporta agli stessi risultati, quantoottenutonell’esperimentooriginaleviene invalidato (vediesperimentosulleplanarie).2tipidiripetizione:direttaesistematica.La ripetizione diretta consiste nel rifare lo stesso esperimento, quellasistematica nel fare un esperimento diverso ma basato su quello dipartenza: se i risultati e la teoria del primo sono esatti, si dovrebbetrovareunrisultatoanchenelsecondo.Raramente si fa la ripetizione diretta, si fanno invece ripetizionisistematiche,cambiandoisoggettiolesituazionioivaloridellostimolo(vaglio lavaliditàesterna)ousandodiversedefinizionioperazionalideiconcetti(vagliolavaliditàdicostrutto).Inqualsiasicasodiripetizionesivaglialavaliditàstatistica.Nelcasositrattidifenomeniconbassaprobabilitàdiverificarsiacaso,èmoltoimportantedimostrarnel’attendibilità.
Ulterioristrategie
54
• Disegnosperimentaleaccurato
I disegni sperimentali vanno sempre adattati allo specifico problemasperimentale.La progettazione dell’esperimento implica il risolvere anticipatamentetuttiiproblemipotenzialidivaliditàapplicandometodidicontrollo.Infinevaverificatocheidatiottenutipossanoessereanalizzatiinbaseaprocedimentistatisticiaccettati.La scelta della situazione sperimentale e degli strumenti costituisce ilprincipioguidadeldisegnosperimentale.
• L’esperimento“elegante”
Semplicità, chiarezza nella progettazione e realizzazionedell’esperimento: una dimostrazione elegante raggiunge unaconclusioneimportantenelmodopiùsemplicepossibile;l’esperimentoelegante è il più semplice possibile per vagliare un’ipotesi in modochiaroeconvincente.La progettazione di esperimenti è un’arte che richiede creatività erifletteigustidellosperimentatore.
Ulterioristrategie
55
Ricerca sperimentale e non sperimentale si distinguono sulla base delgradodicontrollochehailricercatore:
! Sperimentale-Manipolalevariabili-Assegnaisoggettiallecondizioni
! Nonsperimentale-Nonpuòmanipolarelevariabili-Non può assegnare i soggetti allecondizioni-Osserva
Esperimento
Ricercacorrelazionale(*sensolato)Indaga le cause del comportamentoattraverso le correlazioni tra variabili(*in caso di impossibilità dimanipolarelevariabili).NB: (specie in questo caso) lacorrelazione non prova l’esistenza diunarelazionecausa-effetto
La ricerca correlazionale più che ricercare le cause cerca le ragioni deicomportamenti(vediruoliepostiasedere),interpretandoli(ermeneutica).
Laricercanonsperimentale
56
Laricercanonsperimentaleèspessoilprimopassopercominciare a rispondere a questioni teoriche conmetodi empirici: la ricerca sperimentale spesso è lacontinuazionediosservazioninonsperimentali
! Laricercanonsperimentale
57
Concampionamentosiindicalasceltadeisoggetti.
Quando svolgiamo una ricerca selezioniamo uninsieme di elementi di un certo tipo (individui,oggetti,misure…)dauninsiemepiùampio,cioèunapopolazioneoununiverso.
Uncampionequindiè“l’immagineinminiaturadellapopolazione cui appartiene, avendone le stessecaratteristiche”(Rossi,1989).
Campionamento
58
Ilcampionamentoprobabilisticosibasasullaselezionecasuale,cioècontrollatasolodalcaso.REGOLEDELLASELEZIONECASUALE:laselezioneècasualese:1. -Ugualeprobabilitàdi scelta: ognimembrodellapopolazioneha la stessaprobabilitàdiesseresceltoe2.-Indipendenzadellaselezione:laselezionediogniindividuoèindipendentedallaselezionediognialtro.Per prendere un campione probabilistico da una popolazione è anche necessario definireesattamente la popolazione per gli scopi della ricerca (NB: può essere diversa dallapopolazione generale): la popolazione con cui si decide di lavorare è chiamata quadro diriferimentodelcampione.Ogniindividuochecadenelquadrodiriferimentodelcampioneèdettounelemento;ilcampionesaràcostituitodauncertonumerodielementidelquadrodiriferimento.
CampionamentoCampionamentoprobabilistico
59
ConcettocrucialedeldisegnosperimentaleèquellodelCONTROLLO.Quandounnumerosufficientedifattorichepossonominarelavaliditàdell’esperimentoèsottocontrollo,sipuòparlarediveroesperimento:lo sperimentatore può controllare sia l’assegnazione dei soggetti allecondizionisialapresentazionedellecondizioniaisoggetti.Quando non sono soddisfatti i requisiti che definiscono il veroesperimento,siparladiquasi-esperimento.Un quasi-esperimento somiglia a un esperimento ma manca almenounadellecaratteristichechedefinisconoquestoultimo.
Aparitàdialtrifattori,unveroesperimentoèpreferibileaunquasi-esperimentoeunquasi-esperimentoèpreferibileaunmetodononsperimentale.
VeriesperimentiVeriequasi-esperimenti
60
Leprincipalidifferenzesono:Veriesperimenti:
-Controllo completo su: chi,cosa,quando,doveecome
-Assegnazione dei soggetti allecondizionisperimentali(CHI)[preferibilmente casuale, affinchéaltre variabili possano confondersiconlaVIsolopercaso]-Il controllo sul COSA, QUANDO,DOVE e COME comporta che siapadroneggiato totalmente il modoin cui viene eseguito l’esperimento(presentazione delle condizioni aisoggetti, manipolazione dellevariabili)
Quasi-esperimenti:
-Mancacontrollo
-Mancal’assegnazione(selezionedei soggettiper le condizioniin gruppi già esistenti [es: per sesso] -“expostfacto”)-Osservazionedicategoriedisoggettiinbase a una differenza che riteniamoimportante
VeriesperimentiVeriequasi-esperimenti