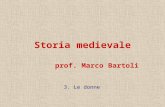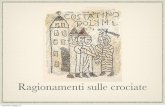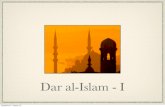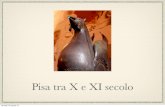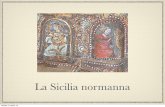Storia Medievale - Introduzione
-
Upload
chiara-gonnelli -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
description
Transcript of Storia Medievale - Introduzione

STORIA MEDIEVALE
Appunti introduttivi
L’importanza del corretto utilizzo delle parole nel suo significato, nella storia.
Nella storia, come in quella medievale, sono importanti e significativi i termini
utilizzati che spesso hanno somiglianze apparenti, in scrittura e pronuncia ma hanno
differenze abissali di contenuti.
Es. La parola terra e territorio non sono assolutamente la stessa cosa.
Per terra ci si riferisce al terreno. Un terreno a sua volta può essere pubblico o
privato. Vi è una differenza in questo caso se ci si trova a parlare di possesso di un
terreno, perché non implica che la persona ne sia anche il proprietario (es.
comodato d’uso, usufrutto, un contadino che coltiva un terreno del comune etc) e
proprietà, dove la persona ne è il proprietario ma non è detto ne abbia il possesso,
per esempio ha affittato il terreno.
Tornando alla differenza citata inizialmente, il territorio si riferisce e qui differisce da
terra, perché rappresenta un concetto di giurisdizione. Es. “Il sig. X ha un terreno nel
territorio di Alessandria”. La frase e la parola stessa sono inclusi in termini di legge.
Analisi delle fonti;
A
Le fonti si possono avere sotto varia forma. Va da se che laddove vi siano fonti per
esempio video, diventano più importanti rispetto alla testimonianza diretta di chi ha
assistito all’evento, perché per sua stessa natura, l’uomo ricorda per stereotipi. Es.
in caso di rapina, il ladro sarà sempre o un giogante o un nano o dalla corporatura
immensa o mingherlino.
Altra cosa da non sottovalutare, anzi da tenere bene a mente, è che la data non
incide sulla veridicità della fonte.
B

Nella storia si deve tenere conto dell’uomo. Tutto nella storia è interconnesso, dalle
manifestazioni spirituali, filosofiche etc.
Nella vita e quindi anche nella storia, quando ci si approccia ad un autore, si deve
porre l’attenzione su come la cosa che leggiamo (può essere un romanzo, come un
saggio, come un articolo giornalistico o una ricerca di uno studioso) viene posta, su
come è scritta. Questo perché basta la scelta di una parola in un dato contesto per
dare un determinato taglio a quello che leggiamo.
A COSA SERVE LA STORIA
Si deve iniziare a comprendere che la memoria di una società è la sua storia. Per
questo si deve considerare la bioantropologia, ossia la storia naturale dell’uomo,
considerando vari aspetti, dal l’origine, l’evoluzione fisica e bio culturale.
Gli italiani sotto questo punto di vista hanno un primato invidiabile, hanno nel loro
patrimonio, ben 19 etnie diverse.
Studioso di cui tenere conto è sicuramente Marc Bloch (Lione 1886 – Lione 1944).
Nato nel polo industriale di Lione è uno dei principali intellettuali che la storia ebbe.
Morì nei campi di prigionia, in cui spesso oltre ai citati ben più noti quali prigionieri
politici o religiosi, oltre ovviamente ebrei, venivano rinchiusi molti intellettuali.
L’opera più nota di Bloch fu edita postuma, ovvero dopo la sua morte, perché scritta
nel periodo di internamento. Lo stesso autore, si scusa perché mentre scriveva i propri
appunti, non era in grado di poter citare sempre l’esatta fonte della sua citazione,
perché non aveva a disposizione la sua biblioteca.
Da tenere di conto che le ideologie malate di un folle come Hitler hanno fatto perdere
all’uomo e alla società stessa tanti patrimoni, di idee, opere, intenti stroncati sul
nascere o interrotti. Spesso nascere nel periodo fortunato nella parte fortunata del
mondo permette di emergere ed anche di arrivare a delle scoperte sensazionali, senza
sapere che molto probabilmente quella stessa cosa era stata scoperta o creata in
precedenza, ma a noi non ne è arrivata testimonianza.
Tra l’altro è curioso considerare il mito della razza ariana istillato e perseguito da
Hitler. Ad oggi se dovessimo arrivare alla giusta definizione di caratteri ariani, nessun
popolo occidentale ne farebbe parte, l’unico che pare rispettare questi canoni di
(apparente) “superiorità” è il popolo afgano di cui fa parte Osama Bin Laden!

L’importanza della scrittura nella storia
Il nostro alfabeto è fenicio e la scrittura è stata creata in Iraq, questo per la presenza
di senso di civiltà occidentale ed influenza mediterranea che ha dato vita alla
storiografia, ossia a popoli di storiografici.
Punti di forza ed importanza del Cristianesimo
A prescindere dalla formazione spirituale individuale, va dato atto della forza e
dell’importanza del cristianesimo. La forza è data dal fatto di essere una religione di
storia.
L’importanza è data anche da alcune regolamentazioni ed istituzioni che fanno parte
attiva nella vita dell’uomo, come quella del matrimonio. Fu istituita ufficialmente a
partire dal 1215 con il “Concilio Lateranense IV” *(prima aveva diverse formule e
tipologie, nell’epoca in cui avvenne il concilio la più diffusa era quella che prevedeva
solo un patto, con scambio di formule pubbliche senza obbligo di un celebrante;
nemmeno di testimoni durante la promessa di nozze a cui assistevano solo i membri
maschi delle due famiglie e ciò era simbolo di alleanza tra le stesse ed era rispetto a
questo, insignificante il consenso della donna, era tra l’altro l’aspetto più importante
del matrimonio; nei vari strati sociali era diffusa anche per via del paganesimo, con
rituale di sacrificio animale in favore degli Dei per ottenere attraverso l’esame delle
viscere dell’animale il loro favore. Per la Chiesa era tutt’altro che una cosa positiva o
innocente perché prevedeva spargimento di sangue ed esamina delle viscere della
bestia, certamente non stordita prima di essere sgozzata e sviscerata. Erano, come
sopra accennato rituali ed usanze pagane in netto contrasto con la Chiesa che arginò
queste barbarie eliminandole dal rito religioso appena istituito, tuttavia ne mantenne
alcune ma solo quelle che non andavano in contrasto con il credo cristiano: ossia la
figura del celebrante, il sacerdote e non più un notaio o un divinatore, la promessa di
nozze e lo scambio del consenso, tramite domanda durante il rito o diretto e il
trasferimento della moglie presso la casa del marito). Tale concilio venne convocato
da Papa Innocenzo III il 19 aprile 1213, ebbe inizio con il discorso inaugurale dello
stesso, l'11 novembre 1215 e si concluse con la terza sessione del 30 novembre. Allora
era a capo dell’impero Federico II di Svevia (Jesi, 26 dicembre 1194 – Fiorentino di
Puglia, 13 dicembre 1250).
L’importanza di un Concilio in una data epoca: Storia di un matrimonio religioso –
La tutela del soggetto più debole

A prescindere dalle diverse forme che il matrimonio ha assunto nel tempo ed anche
le varie tipologie di unioni possibili nella nostra epoca recente, l’istituzione del
matrimonio in quel periodo specifico ebbe un impatto di tutela importantissimo.
Quando si affronta la storia, bisogna capire ed immedesimarsi nel contesto, per
rendersi conto della specifica importanza di un fatto. Nella nostra epoca recente è
possibile, separarsi, divorziare e risposarsi, sia da parte di uomini che di donne, senza
incorrere in grossi problemi. Nel medioevo la donna e i bambini non erano tutelati.
L’uomo, unico che lavorava, poteva tranquillamente lasciare la donna ed accadeva
abbastanza spesso, anche letteralmente da un giorno all’altro, non essendoci nessun
vincolo contrattuale, di tutela dei soggetti più deboli. In questo modo si voleva
arginare il fenomeno. La donna quando si sposava con i riti antecedenti non era
tutelata, perché non vi era un contratto, veniva considerata dall’uomo meno di una
bestia, veniva comprata e col passare degli anni, sfiorendo ed invecchiando, essere
lasciata anche solo per questo, in favore di una più giovane e florida. La donna non
aveva una casa sua di proprietà e non poteva se lasciata restare nella casa in cui aveva
vissuto fino ad allora con il marito e i bambini. Il matrimonio istituito con il Concilio
divenne indissolubile, infatti ne venne impedito il divorzio, il legame cessava
solamente con la morte di uno dei due coniugi. Vi fu l’obbligo delle pubblicazioni, per
evitare matrimoni clandestini e allo stesso modo furono vietati matrimoni combinati,
i due futuri sposi dovevano dichiarare pubblicamente il loro libero consenso
all’unione e questo a tutela prevalentemente del soggetto più debole, la donna,
spesso costretta dalle volontà della famiglia di origine. Ci si poteva tra l’altro sposare
solo in età adulta, attorno ai nostri 21 anni, per evitare il matrimonio di bambine e
giovani donne. Sempre a tutela dei soggetti più deboli, fu posto l’annullamento dello
stesso in casi gravissimi quali: violenze, rapimento, matrimonio clandestino, non
consumazione. Diventerà ufficialmente sacramento nel 1493 con il Concilio di Firenze.
La storia passa ma l’uomo rimane uguale a se stesso: da Homo Sapiens a?
Qualcosa in fondo deve essere andato storto (sigh sob)
Spesso si tende a vedere la storia come un passato in cui si era nel buio e vediamo noi
come l’uomo nuovo, l’illuminazione progressiva di una evoluzione. L’uomo o Homo
sapiens è rimasto uguale a se stesso, non si è evoluto. Siamo semplicemente abituati
tramite etichette a ritenerci evoluti, semmai le industrie hanno avuto dei progressi
grazie all’uomo, ma le scoperte sono sempre state fatte dagli uomini anche in epoche
distanti cronologicamente da noi, uomini di oggi. Un solo esempio: le piramidi. Basta
vedere le piramidi per capire che già da allora avevano fatto scoperte architettoniche,
grazie all’uso della matematica e della geometria; tra l’altro oggi architetti ed

ingegneri non riescono a capire come abbiano fatto a scoprire come fare determinate
opere, così maestose, per i tempi e per quello che avevano a disposizione. Molte cose,
sono con il tempo andate perse, molte fonti scritte ed è sicuro che avevano scoperto
cose che noi ancora non conosciamo, semplicemente a noi non è arrivato il
documento che spiegava il tutto.
La storia passa e si ripete, diciamo che è ciclica, come la moda. Domanda: “In che
epoca viviamo?”
Come abbiamo visto l’uomo è rimasto Homo sapiens. La storia ha avuto tanti diversi
periodi, ma oggettivamente il periodo che stiamo vivendo ora, non lontano da qui, è
molto simile al Crollo dell’Impero Romano D’Occidente (476 d.C [attenzione a non associare il
tutto solo alla data, vedi approfondimento nello stesso paragrafo]). Un moto irrefrenabile e continuo di
persone, continue pressioni: Le Invasioni del V secolo. Vi è l’abitudine di fissare per
qualsiasi cosa una data, è ovvio che le date siano fondamentali, ma non è che L’impero
Romano sia crollato di colpo quel giorno, si sono svegliati e sbam, caduti e crollati a
terra. Il tutto era il risultato di un periodo di pressioni a cui non hanno saputo trovare
una soluzione. Come oggi ed allora, se arrivano in modo continuo persone e badate
bene, con le invasioni del V secolo (e come con quelle continue di questo nostro
periodo storico) non è che arrivassero solo guerrieri e combattenti, anzi, erano intere
popolazioni fatte di uomini, di donne, di anziani e di bambini che fuggivano da
situazioni allucinanti e disastrose, quindi un fiume incontenibile. Come vera invasione
si può considerare quella degli Unni, in realtà gran parte delle popolazioni, stavano
emigrando. Quando si ha un Impero così grande e non si tratta di una città, come può
essere oggi per noi Budapest, ma di interi Stati odierni, si capisce come fu difficile
contrastare un fenomeno che prevalse. Perché oggettivamente se vieni letteralmente
assediato hai solo due possibilità o accogli o uccidi. E determinate invasioni, portano
effetti a prescindere devastanti, perché ti ritrovi nei vari confini persone e popolazioni
con usanze, lingue diverse e gestire un flusso simile, soprattutto con i mezzi di allora
fu impossibile (vedi Merkel e suddivisioni migranti, una quota per stato UE).
Bisogna tenere conto che le invasioni furono continue ed erano già iniziate nella metà
del IV secolo con gli Unni, sui confini di Danubio e Reno, per poi proseguire fino alla
caduta dell’Impero, per capire la fine e il declino di un’era. All’epoca il fiume era
fondamentale sia come mezzo per fa passare uomini e merci, sia perché era un punto
vulnerabile di accesso. La Legione romana era l’unità militare di base dell’esercito
romano. Da tenere presente che nei vari schieramenti, il primo era composto dalla
fanteria, fanti quindi giovani ragazzi o soldati a piedi, reclutati in massa perché erano
i più sacrificabili. Erano sprovvisti di scudo, erano i primi a morire (differenze rispetto al

cinema romanzato storico dove appaiono grandi eroi che corrono con armature, il peso di una sola armatura
impedirebbe a chiunque di correre e saltare).
Oltre agli Unni, migrarono i longobardi e ovviamente fu un processo lungo come
prima descritti i vari flussi migratori, quello longobardo fu plurisecolare: partirono
dalla Scandinavia meridionale alla penisola italiana. Sfruttarono il duplice aspetto
accennato prima dei fiumi, risalirono il fiume Elba nei primi 4 secoli per poi nei 3
secoli successivi stanziare lungo il medio corso del Danubio, fin oltre quindi il crollo
dell’Impero Romano. Nell’impero romano il fiume Reno formava la maggior parte
del confine settentrionale ed era di uso vitale per il commercio interno. (Uno dei più
lunghi dell’Europa ben 1233 km nasce in dalle Alpi Svizzere, segna il confine con la Germania prima di svoltare a nord
presso Basilea, cittadina svizzera. Superata Basilea, segna il confine della parte meridionale tra Germania e Francia per
poi entrare in Germania. Lungo il Reno ci sono molte industrie, concentrate soprattutto nella regione della Ruhr,
attraversando Colonia Düsseldorf e Duisburg, dove vi è il più grosso porto fluviale d’Europa. Da qui gira verso ovest nei
Paesi Bassi e dopo aver oltrepassato il confine olandese, raggiunge la sua massima ampiezza, sfocerà nel Mar del
Nord. Nell’impero romano facevano parte del Reno alcuni tratti finali di fiume che ad oggi non ne fanno più parte e
sono attualmente piccoli fiumi e ruscelli che scorrono verso nord. [Il Danubio nasce in Germania e sfocia nel Mar
Nero).