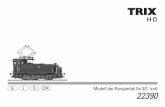SO.CREM Genova | Società Genovese di Cremazione · nel Cinquecento da Aldo Manuzio), cosicché la...
Transcript of SO.CREM Genova | Società Genovese di Cremazione · nel Cinquecento da Aldo Manuzio), cosicché la...
3
EditorialeDalle balze dell’isola di Ventotene dove,
insieme ad altri illustri compatrioti era stato relegato dal nefasto regime, Altiero Spinelli vagheggiò la prospettiva di un’Europa unita. Nella lunga detenzione, il grande italiano tradusse via via le idee in progetti, in vie maestre di una auspicabile comunità.
Finì la guerra e l’“humus” nel quale andò col tempo a germogliare l’ideale di Spinelli, tradotto in soggetto politico nel Manifesto di Ventotene, fu il caos del dopoguerra. Milioni di cittadini di ogni nazionalità, tra deportati ed espatriati coatti, si trovarono dispersi su tutto il Continente. Francesi e olandesi, inglesi e italiani, reduci da atroci comuni sofferenze, sulla via del rimpatrio a rifare la casa, una famiglia, una occupazione, accolsero il messaggio di una unione europea con favore. Ancor più favorevole giunse quello di uomini politici e statisti.
Assistemmo ad anni di incontri, convegni, assemblee, congressi e il Progetto scaturì nel trattato della comunità del carbone e dell’acciaio, le due materie più preziose nel clima della ricostruzione. Era già un primo passo, importante e prodromo di notevoli sviluppi. Infatti sorsero le prime sedi politiche, economiche, amministrative della Comunità a Bruxelles e a Strastburgo e là convennero sempre in maggior numero delegati di ogni nazionalità. Nasceva il Parlamento europeo che di tempo in tempo assunse funzioni legislative emanando leggi, norme e disposizioni comunitarie sugli aspetti e i problemi più numerosi e articolati della convivenza continentale. Passo notevole fu il trattato per la libera circolazione dei cittadini su tutto il territorio comunitario, senza barriere e passaporti.
Altra enorme realizzazione per cementare la Comunità fu l’istituzione dell’ “Erasmus” inteso a promuovere lo spostamento temporaneo di giovani da una nazione in un’altra con programmi di alto profilo, culturale, tecnico e universitario. Proprio là si sono già formate le nuove generazioni di giovani con ideali e acquisite conoscenze, preparazione
culturale e scientifica, accomunati dalla stessa concezione politica.
Con la moneta unica raggiunta e i sistemi economici e bancari in strette relazioni, si pensò proprio che l’Europa si fosse alfine sorta. Certo, ancora molto c’era e c’è da fare, molte le nuove ausicabili mete, ma la comunità era ben salda al primo traguardo. Ben salda fin quando non vennero le stagioni dei guai.
La prima è quella dei migranti che ancora ci tormenta. Paesi, come l’Italia, pronti all’accoglienza e già ben affollati di poveracci nullafacenti da integrare, e Paesi decisi severamente a tener chiuse le frontiere. Un po’ di ragione l’avranno gli uni e un po’ gli altri, ma non ci sembra un buon esempio di unità comunitaria.
In questi ultimi anni sono intervenuti i disaccordi territoriali. Ne son venuti altri fuori del territorio occidentale, come quello russo (Ucraina & Co.) che recise aree e territori dal cuore moscovita della mastodontica ex-Unione Sovietica. A noi però interessano i nostri, i più dolenti, Quello inglese, distacco a più anime con le vecchie cariatidi isolazioniste, sempre prevenute col Continente, e le
giovani generazioni che, già legate nelle comuni convivenze, sono già la nuova Europa.
Un distacco britannico ideologico al quale deve aggiungersene un altro, quello scozzese, uno Stato che da secoli ha sempre pensato in modo diverso dalla “Old England” e che ora vorrebbe fare a meno di Londra e del suo sistema economico e bancario. Ultima, di questi giorni, la frattura della Catalogna dalla Spagna. Una Catalogna benestante contro altrettanta benestante terra degli “hidalgo” madrileni. Una storia millenaria contro un’altrettanta storia millenaria. Che dire? Amareggiati. Dopo quello che da decenni si è fatto per tenere unita l’Europa e quello che tutt’oggi si fa per ricucirla, che cosa possiamo aspettarci?
Dolenti, dobbiamo però dire che decisamente la Comunità non naviga in buone acque.
Giorgio Spina
4
Vedere il manoscritto del “Canzoniere” di
Francesco Petrarca (1304-1374) con le correzioni
di mano del Poeta è un’emozione, poichè centinaia
di anni ci separano dal momento in cui quelle
parole furono scritte, ripensate e corrette. Sino
all’avvento del computer, che è conquista recente,
ogni scrittore usava lo stesso metodo: scrivere di
getto, poi correggere e ricorreggere con aggiunte
a margine o infralineari, che permettono di
ricostruire le fasi dell’attività creativa.
Ma sembra opportuno
conoscere anche la
documentazione dei rapporti
intrattenuti dal Petrarca con i
signori di Padova, i Carraresi,
che gli assicurarono
protezione e forse ne
facilitarono l’accrescimento
della fama con la diffusione
delle sue opere in tutta
Europa, grazie anche al ruolo
degli studenti tedeschi, che
frequentavano la famosa
università patavina.
I signori di Padova
furono molto generosi e
non risparmiarono ricchi
compensi al Petrarca, che spesso inviavano
come ambasciatore nelle varie corti d’Italia. Così
il Poeta poté concedersi il lusso di comprare
manoscritti preziosi e costosissimi, (allora la
stampa non esisteva ancora, perché fu inventata
nel Cinquecento da Aldo Manuzio), cosicché la sua
biblioteca fu la più famosa di Europa.
A questo proposito si ricorda un episodio
significativo: quando il Petrarca ricevette in dono
dall’ambasciatore di Bisanzio Nicola Sigero un
manoscritto contenente i poemi omerici, fu così lieto
che abbracciò con entusiasmo non l’ambasciatore,
ma il manoscritto esclamando: “Purtroppo non
so leggere il greco, ma certo questo è il dono più
importante che abbia mai ricevuto!”.
Occorre precisare che la conoscenza del
greco antico in Italia si
diffonderà più tardi, per
opera di greci fuggiti a causa
dell’invasione dei musulmani:
infatti per sbarcare il lunario
si offrirono d’insegnare il
greco agli uomini colti nelle
città e nelle corti.
Dante, che conosceva
tutte le arti del trivio e
del quadrivio (come si
chiamavano allora) non
sapeva il greco come, appunto,
non lo conosceva il Petrarca.
Solo Giovanni Boccaccio, più
giovane, ebbe la possibilità
d’imparare qualche rudimento
del greco, anche se con molte inesattezze. E ne era
molto fiero, tant’è vero che il titolo della sua opera
maggiore, il Decamerone, è composto da due
parole greche: “deca” (dieci) e “merone”, che sta
per “emeron” (giorni) ossia novelle di dieci giorni:
infatti le novelle sono divise in dieci giornate
LA BIBLIOTECA DEL PETRARCA
· C U LT U R A ·
5
con una struttura che in qualche
modo si vuole rifare alla Divina Commedia: cento canti aveva la
Divina Commedia e centro novelle
ebbe il Decamerone.
Ricordiamo che la
Commedia di Dante fu definita
“divina” proprio dal Boccaccio,
da intendersi nel senso che parla
di Dio. Il Comune di Firenze
affidò l’incarico al Boccaccio di
leggere e commentare nella chiesa
di Santo Stefano di Badia i canti
del Poema. Infatti il Boccaccio
si era pubblicamente pentito
delle novelle licenziose, che aveva incluso nel
Decamerone, e viveva in grande austerità. Così
alla soglia dei sessant’anni ricevette questo grande
onore.
Ma ritornando al Petrarca e alla sua passione
per Omero, c’è da ricordare che nel suo testamento
il Poeta indicò sette città come luogo della sua
sepoltura (Padova, Arquà, Venezia, Milano, Pavia,
Roma, Parma), così come sette erano le città che
si erano contese l’onore di possedere le spoglie di
Omero. Petrarca fu sepolto ad Arquà, a quaranta
chilometri da Padova, dove aveva il suo ritiro
preferito e dove ancora c’è la sua tomba.
Appena un cenno sul “petrarchismo”, ossia la
moda d’imitare il Petrarca, il cui “Canzoniere” fu
preso a modello dai poeti italiani fino all’Ottocento.
Principale ammiratore e imitatore del Petrarca fu
Pietro Bembo, famoso poeta del Cinquecento.
Clara Rubbi
6
Vincent Van Gogh nel quadro di Paul Gauguin “Il pittore dei girasoli” appare seduto di fronte al suo cavalletto col pennello in mano che sta sfiorando la tela, avendo al fianco la sua tavolozza.
Van Gogh è ritratto da Gauguin col viso rivolto verso il vaso di girasoli, quasi stesse immaginando la pennellata prossima. I suoi occhi non sono del tutto aperti, egli è concentrato come se stesse sognando.
Il suo volto non sembra regolare, distorto con la fronte troppo piccola ed il mento ricoperto dalla barba rossiccia, decisamente prominente. Il vaso dei girasoli è posato su dì una sedia impagliata, del tutto simile a quella già dipinta da Van Gogh. Sullo sfondo c’è il muro turchese dell’atelier che da sfondo al braccio del pittore che indossa un giaccone marrone; appeso al muro si scorge Io scorcio di un dipinto che raffigura un panorama, di certo un quadro di Gauguin.
Nonostante l’amicizia dei due pittori forti tensioni si sono sviluppate fra questi due caratteri conflittuali e sembra che Gauguin sia in piedi in posizione predominante rispetto a Van Gogh seduto, riflettendo la sua più forte personalità. Diverse personalità e diverso modo di vedere la pittura: romantico Van Gogh e primitivo Gauguin. Di solito gli impressionisti dipingevano in “plein air”, all’aperto, per cogliere le sfumature che la luce regala, ma dal momento che questo quadro fu dipinto in dicembre, quando Gauguin andò da
Van Gogh, questo quadro venne dipinto in casa. E mentre Gauguin lavorava in gran parte con l’ausilio della memoria visiva e l’immaginazione, Van Gogh era solito lavorare dal vivo col soggetto da riprodurre sulla tela, accanto a lui.
Ad Arles Van Gogh sognava di costituire un sodalizio artistico coi suoi vecchi compagni parigini. Per cui invitò il suo amico Gauguin a raggiungerlo al più presto nella sua nuova dimora, e nell’attesa dipinse quattro tele raffiguranti i girasoli che servivano per decorare la sala per i visitatori nel suo atelier. Gauguin arrivò ad ottobre e vi trascorse dieci tormentate settimane.
Il quadro “Il pittore dei girasoli” fu promesso al fratello di Vincent, Theo, al quale Paul Gauguin lo inviò con questa dedica: “Non è forse una buona somiglianza, ma rivela di sicuro qualcosa della sua interiorità”. Theo rispose che era d’accordo
affermando che era il miglior ritratto che fosse mai stato fatto di Vincent. Questi capi che Gauguin aveva catturato quando egli stesse vivendo e sentendo in quel periodo: “Realmente sono io, tanto tanto stanco e pieno di elettricità”. Durante la loro convivenza anche Van Gogh aveva tentato di fare un ritratto di Gauguin, ma con poco successo. Questa tela riposò per decenni nei depositi del Museo Van Gogh, come ritratto non identificato fatto da un artista sconosciuto. Solo nel 200 l il Museo accettò o meglio riuscì a valutare con certezza chi fosse l’autore ed il soggetto raffigurato.
IL PITTORE DEI GIRASOLIE IL POETA
Van Gogh - Ritratto
7
In una sera di quel dicembre, la loro amicizia finì. Gauguin scrisse in seguito che Van Gogh era certo che lui avrebbe lasciato Arles mentre di notte di soppiatto si recava nella sua camera per accertarsi che fosse ancora lì. Ma soltanto la condizione psichica di Van Gogh trattenne Gauguin: “malgrado i nostri contrasti non posso prendemerla con un uomo malato”. La sera del 23 dicembre 1888 Paul Gauguin esce per fare due passi e Van Gogh, sospettoso, lo pedina. Gauguin si volta e vede un uomo dal viso stravolto con
un rasoio in mano. Vincent, vistosi scoperto, torna a casa e Paul molto turbato va a dormire in albergo. La mattina dopo Gauguin scopre che in Arles c’è un certo trambusto: Van Gogh si era tagliato volontariamente parte dell’orecchio sinistro. Gauguin tornò a Parigi senza più rivedere l’amico. Così finì tragicamente il rapporto fra due mostri sacri, tanto diversi nella loro espressione artistica quanto più nel carattere. Due grandissimi artisti con due indoli, due vite ed un’arte diversa, due personaggi che hanno lasciato un’ impronta enorme nel mondo della pittura. Gauguin parlò del soggiorno ad Arles come un brutto capitolo della sua vita e Van Gogh guardando il suo quadro finito disse: “Sono proprio io nella mia pazzia”.
Proseguendo su Van Gogh, in quanto le sue opere affascinano chiunque le osservi, si può esaminare un quadro, sicuramente tra i meno noti,
ma importante perché segna la linea di confine nel percorso artistico di Vincent, un allontanarsi dal mondo impressionista per andare incontro ad uno stile tutto personale.
Il quadro raffigura Eugene Boch, un pittore belga. Fu un pittore americano, Mac Knight, che lo fece incontrare con Van Gogh e si instaurò un rapporto di amicizia. Il pittore belga colpì Vincent, che disse:: “quel giovanotto ha un viso come una lama di rasoio e occhi verdi”.
Van Gogh scrisse al fratello Theo per annunciargli che aveva deciso di ritrarre il suo amico Boch. Una domenica del 1888 ad Arles, Boch posò due volte, vestito con molta eleganza, nella famosa “casa gialla”, la stessa, dove pochi mesi dopo, finì la storica amicizia con Paul Gauguin. Alcuni giorni dopo Vincent provò a riprodurre una tela definitiva del “poeta contro un cielo stellato”: poeta in quanto Vincent rivedeva in lui lo stesso sguardo di Dante.
E’ opportuno parlare del quadro che raffigura una persona molto magra, col viso affilato, la barba appuntita e le spalle cadenti, che danno l’impressione di un uomo molto debole e vulnerabile. Sul viso troviamo tracce di vari colori: verde,
giallo ocra e rosa; uno sguardo molto penetrante, acuito dalle folte sopracciglia.. Una giacca che approssimativamente si può definire gialla, che contrastava tantissimo con il cielo blu stellato.
Un anno dopo la morte di Vincent il ritratto fu donato dalla cognata di Vincent a Boch, che lo lasciò alla sua morte, avvenuta nel 1941, al Museo del Louvre. La sorella di Boch, Anna, artista, organizzatrice di mostre, musicista e collezionista fu nel 1890 la sola persona a comprare un quadro venduto da Van Gogh nell’arco della sua vita: “Il rosso vigneto”, quadro da lui eseguito dopo la partenza di Boch da Arles. Anna Boch amava la pittura di Vincent Van Gogh nella sua totalità, forse influenzata dai racconti del fratello che gli aveva parlato del periodo vissuto in Provenza col maestro olandese.
Gaetano Francesco Bosano
8
Dante da giovane condusse vita scapestrata, ebbe passioni violente, come quella per madonna Pietra. L’amore per questa donna, dominato dai sensi, fu esempio di quel traviamento, di cui in seguito Dante si pentì. Come si pentì di quella vita trascorsa nelle osterie a bere e a scambiarsi ingiurie fra amici. Compagno di bagordi e di sfrenatezze amorose fu Forese Donati, che Dante incontra nel Purgatorio. Questi si vergogna dei suo passato e dice:
se ti riduci a mentequal fosti meco e quale io teco fui
ancor fia grave il memorar presente (XXIII w. 115-117).
Amore passionale fu anche quello di Paolo e Francesca, che Dante incontra nell’Inferno fra le anime dei lussuriosi. Il termine “lussuria”, che nella teologia cattolica è uno dei sette vizi capitali, indica lo stimolo sessuale violento e non controllato dalla ragione. Così come irragionevole fu la passione che travolse Paolo e Francesca, un amore che condusse alla morte, in quanto i due amanti furono uccisi dal marito di Francesca, Gianciotto Malatesta da Rimini. Pare che Paolo fosse molto bello e prestante a differenza del fratello Giangiotto, brutto e sgraziato.
Dante incontra all’Inferno Paolo e Francesca (canto V,vv. 100-103), incontro che racconta con queste parole. Parla Francesca, mentre Paolo tace e piange.
Amor, che al cor gentil ratto s’apprende. prese costui de la bella persona
che mi fu tolta, e il modo ancor m’offende
Bella era, dunque, anche Francesca, che è stata uccisa in un modo che “ancor m’offende”. Si discute sul significato di questa offesa, ma l’interpretazione più probabile è quella secondo cui Francesca è stata offesa da quella morte improvvisa, che le ha impedito di pentirsi e così di salvare l’anima. Ma anche per il marito ci sarà punizione, perché andrà all’Inferno nella zona della Caina, dove sono puniti i traditori dei parenti (detta “caina” con riferimento a Caino che uccise il fratello Abele).
Dante si commuove sino alle lacrime per questo racconto al punto che Francesca è disposta a raccontargli come avvenne che il loro amore,
nutrito di sospiri e di sguardi, si sia trasformato in passione. Mentre Francesca racconta e Paolo piange, Dante si sente così coinvolto da svenire. (“e caddi come corpo morto cade” v.141). Su questo svenimento di Dante la critica ha versato fiumi d’inchiostro. La più probabile interpretazione
DANTE E L’AMORE
9
è quella secondo cui Dante si commuove per la sventura di Francesca, ma pensa forse ai propri peccati d’amore e a quello che gli sarebbe potuto succedere, magari una pugnalata di notte da parte di qualche marito geloso. Anche fui sarebbe stato colto dalla morte come peccatore senza possibilità di pentimento.
Ma nella vita di Dante compare anche l’amore per Beatrice, amore puro che innalza l’anima a Dio.
“La vita nova” è un esile libretto in cui Dante racconta l’amore per Beatrice, un amore solamente spirituale, un amore che purifica e innalza l’uomo verso Dio. Anche il nome Beatrice è significativo: è colei che beatifica; del resto sarà proprio Beatrice che guiderà Dante in Paradiso sino alla visione di Dio. Diciamo subito che Dante
era sposato con Gemma Donati, dalla quale aveva avuto tre figli. E’ chiaro che ai nostri occhi il fatto di un uomo sposato, che scrive versi per un’altra donna, crea sconcerto. Ma se poniamo la cosa sul piano metafisico, forse possiamo comprendere meglio.
Quello per Beatrice è un amore teologico, un amore che ha effetti morali, che aprono allo spirito una “vita nuova”, rinnovata dall’amore. Celebre il
sonetto che Dante scrive e che qui riportiamo:
Tanto gentile e tanto onesta parela donna mia, quand’ella altrui saluta ch’ogni
lingua divien tremando muta e gli occhi non l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d’umiltà vestutae par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.Mostrasi sì piacente a chi la mira
che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intende non la può chi non la prova,E par che da te sue labbia si mova
uno spirito soave pien d’amoreche va dicendo all’anima: Sospira.
L’interpretazione di questo sonetto ha impegnato gli studiosi da sempre. Soprattutto la parola finale “sospira” ha dato origine alle più svariate interpretazioni. Forse la più conforme al contesto spirituale del sonetto è quella che si rifà alla teologia cristiana, dove” sospira” vuole indicare l’afflato dell’anima verso il cielo. Del resto il verbo latino “suspirare” ha anche il significato di “anelare”.
Arriviamo sino al Paradiso e nel canto VIlI troviamo gli “spiriti amanti”: sono luci limpidissime, che trascorrono veloci per il terzo cielo: l’amore diventa “Caritas”. Qui nel Paradiso la passione d’amore si è purificata totalmente ed è diventata tensione mistica: Dante ha compiuto tutto il percorso dalle infernali taverne alla luce del Paradiso.
Clara Rubbi
10
Col pontificato di papa Francesco si è aperta una nuova stagione del dialogo ecumenico, culminata nel viaggio del pontefice a Lund in Svezia, in occasione dell’inizio delle celebrazioni per i 500 anni della Riforma protestante. È la prima volta che un papa viene invitato alla commemorazione di un anniversario della Riforma. Gesti simbolici come una statua di Lutero posta nell’Aula Paolo VI in Vaticano durante l’udienza a un gruppo di pellegrini tedeschi; espressioni del pontefice come «io credo che le intenzioni di Martin Lutero non fossero sbagliate: era un riformatore», «Lutero ha fatto un grande passo per
mettere la Parola di Dio nelle mani del popolo», indicano un preciso cammino ecumenico. Per Brian Farrell, segretario del pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, il primo motivo di questa commemorazione in comune è che «molte delle critiche e delle proposte avanzate da Lutero erano necessarie»; il secondo motivo è la capacità «adesso di avere una visione comune
dei pregi e dei mali da entrambi le parti e una coscienza che ciò che ci unisce è più importante di ciò che ci divide».
Per dirla in altro modo: la storia non solo non si può cancellare, ma dalle vicende anche le più conflittuali si può trarre insegnamento. Il 31 ottobre 1517, alla vigilia della festa di Ognissanti, il frate agostiniano Martin Lutero affigge alla porta della chiesa del castello di Wittenberg il documento Discussione sulla dichiarazione del potere delle indulgenze, divenuto poi noto come Le 95 Tesi. All’origine c’è l’elezione ad arcivescovo di Magonza concessa da papa Leone X ad Alberto
di Hohenzollern col versamento alla Camera Apostolica di 24 mila ducati, prestati dalla banca dei Fugger. Per compensarlo Leone X, con la bolla Sacrosancti Salvatoris et Redemptoris del 31 marzo 1515, gli concede in esclusiva il privilegio di dispensare nei suoi territori, per un periodo di sei anni, l’indulgenza plenaria che assicura davanti a Dio la remissione delle pene nell’aldilà, dietro versamento di una offerta per la fabbrica di San Pietro.
Col suo documento Lutero interviene contro la prassi dell’indulgenze e la dottrina del tesoro dei meriti della Chiesa su cui essa si fonda, contro il preteso potere del papa sulle anime del Purgatorio e la venalità della curia romana. Per Lutero nessuna azione umana può vincolare il volere divino e la salvezza è soltanto opera della Grazia. Buona parte delle tesi verte proprio sul tema della misericordia e della
IL QUINTO CENTENARIO DELLA RIFORMA PROTESTANTE
11
remissione dei peccati, rovesciando la prospettiva per cui il perdono piova sui fedeli da un’indizione papale e proponendo la conversione individuale come vera e unica fonte della misericordia. Le 95 Tesi redatte in latino per suscitare una discussione fra dotti, vengono subito tradotte in tedesco e diffuse in tutta la Germania, destando grande scalpore. Inizia così lo scisma protestante, un terremoto che non ha conseguenze solo religiose, ma provoca una svolta determinante nella storia europea.
Il 15 giugno 1520 Lutero è condannato da papa Leone X con la bolla Exurge Domine. «“Sorgi, o Signore, e giudica la tua causa… Sono sorte volpi che cercano di demolire la vigna” che Tu hai costruito e affidato a Pietro ed ai suoi successori. “Il cinghiale della selva tenta di devastarla, l’animale selvatico pascola in essa”». Lutero risponde con lo scritto Contro l’esecrabile bolla dell’Anticristo e assiste il 10 dicembre 1520 al rogo dei libri della teologia scolastica e del corpus del diritto canonico, organizzato a Wittenberg dall’umanista Filippo Melantone. Lutero, con grande commozione, dà pubblicamente alle fiamme la bolla papale con un gesto che sancisce la definitiva rottura con Roma. Il 3 gennaio dell’anno seguente, la bolla papale Decet Romanum Pontificem scomunica Lutero. Il caso finisce all’attenzione di Carlo V, eletto imperatore non ancora ventenne nel giugno del 1519, che gestisce la questione con accortezza. A questo fine convoca il ribelle nella prima riunione della Dieta imperiale fissata a Worms nell’aprile del 1521. Lutero vi giunge dopo un giro trionfale in tutta la Germania e all’imperatore che gli chiede di ritrattare le sue dottrine risponde che se non gli si dimostra con la Bibbia alla mano che sbaglia, non può negare ciò che la coscienza gli impone di credere. E conclude con le parole rimaste famose: «Io non posso e non voglio ritrattare nulla perché non è giusto né salutare andare contro coscienza.
Iddio mi aiuti. Amen. Qui sto saldo. Non posso fare altrimenti».
Lutero invita l’imperatore, i principi, i cavalieri e tutti i laici con responsabilità politiche a convocare un concilio di riforma della Chiesa, affermando che ogni credente è sacerdote contro il presunto primato dei chierici sui laici e contro la pretesa papale all’infallibilità e al diritto esclusivo di convocare i concili. In particolare Lutero propone il ritorno del papato a funzioni solo spirituali, una maggiore autonomia delle chiese nazionali, l’abolizione del celibato per i parroci e la loro elettività da parte delle comunità. Ribadisce che l’efficacia dei sacramenti dipendono non dall’atto in sé, ma dalla fede che Dio opera in chi li riceve. Rifiuta i sacramenti non istituiti da Cristo, cioè ordine, cresima, matrimonio ed estrema unzione, e mantiene solo battesimo ed eucarestia, ammettendo la presenza reale di Cristo nel pane e nel vino, ma rifiutando la dottrina della transustanziazione e della messa come sacrificio. Anche la confessione rimane, ma solo come rinnovamento della promessa del perdono. In particolare con l’abolizione dell’ordine sacro Lutero conferma la dottrina del sacerdozio universale e abbatte le pretese teocratiche della Chiesa. Nel De votis monasticis Lutero prende posizione contro il monachesimo enunciando la sua concezione della vocazione cristiana, da realizzarsi nella vita familiare, lavorativa, civile ed ecclesiastica. Lutero stesso si sposa nel 1525 con una ex monaca, Caterina von Bora, da cui nascono sei figli e la sua famiglia costituisce il modello della famiglia patriarcale protestante.
Scrittura e coscienza sono i due pilastri del movimento «protestante», nel senso che «pro-attesta», «fa da testimone» al Vangelo di Cristo. La Riforma ha successo laddove ha l’appoggio del potere politico, come nella Germania settentrionale, in Scandinavia, lungo le coste baltiche dominate
12
dalla Lega anseatica, in Inghilterra. Del 1545 è l’ultimo scritto di Lutero, Contro il papato di Roma, sostenuto dal diavolo, in cui dubita che papa Paolo III voglia un vero concilio perché per lui le tre parole «libero, cristiano, tedesco» equivalgono a «veleno, morte, diavolo e inferno». Il 13 dicembre 1545, infatti, inizia il Concilio di Trento che si conclude nel 1563 e passa alla storia come il Concilio della Controriforma. A vigilare sulla correttezza nel modo di vivere e credere provvede fin dal 1542 l’istituzione dell’Inquisizione (il Sant’Uffizio, poi Congregazione per la dottrina della fede), il cui compito consiste principalmente nell’inquisire, indagare, giudicare, punire i devianti dall’ortodossia. Il 18 febbraio 1546 Martin Lutero muore a Eisleben.
Di fronte a una vita così lacerante e una frattura così dolorante, sorge spontanea la domanda in che cosa oggi possa consistere «il contributo di Lutero al cristianesimo». In un breve volgere di anni la Riforma ha diviso la res publica christiana e innescato guerre, controversie, conflitti destinati a durare per secoli all’insegna del fanatismo e dell’odio teologico. Se da parte luterana il Papa è visto come «l’anticristo» e Roma è definita «la
meretrice coperta di porpora», i cattolici equiparano Lutero a Satana. Ancora nel Catechismo Maggiore di San Pio X del 1905 si legge a proposito della grande eresia del Protestantesimo: «Questi novatori demolirono tutti i fondamenti della fede, esposero il Libri Santi alla profanazione della presunzione e dell’ignoranza ed aprirono l’adito a tutti gli errori. Il protestantesimo o religione riformata, come orgogliosamente la chiamarono i suoi fondatori, è la somma di tutte le eresie, che furono prima di esso, che sono state dopo e che potranno nascere ancora a fare strage delle anime».
Solo la storiografia del Novecento lentamente e con grande fatica supera queste barriere. Un cambiamento epocale è dovuto al cattolico Joseph Lortz che, con l’opera La Riforma in Germania, sottopone a critica imparziale la chiesa tardo-medievale e affronta un’attenta revisione dell’immagine di Lutero. Nella tensione tra l’ideale e il reale, Lutero ha dichiarato guerra al papa e ha rifiutato il cattolicesimo perché non vi ha trovato o non ha creduto di trovarvi l’essenza del Vangelo. Lo storico valdese Giovanni Miegge, per tanti anni professore di storia del Cristianesimo alla Facoltà valdese di teologia a Roma, col suo Lutero giovane,
13
uscito in prima edizione nel 1946 a Torre Pellice e poi in diverse edizioni aggiornate e arricchite, ripercorre con scrupolosità scientifica la vita del giovane riformatore. Lo studio ha il merito di sfatare tanti pregiudizi, pure in campo protestante, e restituire al dialogo ecumenico il Lutero della storia. Nuovi approfondimenti, in particolare sul tema della Giustificazione ad opera di Hans Küng, dimostrano che il pilastro che da sempre ha rappresentato la discriminante tra luterani e cattolici non ha ragione di sussistere. Nella controversia così fondamentale scendono in campo i due padri nobili della teologia contemporanea: Karl Barth per i protestanti e Karl Rahner per i cattolici, entrambi schierati col giovane Küng.
L’evento epocale del Concilio ecumenico (1962-1965) ha impegnato tutti i cattolici a riflettere sul significato delle divisioni confessionali e sulla possibilità, necessità, urgenza di riconciliarsi nell’unica fede in Cristo. Nel decreto sull’ecumenismo, Unitatis redintegratio, si dichiara che «è necessario che i cattolici con gioia riconoscano e stimino i valori veramente cristiani, promananti dal comune patrimonio, che si trovano presso i fratelli da noi separati». «Né si deve dimenticare che quanto dalla grazia dello Spirito Santo viene compiuto nei fratelli separati, può pure contribuire alla nostra edificazione. Tutto ciò che è veramente cristiano, non è mai contrario ai beni della fede ad esso collegati, anzi può sempre far sì che lo stesso mistero di Cristo e della Chiesa sia raggiunto più perfettamente».
In questo iter del dialogo luterano-cattolico può considerarsi una pietra miliare la Dichiarazione sulla giustificazione, firmata ad Augusta nel 1999. Luterani e cattolici affermano ufficialmente il consenso sulle verità fondamentali della dottrina della Giustificazione. Si tratta di una
comune sottoscrizione su un aspetto fondamentale della fede sul piano dottrinale, grazie alla quale i cattolici riconoscono che i luterani non sono più soggetti all’anatema del Concilio di Trento e, nello stesso tempo, i luterani ammettono che i cattolici non sono più estranei alla giusta comprensione del mistero centrale della fede in Cristo. La preminenza della Grazia è una verità fondamentale necessaria per la vita cristiana, per la vita stessa della Chiesa, perché senza la fiducia nella grazia di Cristo i cattolici non possono costruire la Chiesa.
Da qui la Dichiarazione congiunta di papa Francesco e del reverendo Martin Junge, del 31 ottobre 2016 nella cattedrale luterana di Lund in Svezia: «Mentre siamo profondamente grati per i doni spirituali e teologici ricevuti attraverso la Riforma, confessiamo e deploriamo davanti a Cristo il fatto che luterani e cattolici hanno ferito l’unità visibile della Chiesa. Differenze teologiche sono state accompagnate da pregiudizi e conflitti e la religione è stata strumentalizzata per fini politici. E rifiutiamo categoricamente ogni odio e ogni violenza, passati e presenti, specialmente quelli attuati in nome della religione. Oggi ascoltiamo il comando di Dio di mettere da parte ogni conflitto».
Giuseppe Benelli
14
Quando si parla di Risorgimento, ossia il movimento che unificò l’Italia nel XIX secolo, il pensiero corre ai vari protagonisti. Molti di questi personaggi sono già stati ricordati sulle pagine di questa nostra Rivista. Questa volta desideriamo raccontare l’avventurosa vita di Carlo Di Rudio, nato a Belluno il 26 agosto 1832. Dal padre ereditò, oltre al titolo nobiliare, anche sentimenti patriottici e profonda insofferenza al dominio di Vienna. Infatti, all’epoca il Veneto era ancora una colonia dell’Impero Austriaco. Il nonno materno, il conte Fortunato De Domini, era un colonnello dell’esercito austriaco il quale aveva consentito che sua figlia Elisabetta sposasse il conte Ercole Di Rudio, ma non condivideva la fede repubblicana del genero. L’anziano militare fece tutto il possibile affinché il nipote potesse crescere e diventare pure lui un fedele ufficiale asburgico. Pertanto, nel 1845 il giovane Carlo fu mandato a studiare nel collegio militare di San Luca a Milano. Tre anni dopo si estese in Europa un movimento repubblicano che determinò numerose insurrezioni. E’ opportuno rammentare, infatti, che nel 1848 Karl Marx e Friedrich Engels pubblicarono Il Manifesto del Partito Comunista. In Francia la rivoluzione di febbraio fece perdere il trono al re Luigi Filippo. La Seconda Repubblica, affidata provvisoriamente ad Alfonso De Lamartine, come noto, finì poi nelle mani di Luigi Napoleone Bonaparte il quale, anni dopo, si proclamò addirittura imperatore. Nello stesso anno i tumulti di Vienna provocarono la caduta di Metternich, al quale furono revocati gli incarichi di governo. La tranquilla vita del collegio del nostro protagonista fu sconvolta dalla sollevazione popolare contro la dominazione austriaca, ricordata dagli storici con il nome “Le Cinque giornate di Milano”. Martedì 21 marzo 1848 i cadetti lasciarono l’edificio e furono aggregati all’esercito di Radetzky, il quale mosse verso il sistema difensivo delle truppe austriache compreso tra le fortezze di Verona, Peschiera, Mantova e Legnano, conosciuto con il nome di Quadrilatero. Anche il nostro protagonista lasciò
Milano, assieme agli altri cadetti, tra cui suo fratello Achille, pure lui iscritto alla stessa scuola militare. Di Rudio abbandonò l’accademia e alcuni mesi dopo si arruolò tra i volontari di Daniele Manin a difesa della Repubblica Veneziana, sorta dall’insurrezione che avvenne contemporaneamente a quella di Milano. Gli storici hanno trovato traccia dell’attività politica del giovane conte svolta a Venezia, classificata sovversiva dalla polizia austriaca. Il relativo fascicolo giudiziario fu trasferito, in seguito, a Parigi e posto agli atti del processo che si svolse anni dopo in occasione dell’attentato a Napoleone III. Di questo, però, parleremo più avanti. Gli eventi costrinsero Di Rudio a lasciare Venezia clandestinamente. Da quel momento, nonostante la sua giovane età, iniziò un lungo periodo particolarmente duro per Carlo, colmo di combattimenti, arresti, evasioni e latitanze. Nell’aprile del 1849 giunse a Roma con la divisa dei Garibaldini, per combattere assieme ai difensori della Repubblica Romana. Nel frattempo, infatti, le rivolte popolari si erano estese anche nelle strade dell’Urbe. Timoroso delle agitazioni capeggiate da Angelo Brunetti, detto Ciceruacchio, per ottenere le riforme, nel novembre dell’anno precedente Papa Pio IX si era rifugiato a Gaeta, all’epoca ancora territorio di Ferdinando II Borbone. Il pontefice chiese e ottenne la protezione dalle principali potenze europee dell’epoca: Francia, Austria e Spagna. Alle redini della nuova Repubblica Romana c’era il triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini. A Roma il giovane Bellunese trovò anche Goffredo Mameli (autore del nostro Inno Nazionale) Luciano Manara, la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso, Nino Bixio e Felice Orsini. Di Rudio faceva parte della “compagnia dei ragazzi” composta di giovani garibaldini, tutti di età intorno ai sedici anni come lui. Il 30 aprile partecipò con il suo abituale coraggio alla vittoriosa battaglia contro le truppe del generale francese Oudinot, che fu costretto a ritirarsi a Civitavecchia. Garibaldi voleva scagliarsi
L’AVVENTUROSA VITAdi CARLO DI RUDIO
15
contro il nemico in fuga allo scopo di annientarlo. I triumviri, invece, preferirono fermare il Generale allo scopo di poter negoziare. Ritenevano improbabile la definitiva sconfitta della Francia, la quale si sarebbe ripresentata con forze militari ancora superiori. Auspicavano che la loro Repubblica fosse accettata e riconosciuta dalle potenze europee per le vie diplomatiche. Garibaldi conseguì un’altra importante vittoria a Palestrina il 9 maggio contro l’esercito borbonico. In quell’occasione il Generale si complimentò per il memorabile valore dimostrato della “compagnia dei ragazzi” durante le fasi critiche della battaglia. Purtroppo le trattative diplomatiche andarono male. Luigi Napoleone inviò a Roma il visconte Lesseps con l’apparente intenzione di trattare con il triumvirato. La sua strategia, però, era quella di far perdere tempo ai repubblicani per consentire al generale Oudinot di riconquistare le zone perse. Durante la terribile controffensiva francese del 30 giugno Di Rudio fu catturato. Riuscì a fuggire dalla prigione dopo aver accoltellato una sentinella. Fu in seguito arrestato e processato dal tribunale di guerra. Il giovane garibaldino sostenne che, mosso da patriottismo, non aveva ancora dato la sua parola di prigioniero di guerra, pertanto doveva ancora essere considerato un legittimo combattente. Forse per l’audace difesa durante il processo, ma soprattutto per la sua giovane età, Di Rudio fu assolto dall’accusa di omicidio volontario. Fu trasferito, tuttavia, a Civitavecchia assieme ad altri prigionieri con la triste prospettiva di una lunga detenzione. Con temerarietà, e molta fortuna, riuscì a evadere assieme a un altro garibaldino. Si tenne adeguatamente distante dalla città, ormai nuovamente sotto il controllo militare francese, nella speranza di potersi riunire ai garibaldini. Egli non poteva sapere che il Generale, braccato dalle truppe di mezza Europa alleate contro la Repubblica Romana, era fuggito a Comacchio dove spirò Anita. Garibaldi in seguito fu arrestato a Genova. Espulso dal Regno di Piemonte si imbarcò su un piroscafo diretto a New York, ove fu accolto da Antonio Meucci, intento a sbarcare il lunario fabbricando candele. Pure Di Rudio era ricercato e pensò di espatriare in America. Dopo aver superato numerose difficoltà giunse a Genova. In città la vita dei profughi era diventata molto difficile perché la monarchia sabauda mal sopportava i numerosi veterani dei moti che si erano rifugiati
nel capoluogo. In quel periodo il comandante della divisione militare di Genova era il generale Alessandro La Marmora, il quale fece recapitare al giovane Di Rudio un invito a presentarsi al comando. A seguito di analoga raccomandazione del padre di Carlo, stante anche il fiero comportamento del giovane dimostrato a Roma nei mesi precedenti, il fondatore del Corpo dei Bersaglieri propose al conte bellunese di arruolarsi nell’esercito piemontese con il grado di sottotenente. Di Rudio, diplomaticamente, non accolse l’offerta. Non voleva giurare fedeltà alla Casa Savoia la quale perseguitava i suoi massimi referenti politici: Mazzini e Garibaldi. Lui era un fervente repubblicano e non voleva smentire la sua fede arruolandosi nell’esercito monarchico. Alla fine del 1850 Di Rudio riuscì a imbarcarsi diretto in America. Una terribile tempesta fece terminare la navigazione sulle coste meridionali della Spagna. Lì incontrò un altro esule mazziniano, pure lui antimonarchico e anticlericale. Trafugarono due tonache e, travestiti da preti, raggiunsero Marsiglia con mezzi di fortuna, sfruttando anche la loro conoscenza scolastica del latino. In una retata fatta dalla polizia negli ambienti giacobini della città, i due esuli furono arrestati e condannati per sedizione. Dichiararono di essere diretti in Inghilterra e di conseguenza furono espulsi dalla Francia con foglio di via. Dopo numerose disavventure giudiziarie nelle varie nazioni europee per la sua attività rivoluzionaria, il nostro eroe si trasferì a Londra dove sposò la giovane Eliza Booth.
In Inghilterra ritrovò Felice Orsini, pure lui da quelle parti perché era ricercato ovunque, il quale gli propose di partecipare al complotto che aveva organizzato per uccidere Napoleone III, ritenuto colpevole di aver fatto cadere la Repubblica di Roma. Il 14 gennaio 1858 l’attentato all’imperatore di Francia fallì e Bonaparte rimase illeso. La polizia arrestò subito i congiurati. Anche Di Rudio aveva, per l’occasione, documenti falsi come gli altri complici. Fu identificato e durante l’indagine emerse quella nota redatta dalla polizia austriaca di cui abbiamo trattato in precedenza. Il processo fu celebrato il mese seguente e la sentenza fu durissima. Felice Orsini e Giovanni Pieri furono giustiziati, mentre Di Rudio e Antonio Gomez furono condannati all’ergastolo da scontare in Guayana. Il giovane conte bellunese
16
riuscì – con molta fortuna e con la sua abituale audacia - a evadere dalla prigione dopo una detenzione relativamente breve, rispetto a quella di Gomez il quale scontò alla Cayenna ben 29 anni di galera prima di ottenere la grazia e tornare nella sua Napoli. Di Rudio si rifugiò nella Guayana inglese e rientrò in Inghilterra nel 1860. All’età di 28 anni aveva già vissuto una vita così turbolenta da sembrare la trama di un film d’avventura. Era ricercato da tutte le polizie europee e neppure Londra era sicura. Pensò di espatriare in America assieme alla moglie e al loro primogenito. Giunto a New York si arruolò nell’esercito perché era il mezzo più rapido, in quell’epoca, per ottenere la cittadinanza. Si fece registrare dalle autorità militari con il nome di Charles De Rudio e andò al fronte con un reggimento di fucilieri. Da quel momento tutti i suoi documenti riportarono il suo nuovo nome. In quel periodo imperversava ancora la Guerra di Secessione tra gli stati unionisti del nord – detti Yankees - e quelli secessionisti del sud, chiamati Greys per effetto della loro divisa di colore grigio. De Rudio si adattò ben presto alla dura vita delle guarnigioni situate nell’impervio e vasto territorio americano. Dopo aver sistemato la contesa con gli stati del sud, al governo di Washington rimaneva ancora insoluta la questione degli indiani. Per colonizzare uno stato che dall’Atlantico giungeva fino al Pacifico, era obbligatorio costruire vie di comunicazioni sicure. Oltre a ciò, gli ingegneri avevano accertato che il sottosuolo delle zone centrali del continente era ricco di materie prime. Questo era un altro motivo per affrettare la costruzione della ferrovia. Gli indiani, però, non abbandonarono i loro territori e si opposero all’avanzata dei coloni. Conseguentemente il governo pensò all’azione militare per far strada all’espansione. E’ altresì ben noto che l’intervento dell’esercito era richiesto non solo dalle grosse compagnie che avevano investito rilevanti capitali per le miniere e le ferrovie e pretendevano protezione, ma anche dai coloni che consideravano gli indiani una minaccia quotidiana. Il nostro protagonista, ormai naturalizzato cittadino degli Stati Uniti, continuò la carriera militare e fu assegnato al 7° reggimento di Cavalleria il cui comandante era George Armstrong Custer. Prima di continuare dobbiamo fare alcune precisazioni. Siamo abituati a ricordare questo ufficiale con il grado di generale,
mentre era tenente colonnello quando cadde in battaglia. Taluni hanno pensato che egli fosse stato degradato, anche in considerazione della sua proverbiale indisciplina. Per chiarire l’argomento rammentiamo che il regolamento dell’esercito statunitense consentiva allo stato maggiore di assegnare, temporaneamente, un grado superiore agli ufficiali per specifiche missioni. Completato l’incarico, ritornavano al loro grado precedente. Analoga procedura fu adottata anche con Custer. Dopo aver terminato il suo precedente mandato, riprese il grado di tenente colonnello e fu posto al comando del 7° Cavalleria. Numerosi film hanno trattato l’argomento. Un tempo i nativi erano considerati in maniera negativa: l’indiano buono è solo quello morto. Questo era il principio ribadito in quei film. Alla fine degli anni Sessanta le cose cambiarono e fu comunemente riconosciuto che si trattò di un genocidio. In proposito ricordiamo il curioso film western “Non toccate la donna bianca”, opera dissacrante diretta nel 1974 da Marco Ferreri. Nel prestigioso cast troviamo anche Marcello Mastroianni nell’insolito ruolo di Custer.
Charles De Rudio (qui raffigurato in una foto d’epoca) combatté con il grado di tenente nel reggimento di Custer nella famosa battaglia di Little Bighorn. Si tratta di un fiume che scorre tra gli stati federali dello Wyoming e del Montana. Lo scontro avvenne tra il 25 e 26 giugno del 1876, contro una grossa coalizione di indiani. L’esercito americano, in quell’occasione, subì una terribile sconfitta. Con tutta probabilità la causa della disfatta è da attribuire agli errori commessi proprio da Custer. De Rudio si salvò e proseguì la sua carriera militare fino al collocamento in pensione, con il grado di maggiore, avvenuto nel 1896. Si spense nei dintorni di Los Angeles nel 1910 e le sue Ceneri riposano nel Cimitero di San Francisco.
Franco Stefano Gazzo
17
Quando un congiunto viene a mancare, si avverte il dolore per la perdita di una persona cara,. con la quale si era avuto - talvolta per una lunga vita insieme - un legame profondo o comunque continuativo; che viene così, più o meno brusca- mente, interrotto.
Come noto il lutto, soprattutto in passato ed in alcune tradizioni religiose, viene connotato anche da alcuni aspetti formali quali indossare un certo tipo di abiti, ad esempio di colore nero. Oppure, al contrario, bianco per le vedove indiane sfuggite a1 macabro omaggio alla divinità induista Sati: pratica medioevale dichiarata illegale dal Governatore Inglese dell’India fin dal 4/12/1829 (ma di cui residuano ancora casi, 40 circa dal 1947) secondo la quale le vedove si facevano bruciare vive sulla pira funebre del marito appena deceduto come dimostrazione d’amore. Vedove, secondo quella tradizione, non obbligate ma consenzienti perché devote al marito fino al gesto estremo di seguirlo anche nell’aldilà.
Questi aspetti personali e psicologici legati alla perdita di persone care possono manifestarsi talvolta anche in forme dolorose come paura dell’abbandono, rabbia o depressione: che in certi
casi rischiano di cronicizzarsi, di tardare ad essere elaborati e nell’accettare la nuova realtà.
Ma al dispiacere personale si accompagnano anche aspetti sia burocratici che economici poiché proprio l’evento luttuoso è il presupposto del sorgere dell’obbligazione tributaria delle imposte sulle successioni: che, nel comune sentire, appesantisce vieppiù momenti già pesanti di per se stessi.
Nel nostro sistema tributario le imposte si distinguono in dirette ed indirette: le prime si applicano alla creazione diretta della ricchezza quale tipicamente l’acquisizione di un reddito. Le seconde invece alle manifestazioni di ricchezza, solo cioè al momento del suo trasferimento mortis causa (nel caso delle imposte sulle successioni, ma identico è il regime fiscale delle donazioni) da un soggetto all’altro quale presunzione di arricchimento degli eredi. Ed è appunto per il particolare momento in cui solitamente versa l’erede che si trova ad adempiere a questo obbligo fiscale (anche se ovviamente nella vita di un individuo scatta in un numero di casi ovviamente limitato, data la sua natura) che questo tipo di imposta viene percepita come tra le più odiose,
dopo quella sull’abitazione e quella sul canone RAI.
Nel nostro Paese l’imposta di successione ha origini antichissime ma in epoca moderna origina dal sistema francese dei primi del ‘700, in allora sotto forma di imposta fissa di registro che lo Stato pretendeva appunto per registrare, cioè autenticare e datare, i testamenti. In età napoleonica l’imposta si estese anche in Nord Italia, principalmente in Piemonte ed in Lombardia, con l’individuazione
AMORE FAMILIARE E SUCCESSIONE
18
delle prime aliquote variabili sull’ammontare della successione. Mentre prima dell’unificazione nel Regno delle due Sicilie continuavano a vigere solo i citati diritti fissi di registrazione dei testamenti. In tempi più recenti la vera e propria tassa di successione fu introdotta per la prima volta con la Legge del 21/4/1862 n. 585, per estendersi a tutto il Paese dopo l’unificazione. Fu poi soppressa dalla Legge 383/2001 a decorrere dal 25/l 0/2001 per poi esse- re reintrodotta con la Finanziaria del 2007 con decorrenza dal 31/10/2006.
Prima di esaminarne le caratteristiche principali, solo alcuni brevi richiami sulla terminologia giuridica della successione.
In mancanza di un testamento (o lo stesso non valido ed efficace) si verifica la cd. “successione legittima”. In tal caso si applica il Codice Civile e gli eredi ex lege sono il coniuge ed i fi gli, poi i genitori ed i nonni e, da ultimo, se non esistono altri parenti, i fratelli: soggetti che si chiamano eredi legittimi appunto perché chiamati all’eredità ex lege.
Da non confondersi però con i legittimari (detti anche eredi necessari) e cioè coloro ai quali la legge riserva sempre una quota intangibile dell’eredità, che non può quindi essere lesa neanche da un eventuale testamento del de cuius.
Nel nostro Paese non si può quindi “diseredare” un figlio che rimane erede per legge della sua quota di legittima anche contro l’espressa volontà contraria di un testatore.
Altro termine similare (ma di significato ancora diverso) è legatario e cioè colui al quale il defunto lascia solo un bene od un diritto specifico: e che quindi non risponde, a differenza degli eredi, anche degli eventuali debiti ereditari. Legittimari sono il coniuge, i figli o, in loro mancanza, genitori e nonni. Pertanto il testatore può lasciare a chi non sia erede legittimano solo una parte dei suoi averi, la cosiddetta quota disponibile la cui percentuale oscilla a seconda del numero e della qualità egli eredi necessari. Ad esempio nel caso vi sia solo un coniuge superstite senza figli, la sua quota intangibile (quota cosiddetta di riserva o legittima) è del 50%, mentre la restante parte potrà essere
lasciata a chiunque altro. Oppure nel caso in cui oltre al coniuge vi siano due o più figli, al coniuge andrà necessariamente lasciato per legge un 25% ed ai figli in parti uguali tra di loro il 50%: la quota disponibile sarà quindi solo del 25%.
Infine, sempre per fare esempi, in caso di una coppia senza figli, il vedovo o la vedova potrà disporre dei 2/3 dei suoi averi, mentre il rimanente terzo andrà per legge agli ascendenti, ovviamente se ancora in vita.
Anche la percentuale dell’imposta di successione varia a seconda della qualità giuridica degli eredi. Nel caso però di coniuge e parenti in linea retta vi è una franchigia (cioè una quota di esenzione totale dall’imposta) per ogni erede assai elevata (fino a l milione di Euro), tenuto anche conto che il valore degli immobili (che soggiacciono anche all’imposta ipocatastale) non va calcolato secondo la quotazione di mercato bensì quello ben minore catastale, rivalutando le relative rendite. Oltre il milione di Euro, caso raro a verificarsi, scatterà poi l’aliquota del 4%.
Diversa invece è la situazione tra fratelli e sorelle, per i quali la franchigia è ridotta a soli €. l00.000 di valore ereditario, superata la quale scatta la aliquota del 6%. Che aumenta all’8%, e senza franchigia, per tutti gli altri soggetti che non siano parenti sino al quarto grado, legatari compresi, a meno che ovviamente non siano parenti. In conclusione l’aliquota e le esenzioni sono strettamente connesse solo al grado di parentela: se ad esempio nomino mio erede universale il mio convivente da una vita, i figli avranno la loro quota di legittima e utilizzeranno l’esenzione fino a l milione (oltre il 4% d’imposta) ma l’erede invece - non parente - dovrà pagare integralmente tutto il restante compendio successorio e con l’aliquota più alta dell’8%.
Talvolta si legge di matrimoni celebrati in punto di morte, nel caso di un evento rapido ed improvviso, certamente per amore ma in presenza di patrimoni ingenti, potrebbero in teoria esservi anche altri risvolti, per quanto residuali al primo.
Sono poi previste franchigie e aliquote particolari per i soggetti portatori di handicap.
19
Per quanto riguarda i beni mobili quali denaro, gioielli e arredamento, si presume un valore del l 0% della quota ereditaria, fatta salva la prova contraria. Infine non rientrano nell’eredità, tra l’altro, le polizze di assicurazioni stipulate a favore degli eredi, i titoli di Stato quali BOT e CCT e i veicoli iscritti al P.R.A. Sono invece poi esclusi dall’imposizione alcuni soggetti quali Stato, Enti Pubblici ed Onlus. L’imposta è dovuta per tutti i beni che ricadono nella successione, in Italia ma anche in qualsiasi altra nazione essi siano. La quota di esenzione dell’imposta italiana è tra le più elevate al mondo. Così come le aliquote del 4, del 6 e dell’8% sono, al contrario, le minori: si consideri ad esempio che nel Regno Unito l’imposta c.d “Inheritance tax” si applica sopra la soglia di £ 325.000, ma nella elevata aliquota standard del 40%.
In Germania l’aliquota più bassa scende al 7% con una franchigia massima di 500.000 Euro. In Francia la franchigia massima è di 100.000 Euro e l’aliquota è progressiva, a scaglioni con un minimo del 5%. Infine nel Principato di Monaco i cittadini stranieri ivi residenti sono esenti da imposta su tutti i beni posseduti all’estero cioè fuori dal Principato.
In conclusione: un’eredità (che non ricomprenda beni immobili) fino a l milione di Euro tra genitori e figli sarà esente da qualsiasi imposta in Italia, sconterà £ 75.000 in Germania; € 195.000 in Francia e € 250.000 in Inghilterra.
La dichiarazione di successione va presentata entro un anno dal decesso sempre che il valore dei beni lasciati al coniuge e ai parenti in linea retta superi i l 00.000 Euro circa o vi ricadano beni immobili. L’obbligo grava in solido su tutti i soggetti interessati ma è sufficiente che venga presentata solo da uno di essi. Nei casi più semplici può essere compilata anche da un privato ma solitamente è un adempimento che viene lasciato ai notai. Comunque dal prossimo l Gennaio 2018 anche questa formalità dovrà essere espletata tramite invio all’Agenzia delle Entrate (dell’ultima residenza del de cuius) solo in via telematica, con un software ad hoc e quindi sarà
più complicato non affidarsi a professionisti.Mentre le imposte ipocatastali (che gravano
sui beni immobili nella misura del 3% del valore catastale, con l’eccezione della prima casa) devono essere autoliquidate contestualmente alla presentazione della denuncia, per l’imposta di successione. L’Agenzia delle Entrate ha fino a tre anni di tempo (ma solitamente è più sollecita) per notificare l’avviso di liquidazione che deve essere pagata entro 90 giorni, fatta salva la possibilità di rateizzare l’imposta fino a 5 anni.
L’Erario mantiene però la facoltà di rettificare d’ufficio i valori dichiarati dagli eredi in misura che ritenga inferiore a quelli reali, liquidando la conseguente maggiore imposta entro due anni dal primo avviso, con una pesante sanzione che può arrivare fino al 200% della differenza con la nuova imposta così ricalcolata dall’Ufficio.
L’eredità deve essere accettata dai soggetti che intendono entrare nel possesso delle quote ereditarie (massimo entro dieci anni dal decesso) ma l’accettazione solitamente è tacita, cioè desumibile dal comportamento dell’erede che agisca come tale dopo il decesso.
In alcuni casi invece si può anche ricorrere (talora è obbligatorio) all’accettazione con il cosiddetto beneficio di inventario quando cioè si abbia il timore che i debiti ereditari superino le attività e non si voglia pertanto risponderne fino a quando non sia chiarita, tramite appunto l’inventario, la relativa contabilità.
Infatti chi accetti con beneficio di inventario risponde con i propri beni soltanto nei limiti dell’attivo, a differenza dell’erede, senza doversi cioè sobbarcare le passività.
Francesco Tiscornia
20
Al contrario di Lutero che elaborò e diffuse un’insanabile frattura teologica all’interno del cristianesimo, incentrandola in particolar modo sulla dottrina della grazia (e quindi della salvezza) intesa come dono gratuito di Dio senza alcun merito da parte dell’uomo, Erasmo si limitò a fustigare costumi, superstizioni e abusi della Chiesa, spingendosi a chiederne una riforma radicale in termini evangelici. Per la verità le critiche di Erasmo a Roma e alle sue legioni di predicatori e di frati mendicanti potevano apparire per buona parte in sintonia con quelle mosse da Lutero (e di fatto lo erano, come riconobbe lo stesso Erasmo nel 1519, pur con tutte le cautele di cui era capace), solo che il grande umanista si guardava bene dal lanciare anatemi di ordine teologico. Di fatto, un abisso separava Erasmo da Lutero, il massimo esponente dell’umanesimo cristiano dal padre della Riforma protestante. Eppure numerosi luterani della prima ora – soprattutto coloro che non avevano colto l’autentico messaggio erasmiano e che avevano inteso superficialmente l’insegnamento di Lutero, soffermandosi di più sui suoi aspetti sociali, nazionalistici e di purificazione delle pratiche devote che sulla sua dimensione essenzialmente teologica e religiosa – non esitarono a considerare Erasmo un compagno di strada di Lutero, se non addirittura un suo precursore.
Una conferma inconfutabile ce la fornisce Albrecht Dürer, il quale, non appena appresa la notizia del rapimento di Lutero nel maggio 1521 sulla via di ritorno dalla dieta di Worms, ritenendola drammaticamente vera – in realtà il rapimento era stato organizzato dal principe di Sassonia suo protettore per metterlo al riparo – annotava sul suo Diario un’invocazione ad Erasmo perché operasse la definitiva scelta di campo e si preparasse a conquistare la corona del martirio, cioè a sostituire Lutero nella guida del movimento luterano.
Del resto, proprio nel settembre 1521, l’anno di Worms e delle definitive scelte di campo nei confronti di Lutero e della sua dottrina, fu diffusa alla fiera di Francoforte un’opera anonima in lingua tedesca, articolata in 15 agili scritti privi di note tipografiche. Erano i Fünfzehn Bundsgenossen (Quindici Confederati) di Johann Eberlin da Günzburg, un contributo ingegnoso ed efficace in favore della causa luterana, che riscosse immediatamente notevole successo, inserendosi in maniera incisiva in quell’esercito di opuscoli che segnò i primi anni della Riforma e che contribuì in maniera determinante alla sua crescente diffusione.
Frutto di un uso decisamente efficace e innovativo della neonata arte tipografica, la marea di opuscoli pubblicati in appoggio al movimento luterano (tra i quali si inserivano autorevolmente quelli di Eberlin) erano stesi in un tedesco comprensibile a tutti, con uno stile mordace e in rigoroso ossequio alle regole della retorica; erano inoltre stampati con molte immagini, quindi in maniera accattivante e sulla base di efficaci regole di comunicazione, oltre che in un agile formato, ben funzionale alla loro diffusione sulle piazze dei mercati e alle porte delle chiese. Erano infine contenuti in un numero di pagine che nella maggior parte dei casi non superavano la ventina, perché potessero essere letti d’un soffio, anche ad alta voce per coloro (i più) che non sapevano leggere. Tali opuscoli venivano cioè pensati e prodotti per essere gettati – in migliaia di copie e in edizioni economiche ristampate in rapida successione – in un campo di battaglia nel quale entrarono ben presto in gioco le sorti della Germania e della cristianità. Significativi a questo proposito sono sia il termine Flugschrift (scritto volante), col quale questi opuscoli vengono designati, sia la locuzione Flugschriftenkrieg (guerra dei libelli), che esprimono in maniera puntuale la dimensione
ERASMO, LUTEROLA “GUERRA DEGLI OPUSCOLI”
E IL “LIBERO ARBITRIO”
21
e l’asprezza degli scontri tra luterani e “romanisti”, vale a dire i “seguaci” della Chiesa di Roma, i quali continuavano però a prediligere, tranne qualche rara eccezione, il latino, vale a dire la lingua dei teologi.
I Quindici Confederati furono stesi frettolosamente nella primavera e nell’estate 1521, dopo che Eberlin, francescano osservante e predicatore ad Ulm nella Germania meridionale, aveva abbracciato la dottrina di Lutero con tanto entusiasmo da determinare la sua cacciata dall’Ordine e dalla città. I 15 opuscoli erano stati immediatamente pubblicati a Basilea e forse erano stati anche diffusi singolarmente; in ogni caso a Francoforte (la fiera era iniziata l’8 settembre) comparvero tutti e 15 e sempre congiuntamente furono subito ripubblicati ad Augusta e a Spira: erano solo i primi dei numerosi scritti di propaganda pubblicati da Eberlin, tutti a tal punto incisivi – grazie anche alla sua formazione umanistica e alla padronanza della retorica – da procurargli la prestigiosa denominazione di “la voce della Riforma della Germania del sud”.
Si tratta di un’opera articolata in quindici opuscoli autonomi sia per argomento, sia per veste editoriale, che si imposero subito all’attenzione dei contemporanei per la spregiudicatezza delle loro affermazioni e per il disegno originale che li univa e li caratterizzava. Eberlin li fece apparire, infatti, come opera di 15 laici, che si sono uniti in una lega (“Verbündtnüss”) e avevano giurato “di voler svelare ai comuni cristiani da quale scandaloso e insopportabile fardello questi siano oppressi”; ognuno dei 15 Confederati si impegnava così a “fornire per un giorno il proprio consiglio e la propria opera”, con la determinazione di “mettere a nudo le considerevoli piaghe della comunità per il bene della comune nazione tedesca”.
Mentre ogni opuscolo ha un proprio titolo, l’opera risulta invece sprovvista di un titolo generale; questo si desume tuttavia in maniera trasparente dalla sua struttura complessiva, alla quale rimandano ripetutamente i singoli Bundsgenossen, come pure dai sottotitoli dei 15 opuscoli e dalle citazioni inserite a più riprese da Eberlin nelle sue opere successive. Quanto all’anonimato — un espediente assai comune tra
i polemisti del tempo, che lo usavano spesso per presentare gli opuscoli come portatori di istanze non soggettive, ma corali, e per renderli, come tali, più accettabili alla gente comune — non è escluso che Eberlin vi abbia fatto ricorso anche perché spinto dall’incertezza del momento e dal timore per la propria sorte, specie dopo le severe norme emanate a Worms contro gli autori di libelli empi ed ingiuriosi.
Ne tratto in questa sede perché i 15 opuscoli incarnavano un singolare modello di incontro tra Umanesimo, Riforma e spirito nazionalistico, in un momento nel quale ci si poteva ancora illudere (come faceva appunto Eberlin) che Erasmo, Reuchlin, Hutten, Carlostadio, Melantone e Lutero combattessero per la stessa causa e con gli stessi intenti: non a caso il 1° Confederato conteneva un’accorata invocazione a Carlo V affinché accogliesse e realizzasse le proposte di Lutero e di Hutten, e indicava in Erasmo il vero precursore di Lutero, secondo in questo solo a Reuchlin, ma in ordine di tempo e non per importanza; il VI e il XIV traducevano e commentavano due brani dell’Elogio della follia di Erasmo, rispettivamente sulla predicazione degli ordini mendicanti e sul culto dei santi, mentre l’VIII spiegava all’uomo comune “perché viene tradotto Erasmo in tedesco” e “perché Lutero e Hutten scrivono in tedesco”. I due opuscoli della serie sicuramente più noti sono in realtà il X e l’XI, nei quali sono riportati gli “statuti” che regolano la vita religiosa e temporale dell’immaginario Paese di Wolfaria, dove tutto “funziona bene” (wohl fährt) e dove regna il benessere (Wohlfahrt): la prima utopia luterana e in ogni caso la prima imitazione del trattato utopico di Thomas More.
Subito i 15 opuscoli furono tradotti in latino, almeno in parte, dal teologo antiluterano Giovanni Cocleo che a fine settembre 1521 li inviò scandalizzato a Girolamo Aleandro, nunzio pontificio in Germania, mentre un altro animoso avversario di Lutero, Johannes Eck, già in ottobre li portò a Roma, dove lo spagnolo Diego López de Zúniga – redattore non particolarmente autorevole della Bibbia poliglotta di Alcalà – li utilizzò immediatamente per assestare la stoccata risolutiva contro Erasmo, pubblicando nella primavera del
22
1522 una rassegna delle “bestemmie ed empietà” contenute nelle opere del grande umanista con l’intento di mostrare come Erasmo fosse “non solo luterano, ma anche vessillifero e principe dei luterani” e che di fatto fa il verso ad Erasmo, insomma, entrambi dicono la stessa cosa.
Del resto, Zúniga era stato ancor più esplicito e velenoso nella lettera all’umanista spagnolo Juan Vergara del 9 gennaio 1522: i Quindici Confederati, consideravano Erasmo dalla loro parte e alla stessa conclusione era giunto persino papa Leone X, che non avrebbe mancato di prendere seri provvedimenti contro di lui, se la morte (1 dicembre 1521) non glielo avesse impedito, anche perché era informato dalla Germania della connivenza di Erasmo con Lutero. Insomma, la Curia romana era quasi arrivata, se dobbiamo credere a Zúniga, ad avviare un processo per eresia contro Erasmo.
Tutto questo succedeva mentre si susseguivano le critiche di connivenza di Erasmo con Lutero, e nel contempo prendevano sempre più corpo i tentativi di trascinare Erasmo nel campo luterano, mentre soprattutto in ambito cattolico aumentavano le pressioni perché Erasmo prendesse posizione contro Lutero. Lo spirito indipendente e distaccato del grande umanista – che si viveva come intellettuale al di sopra dei conflitti, tutto dedito agli studi, ma anche fortemente critico nei confronti della Chiesa romana – gli permise di resistere con tenacia a questi reiterati tentativi. Almeno sino a quando la dottrina luterana mostrò sempre con maggior chiarezza l’effetto dirompente delle divisioni religiose, sociali e politiche alle quali aveva dato origine nel mondo tedesco, sino a quando l’irruenza di Lutero aveva cancellato, non solo per effetto della scomunica, ogni aspetto anche minimo di impegno comune e aveva segnato la sconfitta di quell’alleanza tra
Vangelo e “buone lettere” che Erasmo aveva eretto a vessillo della propria esistenza. Il tempo di tacere era finito e l’umanista olandese doveva prendere una posizione decisa, anche perché non poteva restare insensibile alle numerose sollecitazioni che gli pervenivano, in particolare quelle di papa Adriano VI (dicembre 1522), suo estimatore oltre che connazionale, e di Enrico VIII (giugno 1523), sovrano di quell’Inghilterra che Erasmo aveva assunto per qualche tempo come seconda patria.
Il tentativo di Lutero di intervenire personalmente per far recedere Erasmo dalla pubblicazione dello scritto contro di lui non sortì alcun risultato. Il De libero arbitrio venne pubblicato a Basilea ai primi di settembre del 1524
dall’editore Froben col quale l’umanista aveva stabilito ormai da tempo rapporti di amicizia e di collaborazione, ma già dall’inizio dell’anno Erasmo vi stava lavorando, al punto che già nel febbraio lo indicava come di prossima pubblicazione.
Il protrarsi della stesura dello
scritto, peraltro decisamente snello ed essenziale, ci dice quanto Erasmo lo ritenesse importante; del resto la notizia si era ormai diffusa da tempo per tutta la cristianità ed era sempre più accompagnata da commenti e da una fervida aspettativa.
L’operetta, che ebbe un ruolo tanto cruciale nel dibattito del tempo e nel mondo cristiano, si articola in cinque parti: un’introduzione, un elenco dei testi scritturali che affermano il libero arbitrio, una rassegna di quelli che “sembrano” negarlo, la concezione di Lutero e una conclusione che sembra prospettare una posizione mediana tra queste.
Inutile cercare un attacco frontale e veemente a Lutero, che pure emergeva chiaramente dai toni prudenti di Erasmo, con stoccate alle sue “certezze” e con ironie sul pochissimo valore da
23
lui attribuito alla cultura mentre ne riconosceva moltissimo allo Spirito; così come si cercherebbe invano un’esaltazione del libero arbitrio che in ogni caso attraversa tutta l’opera. Il tutto nello stile elegante e garbato di Erasmo, nel raffinato latino da lui usato in tutti i suoi scritti e, come al solito, infarcito di termini greci. Del resto Erasmo esordiva ribadendo che “tra le non poche difficoltà che ci presenta la Sacra Scrittura, è difficile trovare un labirinto più complicato del libero arbitrio”, peraltro oggetto di continue riflessione da parte degli antichi filosofi e poi dei teologi sin dai primordi del cristianesimo: in ogni caso Lutero gli risparmiava “un bel po’ di lavoro” dal momento che “non ammetteva l’autorità di nessun scrittore” e dava “ascolto solo alle Scritture canoniche”. Ben poteva dirlo lui, studioso di testi classici, oltre che autore di impeccabili edizioni critiche dei Padri della Chiesa e in particolare dell’edizione grandiosa del Novum Instrumentum, il Nuovo testamento in lingua greca e latina (1516), che ebbe molteplici elogi dai vertici della Chiesa. Era quindi ben consapevole di essere in disaccordo con Lutero, ma auspicava che il dibattito avvenisse “senza insulti”; del resto lui non intendeva farsi portatore di verità assolute (e qui era chiara l’allusione al ben diverso comportamento del padre della Riforma), né assumere il ruolo di giudice, emanando sentenze e condanne.
In realtà, Erasmo già col titolo della sua opera coglieva in maniera puntuale l’elemento di massimo dissenso tra lui e Lutero (il quale non esiterà a riconoscerlo nella sua replica), che era costituito dalla dignità dell’uomo e dalla sua libertà d’azione, resa tuttavia pienamente efficace dalla grazia divina. Insomma, un’umanistica dignità umana armonicamente integrata dalla Grazia.
Ben diversa era la posizione di Lutero, pienamente ribadita nel De servo arbitrio, la sua aggressiva risposta, peraltro scritta e pubblicata nel pieno della tragica “guerra dei contadini” del 1525: “Il libero volere, dopo il peccato, [vale a dire senza la Grazia], è una nuda parola e ogni volta che l’uomo fa ciò che sta in lui, pecca gravemente”. E non basta: “Per quanto riguarda Dio e le cose pertinenti alla salvezza o alla dannazione, la volontà umana non ha libertà: e l’uomo è prigioniero, soggetto e schiavo della volontà di Dio o della volontà di Satana”.
La svalutazione della libertà e delle “opere” umane non poteva essere più esplicita, cosa che l’umanesimo cristiano di Erasmo non poteva in alcun modo accettare. Non stupisce quindi la sua replica, pubblicata nel 1526 a Basilea, sempre dall’editore Froben.
Era questa non solo la conclusione di uno scontro teologico, ma soprattutto la fine della iniziale ed entusiastica stagione della Riforma luterana, caratterizzata da incertezze e ambiguità in ambito religioso, ma anche da grandi speranze di riscatto sociale ed umano: speranze definitivamente abbattute dalle tragiche e sanguinose sconfitte dei contadini in rivolta, che si erano principalmente mossi sulla base di un’erronea comprensione dell’insegnamento di Lutero e in particolare della sua concezione di libertà, da loro intesa non in termini spirituali, ma come liberazione dalle servitù signorili ed ecclesiastiche. Praticamente definitiva fu la sconfitta di Frankenhausen del maggio 1525, che apparve come inevitabile conseguenza della durissima condanna di Lutero (peraltro coerente con la sua concezione dell’autorità politica) e dell’invito da lui lanciato con enfasi ai principi tedeschi a lavarsi le mani nel sangue dei contadini insorti.
Non pochi compagni di strada di Lutero lo abbandonarono senza esitazione; Eberlin fu tra questi, anche se dal 1522, trasferitosi a Wittenberg, sembrò aderire con convinzione alla piena ortodossia luterana. Si apriva di fatto una nuova stagione del luteranesimo, nella quale l’irenismo erasmiano, peraltro da tempo sempre più emarginato e ignorato, fu del tutto messo alle porte.
Strana sorte quella del grande umanista olandese. Dopo che da Roma nel 1535, l’anno prima della sua morte, gli era giunta l’offerta di una nomina a cardinale di Santa Chiesa – nomina che egli non esitò a rifiutare in sintonia con la sua solita istanza di indipendenza – la neonata Inquisizione romana inserì nel 1559 nell’Indice dei libri proibiti tutte le opere di Erasmo. Ma questo esula dal rapporto tra Erasmo e Lutero e rientra in una stagione non particolarmente luminosa della Chiesa di Roma.
Enzo Baldini
24
A mio giudizio il disegno di legge sul testamento biologico, inviato all’esame del parlamento, è un compromesso dettato da motivazioni e interessi politici, che, nonostante segua le più recenti autorevoli indicazioni della comunità scientifica sul consenso informato, sulla terapia del dolore e sul rifiuto dell’accanimento terapeutico, tuttavia non garantisce il pieno rispetto degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, concernenti la tutela della libertà del cittadino, per una fine vita coerente ai suoi convincimenti morali e religiosi. È comunque apprezzabile nel testo del disegno di legge l’aver ribadito senza riserve la tesi della legittimità bioetica e deontologica della sospensione dell’idratazione e nutrizione artificiali su disposizione anticipata di trattamento sanitario. È scientificamente inattendibile e per ciò, oserei dire, ai limiti della favola, ignorare e/o negare che l’idratazione e la nutrizione artificiali vengano effettuate mediante un dispositivo medico e che, pertanto, rifiutarle sia un diritto del paziente. Inoltre, a tal proposito, non si può non manifestare disagio e indignazione nei confronti di accuse di “condanna a morte per sete e per fame”, rivolte al testo da alcuni parlamentari, che rivelano fanatismo religioso, o meglio pseudoreligioso.
A mio parere, da cattolico
adulto, per usare questa felice definizione di Romano Prodi, ritengo che il testo del disegno di legge dovrebbe prevedere anche la possibilità di scelta del suicidio assistito e dell’eutanasia, come si verifica in altri paesi europei. Ovviamente non si può ignorare l’ostacolo costituito dal reato di omicidio del consenziente previsto dal nostro codice penale, ostacolo che andrebbe abolito o radicalmente modificato. Ne consegue pertanto che la realizzazione di quanto auspicato, per garantire una rigorosa tutela della libertà di scelta, non può essere immediata.
Ad avallo di tale affermazione, ricordo che la chiesa cattolica ha il dovere e il diritto di chiedere unicamente ai suoi fedeli un comportamento coerente al principio della sacralità della vita, principio strutturalmente connesso alla fede e
non dimostrabile (ma nemmeno confutabile) in ambito scientifico e filosofico. Ma, essendo la fede una scelta libera, privata e non garantita in termini di certezza conoscitiva, è compatibile con il diritto di scelte agnostiche o di segno opposto, nel rispetto del pluralismo e delle insindacabili diverse opzioni, purché venga garantita la convivenza pacifica tra persone di opinioni differenti.
In altri termini, da cattolico la cui fede si fonda sulla Scrittura, sono incondizionatamente fedele
RIFLESSIONI SUL TESTAMENTO BIOLOGICO
· A T T U A L I T À ·
25
all’osservanza del principio della sacralità della vita, ma mentre rivendico questo mio diritto alla liberà di coscienza comprendo, non solo ma anche apprezzo, scelte di segno opposto purché rigorosamente motivate e autenticamente vissute. Sempre in quanto cattolico adulto, ritengo quindi inviolabile e irrinunciabile il principio della laicità dello Stato, conquista fondamentale del pensiero moderno, grazie, soprattutto ma non solo, all’Illuminismo francese. Ritengo pertanto che le leggi statali non devono venir modellate in funzione di una determinata etica, nel nostro caso quella cristiana, ma devono invece non solo consentire ma anche favorire il pluralismo delle varie concezioni e, quindi, la libertà di scelta di tutti i cittadini in coerenza con i loro convincimenti etici e religiosi. E spiace dire che si verifica purtroppo anche oggi una nostalgia più o meno consapevole del potere temporale in alcuni ambienti della Chiesa, tuttora in qualche misura condizionati dalla condanna di Pio IX della libertà religiosa nell’Enciclica Quanta Cura del 1864, in piena sintonia con l’Enciclica Mirari Vos del 1832 di Gregorio XVI e con le successive encicliche Immortale Dei del 1855 e Libertas Prestantissimum del 1888 di Leone XIII. È quindi difficile non essere d’accordo con Hans Küng, che è indubbiamente uno dei più acuti e dotti teologi contemporanei, sulla sua richiesta dell’abolizione del dogma dell’infallibilità pontificia. Così come è oltremodo significativa la risposta dell’attuale Pontefice che dichiara la sua
disponibilità all’esame del problema.Infatti è solo con Giovanni XXIII, con
l’Enciclica Pacem in terris del 1963 e con il Concilio Vaticano II, che viene riconosciuto il diritto alla libertà di pensiero, nell’ottica della radicale rinuncia al modello confessionale dello Stato. Questa svolta purtroppo è stata ed è tuttora contrastata all’interno della Chiesa da fautori della tradizionale opzione per la teocrazia, ignorando, più o meno in buona fede, che tale opzione non ha alcun fondamento nel Vangelo e nel Cristianesimo dei primi secoli e che attualmente è sopravvissuta
solo nei Paesi islamici ove vi è palese carenza di democrazia. Non può quindi stupire che un pontefice come Papa Francesco, fedele al Vaticano II ed erede dell’orientamento riformatore della Compagnia di Gesù a partire dall’inizio del secolo XX con Teilhard de Chardin, De Lubac, Martini, in netta controtendenza ad uno passato di conservatorismo che aveva giustamente meritato le dure critiche di
Pascal nelle Lettere Provinciali, ha suscitato consensi ed
apprezzamenti sia tra i fedeli, sia, soprattutto, tra i non credenti acculturati.
Un accenno, infine, al ruolo del medico che non deve venir degradato ad una funzione meramente notarile di tutela dell’autodeterminazione del paziente, senza che sia stata verificata una sua adeguata capacità valutativa. E questo per tenere conto dell’ampia diffusione di messaggi e consigli sulla salute e sulle malattie, privi di fondamento scientifico, che possono indurre a
Blaise Pascal
26
scelte e comportamenti irrazionali soggetti privi di una adeguata capacità comprensiva e valutativa.Ed è inoltre doverosa da parte del medico una rigorosa valutazione diagnostica e clinica del paziente che manifesta desiderio di morire. È noto infatti che non esiste un rigido confine tra normalità e follia e che disturbi dell’umore, anche lievi, sono pressoché sempre connessi e conseguenti a malattie somatiche. Accade, inoltre, frequentemente che alterazioni dell’equilibrio emotivo e affettivo siano non solo connesse ma anche determinate da malattie somatiche. Ed è pressoché fatale che una situazione drammatica di sofferenza esistenziale, per il degradato ed infimo livello della qualità della vita, sia etiologicamente connessa a sofferenza psichica. Talvolta, infatti, come accade nel malato oncologico, senza che siano stati rilevati precedentemente elementi atti a diagnosticare una patologia psichiatrica, avviene che il paziente si suicidi.
Tutto ciò conferma la continuità di sofferenza fisica e sofferenza psichica e il rischio che emerga il desiderio di morte in tale contesto esistenziale. In particolare va inoltre ricordato che il disturbo depressivo maggiore, in quanto ad alto tasso di auto-aggressività, può sovente indurre al suicidio. Sotto l’aspetto bioetico è dunque chiaro che
non si può e non si deve riconoscere al paziente affetto da disturbi psichiatrici il diritto alla scelta della morte, mentre in realtà il suo vero diritto è quello della cura e che la sua richiesta potrà venire riesaminata solo dopo la guarigione o almeno dopo un soddisfacente equilibrio del suo vissuto emotivo ed affettivo.
La soluzione più ragionevole è quindi quella di attribuire una competenza cognitiva e valutativa al malato mentale, dinamica, fluida, flessibile, in un percorso oscillante a fasi alterne di deterioramento e di parziale recupero.
Va osservato inoltre che in questi soggetti vi è un’interazione molto più pervasiva tra cognizione e affettività di quanto avviene nei soggetti cosiddetti normali: pertanto, informazioni sgradevoli possono venir mal tollerate e quindi “non comprese” ad opera di un elementare meccanismo di difesa. D’altronde anche tra coloro che non hanno disturbi mentali si nota che vi sono fluttuazioni sensibili alla disponibilità a recepire l’informazione spiacevole, in relazione a variazioni provvisorie ed occasionali del tono dell’umore, fluttuazioni che non impediscono tuttavia il ripristino di una piena ed integra facoltà cognitiva, valutativa e decisionale in momenti successivi al recupero dell’equilibrio emotivo-affettivo.
È quindi ineludibile il dovere del medico di procrastinare la sua decisione sia di accettazione che di rifiuto della richiesta del paziente dopo aver accertato con la massima diligenza la presenza o l’assenza di condizionamenti patologici. Sotto l’aspetto bioetico è infatti fondamentale l’obbligo di tutelare sia il diritto all’autodeterminazione che il diritto alla tutela e alla cura della salute.
Michele Schiavone
27
La tentazione di collocare ai giorni nostri la nascita di una coscienza ambientalista nella so-cietà civile è forte, soprattutto con riferimento a quelle problematiche riguardanti il clima del Pia-neta attualmente all’attenzione dei protagonisti della politica mondiale. Tuttavia, ad un esame storiografico più approfondito risulta evidente che l’inizio dell’ambientalismo si può registrare nel-le società occidentali all’inizio degli anni Settan-ta del secolo scorso, segnati da alcuni eventi che possiamo considerare le pietre miliari del percorso di nascita e di evoluzione dell’ecologia: il primo Ministero dell’Ambiente, varato in Gran Bretagna e successivamente introdotto in diversi Paesi euro-pei; il primo Earth Day negli Stati Uniti, dove fu costituita l’Environmental Protection Agency. Ma se il nostro sguardo si spinge a scrutare un poco più lontano nel tempo, possiamo scoprire preziose testimonianze di attenzione alla tutela della natu-ra anche nei decenni immediatamente precedenti, principalmente negli anni fra il 1955 e il 1965, devastati dalle esplosioni sperimentali delle bom-be nucleari, i cui effetti immisero “per sempre” nell’atmosfera atomi radioattivi portatori di malat-tie e di morte per tutti gli esseri viventi.
È in questa cupa cornice che inizia la sua carriera di scrittrice la statunitense Rachel Carson, riconosciuta come la madre dell’ambientalismo in quanto pioniera di quella sensibilità ecologista oggi ormai “a sistema”. L’Autrice di Primavera silenziosa - un classico del pensiero naturalisti-co – si dedicò fin dall’infanzia all’esplorazione dell’ambiente e, in parti-colare, all’attività definita birdwatching, coltivando una passione ecologica che la condusse a laurear-si in biologia marina e le consentì di prevedere nei cosiddetti “tempi non so-spetti” i danni che avreb-bero provocato uno scrite-riato intervento dell’uomo
sull’ambiente e l’abuso di prodotti chimici. Pri-mavera silenziosa giunse, quindi, a rappresentare coraggiosamente un’azione di denuncia dei rischi ai quali le Multinazionali della chimica esponeva-no la natura. La reazione dell’industria non si fece attendere e l’Autrice divenne oggetto di un attacco denigratorio pesante. D’altra parte la Carson non era una “penna” comune: era stata funzionario go-vernativo dal 1935 al 1950 proprio con l’incarico di divulgare scritti sull’ambiente naturale. La pri-ma di queste opere, riscosse un successo limitato, ma il secondo libro e il terzo ottennero l’apprezza-mento di un pubblico decisamente più vasto, affa-scinato dalla straordinarietà delle forme di vita che abitano le spiagge e le rive del mare, raccontata con la perizia della biologa e la passione dell’at-tivista. Furono proprio le osservazioni della vita marina a condurre la Carson alla consapevolezza di quanto fossero pericolose le nuove sostanze chimiche usate per eliminare insetti e parassiti, come il famoso DDT, in origine prezioso alleato per sconfiggere le epidemie scatenate dai contagi portati dai soldati impegnati nella Seconda Guer-ra Mondiale, in seguito usato ed abusato in agri-coltura. Il prodotto, in quanto non biodegradabile, dopo l’applicazione rimaneva attivo nel terreno e da esso passava alla vegetazione, agli animali e ai prodotti alimentari; inoltre, l’utilizzo su larga sca-la determinava il rinforzo della presenza di alcune specie di parassiti, la cui resistenza ne richiedeva quantità sempre maggiori.
Il libro di Rachel Carson, pubblicato nel 1962 e subito divenuto un successo mondiale, richiama nel titolo una poesia di John Keats, uno dei maggiori poeti romantici inglesi, ed è dedica-to ad Albert Schweitzer, pre-mio Nobel per la pace, filoso-fo, teologo, grande medico, definito da Einstein “l’uomo più buono del secolo”, profeta della distruzione della Terra a
RACHEL CARSON,VISIONARIA MADRE DELL’ECOLOGIA
28
causa della cecità degli uomini rispetto alle conse-guenze dell’azione scellerata sulla natura. L’opera non solo conquistò il consenso del pubblico, ma ebbe inaspettatamente ricadute sociali di portata storica: nel 1970 il DDT fu abolito negli USA e otto anni più tardi in Italia.
Il “libro-bomba”, come l’Autrice stessa lo definiva, nonostante i tentativi di irriderne il mes-saggio da parte delle grandi società chimiche ame-ricane, aveva ormai inaugurato la strada di una consapevolezza che nessun intento diffamatorio avrebbe potuto arrestare, poiché la pubblica co-scienza era stata risvegliata una volta per tutte e di lì a poco avrebbe segnato la nascita dell’ecologia. Significativamente, il libro si conclude, quasi con-temporaneamente all’esistenza terrena dell’Autri-
ce, sopravvissuta solo due anni alla pubblicazione, con la sollecitazione al genere umano a dialogare con la vita, con l’ambiente e con tutti gli esseri che abitano il Pianeta, per saldare un’alleanza che tuteli la coesistenza universale e si riveli salvifica per quella “primavera” che non può essere messa a tacere. Non è stato certamente un caso che, proprio negli anni Settanta, centotredici nazioni decisero di incontrarsi a Stoccolma nella Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano. Era il 1972 e nasceva un Piano d’azione mondiale centrato sul principio che le risorse naturali del Pianeta devono essere preservate attraverso pianificazioni strategi-che per il beneficio delle generazioni future e per il futuro stesso della Terra. La “visionaria” Rachel Carson aveva visto giusto.
Tuttavia, dopo la pubblicazione di Primavera silenziosa non fu registrata una reale diminuzione dei pesticidi, la cui esportazione continuò a costi-tuire un pericolo per la catena alimentare globale e contribuì ad alimentare quelli che la scrittrice chia-mava “fiumi della morte”, con le acque avvelena-
te da sostanze tossiche che arrivano a minacciare luoghi ben più lontani della zona dove sono state immesse. ”La natura”, scriveva la Carson, “molto di rado opera a compartimenti stagni”, sottoline-ando così l’importanza di quella corrispondenza globale che collega le forme viventi e l’ambiente che abitano: “intima connessione con la vita delle piante e degli animali”. Il grido di allarme di Ra-chel Carson ha, dunque, lanciato l’S.O.S. per un Pianeta in codice rosso e avviato un movimento politico in cui si riconoscono gli ambientalisti di tutto il mondo ancora ai nostri giorni.
Diventa, quindi, fondamentale la nostra ca-pacità di affrontare adeguatamente l’accelerazione tecnologica, i cambiamenti globali, divenuti più brevi della vita di un uomo, e le ripercussioni sulla natura. Le emergenze sono diverse: il degrado am-bientale; l’impoverimento delle risorse naturali, anche non rinnovabili; l’inquinamento dell’atmo-sfera, del terreno e delle acque, con la conseguente ipertrofizzazione dei mari; la presenza di agenti chimici cancerogeni, subdoli “killer” che possono manifestare effetti letali anche a distanza di tempo.
L’’Autrice di Primavera silenziosa evocava immagini che rappresentavano un mondo in peri-colo attraverso l’inquietante magia della mitologia e delle fiabe. È uno scenario in cui le foreste incan-tate diventano avvelenate, dove un insetto muore dopo aver masticato una foglia e un’ape ritorna al proprio alveare con un nettare tossico. È il veleno che permea di sé tutte le cellule di una pianta o di un animale. Non è, dunque, solo in gioco l’esisten-za in atto, ma anche la prospettiva di sopravviven-za, poiché, spiega la Carson, affinché “il corpo si sviluppi e il flusso vitale continui a scorrere di ge-nerazione in generazione occorre che le cellule co-stituenti organi e tessuti possano moltiplicarsi...”.
Eppure, i Cittadini del terzo millennio si ri-velano eredi ingrati di Rachel Carson, le cui pro-fezie continuano drammaticamente ad avverarsi e per questo diventa sempre più urgente soffermarsi, non “romanticamente”, ma con tutta la forza del nostro senso di responsabilità rispetto alle sorti del mondo e del futuro delle prossime generazioni, sul bene inestimabile che ci circonda, ritrovando le ragioni più autentiche e vitali del nostro esse-re, poiché, “coloro che indugiano sulle bellezze e i misteri della Terra non sono mai soli o stanchi della vita”. Grazie, Rachel.
Maddalena Carlini
29
L’invecchiamento è un fenomeno complesso che coinvolge l’individuo in tutta la sua essenza biologica e mentale. Una persona che si muove a rilento, col pensiero rivolto prevalentemente a se stessa e al suo passato simbolizza l’immagine della vecchiaia.
Il suo vissuto l ‘avviluppa sino a farle perdere ogni ambizione per il futuro: apprende male e lentamente le innovazioni, ha avversione per i cambiamenti, è legata alle proprie convinzioni, vive senza aspirazioni, immersa nei ricordi.
Oltre a non evolvere, l’anziano spesso regredisce, entra in una specie di seconda infanzia, diventando sempre più egocentrico, irritabile, litigioso, capriccioso come un bambino. Il termine “rimbambito”, parola irriverente e provocatoria, usata spesso per apostrofare il vecchio, ha invece il significato etimologico di “ritornato bambino”.
Tutto ciò accade in quanto spesso la persona anziana ha perso il compagno o la compagna, gli amici, il lavoro, lo status sociale e la credibilità. Nella maggior parte dei casi i figli sono lontani e hanno una vita propria; a volte, la persona “vecchia” è impedita nel muoversi, cosa che le preclude anche i residui piccoli piaceri della vita.
Significativa è la differenza nell’invecchiare tra uomo e donna.
Per lui i primi segni cominciano con l’età della pensione. L’attuale società considera il maschio come soggetto produttivo e quindi la cessazione dell’attività lavorativa, viene a togliere all’uomo il suo ruolo, relegandolo così in una posizione m a r g i n a l e della società e l’esclusione non è quasi mai ben accetta.
Per quanto riguarda lei, i segni del declino cominciano a vedersi con la m e n o p a u s a ,
seppure molto dipende dalla personalità individuale. Spesso, nell’immaginario femminile, il climaterio coincide con la fine della vita sessuale, vissuta come fertilità e rapporto con l’uomo. La donna avverte di aver esaurito il proprio ruolo e comincia a sentir scemare la propria femminilità. Spesso ne consegue una diminuzione del desiderio, dei rapporti sessuali e anche dei legami affettivi. Nella coppia, ove il ruolo genitoriale è ormai secondario, può emergere una conflittualità sino ad allora latente con un marito ancora in buone condizioni che vorrebbe continuare a vivere la sessualità come prima. A tutto ciò si uniscano i possibili disturbi fisici e neuro-psichici conseguenti alle modificazioni ormonali tipiche della menopausa.
Questo comune sentire offre un’immagine stereotipata della senescenza, ormai superata sia per le mutate condizioni socioeconomiche che per i progressi scientifici i quali hanno apportato nuove conoscenze sul fenomeno. Il 70-75% delle persone di età avanzata è intellettualmente e socialmente abile, mentalmente vivace, interessato all’ambiente che lo circonda e sarebbe anche produttivo se avesse l’opportunità di continuare ad essere inserito. Mantenere viva la mente ed aggiornarsi con l’acquisizione di nuove esperienze è di fondamentale importanza: la mente si tiene attiva principalmente con gli stimoli delle esperienze quotidiane.
La struttura del sistema nervoso è determinata dai geni, ma è l’ambiente che stimola la plasticità dello stesso, che dà forma ai suoi circuiti, che ne rinnova la “complessione” e la “funzione”. Le
modificazioni dell’età avanzata dipendono direttamente dalla personalità e dalle esperienze dell’individuo sicché l’invecchiare può essere interpretato come la sintesi dell’esistenza: nella senilità è il possibile spazio della saggezza.
Recenti ricerche
INVECCHIARE OGGI
30
hanno evidenziato la possibilità di mantenere l’efficienza psichica globale: l’anziano può, attraverso l’allenamento mentale, sfruttare le risorse residue. Ulteriori indagini hanno permesso di osservare che la elasticità mentale permette il recupero di funzioni cerebrali danneggiate.
Il fenomeno, detto “sinaptogenesi”, consiste nel modificare le interconnessioni neuronali attraverso la creazioni di nuovi collegamenti tra le cellule: tale procedura consente di eliminare alcune cellule nervose danneggiate e instaurare nuovi rapporti tra i vari tipi di neuroni.
È possibile, per il sistema nervoso, modificare la sua struttura e la sua funzionalità in modo più o meno duraturo e in relazione agli eventi. A seguito di danni cerebrali, si verificano processi di riparazione che sono alla base del recupero funzionale. Essi provvedono alla riorganizzazione della funzione in sede originaria, allo spostamento di quest’ultima in un’altra area cerebrale, o alla sostituzione del deficit con l’apprendimento di strategie comportamentali.
Dalle nuove conoscenze si è potuto acclarare come molti luoghi comuni fossero errati e che funzioni, come memoria e capacità di concentrazione, rallentino, ma non perdano efficienza. È stato dimostrato per mezzo di appositi test mentali, con tempi di risposta adeguati, che l’anziano è più lento, riflessivo, ma non meno produttivo.
Le analisi, condotte con osservazioni sul lungo periodo, hanno evidenziato che le cause del rapido declino psicofisico nell’anziano non sono dovute alla senescenza, considerata di per sé come “condizione patologica”, ma alla presenza di eventi morbosi concomitanti.
In questo la storiografia testimonia quanto illustri personaggi come scrittori, filosofi e artisti abbiano prodotto molte opere, considerate il coronamento della loro produzione, proprio nell’età senile. Si può evincere che l’invecchiamento dipende, come si è detto in apertura, da molteplici aspetti e soprattutto da una alta variabilità individuale.
Nella storia le opinioni sulla senescenza sono state diverse. Nell’antichità si riteneva che la vecchiaia fosse sempre accompagnata da deterioramento mentale permanente: da declino patologico delle capacità intellettive e da l’inadeguato controllo dell’emotività. Gli
scritti di S. Antonio da Padova utilizzano il termine “senescere” per indicare la perdita della cognizione di sé. In particolare Cicerone e Catone ritengono che la vecchiaia non sia solo un processo necessariamente legato al decadimento globale dell’organismo, ma sottolineano l’importanza di coltivare molti interessi per mantenere vivace la mente: fonte di frutti meravigliosi.
Ma quali sono i fattori che influenzano i processi di invecchiamento? Molteplici sono i fattori che concorrono all’invecchiamento. I più importanti, pare, siano i fattori genetici. La condotta di vita, i caratteri sessuali, il livello culturale, il benessere economico, lo stile di vita, l’appartenenza ad un nucleo socio- familiare coeso lo condizionano molto. L’insieme di questi fattori evitano all’anziano la sensazione di marginalità nel contesto sociale.
Pur essendo la creatività caratteristica peculiare del bambino, fondamentale per la sua crescita, la stessa è necessaria per incanutire senza sviluppare demenza, mantenendo attive le funzioni cerebrali dell’anziano. Nell’età senile la funzione della creatività si può manifestare nelle piccole azioni quotidiane: all’interno della coppia, del gruppo, ma anche individualmente. La malattia e l’abbandono rappresentano il maggior timore nell’anziano.
La popolazione di età avanzata rappresenta, nei paesi industrializzati, una percentuale sempre più elevata con un peso socio-economico più rilevante quindi, in questo settore, diventa indispensabile che al crescere della longevità parallelamente cresca la qualità di vita dell’anziano, aumentando gli anni di salute e non quelli di invalidità e malattia. A questo riguardo sono da tener presenti alcuni fattori collegati fra di loro: si devono conservare le risorse psicofisiche al fine di ridurre le necessità di trattamento e di riabilitazione.
Stimolare i rapporti con l’esterno, inserire nel mondo del lavoro la possibilità di avere un’età di pensionamento flessibile, incoraggiare il volontariato ed utilizzare l’esperienza dell’anziano nel trasferimento delle esperienze alle giovani generazioni porterà all’affermazione che invecchiare è continuare a crescere, ovvero recuperare il senso di sé.
Marco Cingolani Mauro Nicoscìa
31
Si (ri)comincia da 70. Un traguardo che sino a qualche decennio fa siglava la vecchiaia e avviava al tramonto, mentre oggi per la maggior parte di noi costituisce il trampolino di lancio verso una nuova epoca della nostra vita; non di rado più dinamica e appassionante, posto che di solito ci siamo liberati da impegni lavorativi e familiari. Un’annotazione importante, considerato che, dopo il Giappone, con un’aspettativa media di vita che sfiora gli 85 anni per le donne e gli 80 per l’uomo, siamo il secondo Paese più longevo al mondo.
Secondo i nuovi parametri statistici, fra l’altro, sino ai 75 anni rientriamo nella categoria dei giovani: “giovani anziani”, più precisamente. Certo, per restare attivi, propositivi e non farci mettere da parte dobbiamo prima di tutto lottare contro una serie di pregiudizi, quelli sì, ormai decrepiti, che vedono chi ha i capelli bianchi come un po’ smemorato, noioso, ripetitivo e privo di interessi.
Sarà davvero così? In realtà le più recenti teorie scientifiche hanno smontato gli studi sinora
più accreditati che stigmatizzavano le cellule della mente delle persone anziane come impossibilitate ad auto rinnovarsi. Ce ne parla Elio Musco, neuropsichiatra, geriatra e autore con la giornalista Franca Porciani del saggio Restare giovani si può.
«Al contrario, è proprio il nostro cervello la centralina anti senescenza, l’arma principale contro il decadimento intellettivo. Questo perché ormai la scienza ha appurato che la plasticità cerebrale, se tenuta in continuo esercizio, non conosce limiti di età. La vecchiaia, insomma, non va più considerata
una “malattia inguaribile”, secondo una definizione in voga anni or sono: sino a poco tempo fa, infatti, si pensava che i neuroni, le cellule che compongono la materia grigia del cervello, non si rigenerassero più nel corso della vita. Secondo una ricerca condotta da Gerd Kepermann dell’università Humboldt di Berlino, invece, a molti degli anziani vengono anzi garantite performance mentali addirittura ottime proprio grazie alla neurogenesi, ossia alla formazione di nuove cellule nervose soprattutto a
livello dell’ippocampo. Non solo, ma di recente si è scoperto che il fiorire di nuove connessioni tra i neuroni, che è uno dei meccanismi della plasticità cerebrale, raggiunge la sua massima espressione nell’ippocampo proprio tra i 50 e i 70 anni. E c’è anche un altro elemento: si è visto che la maggior capacità di controllo delle emozioni, tipica della persona matura, trova corrispondenza nelle funzioni cerebrali: gli scienziati hanno dimostrato infatti che con il passare degli anni continua a diminuire l’attività della amigdala, la piccola
CERVELLO GIOVANE
32
area posta nelle profondità dei due emisferi cerebrali che ha il compito di gestire le sensazioni di paura. Ecco spiegato il motivo per cui gli individui avanti con gli anni sono emotivamente meno fragili. Non solo, ma chi ha i capelli bianchi tende a essere meno colpito da stimoli emotivi negativi, mentre reagisce intensamente a quelli positivi».
Tutto bene, allora? Certo, tuttavia niente è scontato e c’è una formuletta magica che è bene tenere sempre a mente se si vuole confermare quello che già Solone, il grande legislatore ateniese, sosteneva nel VI secolo a.C.: “Invecchio e qualcosa di nuovo imparo sempre”.
Per mantenere in pista il cervello è indispensabile l’esercizio mentale, tanto è vero che chi si dedica ad attività che richiedono molta concentrazione è meno a rischio di demenza. Il segreto, dicono gli scienziati, è non stancarsi di sperimentare esperienze diverse, continuare a studiare materie nuove mai prese in considerazione prima, mettersi in gioco in attività inedite. Senza con questo doversi inventare pratiche mirabolanti. Può essere utilissimo e piacevole praticare yoga, ballare, leggere generi nuovi, provare a giocare a scacchi o a carte, iscriversi a un cineforum, imparare “ex novo” una lingua straniera.
«L’allenamento mentale più efficace, - sintetizza Musco, - è la curiosità di sperimentare esperienze diverse, di sapere cose nuove, di dedicarsi a interessi magari in campi opposti a quelli che ci hanno appassionato nel corso della vita».
Sempre per tornare alla saggezza antica, ricordiamo il detto mai smentito: “mens sana in corpore sano”. Nella terza età, un’attività fisica moderata e costante commisurata alle
possibilità fisiche, acquista proprio una valenza terapeutica sul cervello, conservandolo agile e lucido: la scienza conferma che muoversi migliora l’attenzione, la concentrazione e la registrazione delle informazioni; in altre parole la memoria, aumentando anche il numero dei collegamenti sinaspici, i contatti fra i neuroni.
Uno studio realizzato dall’Università di Edimburgo, ha messo in luce come la stimolazione mentale negli anziani tramite cruciverba o lettura non produce assolutamente gli stessi benefici se, nel frattempo, il corpo rimane fermo.
Infine, aiuta moltissimo la lucidità mentale anche il cercare di minimizzare gli inevitabili piccoli fastidi fisici, abituarsi a non dare spazio a rabbia, rancore ed emozioni negative, fare attenzione a curare anche una migliore comunicazione con figli, parenti e amici.
Paola Tiscornia
33
Nell’aprile di quest ‘anno è stato ricordato il cinquantesimo anniversano della scomparsa del principe Antonio De Curtis Gagliardi, in arte Totò, indubbiamente uno dei personaggi più popolari del mondo dello spettacolo italiano del Novecento. Durante questo mezzo secolo è stata prodotta una imponente messe di analisi, biografie e considerazioni varie sui molteplici aspetti della vicenda professionale e umana del “Principe della risata”, una messe di studi andata strettamente intrecciandosi a quella progressiva rivalutazione delle qualità artistiche di un protagonista della scena teatrale e cinematografica, in vita spesso sottovalutato dagli “addetti ai lavori”, anche se sicuramente tutt’altro dal grande pubblico.
Risulta dunque difficile dire qualcosa di nuovo su Totò: anche per questo motivo, si è deciso di imperniare il presente articolo sul tentativo di formulare alcune riflessioni su quella che latu sensu potremmo chiamare la filosofia di un attore, nato a Napoli al tramonto del XIX secolo da famiglia di lontane origini nobiliari, ma impostosi con un personaggio strettamente legato all’anima popolare(sca) e semi-proletaria del capoluogo partenopeo.
In tale ottica appare opportuno partire proprio dal “dualismo” tra il Principe e la Maschera ossia, parafrasando il titolo di una fortunata pellicola cinematografica interpretata da Totò nel 1954 e tratta da un’altrettanto celebre commedia teatrale scritta da E. Scarpetta tra Miseria e Nobiltà. Un dualismo a base antropologico-psicologico-sociale che potremmo hegelianamente (o forse meglio, crociamente) definire dialettico nel quale, al di là della versione volutamente autoironica offertane da De Curtis in un’intervista televisiva curata dal giornalista RAI Lello Bersani (‘63), nessuna delle due parti in campo finiva per prevalere in maniera netta e tantomeno definitiva sull’altra. Non a caso la figlia Liliana, a proposito dell’orientamento filosofico-politico del padre, ha espressamente parlato di simpatie monarchico-socialiste; un dualismo, insomma, in cui il registro comico e quello tragico, la dimensione farsesca e quella
malinconica non solo si dividevano i compiti in maniera complessivamente ordinata, ma anche spesso si intersecavano senza alcuna particolare conflittualità.
Passando ora al “cuore” della “totologia”, è opinione piuttosto diffusa che essa possa essere rintracciata soprattutto all’interno di pellicole come Siamo uomini o caporali? (’55) dove sono narrate le tragicomiche avventure di un pover’uomo costantemente ostacolato e tormentato a livello professionale ed umano da varî’ soggetti potenti e prepotenti, i “caporali” di turno, che finiscono per avere tutti quanti le medesime sembianze fisiche, incarnate nel film da un camaleontico Paolo Stoppa, e che soprattutto frustrano qualsivoglia valido tentativo dell’omino di migliorare le proprie condizioni socio-economiche. Trattasi evidentemente di una mordace metafora delle prevaricazioni e delle vessazioni alle quali i molteplici volti del Potere che, ogniqualvolta rischia concretamente l’impotenza, tende ad assumere i contorni della prepotenza e spesso sottopone l’uomo comune, a sorta di vittima metafisicamente predestinata.
Nel corso di una carriera teatrale quarantennale (dalla metà degli Anni Dieci al 1956, allorquando un’improvvisa e seria malattia alla vista lo costrinse al ritiro dall’attività diretta sul palcoscenico) e soprattutto durante una trentennale carriera cinematografica, che dal ‘37 alla morte, ha visto De Curtis interpretare un centinaio di pellicole di varia qualità tecnico-artistica ma complessivamente baciate da un buon successo di pubblico, la maschera-Totò ha assunto il ruolo di una sorta di “battitore libero” in perenne lotta non solo contro l’antico spettro della miseria e della fame ma anche contro le mille forme in cui appunto via via si incarna il potere politico. In tale scenario l’arte di arrangiarsi, tradizionalmente afferente alle classi popolari non solo campane e meridionali ma anche italiane e mondiali, assume i connotati del principale strumento a disposizione per invertire tale tendenza ed ampliare così i diritti e le possibilità di effettiva emancipazione economico-
SIAMO UOMINI O CAPORALI?Brevi note di una eventuale “totologia”
34
politico-sociale da parte dell’uomo della strada. Una prospettiva evidentemente ricollegantesi anche a classiche maschere della Commedia dell’Arte, a cominciare da Pulcinella. Ne sono derivati alcuni efficaci affreschi sociologici cronologicamente collocabili tra i primi Anni Cinquanta e il periodo del “boom economico” italiano ed europeo, ovvero sul crinale tra il tramonto della stagione neorealista e la progressiva affermazione della cosiddetta Commedia all’italiana i cui attori come Sordi e registi come Monicelli sarebbero stati i protagonisti.
Questo approccio tendenzialmente “anar-chico” e potenzialmente “rivoluzionario” si ma-nifestava anche nella creatività mimico-gestuale e soprattutto linguistica, testimoniata dalla nutrita serie di neologismi coniati da Totò: Basti pensare alla locuzione ‘a prescindere’, che tra l’altro dava il titolo all’ultima commedia interpretata in palco-scenico dal Principe, che negli Anni Trenta e Qua-ranta fu grande protagonista del Teatro di rivista con il film antologico I pompieri di Viggiù - 1949, spesso in compagnia con Anna Magnani.
Tutto ciò non deve far dimenticare la notevole versatilità dell’attore partenopeo, che al di là della qualità non eccelsa della maggior parte dei copioni e delle sceneggiature che via via gli venivano proposte, ha saputo ricoprire non solo ruoli comico-brillanti, peraltro frequentemente venati da tonalità decisamente amare e malinconiche, come nel caso di Guardie e ladri - 1951 e I soliti ignoti - ‘58, ma anche esplicitamente drammatici. Si pensi a pellicole come Dov’è la libertà? - (‘53) e Il Comandante (‘64); per tacere del carattere sostanzialmente surreale delle pellicole interpretate negli ultimi anni con la regia di Pier Paolo Pasolini e che valsero a De Curtis alcune tardive attestazioni di stima da parte dei critici cinematografici più “impegnati”. A questo proposito vale la pena di ricordare le altre interpretazioni di buon livello offerte da Totò con altri registi di chiara fama, da Vittorio De Sica a Monicelli, Steno, da Lattuada a Risi e a Rossellini, senza dimenticare l’ottimo “artigiano” della cinematografia italiana di metà Novecento Marco Matteoli, a lungo regista favorito del Principe.
La dimensione amara, malinconica e tendenzialmente pessimistica di A. De Curtis risulta piuttosto facilmente rintracciabile anche nella non marginale produzione di testi poetici e
per canzoni in dialetto napoletano. In tale ambito ricordiamo le celebri ‘A livella e Malafemmena.
Più problematico per ovvie ragioni cronologiche è stato il rapporto avuto da Totò con la televisione: un medium destinato a grande diffusione e rilevanza ma che prese ufficialmente le mosse quando De Curtis aveva già ampiamente superato il mezzo secolo di vita. Ciononostante, anche qui il Principe riuscì a lasciare qualche traccia non trascurabile della propria statura artistico-professionale. Basti pensare alle due partecipazioni alla popolare trasmissione ‘Studio Uno’ (1965 e ‘66). La RAI inoltre non ha mancato di dedicare, a partire dagli Anni Settanta, una crescente attenzione e un buon numero di trasmissioni retrospettive alle pellicole cinematografiche, frequentemente trasmesse, e in generale, alla multiforme carriera dell’attore napoletano.
In conclusione, si può osservare che il mezzo secolo trascorso dalla scomparsa ha manifestamente visto così numerosi e così imponenti mutamenti nello scenario politico, culturale e scientifico-tecnico italiano ed europeo da rendere conseguentemente piuttosto problematica la valutazione complessiva di un percorso certamente lungo e prestigioso ma inevitabilmente collocato in un contesto profondamente diverso.
Tuttavia, non soltanto la maggior parte delle interpretazioni di Totò sembrano resistere bene al lento ma inesorabile trascorrere del tempo, ma anche la Maschera stessa dell’attore napoletano appare essere ormai entrata in quella ristretta e selezionata categoria dei “classici” in grado di metterla definitivamente al riparo dal rischio dell’oblio. Come Chaplin/Charlot e pochi altri grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, Totò sembra ormai definitivamente assurto non solo al prestigioso rango di icona popolare, consacrazione certamente già iniziata durante la vita e la carriera del Principe, ma anche a quello di beniamino di gran parte non solo della critica teatrale e cinematografica ma anche del mondo culturale “ufficiale”, che in quest’ultimo mezzo secolo ha via via accresciuto la propria attenzione e la propria stima per il poliedrico artista partenopeo: interesse e stima che non sembrano destinati ad affievolirsi nel breve-medio termine.
Claudio Pestarino
35
Sono davvero molte le trasformazioni che hanno segnato negli ultimi trent’anni il mercato del cinema in Italia. Un tempo a Genova le pagine spettacolo dei quotidiani riportavano almeno una quarantina di sale e quelle di maggior pregio erano aperte nell’area attorno a via XX settembre. Questi esercizi facevano capo a molte aziende, le maggiori delle quali potevano contare sul controllo di tre - quattro schermi al massimo. In città funzionavano anche numerose agenzie di distribuzione e questo era uno dei dati che contribuivano a testimoniare l’importanza di questa piazza dal punto di vista del mercato.
Oggi la situazione è totalmente diversa e non ci sono più agenzie di noleggio che si sono trasferite a Milano o a Roma. Per quanto riguarda i cinematografi sono raggrupparti in due gruppi: Circuito Cinema con 14 schermi, di cui 3 fra Riviera ligure e basso Piemonte, e Cinema Genova Centro con 3 schermi concentrati in città. Accanto a queste due imprese operano un paio di multischermi: The Space (10 schermi e 37
esercizi in varie parti d’Italia) e UCI Cinemas - Fiumara (14 schermi e numerose presenze in Italia, Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Germania, Portogallo e Spagna). Queste due ultime realtà agiscono in modo autonomo e non fanno parte dell’associazione di categoria degli esercenti, ma aderiscono ad una propria organizzazione.
Questo vasto quadro ha influenzato anche le sale parrocchiali, oggi dette dJ comunità, spesso sempre ubicate in spazi vicini a chiese e di proprietà ecclesiastica. In passato questi locali erano inseriti nell’attività degli oratori e facevano riferimento ad un vero e proprio mercato parallelo: noleggiavano i film da una società a forte influenza religiosa - La San Paolo Film - che svolgeva anche, oltre una sua politica di acquisizione, una sorta di filtro - garanzia nei confronti dei titoli proposti con buona pace di preti e curati che avevano la responsabilità di questi locali. Da notare che spesso questa azienda era un’ottima cliente delle cinematografie est-europee con cui condivideva gli obiettivi educativi.
Oggi tutto è cambiato, in primo luogo per un dato tecnico: la fine della pellicola tradizionalmente intesa e la sua sostituzione con i DCP, sorta di DVD rinchiusi in particolari scatole e dotati di una serie di blocchi che ne consentono l’utilizzo solo ai possessori di codici specifici. Questa trasformazione tecnica ha imposto ristrutturazioni e investimenti che non tutte le sale periferiche sono state in grado di fare. Ciò ha causato un prima
LE SALE PARROCCHIALI Nel nuovo quadro del consumo cinematografico
36
scrematura che, se ha tolto dalla circolazione gli esercizi meno solidi, ha anche segnato la fine di decine di cinematografi che presidiavano territori ora, da questo punto di vista, del tutto desertificati.
È un processo che ha interessato in modo particolare le sale di secondo livello, alcune delle quali sono scomparse, mentre altre sono rimaste sul mercato con compiti nuovi. Oggi i cinema di comunità in attività a Genova sono sette (Cappuccini, Club Amici del Cinema, Nickelodeon, Palmaro, Ritz D’Essai, San Pietro, San Siro). Uno di questi, Ritz D’Essai, fa parte di un vero e proprio circuito commerciale- Cinema Genova Centro- un altro, il Club Amici del Cinema, costituisce un punto d’eccellenza sia per la programmazione sia per il confort: alcuni anni or sono ha vinto uno dei riconoscimenti dalla rivista Ciak destinati alle sale migliori. C’è da dire che dal punto di vista della qualità delle iniziative, questa sala segna un momento particolarmente alto nel quadro delle programmazioni genovesi con rassegne, discussioni, recupero di opere trascurate o del tutto dimenticate.
Se allarghiamo lo sguardo sino a comprendere l’intera provincia genovese all’elenco si aggiungono altre cinque sale di comunità (Casella, Bargagli, Masone, Bogliasco, Ruta
di Camogli) che mantengono viva l’offerta cinematografica in territori altrimenti desertificati. Ne nasce il quadro di un settore di mercato tutt’altro che trascurabile tanto che la consistenza di questi esercizi è deducibile dal fatto che sono riuniti in un’apposita associazione e quasi tutti si rivolgono alla distribuzione come altrettante realtà imprenditoriali tese a raccogliere sul mercato i titoli più appetibili. Si può anzi dire che funzionano come quelle che un tempo si dicevano seconde visioni, quando non entrano in concorrenza più o meno aperta con i locali commerciali per accaparrarsi i titoli più interessanti.
I film che mettono in programma sono, quasi sempre, quelli appena usciti dai cartelloni dei locali di prima visione e spesso sono presentati a strettissimo giro di programmazione in sale che rappresentano un’eccellenza sia dal punto di vista della qualità sia da quello del livello di proiezione. Con l’introduzione dei DCP quest’ultima si è venuta livellando in qualsiasi tipo di esercizio. È una omologazione che ha fatto perdere un certo livello di calore nell’immagine, visto che la proiezione elettronica è decisamente più fredda di quella chimica, ma ha l’indubbio vantaggio di rendere eguali le offerte nei vari tipi di locali. Senza dimenticare, poi, l’enorme riduzione dei
costi di trasporto e riproduzione: oggi al posto delle ingombranti pizze di un tempo, girano scatole non più grandi di una piccola valigia. La standardizzazione di questi involucri consente anche ai gestori delle sale di proiettare facilmente titoli diversi nel corso della medesima giornata, cosa che avviene quasi quotidianamente nelle sale commerciali e che inizia ad affacciarsi anche a livello di esercizi periferici, sale di comunità comprese.
Umberto Rossi
37
Durante la torrida estate appena trascorsa i mezzi di comunicazione ci hanno sommerso di notizie riguardanti una serie di contagi trasmessi attraverso le punture di zanzare, prima a Brescia per il caso di una bambina di soli 4 anni morta per aver contratto la malaria, poi per gli episodi di febbre da virus Chikungunya verificatisi sul litorale romano.
Notizie incontrollate, approssimative, se non addirittura false, e frammentarle non solo sono inutili, ma contribuiscono a provocare ansia e confondere le idee, mentre è indispensabile essere informati in modo corretto su quanto sta accadendo, soprattutto per non lasciarsi prendere dal panico e non provocare reazioni incontrolllate.
Delle circa tremila specie di zanzare diffuse in tutto il mondo, in Italia ne sono presenti poco meno di settanta, tutte con caratteristiche ed abitudini diverse, che bisogna conoscere per potersi difendere meglio dalle loro punture.
Pur essendo le specie diffuse sul nostro territorio numericamente rilevanti, le zanzare più diffuse e più fastidiose sono soltanto quattro: la zanzara comune (Culex pipiens) con la quale le popolazioni italiane hanno convissuto per secoli, l’anofele (Anopheles labranchiae) con habitat in ambiente rurale, la zanzara delle risaie (Ochlerotatus caspius), che si sposta a sciami ed infesta ampie aree umide, ed infine le Aedes, specie di cui fanno parte la famigerata zanzara tigre e la zanzara coreana, particolarmente aggressive e attive durante tutta l’arco del giorno, con una
maggiore intensificazione dell’attività all’alba e al tramonto.
A partire dal 2015 è stata segnalata anche la zanzara giapponese, Aedes japonicus, molto simile a quella coreana e che purtroppo è tra le zanzare più invasive presenti nel mondo.
In generale l’ambiente ideale per le zanzare è costituito dall’acqua stagnante, dai piccoli microsistemi acquatici alle acque ferme di sottovasi, tombini e caditoie, alle pozzanghere, alle risaie, fino alle grandi zone umide di stagni e zone costiere.
Le zanzare ricevono l’energia di cui hanno bisogno per il loro ciclo vitale dalla assunzione di liquidi zuccherini, come il nettare dei fiori, mentre le femmine devono succhiare il sangue
di mammiferi, uomo compreso, uccelli, rettili ed anfibi per procurarsi l’adeguato apporto proteico che fa maturare le uova.
Come molti altri insetti, le zanzare occupano una posizione fondamentale all’interno della catena alimentare dato che molti animali sono insettivori,
però, oltre a svolgere un importante ruolo ecologico, moltissime specie di zanzare sono anche vettori di agenti patogeni, responsabili di un gran numero di infezioni umane ed animali in ogni parte del mondo.
Tra queste ultime sono particolarmente importanti per la salute dell’uomo la malaria, la dengue, la febbre gialla, la febbre da West Nile virus e molte altre provocate dagli arbovirus, un gruppo di agenti patogeni trasmesso principalmente da
ZANZARE,, MALARIA E VIRUS
38
zanzare dei generi Aedes, Ochlerotatus e Culex.Nella fauna indigena italiana, che attualmente
comprende anche la zanzara tigre, di provenienza tropicale ma ormai adattatasi per la sua grande plasticità ecologica ai nostri climi, sono già presenti i potenziali vettori di malaria ed arbovirus, anche se fortunatamente mancano finora i serbatoi umani ed animali necessari per trasmettere il contagio.
In particolare la zanzara tigre nei paesi di origine è un efficiente vettore di oltre 20 diversi tipi di virus che sono assenti in Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo, ma i cambiamenti climatici ai quali stanno andando incontro i paesi che si affacciano su di esso potrebbero già essere in grado di modificare lo scenario e consentire l’introduzione di questi virus anche nei paesi a clima temperato.
Anche la dengue, malattia presente in forma endemica in tutta la fascia tropicale dell’Asia, del Pacifico meridionale e del continente americano, oltre che dalle zanzare appartenenti al genere Aedes (tra cui Aedes aegypti, vettore anche della febbre gialla) può essere trasmessa all’uomo dalla zanzara tigre.
La stessa zanzara tigre può essere chiamata in causa anche come vettore dei numerosi casi di febbre di cui è responsabile il virus Chikungunya dal momento che nei paesi di origine molti esemplari di questa specie sono risultati infettati dal virus.
Non possiamo neppure passare sotto silenzio il fatto che zanzare appartenenti a generi diversi, compresa la zanzara tigre, possono essere responsabili delle filariosi, malattie causate da vermi parassiti le cui forme più pericolose per l’uomo sono presenti solo nei paesi tropicali e sub-tropicali, ma che in Italia sono comuni parassiti del cane e del gatto e potrebbero essere
trasmessi accidentalmente anche all’uomo.Pertanto la zanzara tigre, vista l’ampia area di
distribuzione, potrebbe amplificare la trasmissione di questi patogeni anche nelle aree densamente popolate del bacino del Mediterraneo.
La malaria può essere trasmessa solo da un vettore, cioè la zanzara del genere Anopheles, o per scambio di siringa volontario tra tossicodipendenti o per incidente in ospedale (trasfusione, trapianto d’organo o altro tipo di evento che comporti l’inoculazione del sangue di un paziente malarico in un’altra persona).
Nell’uomo sono cinque le specie di plasmodi in grado di causare la malaria, mentre le specie di Anopheles che li possono trasmettere sono circa 30-40, ma ciascuna di esse si è adattata solo ad una specie di plasmodio o ad una sua sottopopolazione.
In Italia sono tuttora presenti popolazioni di Anopheles, specie responsabile fino al dopoguerra di migliaia di casi di malaria da Plasmodium vivax, che causa la forma terzana benigna, da Plasmodium malariae, cui è ascrivibile la quartana e da Plasmodium falciparum, agente della forma più pericolosa di malattia per l’elevato tasso di complicanze e di mortalità.
Il nostro paese è stato dichiarato affrancato dalla malaria solo nel 1970 e attualmente non sembra che le popolazioni autoctone di Anopheles siano “competenti”, possano cioè infettarsi, con ceppi di Plasmodium falciparum provenienti dall’Africa.
I dati del Ministero della Salute attestano in Italia la notifica di 3.633 casi di malaria nel periodo
.
39
2011-2015, quasi tutti d’importazione, mentre dei 6377 casi verificatisi nel periodo 2000-2008 solo nove sono stati classificati come autoctoni, dimostrando che la trasmissione ospedaliera, pur se eccezionale ed infrequente, può comunque verificarsi.
La trasmissione all’uomo della malattia sostenuta dal virus Chikungunya avviene attraverso la puntura di zanzare infette appartenenti al genere Aedes, rappresentato in Italia dalla Aedes albopictus o zanzara tigre, che, pur importata accidentalmente solo nel 1990, è già dal 2006 presente su quasi tutto il territorio nazionale, con maggiore intensità in pianura, nelle aree costiere ed in zone con vegetazione abbondante.
Una mutazione, avvenuta probabilmente all’inizio di questo secolo, ha consentito al virus di adattarsi alla zanzara tigre, che ne è diventata un importante vettore, rendendo la malattia potenzialmente diffusibile nel nostro paese e in altre aree dell’Europa mediterranea.
Recentemente a queste malattie si è aggiunta una nuova minaccia, il virus Zika che si trasmette anch’esso attraverso le punture di una zanzara, la Aedes aegypti, detta anche zanzara della Febbre Gialla, originariamente presente solo nelle zone tropicali e subtropicali, ma che, causa del riscaldamento globale e i traffici internazionali, si è ormai diffusa in molti continenti.
Il crescente disagio creato da questi insetti ematofagi, sempre più numerosi e potenziali vettori anche di malattie fino a poco tempo fa sconosciute sul nostro territorio, segnalano la necessità di indagare più a fondo per capire con quale specie di zanzara si ha a che fare e, di conseguenza, individuare il metodo migliore per intervenire.
Per far questo non basta il potenziamento dei programmi di controllo dei vettori delle malattie tropicali e la predisposizione di progetti di
sorveglianza epidemiologica per l’identificazione tempestiva dei casi di importazione e dei focolai autoctoni, ma è indispensabile anche la concreta collaborazione di tutti i cittadini che possono intervenire in prima persona prestando attenzione ad eliminare ogni piccolo ristagno d’acqua superfluo o, qualora ciò non fosse possibile, procedere alla regolare somministrazione di prodotti antilarvali, disponibili in formulati biologici estremamente specifici e sicuri per l’uomo e gli animali.
Con un’osservazione più attenta degli orari in cui si viene punti e di come le zanzare si presentano, informazioni apparentemente di
poco conto, si riesce a capire quali zanzare sono presenti, potendo così effettuare trattamenti ad azione abbattente/residuale, con risultati buoni, anche se di efficacia limitata nel tempo.
Un’alternativa meno impattante sull’am-biente può essere l’utilizzo di dispositivi per la cattura di insetti ematofagi, strumenti che permet-tono, tramite la produzione di stimoli attrattivi, di catturare gradualmente nel tempo le zanzare pre-senti, contribuendo alla loro diminuzione e conte-nendo il numero di quelle provenienti dall’esterno.
Ancora una volta il detto “conosci il tuo nemico per poterlo combattere efficacemente” si rivela più che mai pertinente.
Marco Cingolani
40
L’autore racconta di essersi recato a Barcellona, nel dicembre del 1936, con la “...vaga idea di scrivere degli articoli per qualche giornale ... “, e, spinto dai propri ideali di giustizia e libertà, sente il dovere morale di arruolarsi immediatamente nella milizia repubblicana del P.O.U.M. (Partido, Obrero de Unificaciòn Marxista) “...perché a quel tempo e in quell’atmosfera sembrava la sola cosa che si potesse pensare di fare ....”.
Visse quindi le giornate del maggio 1937 e fu coinvolto direttamente in alcuni avvenimenti della guerra civile spagnola; per questi motivi Omaggio alla Catalogna scritto nel 1938, rappresenta un libro/diario di guerra; testimonianza lucida, drammatica e disincantata di alcuni episodi avvenuti a Barcellona e sul fronte catalano.
George Orwell scrive in prima persona, con uno stile asciutto e con grande onestà; non mancano i momenti diretti esplicitamente al lettore; a volte anche preavvisandolo della volontà di affrontare riflessioni politiche e polemiche sulla visione errata che trapela dalle pagine della stampa estera; “... una massa d’accuse e di propaganda di partito .... “; causa delle diffamazioni di illegalità e spionaggio rivolte al partito alla fine di giugno 1937.
Questo testo rappresenta un documento di grande rilevanza storica, in cui confluiscono una
dimensione autobiografica e una versione vivida della guerra; esso si apre con tante speranze nella lotta per una società migliore, confermata dall’atmosfera rivoluzionaria e dall’aria densa di fiducia nel futuro che la città trasuda; e si conclude
con la scoraggiante idea di fallimento e la progressiva disillusione del possibile cambiamento che in pochi mesi aveva invaso la città.
Una situazione di sospetto, odio politico e amarezza: “...Non è facile far comprendere l’ atmosfera da incubo di quel periodo, il particolare malessere procurato dalle voci estremamente contraddittorie, dai giornali censurati, dalla continua presenza di uomini armati ... “, con la consapevolezza che non avrebbe potuto esistere una vera rivoluzione in un paese confuso e disorganizzato come la Spagna, in cui avverte la mancanza di una profonda coscienza politica, e di una
volontà effettiva di cambiare l’ordine delle cose.Il tono leggero, e a tratti divertente, del
periodo di approssimativo addestramento, in cui non veniva insegnato niente che potesse dimostrarsi utile al momento di un attacco, si trasforma in un’analisi riflessiva della situazione politica, evidenziando l’inutilità di quella guerra portatrice di miseria, fame e devastazione. “...tutti erano stanchi di questi assurdi combattimenti, che non potevano portare a nessuna vera soluzione: nessuno voleva infatti una guerra civile vera e propria, che avrebbe solo servito la causa
CRONACA DI UNA RIVOLUZIONE “Omaggio alla Catalogna” di George Orwell
· S T O R I A ·
41
di Franco, e il timore di questa possibilità io lo sentivo esprimere da ogni parte .... “
Lo stile e la potenza evocativa trasmettono al lettore le sensazioni provate nel momento del ferimento in trincea, a Huesca: un proiettile gli trapassa di netto il collo “...nessun dolore, ma una scossa violenta, come quella che vi può dare l’estremità di un filo elettrico; ed insieme un’estrema spossatezza, il senso di venire folgorato e di contrarvi fino all’annientamento.[...] una sensazione vaga, torpida, la consapevolezza d’essere ferito gravemente, ma nessun dolore nel senso ordinario della parola....”, e soprattutto il forte rammarico ed il fastidio per il modo e la situazione assurda in cui venne colpito.
Durante la convalescenza, il partito viene accusato di spionaggio e tradimento, e di conseguenza Orwell è costretto alla fuga clandestina, da quel paese pieno di bellezze artistiche che avrebbe voluto visitare con gli occhi di un turista e di cui si rammarica di aver visto solo quell’angolo di nord-est, in mezzo ad una guerra che definisce caotica.
I documenti di congedo, ottenuti con fatica, non servono più, anzi sono una prova del servizio reso al partito, e solo dopo giorni passati tra ambasciate e consolati britannici, riesce, con la moglie, a pianificare la fuga in treno verso la Francia; anche tra le carrozze si avverte il cambiamento, la polizia; vedendo i due fuggiaschi seduti nella carrozza-ristorante non controlla la loro identità, “...Era strano come tutto fosse cambiato. Solo sei mesi prima, quando regnavano ancora gli anarchici, era il sembrar proletario che vi rendeva rispettabile .... “, l’apparenza borghese era ora ritenuta l’unica salvezza.
Arrivati nella prima stazione in territorio di pace, Banyulus, si aspettano un’atmosfera accogliente e, con stupore ed un filo di amarezza, l’autore si accorge che il clima di guerra aveva invaso ogni luogo ... “...Non ci accolsero con troppo entusiasmo[...]e poi un’accentuata freddezza. La cittadina sembrava compattamente filofranchista, senza dubbio per i numerosi fascisti spagnoli che vi si erano rifugiati[...]. Era una strana epoca agitata. In quella tranquilla cittadina peschereccia, lontana dalle bombe, dalle mitragliatrici, dalle file per la spesa, dalla propaganda e dai complotti,
avremmo dovuto sentirci pieni di sollievo e di soddisfazione. Neanche per sogno. Ciò che avevamo visto in Spagna non indietreggiava per disporsi nella sua giusta prospettiva, ora che ce ne trovavamo distanti. Rifluiva anzi su di noi, e tutto era più che mai vivido. Pensavamo, discorrevamo, sognavamo continuamente della Spagna. Per mesi ci eravamo detti che, quando fossimo partiti dalla Spagna, ce ne saremmo andati in qualche paesino sul Mediterraneo per starcene un po’ tranquilli, magari a pescare; ma ora che ci eravamo, non trovavamo che tedio e delusione. Parrà follia, ma la cosa che entrambi volevamo era di ritrovarci in Spagna[...] entrambi avremmo preferito restare per essere imprigionati con gli altri ... “.
Nelle ultime pagine del libro, Orwell riflette sulle sue vicende di guerra “...in cui ho contato così poco ... “ e a cui, tuttavia, rimane legato e coinvolto, convinto della propria partecipazione. Avverte il lettore che la sua testimonianza è stata scritta con una certa partigianeria inevitabilmente causata dall’aver visto solo un angolo degli avvenimenti; è provocatorio e critico nei confronti dell’Inghilterra, che giudica mite e lontana dalle vicende del mondo.
Sente la necessità di denunciare la pericolosità del totalitarismo, che ha come scopo la conservazione assoluta, e con ogni mezzo, del potere, con la conseguente distruzione di qualsiasi forma che possa essere alternativa; si fa garante di questo pericolo e, come testimone diretto, si sente uno dei pochi pienamente cosciente. La guerra franchista diventava l’inizio di una serie di guerre contro i totalitarismi, mentre altrove la vita trascorreva in una calma apparente: “...tutto dormiente del profondo, profondo sonno d’Inghilterra, dal quale temo a volte che non ci sveglieremo fino a quando non ne saremo tratti in sussulto dallo scoppio delle bombe. “
Non è difficile percepire come, in questa esperienza di vita, fossero già presenti le radici ed i presupposti per i futuri scritti di George Orwell, la coscienza critica e civile di un autore che, dieci anni più tardi, iniziò a scrivere un libro intitolato La Fattoria degli Animali che ancora oggi spaventa, risultando di grande contemporaneità.
Giulia Repici
42
L’ampio tratto dell’ Oceano Atlantico , che nella sua parte più occidentale bagna la Florida e il Messico, ingloba una miriade di isole grandi e piccole che formano la Cordigliera della Costa, quale raccordo tra il Nord e il Sud delle Americhe. Sono le Grandi Antille come Cuba, Hispaniola, Giamaica, Puerto Rico, Haiti e molte altre minori come la Martinica, Guadalupa, Antigua ,Grenada dette Piccole Antille che separano a oriente, da Nord a Sud, quasi a scogliera frangiflutti, l’Atlantico dal Mar delle Antille mentre, a ponente, vi è la penisola messicana dello Yucatan.
Il nome di queste isole deriva da una località a Sud/Ovest della Spagna, bagnata dall’Atlantico e chiamata “La Antilla” (Prov. Huelva). Da qui provenivano i primi marinai che approdarono, nel XVI secolo, alle isole caraibiche. Questa cittadina è ancora oggi molto rinomata per le sue spiagge.
L’isola di Barbados è la più orientale di tutte le Antille, malgrado ciò è forse una delle più frequentate dal turismo internazionale e, in particolare, da quello inglese. Volle il caso che il 14 maggio 1625 la nave inglese Olive Blossom, al comando del capitano John Powell, approdasse sull’isola per approvvigionamento di acqua e cibo. Subito apparve lussureggiante e accogliente. Nei giorni successivi, dopo una particolareggiata verifica dei luoghi , il capitano decise di prenderne possesso a nome della monarchia britannica. In
pochi anni giunsero dall’Inghilterra altre navi con i primi coloni e schiavi africani, che cominciarono a coltivare piantagioni di tabacco, cotone e canna da zucchero; la colonizzazione era iniziata e durò per tre secoli.
In realtà gli inglesi non furono i primi a metter piede sull’isola. Nel1511 navi spagnole fecero scalo a Barbados con l’intento di sfruttare, rendendo in schiavitù la popolazione indiana “Caribi”, le risorse che in essa si potevano trovare.
L’ISOLA DI BARBADOSLa piccola Inghilterra
Mentre mi accingo ad illustrare questo lembo di “paradiso terrestre”, nel contesto di un’area tra le più lussureggianti e accoglienti, voglio ricordare che proprio nei primi giorni del settembre 2017, il surriscaldamento della superficie del Mar Caraibico (+di 28°/30°), ha generato nella zona, una serie di uragani (Harvey, Irma, Katia e Maria) di inusitata estensione e potenza. Venti con velocità tra i 200 e i 300 Km...ora che hanno seminato distruzione e decine di morti in tutta l’area della Cordigliera della Costa. Da Puerto Rico a Cuba fino al Golfo del Messico e alla penisola della Florida, si sono allagate città come Miami, rendendo impossibile la viabilità. Sono mancati i generi alimentari e l’acqua potabile, paralizzati i presidi sanitari, crollati gli impianti della luce per i servizi alla cittadinanza e alle industrie. Oltre al danno economico, che si valuta in decine di miliardi dollari, si pensa alle migliaia di persone che hanno perso tutto. Saranno necessari molti mesi prima di poter tornare a vivere nella condizione di normalità. L’isola di Barbados ha subìto anch’essa gravi danni alle abitazioni e infrastrutture. Le attività turistiche, sostegno dell’economia, sono quasi inesistenti.
Contemporaneamente a quanto accadeva ai Caraibi e negli Stati Uniti, in India e in Nepal si registravano più di mille morti, a causa dei monsoni che hanno imperversato con eccezionale violenza.
43
Nel 1536 approdò anche il capitano portoghese Pedro a Campos, che soggiornò brevemente senza mostrare alcun interesse per l’isola. Nei fatti, sia gli spagnoli che i portoghesi, non ritennero mai di poterla colonizzare a favore delle rispettive corone. Il loro passaggio lasciò traccia perché , alla visione delle copiose radici aeree di grandi alberi Ficus, battezzarono l’isola “Los Barbados” (‘’I barbuti”). Ancora oggi questo metodo di evidenziare certe caratteristiche di un luogo è usato nei rilievi topografici.
I primi anni della vita della colonia inglese furono molto burrascosi; si generarono feroci faide per poter avere il predominio economico e politico dell’isola. Naturalmente la contesa era unicamente tra inglesi. Si ricorda il mercante sir William Courteen e il conte Carlisle, il primo interessato allo sviluppo economico dell’isola, il secondo
interessato ad assumere il governo amministrativo. La spuntò Carlisle che convinse il re a dichiararlo proprietario delle Isole dei Caraibi. Fu un conflitto aspro e sleale, i sostenitori di W. Courteen si insediarono nella città di Holetown mentre quelli di Carlisle scelsero la zona della capitale Bridgetown. La conclusione premiò Carlisle che ebbe la meglio e riuscì a far nominare Governatore dell’isola il suo protetto Henry Hawley , inviato dal re. Non finirono le difficoltà del Governatore che, per sostenere la sua posizione, decise di dar voce ai proprietari terrieri che lo sostenevano e, nel 1639, costituì la “House of Assembly” riconosciuta, nel 1640, dal Consiglio della Corona inglese che la definì “Il Consiglio dei cittadini di Barbados, il loro organo rappresentativo”.
Questo fatto straordinario, che si registrò in quel tempo, anticipò di 135 anni la nascita della “Camera dei rappresentanti” degli Stati Uniti.
L’ intuizione di dare spazio ad un organo che rappresentasse i cittadini, nel breve tempo permise di costruire una solida democrazia, consentendo di migliorare la vita associativa e la convivenza delle etnie con pacifiche riforme.
Si ricorda che tra le tante riforme, nel 1835, si proclamò l’emancipazione degli schiavi che erano ancora legati ai loro padroni.
Questa Assemblea fu sciolta nel 1951, quando venne introdotto il suffragio universale dal quale nacque un Parlamento Bicamerale, modellato su quello di Westminster. Nel 1966 l’isola, con l’ottenimento dell’indipendenza, entrò a far parte del Commonwealth.
All’origine della colonizzazione la maggioranza della popolazione era costituita da bianchi, provenienti dalla Scozia e dall’Inghilterra, che lasciavano le loro terre di origine a causa di una grave instabilità politica. Appartenevano a tutte le classi sociali: prigionieri di guerra, piccoli criminali che preferivano l’esilio alla forca,
44
oppositori politici ma, principalmente, lavoratori legati che cercavano sicurezza e fortuna sull’isola. Non mancavano quelli che venivano rapiti, trovandosi per strada, durante un reclutamento e messi a forza sulle navi in partenza per Barbados.
L’emigrazione continuò per tutto il secolo XVII favorendo i ricchi latifondisti che conducevano una vita agiata coltivando e commercializzando mais,cotone e tabacco.
Questo incremento delle coltivazioni influì negativamente sulla forza lavoro offerta dai sudditi britannici o, in genere, dai coloni bianchi. I proprietari dei terreni si rivolgevano sempre più all’immigrazione africana o all’impiego degli indiani americani (amerindi).
Oggi l’isola, con l’economia basata principalmente sul turismo e sulla canna da zucchero, pur avendo una superficie solo il doppio dell’isola d’Elba, ha la più alta densità di popolazione di tutto l’emisfero occidentale; si stimano circa 300.000 abitanti distribuiti
principalmente tra la capitale Bridgetown e altri centri urbani molto importanti. Nell’area delle Antille è considerata la più ricca, con un alto reddito pro capite. Una Nazione poggiata su una solida democrazia che può celebrare, con orgoglio, la sua lunga storia di riforme democratiche, nel rispetto dei diritti sociali e religiosi, amalgamate da una straordinaria cultura multietnica che oggi vede la sua popolazione, a stragrande maggioranza, di origine africana o di discendenza mista, con una minoranza di origine bianca.
Simbolo di questo importante risultato è Sir Grantley Adams di origine africana, vissuto nel XX secolo, ricordato come l’artefice di importanti riforme democratiche.
Giuseppe Visdomini
BibliografiaF.A. Hoyos “Barbatos” Macmillan Caribbean, Londra
1978.
45
Figlie di un burbero ministro anglicano, sorelle di uno scapestrato ubriacone, Charlotte, (1816-55), Emily (1818-48), e Anne (1820-49) Brontë vissero la loro breve vita, tra Thornton dove nacquero e Haworth, entrambe nello Yorkshire dove passarono parte della loro vita e morirono. La casa di Haworth sorgeva al limite del villaggio, alta sulle brughiere di erica, circondata da laghi, silenzi e orizzonti larghi, in cui il vento aveva libero gioco; Un’aria ruvida e sana; una lingua con accenti duri, parlata da una razza sincera e indipendente; un popolo logorato dal tempo, forte e pesante come le pietre del suo suolo, ma saggio e intelligente. In questo ambiente si sviluppò e si affinò in loro una sensibilità estrema, non influenzata da rapporti esterni, né sociali né letterari, più fantasiosa in Emily (autrice del geniale e originalissimo Wuthering Heights, (Cime tempestose, 1847); più sottile e vera - per quanto mai “ verista”, in Charlotte, la maggiore, autrice del romantico e autobiografico Jane Eyre, oltre che dei romanzi Shirley, The professor, e Villette, meno conosciuti; non così spiccata la personalità di Anne, autrice di Agnes Grey e di The Tenant of Widfell Hall. Le tre sorelle avevano cominciato col pubblicare una silloge di poesie insieme, in un solo volume, con i nomi di Currer, Ellis e Acton Beli. Questa anonimità, che, finchè
esse furono vive, non venne mai ufficialmente abbandonata; era non solo la maschera che così spesso le scrittrici del tempo ritenevano opportuno assumere nel presentarsi al mondo come romanziere, ma era anche parte dell’interiorità delle sorelle Brontë, del loro intenso modo di vivere per se stesse. Nel caso di Emily tale atteggiamento assunse proporzioni eccezionali e fu alla base di quella solitaria capacità di fantasticare che si palesò in modo così spiccato nel solo romanzo che scrisse; Wuthering Heights. Le poesie di Emily traggono ispirazione dalla stessa fonte :
situazioni emotive create da una immaginazione dotata di una forza quasi spaventosa e che non viene alimentata da banali fatti esterni. Charlotte, di temperamento sensibile e appassionato, si lasciò prendere dal mondo esterno più di Emily e tentò di dare alla sua narrativa una forma che almeno somigliasse a quella dei romanzieri più convenzionali. Jane Eyre (1847), il primo romanzo da lei pubblicato e quello che la rese famosa in vita, la rivela come una scrittrice che trae
materia per la sua opera dalle proprie passioni, dai propri sogni, dalle proprie delusioni. Si può dire che alcune parti del libro siano una vera e propria autobiografia, altre rappresentano quel genere di appagamento del desiderio che poche donne vittoriane ebbero la capacità o il coraggio
LE SORELLE BRONTË LA VOCE NELLA BRUGHIERA
46
di trasferire nella narrativa. Talvolta il romanzo è assurdo, ma dal principio alla fine è condotto con vero e proprio vigore. Ma quando si legge Wuthering Heights, di Emily Brontë, si ha la sensazione di un’opera assolutamente grandiosa nella quale il mondo amorale di una truce vicenda simbolica, viene collocato nello Yorkshire, regione ben familiare all’autrice, il desolato Yorkshire dalle più remote brughiere. Il paesaggio è adattato così abilmente alla rappresentazione delle passioni umane che quasi le rende inevitabili, e durante la lettura non si avverte alcuna frattura tra gli aspetti realistici del romanzo e quelli fantastici e simbolici. Lo stile è sicuro e incisivo e l’azione si svolge attraverso abili interventi di narratori che fanno da intermediari, così da mettere in risalto sia la singolarità, sia la forza di questa vicenda strana e avvincente. Non c’è niente di simile a Wuthering Heights in quasiasi altro periodo della letteratura inglese. E’ l’opera di una scrittrice che si ritrasse deliberatamente da ogni contatto umano e visse tutta la sua breve vita in un mondo suo personale di passione fantastica . Anche Charlotte, in una certa misura, condusse lo stesso genere di vita, ma ella tentò di venire a patti col mondo esterno, di cui subì le ferite e
in cui cercò conforto, e questa concessione nei confronti della società si rispecchia nei temi e nella struttura dei suoi romanzi. Tuttavia la validità della sua opera, come di quella di Emily, proviene dal lavorio di un’immaginazione solitaria. In quanto ad Emily, niente le viene dall’esterno e il suo unico straordinario romanzo rappresenta il solo sorprendente esempio nella prosa inglese di un sentimento fittizio che crea il suo correlativo- oggettivo solo per mezzo della forza e della convinzione con cui viene espresso. Anne, la minore della famiglia, di carattere introverso come le sorelle, non ebbe la stessa fantasia di Charlotte ed Emily. Il suo romanzo Agnes Grey è il meno dotato dei tre romanzi. Ha un indubbio fascino che innanzitutto scaturisce dallo stile asciutto di Anne, lineare, senza orpelli, essenziale. In questo minimalismo navigano parole perfettamente pesate, ognuna delle quali ha significati molto profondi, sempre in bilico tra terra e cielo, tra disperazione e salvezza. Non c’è la passione travolgente di Jane Eyre, né quell’epopea tragica di Wuthering Heights. Ma Agnes Grey sa essere estremamente rivoluzionario: quale romanzo ottocentesco ci racconta di una donna lavoratrice che a tutti i costi vuole affermarsi, sacrificando ogni cosa, fonda una propria scuola e che decide di trovarsi un compagno. Ma solo per amore?. Volendo, in Agnes Grey, ci sono tutti i presupposti per un racconto femminile e femminista, oltre che per un’analisi intramontabile dell’Educazione.
Silvana Canevelli
47
Gli Stati Uniti abbandonarono la neutralità nel secondo conflitto mondiale, imposta da gran parte dell’opinione pubblica, all’indomani del proditorio attacco sferrato dal Giappone nell’Oceano Pacifico nel dicembre del 1941; circa due settimane dopo quella fatidica data, si teneva a Hollywood la prima riunione del Comitato per la vittoria; l’obiettivo primario che questa organizzazione, fondata il 10 dicembre 1941, a soli tre giorni di distanza da Pearl Harbor, si prefiggeva era quello di permettere agli artisti di ogni ambito, di dare il proprio contributo allo sforzo bellico, anche senza un’effettiva partecipazione in campo militare. A capo della divisione degli attori, era stato nominato Clark Gable, in quel tempo divo per eccellenza e figura assai simbolica del movimento patriottico. Allo stesso modo, a capo della divisione degli attori afroamericani, fu posta Hattie McDaniel, la prima attrice di colore a vincere un Oscar per il film Via col vento.
Un aspetto fondamentale che caratterizzò l’attività del comitato fu la raccolta di fondi. Il programma di difesa necessitava infatti di un finanziamento notevole, anche maggiore di quello relativo alla prima guerra mondiale, data la lunghezza prevista delle operazioni e la quantità di spese a cui si doveva far fronte.I titoli emessi sotto la presidenza di Franklin Roosevelt, erano prestiti volontari da parte di privati cittadini che assicuravano un rapido ritorno di liquidità al governo e accrescevano il senso di partecipazione degli americani ad un conflitto al quale, negli
anni precedenti, avevano guardato da semplici spettatori. Come era accaduto tra il 1914 e il 1918 con le celebrità del cinema muto come Mary Pickford, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, anche negli anni quaranta attori del calibro di Irene Dunne, Greer Garson, Ronald Colman, Hedi Lamaar, Marlene Dietrich,fra gli altri, prestarono il proprio volto e il proprio tempo alla campagna di vendita dei titoli.Uno dei progetti di maggior
successo fu l’organizzazione, nella primavera del 1942, dell’“Hollywood Victory Caravan”, un tour in treno di due settimane che toccò 12 città statunitensi e che coinvolse in spettacoli di vario genere attori e attrici tra i quali Laurel e Hardy, Cary Grant, Bob Hope, Claudett Colbert, Bing Crosby. Nel gennaio precedente un evento tragico aveva funestato tuttavia il normale corso delle attività.
Carole Lombard era considerata da tutti la regina di Hollywood perché di Hollywood ne aveva sposato il re, lo stesso Gable, ma soprattutto era una persona affabile ed estrosa che aveva conquistato i colleghi e tutti gli spettatori, che ne apprezzavano tanto la bravura nel ruolo di attrice comica, la migliore degli anni Trenta, quanto la spumeggiante personalità.Assieme al marito aveva scritto una lettera al presidente americano per offrire la propria attiva disponibilità e perciò divenne un punto di riferimento per il neonato Comitato; il destino crudele volle che fosse il consorte a prendere la decisione di farla partire per un viaggio nello stato dell’Indiana, di cui era originaria, per la vendita dei titoli.
Hollywoode la seconda guerra mondiale
48
Non tornò mai poiché morì in un tremendo incidente aereo proprio nel volo che la riconduceva a casa lasciando distrutto il grande attore e affranti tutti i colleghi. Riuscì tuttavia a guadagnare oltre due milioni di dollari alla causa e la profezia che fece nella sua ultima apparizione pubblica, con le braccia alzate a formare una V di vittoria che, sebbene dopo un’attesa lunga tre anni divenne realtà. Un giusto riconoscimento, dopo la medaglia postuma come “prima donna a morire in battaglia” e il suo nome inciso su una delle navi Liberty, per una donna generosa a cui anche Roosevelt rese omaggio definendola “una stella che non dimenticheremo mai e a cui non smetteremo mai di essere grati”.
Nel corso della guerra 85 milioni di amer-icani comprarono titoli per un totale superiore ai 180 miliardi di dollari. Clark Gable non si riprese per molto tempo dallo shock per la perdita del-la moglie e decise di impegnarsi per celebrarla con un ruolo più attivo nel conflitto arruolando-si ed iniziando una serie di missioni aeree in Eu-ropa sotto la costante minaccia di un possibile rapimento ordinato dal Fuhrer. Non fu l’unico attore dinamicamente presente nel conflitto,altri come James Stewart, Tyrone Power, Henry Fon-da si mobilitarono in tal senso.Oltre alla vendita dei titoli, il comitato si occupava anche dell’in-trattenimento dei soldati al fronte o di quelli ri-coverati, con l’allestimento di spettacoli gratuiti. Un’altra iniziativa di estremo valore fu quella che prese l’avvio grazie all’intraprendenza di Bette Davis e John Garfield: il 3 agosto del 1942 venne inaugurato l’“Hollywood Canteen”, un locale dove i soldati destinati al fronte potevano trovare gra-tuitamente l’intrattenimento dei divi più celebri, che si prestavano alle mansioni di cuochi, cameri-eri, firmavano autografi, mentre le dive regalavano anche balli e distribuivano baci. La divisa divenne il biglietto d’ingresso, quasi tutti gli attori più fa-mosi presero parte a queste attività da Fred Astair a GingerRogers, da Ava Gardner a Shirley Tem-
ple da Barbara Stanwych a Judy Garland, da Louis Armstrong a tanti altri.
Mentre l’Europa stava attraversando la sua stagione di notte e nebbie, alcuni tra i suoi artisti più importanti erano già fuggiti nella Mecca californiana del cinema, molti per frapporre lo spazio di un oceano tra se stessi e la dominazione nazista, altri più semplicemente per trovare fortuna e gloria o consacrare quella già ottenuta in patria. Durante il conflitto tutti cercarono di dare il proprio contributo all’unica causa che ritenevano indispensabile per il futuro dell’umanità; chi era fuggito preventivamente, chi era venuto a contatto con il fanatismo, chi sentiva il desiderio profondo di aiutare la madrepatria. Alcune storie più di altre hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo del tempo e meritano di essere ricordate. Marlene Dietrich era nata nella Berlino, futura innovativa capitale del cinema espressionista, e quando, nel 1930, lasciò la sua terra, all’indomani del clamoroso successo del film L’angelo azzurro per raggiungere Hollywood, Hitler non era ancora salito al potere, ma il suo partito stava prepotentemente guadagnando consensi. Nel 1933, mentre l’attrice diventava la diva per antonomasia del cinema americano, la situazione virò al peggio. L’intenzione del Fuhrer, che conosceva la forza propagandistica della settima arte, fu sin da subito quella di riportare Marlene in patria per trasformarla nella
49
regina della Germania nazista. Lei non accettò mai, manifestando a più riprese il disprezzo nei confronti del dittatore. Dapprima si impegnò ad aiutare coloro che fuggivano dal regime, poi una volta divenuta nel 1939 cittadina americana, allo scoppio del conflitto,partecipò a tutte le iniziative del Comitato, tenendo spettacoli al seguito delle truppe in Africa e in Europa in rigorosa divisa militare, affrontando condizioni proibitive con il rischio di essere catturata dal nemico e visitando i feriti negli ospedali.
Fu lei a rendere leggendaria la canzone pacifista e trasversale “Lili Marleen”, ma dovette sopportare l’affronto, per colpa del nazismo, di non essere mai più perdonata da una parte del popolo tedesco.Hedy Lamarr era invece nata in Austria da una famiglia borghese con origini ebraiche; nel 1933, da giovanissima, divenne molto famosa per un film Estasi che fece clamore per la sua audacia, poi si sposò con un imprenditore nel settore dell’armamento, che veniva definito il “mercante di morte” per la sua predisposizione a collaborare con i regimi fascisti. Al suo fianco, Hedy venne a contatto con figure importanti dei più svariati campi ed ebbe persino la possibilità di conoscere Mussolini ed Hitler in persona, ma lei odiava quelle dittature e ben presto fuggì dalla prigione dorata che il marito le aveva costruito attorno. Giunta ad Hollywood riprese la carriera di attrice diventando in breve tempo la nuova stella, grazie soprattutto alla straordinaria bellezza. Non è stata però questa la qualità che l’ha resa ancora oggi
celebre, bensì un’intelligenza fuori dal comune. Dopo l’inizio delle ostilità si dedicò alle attività di raccolta fondi con risultati notevoli, viaggiando da un capo all’altro della nazione, firmando autografi, distribuendo baci, ma fu nel 1941 che ebbe l’intuizione che avrebbe dovuto, nei suoi propositi, cambiare repentinamente le sorti del conflitto: assieme al compositore avanguardista George Antheil brevettò un sistema segreto di guida radiocomandata dei siluri. Purtroppo l’idea risultò essere troppo innovativa per i mezzi tecnologici a disposizione all’epoca e l’attrice dovette accontentarsi di un contributo legato maggiormente al suo fascino che alla sua mente, ma col tempo giunsero anche i riconoscimenti, a tal punto che i moderni telefoni cellulari e i sistemi “wireless” funzionano grazie a quella lontana idea di una tra le intelligenze più sottovalutate del cinema.
David Niven e Leslie Howard, attori inglesi, per amore della terra d’origine, collaborarono alacremente alla sua difesa; il primo prestando servizio nell’esercito con il grado di colonnello e partecipando allo sbarco in Normandia, ma soprattutto usando le sue capacità per lavorare come agente segreto nel servizio informazioni dell’esercito. Il secondo legando il suo nomead una storia controversa che, anche nel presente, non ha trovato una risposta certa. Dopo la fama ottenuta in Via col vento e in altri film hollywoodiani, allo scoppio della guerra, rientrò in patria per dirigere ed interpretare una serie di film propagandistici; si impegnò in molte trasmissioni radiofoniche della BBC e in conferenze in favore degli alleati. Al ritorno da uno di questi incontri dal Portogallo, morì misteriosamente in un incidente aereo nel golfo di Biscaglia.Il mezzo su cui viaggiava fu intercettato e abbattuto da una squadriglia di “Junkers” tedeschi, ma i motivi di tale azione, che procurò l’inabissamento del velivolo, sono sempre stati dibattuti senza giungere ad una spiegazione: I tedeschi scambiarono il suo aereo per quello su
50
cui viaggiava Churchill data la somiglianza del suo impresario con il politico inglese? L’attore era in realtà a servizio dell’intelligence inglese e quelle conferenze in giro per l’Europa solo una copertura per missioni diplomatiche? O più semplicemente l’attività antinazista di Howard giocò un ruolo decisivo nel rancore provato dai tedeschi e quell’evento ne rappresentava l’estrema punizione?
Anche l’industria cinematografica vera e propria, quella cioè che riguardava la realizzazione dei film, risentì inevitabilmente degli avvenimenti storici in atto.
Dopo l’iniziale indifferenza, che portò, sino al 1940, le grandi case, gli studios come MGM e Paramount, ad accettare le inique regole di censura dei nazisti riguardo la cancellazione dai cartelloni e dai titoli dei nomi ebraici per continuare a distribuire i propri film in Germania, vennero prodotti numerosi film antinazisti che ebbero anche ottimi riscontri in termine di pubblico.
Accanto ai titoli che celebravano battaglie ed eroi a stelle e strisce o eventi realmente accaduti in territorio europeo, si affiancavano i film satirici e di propaganda.
I primi videro tra i registi più efficaci Charlie Chaplin, inglese, con il suo immortale e dissacratorio Il grande dittatore girato, in ogni caso, prima dell’ingresso statunitense nel conflitto, non amato da Roosevelt, nonché proibito in Europa, seguito da Ernest Lubitsch con Vogliamo vivere del 1942, altra satira sbeffeggiante allestita grazie al sapiente tocco di un regista tedesco, trapiantato in America sull’onda del successo, e che, nel tempo, si era adoperato per aiutare in ogni modo i compatrioti esuli fuggiti dalla morsa di Hitler.
Tra i film propagandistici, si possono ricordare, Casablanca che, oltre ad una trama fondata su una struggente
storia d’amore tra i due protagonisti interpretati da Humphrey Bogart ed Ingrid Bergman, ad una canzone rimasta memorabile, si caratterizzò per la presenza di tantissimi attori fuggiti dall’Europa, dove erano famosi, calati in ruoli da comparse e per una scena altamente evocativa di un canto nazista sovrastato dall’esecuzione trionfante della Marsigliese.
La signora Miniver film americano ambientato in Inghilterra, girato da William Wyler nel 1942 che, con un abile combinazione di accettazione del dolore e risoluto orgoglio britannico, riuscì a suscitare sentimenti talmente forti di immedesimazione negli spettatori, da fare invidia persino allo spietato ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels e da indurre Winston Churchill a far stampare il discorso finale del film in migliaia di copie.
I migliori registi hollywoodiani tra cui John Ford, lo stesso Wyler, Frank Capra, George Stevens, John Huston si attivarono inoltre per mettere la propria arte al servizio dell’esercito, seguendo le truppe o realizzando film-documentari per mostrare a tutti la cruda realtà della guerra; molti dei filmati girati dal vivo divennero poi elementi probanti delle nefandezze naziste durante il processo di Norimberga.
Nicoletta Spinozzi
51
La battaglia di Waterloo si svolse il 18 giugno 1815 tra l’esercito francese, guidato da Napoleone Buonaparte, e le truppe prussiane, condotte dal maresciallo Gebhard Leberecht von Bluecher, alleate con l’esercito del Duca di Wellington. Fu l’ultima battaglia, che sancì la definitiva sconfitta di Napoleone, alla quale sarebbe seguito l’esilio di Sant’Elena.
Lo scontro iniziò all’una del pomeriggio, quando il Corpo d’Armata dell’esercito francese era pronto a sferrare l’attacco contro Mont Saint -Jean. Di fronte, in quel momento, si mostrarono ben trentamila soldati prussiani, guidati dal maresciallo von Bluecher.
Ogni divisione di Napoleone muoveva con otto battaglioni, posizionati uno dietro l’altro: una formazione non molto efficace, perché potevano sparare unicamente duecento uomini, quelli della prima fila del primo battaglione. Tra le fila inglesi, invece, i battaglioni erano collocati uno di fianco all’altro, con due linee di fucilieri: in questo modo i fanti britannici riuscivano a sparare senza problemi, così che sui francesi il fuoco provenisse da più parti. Sui battaglioni francesi, infatti, si abbatté una bufera di proiettili. Benché la potente artiglieria francese avrebbe avuto la possibilità di causare perdite alle file dei fucilieri di Wellington, lunghe, ma sottili, tale evento non si verificò, perché i britannici si erano schierati dietro il crinale della collina, così da non essere visti dalle batterie avversarie. Uscirono allo scoperto unicamente nel momento in cui i francesi si trovarono a un paio di centinaia
di metri, ossia a un tiro di fucile. Le colonne di Napoleone, già ridotte per i molti feriti e morti, non riuscirono a mantenersi compatte, anche perché composte soprattutto da giovani coscritti privi di esperienza, o da uomini troppo anziani e, quindi, non dotati della necessaria forza fisica, che sarebbe servita per condurre una battaglia con buoni risultati.
Le truppe napoleoniche si fecero prendere dal panico e subirono la carica della brigata di Ponsonby, cui seguì poco dopo quella della cavalleria di Somerset. Sugli sprovveduti francesi si avventarono anche gli Scots Greys ( denominati così a causa del colore dei loro cavalli), che tuttavia si spinsero più in là di quanto fosse necessario: un eccesso che provocò la morte di almeno metà di loro.
Tra le quattro e le cinque del pomeriggio si verificò un fatto, che decise in maniera definitiva le sorti della battaglia: il
maresciallo Ney commise un gravissimo errore. Un arretramento inglese gli sembrò un segnale di ritirata: in realtà quelli che stavano abbandonando il campo di battaglia erano solo i soldati feriti, che venivano raccolti dai carri.
Pertanto il maresciallo Ney si lanciò all’assalto con cinquemila tra corazzieri, cacciatori
e lancieri francesi. L’impeto dei francesi fu accompagnato da una enorme ovazione, ma, quando il resto della cavalleria francese si scagliò contro gli inglesi, si ebbe coscienza della fine. Gli uomini di Wellington si schierarono in quadrati per respingere gli assalti, in modo tale che la fila più esterna di ciascun quadrato fosse formata da uomini in ginocchio con il calcio del fucile ben
LA BATTAGLIA DI WATERLOOPose fine alle guerre di Napoleone
Napoleone
Il duca di Wellington
52
piantato a terra, così da sventrare i cavalli. E intanto dalle file più interne si sparava contro gli uomini.
Fu proprio grazie a questo posizionamento strategico che la fanteria britannica riuscì a difendersi dalla cavalleria avversaria, anche perché i cavalli si rifiutavano di calpestare gli uomini. Così i cavalieri non poterono puntare direttamente contro i nemici e furono costretti a galoppare intorno agli inglesi sparando con le pistole.
Subentrò la cavalleria britannica di Uxbridge, che riconquistò la maggior parte dell’artiglieria, che era finita in mano ai francesi e che non era stata ancora messa fuori uso. Tuttavia Napoleone non si considerò fuori gioco, perché poteva contare ancora su una decina di battaglioni di Granatieri della Guardia, che facevano parte della riserva strategica e che erano composti da veterani molto esperti.
Ma la tragica fine era in agguato: Napoleone e i suoi uomini giunsero a poco più di seicento metri dalle linee nemiche, mentre i fucilieri e gli artiglieri inglesi li aspettavano, nascosti nel grano. Mentre l’Armata francese esitò per qualche istante, Wellington lanciò il proprio cappello in aria: un segnale che venne raccolto da quarantamila inglesi, che si precipitarono nella pianura, dove si trovavano i francesi, che furono dispersi e uccisi.
Il termine Waterloo è entrato addirittura nel linguaggio comune come sinonimo di clamorosa sconfitta. Infatti fu l’ultima battaglia di Napoleone, che fu fatto prigioniero e confinato nell’esilio di Sant’Elena.
Si dice anche che gli inglesi, non del tutto tranquilli per quali sorprese potesse riservare Napoleone, che era già fuggito dalla prigionia dell’isola d’Elba, lo abbiano avvelenato a poco a poco. O mettendo il veleno nelle bevande con l’aiuto di domestici infedeli o addirittura impregnando le tappezzerie della stanza in cui dormiva, in modo che il prigioniero assorbisse il veleno durante il respiro notturno. Di questo avvelenamento sembra che sia rimasta traccia nei capelli.
Resta da ricordare la celebre poesia di Alessandro Manzoni, intitolata” Il Cinque Maggio”, giorno della morte di Napoleone, che morì a Sant’Elena il 5 maggio del 1821.
“Ei fu”. Così comincia l’ode del Manzoni, che si preoccupa di precisare di non aver mai scritto versi in lode di Napoleone, quando l’imperatore era al massimo della potenza:“ lui folgorante in solio/ vide il mio genio e tacque.Sorge or commosso al sùbito /sparir di tanto raggioe scioglie all’urna un cantico/ che forse non morrà.
Clara Rubbi
53
La storia La formazione della Genova urbanistica e
demografica di oggi è il frutto di due importanti aggregazioni: quella del 1874 con l’annessione dei sei comuni della Val Bisagno e Levante e, soprattutto, quella del 1926 con la costituzione della “Grande Genova”, fino ad arrivare, negli anni trenta, a superare i seicentomila residenti. Già nel censimento del 1931 emergeva una città a forte composizione di famiglie operaie concentrate negli ex comuni annessi, mentre nei sestieri storici risiedevano le famiglie più agiate. Si delinea così quella situazione sociale che negli anni sessanta Luciano Cavalli definiva “citta divisa”: il centro/levante abitato da impiegati e ceti professionali, il ponente, la Valpolcevera e la Val Bisagno abitato dai ceti popolari. Queste caratteristiche abitative verranno “istituzionalizzate” con le costruzioni dell’edilizia popolare (quartieri INA case) e con la disordinata e caotica urbanizzazione delle colline: nomi come “Il Biscione”, “Le Lavatrici”, “Il Cep”, “La Diga”, sono l’espressione di quel particolare contesto storico, poco attento alla sostenibilità ambientale. Un caso a parte è rappresentato dall’esperienza urbanistica di Sestri Ponente che durante l’amministrazione dell’ing. Carlo Canepa (1903-1922) riesce a dotare il Comune di complessi residenziali operai in pieno centro (via Caterina Rossi, nel viale chiamato delle palme) con caratteristiche di elevato pregio decorativo, apprezzate dai residenti. La storia di Voltri, Sestri
Ponente e Sampierdarena era visibilmente dominata dalla cantieristica navale e dall’elettromeccanica e portava nomi che rimarranno nella memoria dei genovesi, come il “Cantiere” o il “Meccanico”. Il 1933 rappresenta una data simbolo per la città: nasce l’IRI che incorpora a Genova le sue principali
imprese. Molti anni dopo, nel 1956, la costituzione del Ministero delle partecipazioni statali vede, non a caso, tra i suoi principali esponenti, un illustre parlamentare genovese, Giorgio Bo (1905-1990). Tutti i processi d’innovazione tecnologica e organizzativa si sviluppano all’interno del tessuto produttivo storico; da Ansaldo, San Giorgio e Italsider nascono, rispettivamente, l’elettronica e l’automazione industriale (il primo nucleo biomedicale nasce come Divisione Ansaldo), l’ICT (Information and Communication Technology) e l’impiantistica. Le partecipazioni statali, nel bene e nel male, accompagneranno la storia produttiva e culturale genovese fino a metà degli anni Ottanta quando si avvierà l’inesorabile declino.
GENOVA : DA CITTÀ INDUSTRIALE E PORTUALE
A CITTÀ ANCHE TURISTICA
54
La città delle grandi famiglie. Sull’altro versante, dell’alta società,
abbiamo le caratteristiche ville con parco costruite dall’antica oligarchia nobiliare e dalla borghesia mercantile: da Villa Duchessa di Galliera a Voltri alle ville di Sampierdarena e di Nervi e alle tante ville diffuse nelle zone interne. La memoria dei grandi benefattori provenienti da queste famiglie è tuttora visibile anche nelle statue collocate lungo i viali dell’Ospedale San Martino o nell’Albergo dei Poveri. Il periodo più esaltante della storia genovese venne definito “el siglo de oro de los genoveses” tra il 1550 e il 1640, che sedusse il famoso pittore fiammingo Paul Rubens e fu oggetto dell’indovinata mostra del 1999/2000, come lo era stata quella di due anni prima sul periodo di Anton Van Dyck (1621-27) a Genova. Ancora nel 1857 durante l’inaugurazione della “Società ligure di storia patria”, Vincenzo Ricci (1804-1868), più volte ministro del Regno di Sardegna, esaltava il passato della città facendo il confronto con altre capitali europee “quando Parigi e Londra erano umili borghi coperti di paglia e fabbricati di rozze tavole”. L’immagine di tale splendore è rappresentato dai “Palazzi dei Rolli” e dalle vie delle “Strade nuove” (via Garibaldi, via Luccoli, via Balbi) costruite tra il XVI e XVII secolo e dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Il Castello Raggio. Ancora oggi tra gli anziani di Cornigliano
permangono i ricordi di un borgo balneare che aveva al suo centro il Castello Raggio: tra memorie di acciaio e nostalgia del mare, recita il titolo di un mio video documentario visibile su Youtube. Nel 1892, alle celebrazioni del IV centenario delle Colombiane, esso ospitò i Reali Umberto I e Margherita di Savoia. Durante la Conferenza Economica Internazionale del 1922 venne messo a disposizione della delegazione italiana capeggiata
dal Presidente del Consiglio, Luigi Facta, e fu luogo riservato a importanti incontri diplomatici. Agli inizi degli anni ’50 la SIAC chiede la concessione di tutta l’area e il 14 aprile 1951 il Castello Raggio fu demolito per la costruzione dello stabilimento siderurgico Oscar Sinigaglia.
Il mutamento industriale e il porto. Negli anni ’80 avvennero processi
inversi: abbattimento dei manufatti industriali e trasformazione in centri commerciali o comunque del terziario. I casi più eclatanti sono quelli del “Meccanico” di Sampierdarena diventato “Centro Fiumara”; l’area deIl’Italsider di Campi bonificata e convertita in centro polifunzionale (rimane soltanto una gigantesca pressa collocata in piazza); la chiusura dell’area a caldo dell’Ilva (sollecitata dalle proteste della popolazione residente, in particolare femminile) e conseguente risanamento ambientale; la dismissione delle raffinerie e dei serbatoi Erg a Bolzaneto (Area San Biagio) sostituiti da un centro commerciale e da moderni insediamenti abitativi.
In centro, a Piccapietra, avviene la chiusura/smembramento dell’Italimpianti e il cambiamento d’uso di due centri direzionali (in piazza Carignano dall’Ansaldo alla sede dell’Agenzia delle entrate, in via Corsica dall’Italsider a un hotel a cinque
55
stelle). Nell’area portuale assistiamo alla privatizzazione delle banchine, alla nascita dei terminalisti, e al nuovo porto di Pra/Voltri. La ristrutturazione e privatizzazione delle aziende Finmeccana si conclude col cambiamento del nome in “Leonardo”, mentre Ansaldo Energia va ai cinesi di “Shanghai Electric” e Ansaldo Sts – segnalamento ferroviario - ai giapponesi di Hitachi. Rimane nella società “Leonardo spa” soltanto l’ex Elsag di Sestri Ponente. La Fincantieri, invece, ha conquistato la leadership internazionale sul segmento “navi da crociera” e verrà valorizzata la sua presenza a Genova (cantiere di Sestri Ponente e Direzione navi militari) e in Liguria (Riva Trigoso e Muggiano).
Sul versante marittimo portuale, nonostante la lunga crisi economica, il porto prosegue la crescita e il 2016 si chiude con oltre due milioni e duecentomila Teu di container movimentati e con oltre tre milioni di passeggeri trasportati (un milione nelle crociere e due milioni nei traghetti). Infine, dopo decenni di discussione sulla necessità di aggregare i porti, nell’agosto del 2016 è approvata la legge istitutiva dei “Sistemi portuali”, nel nostro caso riguarda la costituzione dell’Autorità di “Sistema portuale del Mar ligure occidentale” che comprende il porto di Genova e quello di Savona/Vado ligure.
La popolazione Il nuovo millennio a Genova si apre, secondo
i dati del censimento del 2001, con 223.287 persone occupate, di cui gli operai sono ridotti al 27% e l’industria occupa 34.092 addetti pari al 15%. Il livello di scolarità della gente che lavora è piuttosto elevato: la maggioranza è costituita da diplomati e laureati, mentre abbiamo una notevole presenza di
impiegati pubblici. L’andamento della popolazione prosegue il declino: i residenti al 31/12/2016 sono scesi a 584.550 con una diminuzione di 22.553 unità rispetto al 2011. L’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione in età 65 ed oltre e quella in età inferiore a 15 anni) continua ad aumentare. Anche i matrimoni sono diminuiti e di questi soltanto il 30% si è svolto col rito religioso, il che dimostra il forte processo di secolarizzazione che caratterizza le giovani coppie. L’età media degli sposi rimane piuttosto elevata (41 anni per l’uomo e di oltre 37 anni per le donne) ed esprime la tendenza a rimandare nel tempo le scelte personali più impegnative. Riguardo agli immigrati sembrano stabilizzarsi intorno alle cinquantacinquemila unità pari al 9,4% dei residenti. Dalla suddivisione per nazionalità risultano in maggioranza i latinoamericani (oltre 18 mila di cui 14.146 provengono dall’Ecuador), seguiti dagli albanesi (con quasi seimila persone), in terza posizione troviamo i romeni con oltre cinquemila unità e poi i marocchini che invece negli anni novanta costituivano la prima comunità straniera. Rispetto al genere le donne prevalgono nettamente sugli uomini tra gli ecuadoriani, i romeni, i peruviani e soprattutto tra gli ucraini . Le attività lavorative prevalenti riguardano, per le donne, l’assistenza alle famiglie (colf e badanti), per gli uomini, l’edilizia. Pur essendo difficile
56
quantificare con precisione il numero delle lavoratrici domestiche, possiamo senz’altro affermare che esse superano i gloriosi metalmeccanici!
Genova 2004, la cultura e il turismo Il 2004 è stato il momento più alto di
riappropriazione del valore storico-culturale della città da parte dei suoi abitanti, che la mostrano con orgoglio a parenti e amici che vengono a visitarla. La nomina di Genova a “capitale europea della cultura” è stata il frutto di un lungo lavoro di rinnovamento urbanistico che ha saputo utilizzare i finanziamenti derivanti dall’anniversario più significativo della sua storia - le Colombiane del 1992 - poi i fondi europei (Urban 1 e 2) e la stessa celebrazione del G8 del 2001. Il collegamento del centro col vecchio porto (pedonalizzazione di via San Lorenzo) e l’intervento progettuale di Renzo Piano, riallacciano un legame con il mare che nel corso degli anni si era perso. La scelta del tema del “viaggio”, sia in senso fisico che metaforico, quale simbolo di Genova 2004, aveva infatti riscosso il consenso dei cittadini che avevano risposto a un questionario distribuito per individuare il filo conduttore dell’evento. La vivacità della partecipazione è dimostrata dagli oltre mille progetti presentati, mentre nella gestione dell’intero anno
viene privilegiato l’investimento in opere durevoli e nella qualificazione dei beni culturali esistenti, superando la tendenza, forte in questi casi, della sola programmazione di grandi eventi. Per la prima volta, in maniera organizzata, la città si attrezza per comunicare col mondo e oggi si vedono i risultati con la presenza dei turisti. L’azione successiva di “Palazzo Ducale Fondazione per la cultura”, ha ulteriormente qualificato l’offerta culturale che è diventata una componente significativa dello sviluppo della città.
Il futuro Il futuro dello sviluppo socio economico di
Genova appare ormai centrato su tre grandi direttrici: l’economia del mare e del porto, l’economia dell’alta tecnologia industriale, l’economia della cultura e del turismo. Ciò presuppone un cambiamento di mentalità che dovrà sempre di più poggiare sulle proprie risorse vocazionali e sulla capacità di attrarre risorse esterne, senza nessuna rendita di posizione (come si pensava nel passato). Ogni risultato va conquistato giorno per giorno perché tutte le grandi metropoli si pongono obiettivi analoghi e quindi sono in competizione.
Salvatore Vento
57
Roma: una corona tempestata di pietre preziose, ogni gemma un monumento o un’opera d’arte. Tra le pietre più splendenti sicuramente i Musei Vaticani, custodi di tesori inestimabili. Il loro percorso, di oltre sette chilometri, racconta, attraverso testimonianze musive, scultoree e pittoriche, la storia della civiltà dall’Antico Egitto ai giorni nostri, passando attraverso momenti “forti”, culturalmente parlando, come il Rinascimento. Il centro ideale di questo percorso è la Cappella Sistina, affrescata da Michelangelo: ogni giorno migliaia di visitatori la ammirano, affascinati dai suoi affreschi brillanti e dalle sue figure plastiche che, diverse una dall’altra, lasciano trasparire carattere e dignità propri.
Le stanze e i corridoi dei Musei hanno ognuna il proprio tema conduttore. Una delle prime stupefacenti - e forse meno note - tappe di questa cittadella dell’arte è il Museo Gregoriano Egizio, voluto da Papa Gregorio XVI nel 1839 per esporre al pubblico i manufatti egizi di proprietà della Chiesa. Descriverlo per intero sarebbe impossibile, ma alcuni suoi aspetti meritano di essere condivisi.
Due alte e robuste colonne con fiori
di loto scolpite sui capitelli ci introducono nella terra dei Faraoni. La luce è soffusa, come si addice al regno dell’oltretomba, la delicata stele funeraria a “falsa porta” di Iry, ci parla subito di un’amministratore della necropoli di Giza, vissuto nel 2000 a.C. La sua memoria ha superato millenni e i geroglifici che ne hanno immortalato nella pietra il nome lo continuano a ricordare, accanto a testimonianze di Faraoni e regine, come per sottolineare
il fatto che la Storia è fatta anche di uomini comuni, come l’amministratore di una necropoli.
Emozione e reverenza ci accompagnano nella seconda sala dove, accanto a un raffinato sarcofago ligneo dipinto (1000 a.C.), riposa una piccola mummia femminile, ancora parzialmente
MUSEO GREGORIANO EGIZIO
58
avvolta nelle sue originali bende di lino proveniente da Tebe, il famoso sito archeologico situato tra Luxor e Karnak. Attraverso le esposizioni nelle bacheche sono illustrati la mummificazione e il rito della sepoltura: manufatti !ignei, pezzi di arredamento, gioielli, ushabti (statue di piccole e medie dimensioni che avevano la funzione di compagni del defunto nel Regno dei Morti, con il compito di lavorare per lui, se necessario) e vasi canopi (i contenitori degli organi prelevati dal defunto per la mummificazione). Dopo l’attenta lettura delle spiegazioni, ci scopriamo a riguardare l’esile figura nel sarcofago con occhi nuovi: non più curiosità, magari venata da un sottile senso di raccapriccio o di morbosità, non più fredda attenzione scientifica bensì umana simpatia, dettata dalla consapevolezza che a unirci c’è l’inesorabile effimero destino umano e che a renderla un “pezzo da museo” è stato il profondo senso del sacro con cui uomini di migliaia di anni fa percepivano la morte, solenne passaggio dalla vita terrena alla vita nell’aldilà. Un nuovo capitolo, dunque, non
l’epilogo di un’esistenza.La particolarità di questo museo è avere creato
attraverso la sua esposizione un collegamento
ideale tra l’Antico Egitto degli Egizi e l’Antico Egitto dei Romani, che ne subivano il fascino esotico e quasi mitico. Tra i massimi estimatori ci fu l’imperatore Adriano. A sorpresa davanti al nostro sguardo si apre una sala che riproduce proprio il Serapeum della sua villa a Tivoli (tempio dedicato a Serapide, dio creato e adorato nell’Egitto ellenistico, successivo alla conquista di Alessandro Magno). E’ stata persino riprodotta la volta affrescata come cielo stellato: non si sa dove posare lo sguardo tanto tutto è sontuoso e siamo quasi intimoriti dalle statue a grandezza naturale in marmo bianco e marmo nero, tra le quali possiamo camminare. Le più suggestive, per dimensioni e caratterizzazione, sono il busto colossale in marmo bianco di lside/Demetra, che, su un alto supporto, domina l’intera sala e la statua a figura intera di Antinoo, il bellissimo favorito dell’imperatore Adriano, tragicamente annegato nel Nilo. Il giovane è rappresentato come il dio Osiride, il dio principale della religione egizia: la pastura ieratica e l’acconciatura ricordano i tratti scultorei egizi, ma la prestanza fisica resa con plasticità tradisce un gusto proprio dell’arte classica greco-romana. La contaminazione artistica è ancora più evidente nella statua del dio Anubi: il dio sciacallo, traghettatore dei defunti, indossa la toga romana. Una licenza scultorea, per così dire, che evidenzia il tentativo di convertire al gusto romano
59
anche una delle divinità più rappresentative del pantheon egizio. Impressionante per dimensioni ed espressività anche la personificazione del Nilo come dio fluviale: barba fluente, corpo atletico, adagiato tra un coccodrillo, una cornucopia e una piccola sfinge.
Torniamo nuovamente nell’Egitto più autentico, quello dei grandi Faraoni e dei loro temibili dei, metà uomini e metà animali. Anche la scenografia ha la sua importanza, come abbiamo visto. I capolavori della statuaria faraonica ci accolgono in una sala a emiciclo, contro una parete rosso scuro. Intimoriti dalle due statue da Sekhmet, dea della guerra, delle epidemie ma anche della guarigione, con il corpo di donna e volto leonino, proseguiamo l’esplorazione fino a fermarci davanti a due effigi regali, particolarmente significative. Una rappresenta la regina Tuya, madre del grande faraone Ramses Il. Secondo molti si tratta del pezzo più pregevole dell’intero Museo Gregoriano e proviene dal Ramesseum di Tebe. Realizzata in granito grigio scuro, è uno dei più tipici esempi di scultura egizia, connotata da solennità ieratica. Stesse caratteristiche si ritrovano in Tolomeo Filadelfo. I due sovrani egizi sono separati da circa mille anni ma la percezione del faraone/regina quale dio in terra rimane immutata, solo in
parte stemperata dalla scelta del materiale, granito rosso, anziché grigio.
E’ con reverenza e soggezione che ci congediamo da questo inestimabile museo: in esso le espressioni del sacro delle civiltà antiche ci regalano l’immagine di un mondo in cui, nonostante le guerre, anche efferate, si aveva il desiderio di accostarsi al divino, la saggezza di guardare alla morte senza paura, l’abilità di trovare nell’arte un
linguaggio per onorarla e per onorare uomini e donne che a vario titolo contribuirono a scrivere la storia, quella che ritroviamo anche nei papiri, sulle epigrafi, e incise sulle pareti delle piramidi. Una narrazione diventata Storia e leggenda.
Chiara Colella
60
Nei primi anni del Novecento in Europa si registrava un notevole sviluppo economico e industriale con particolare riguardo alla siderurgia, alla cantieristica e agli armamenti. I potentati europei erano sempre gli stessi del Congresso di Vienna· e della Restaurazione, teste coronate e lobbi plutocratiche; quelle che alimentavano il fuoco dei nazionalismi, delle invidie, dei rancori, delle vendette. Covava ovunque la brama della “revanche”.
Lo Zar, dopo le sberle in Crimea e nel Mar Giallo, anelava ai mari occidentali e sosteneva la Serbia come utile trampolino sull’Adriatico; quella Serbia bellicosa e arcigna che voleva unificare sotto le sue grinfie tutti gli slavi dei Balcani. Odio viscerale, dunque, per gli Asburgo che, proprio allora, conclusesi le guerricciole serbe nelle aree tra Egeo e Mar Nero, si annettevano la Bosnia Erzegovina. Di qui Sarajevo, l’ultimatum di Vienna, tardivo perché voleva sapere se l’attentatore serbo era un cane sciolto o un emissario governativo e, di converso, la Corte non si rallegrava alla prospettiva
di vedere la moglie morganatica dell’ucciso come nuova imperatrice. Di qui ancora la guerra austro-serba, l’intervento della Russia, della Germania contro la Russia e, tanto per gradire, la guerra della Francia avversa al Kaiser per Sedan e l’Alsazia Lorena e, infine, l’intervento degli Inglesi per i timori di una Germania sempre più forte in terra, in mare e nelle Colonie che a nessuno permetteva di toglierle loro di bocca.
Ecco dunque che nel giro di due mesi nel 1915 tutta l’Europa si trova a ferro e fuoco, in Occidente come in Oriente, tutti convinti di marciare con tamburi in testa a occupare il Paese nemico. Fidenti tutti in una guerra di movimento ma ben presto tutti consapevoli che quella era una guerra di posizione, di logoramento di uomini e mezzi, di orride trincee, con milioni di poveracci al massacro.
Negli anni si susseguono scontri epici: la Marna, Parigi salvata dai suoi tassisti, la Somme, Chemin de Dames, Ypres, Verdun che solo Petain riesce a
scongiurare, Tannenberg con eserciti russi distrutti, ma nulla cambia.
Passa il tempo in tali falcidie senza alcun esito, senza vinti o vincitori e con le nere prospettive si levano le accuse agli alti comandi, incapaci di trovare decisive soluzioni strategiche. Si diceva che non difettavano gli uomini ma i cervelli, che ogni suggerimento intelligente era odioso agli interlocutori, che i belligeranti avevano come generali delle teste di legno, che la cretineria era proporzionale al quadrato dell’età e al cubo del grado.
CAPORETTO 1917Crollo improvviso - Fulminea ripresa
61
Nel 1915 da noi vincono gli interventisti e l’Italia entra in guerra con studenti e professori a urlare per le strade e contadini a morire nelle trincee. Interventisti che col sangue pretendevano Trento, Trieste, la Dalmazia, il predominio in Adriatico, l’Albania, le Colonie e chissà quant’ altro. I neutralisti con Giolitti, i cattolici e i socialisti, più concreti, attenti alla trentennale Triplice Alleanza e consapevoli che con il Trattato di Londra l’Italia avrebbe cambiato casacca (anche allora). Pensavano che con una strizzata d’occhio a Cecco Beppe, avremmo avuto Trento e il Trentino senza colpo ferire. Il poco si conta. Ma sì; gli altri volevano l’olocausto. Dunque, la guerra. Il metodo, vecchio come il cucco, era quello delle spaliate con centinaia e migliaia di uomini falciati dalle mitragliatrici. Ben 11 spallate dal maggio 1915 al settembre 1917, condotte da Cadorna, un generale onesto, senza dubbio, inflessibile anche con se stesso, ma con tanti difetti come lo sprezzante autoritarismo, la scarsa preparazione, l’arroganza intermerata, la caparbia ostinazione, il rifiuto categorico di riconoscere gli errori! Unico risultato, la presa di Gorizia al prezzo del Carso, dell’Isonzo con fiumi di sangue e della “Strafexpedition” di Conrad per vendetta del tradimento, che per poco non scende in pianura.
Si giunge così al 1917 senza che l’ingegno non abbia saputo su ogni fronte trovare soluzioni, una delle quali viene, guarda caso, da Oriente: la rivoluzione bolscevica. Milioni di “mugik” gettano le armi e tornano a zappare. Il fronte orientale non esiste più e gli eserciti austro-tedeschi, disoccupati, vengono trasferiti sui fronti occidentali. Con più uomini e i mezzi rimasti gli scontri si fanno più aspri e sanguinosi nello
spasmodico sforzo di finire il conflitto. Ma invano; non si sa come. Mentre i popoli sono alla fame, tutto è alla consunzione e gli eserciti, sfiduciati, non hanno più spirito combattivo. E’ la crisi generale. Tuttavia, con i tedeschi sul nostro fronte (e c’è un tenente Rommel in un battaglione del Württenberg e un von Vitzleben in una divisione del Brandeburgo, entrambi fucilati da Hitler nel 1944) ci sono Krauss, Edelweiss, Schützen, Alpenjager. Un capo di stato maggiore prussiano, Kraft von Dellmensingen, escogita nuove strategie come la difesa elastica e l’attacco per infiltrazioni.
Studiato con cura il fronte della nostra II^ Armata, lo stratega trova un punto debole della difesa italiana tra l’alto Isonzo e la Bainsizza con una testa di ponte a Tolmino. Donde un formidabile attacco in una piccola area nella conca di Plezzo. E’ il 24 ottobre del ‘17, nottetempo. La pressione in un punto mirato provoca un rovinoso sfondamento a Caporetto che nessuno aveva mai pensato di provocare.
Cent’anni fa, come oggi lo ricordiamo, 51 divisioni austro-tedesche dilagano ovunque, aggirano, dissolvono e catturano truppe in rotta. Crolla l’intera IIA Armata e con essa tutte le altre: confusione totale, comandi che hanno perso i contatti, ordini, controdini, disordini: lo
62
schieramento delle nostre artiglierie tagliate a metà, ma sempre ben efficenti con un Badoglio che, nonostante il Corpo d’Armata ben dotato di bocche da fuoco di ogni calibro, che avrebbero potuto sbaragliare l’infiltrazione austro-tedesca nelle strettoie tra Plezzo e Tolmino, non apre il fuoco ma si rende latitante. È questa l’imputazione alla resa dei conti.
Tutto il fronte è nel caos; la rotta investe il Veneto che subisce saccheggi, depredazioni e violenze da sitibonde soldataglie. L’intera nazione, col governo in testa, si arrende alla sconfitta che grava come un’ombra funerea. Intanto la rotta non si ferma: arriva al Tagliamento e lo supera perché sulle sue sponde non è possibile creare un argine alla marea teutonica. Si scende fino al Piave e là ci si ferma vuoi perché il nemico, esaurita la sua spinta non ha più le forze per proseguire, vuoi perché il nostro esercito è allo sfascio ma non domo. Divisioni sbandate, squadernate, devono ricostituirsi. E’ lo sforzo terribile che il nuovo condottiero, Armando Diaz, e il Paese tutto, con le sue industrie e le risorse umane, deve compiere. Tra tanta desolazione, ecco infatti accadere una miracolosa,
sorprendente ripresa. Altre armi, altre divise, altri reparti da truppe raccogliticce, altro spirito, come una nuova ventata. Si ricostituiscono le Armate, si riprende decisi la lotta. Ora è il nemico a essere sfiduciato, senza speranza, Notevole il contributo della nuova leva, quella dei “ragazzi del 99”, e lo spostamento di alcune divisioni anglo-francesi dal fronte occidentale. Arrivano anche modesti contingenti americani che, digiuni di arte bellica, non esercitano una decisa influenza
al fronte ma un notevole effetto psicologico sul nemico, colpito dall’intervento americano.
Spronato dagli Imperi Centrali al collasso, il nemico prova ancora di attaccare con disperata violenza ma fallisce uno scontro nel giugno del 1918. Quelli definitivi avvengono in autunno, sul monte Tomba, sul massiccio del Grappa, e lungo l’argine del Piave, al ponte della Priula. La fine è quella ben nota di Vittorio Veneto, da noi e in tutto l’Occidente. Finisce un’epoca ma a Versailles si annunciano i prodromi di un’altra.
Giorgio Spina
63
Andrea Guglielmino, figlio del compianto Dr. Edoardo Guglielmino, ci ha fatto pervenire il seguente brano di clima natalizio, pregevole postumo tra gli scritti del nostro collaboratore. Lo offriamo ai nostri lettori nel ricordo dell’amico fraterno.
La Redazione
Visto dall’ultimo piano di un caseggiato di Via Piantelli, Pasquale Caccavale non era che un puntino nero, fermo in mezzo al cortile del carcere di Via del Piano.
Poco più in là altri puntini bianchi e rossi utilizzavano l’ora all’aperto giocando a pallavolo, altri a bocce.
Qualcuno nascondeva la testa nel foglio dello sport, ma Pasquale Caccavale no, Pasquale Caccavale spendeva la sua ora al sole, isolato ai margini del cortile carcerario.
I suoi pensieri, era facile immaginarlo, sempre gli stessi: non importa al sottoscritto, Pasquale Caccavale fu Gennaro, detto il pataccaro, che una svizzerotta sia andata a denunciarmi dall’appuntato Flores: “un tizio a me dare cento orologi oro pregiato, spacca minuto. Essere le quattro e questo orologio fare ancora mezzogiorno”.
Flores aveva pescato il pataccaro alla tripperia del Biondo e per il giudice Pietra non ci furono dubbi: sole a quadretti per sei mesi.
L’Avvocato Pulce si era, al solito, fatto in quattro. Pasquale l’aveva fatta grossa e per la sesta o settima volta avrebbe misurato il tempo dallo sferragliare delle chiavi dei secondini, dal canto del solito detenuto partenopeo e si sarebbe accorto dell’arrivo della domenica dall’urlo dei genoani,
accorsi in massa nell’attiguo campo sportivo a incitare il Vecchio Grifone.
Anche Pasquale stava per farsi vecchio, anche per lui era segnato il declino: era ormai un pataccaro di serie B. Ma non a quello pensava Pasquale sull’orlo del cortile.
Miriam, la sua dolce Miriam di Vico Esca, radio carcere solamente sapeva dov’era. Era con Peppino il carbonaio, dalla faccia nera come la pece, detto anche il prete, specialista in truffa con assoluzione.
In abito talare, Peppino aveva convinto svariate beghine a cospicui versamenti per l’Associazione Redenzione Giovani Fanciulle Traviate (ARGIFT). Il prete aveva la parlantina sciolta e Miriam aveva preferito il suo sottile insinuare al chiasso del pataccaro.
“L’appuntato Flores con me doveva avercela quel giorno ... non poteva farsi i fatti suoi, andare allo Zerbino, con la nipotina all’Acquasola ... no, il suo tempo libero se lo passava a incontrare lui, il pataccaro, con i guai che aveva con la Miriam. Una mano sulla spalla e addio brodo di trippa. Quello era niente da rimpiangere. La brodaglia di Marassi era più o meno lo stesso beverone. Ma
LA DRITTA DI NATALE
· VA R I E ·
64
la Miriam, le sue lunghe mani con unghie rosse nelle mani del prete, i suoi candidi seni curvi sulla faccia del prete: roba da impazzire. Appena uscito, la vendetta.”
Così i giorni si snocciolavano e, prima del previsto, l’Avvocato Pulce, un vero amico, riuscì a impietosire il Giudice Pietra.
Al Commissariato Pasquale Caccavale incontrò il Flores. “Buongiorno appuntato” “Riga dritto Pasquale” “Non dubiti, servo vostro” e Pasquale sparì dietro alle mura calcinate della Chiappella, con un sorriso obliquo, per rientrare alla svelta nel lungo ombroso budello di via Prè; quella notte dormì e non dormì in una casa accanto alla Torre degli Embriaci.
Al mattino Pasquale Caccavale corse al Bar Giulio; Antonino il Sapiente si prendeva il solito latte.
“In vico Vivaldi deve essere la Miriam, in vico Vivaldi, a ridosso dei truogoli di Santa Brigida” gli diceva il Giulio. Pizzarelli il farmacista doveva saperne qualcosa. Pasquale entrò nella farmacia con una mano sulla guancia.
“Sei uscito Pasquale” gli disse lietamente il farmacista.
“In carne ed ossa per servirla, Pasquale Caccavale, tengo mal di denti”.
Pizzarelli tralasciò di compilare la denuncia
di furto gomme auto e gli porse un cachet. “E la Miriam?”
“Dimenticata!”…“Ma ha ancora roba mia: il cappotto, le
scarpe, una sveglia svizzera originale. Interessa, dottò?”
Il Pizzarelli capì l’antifona.“Lascia in pace la Miriam, Pasquale. Si
è messa col prete che è più bello e dritto di te”. Pasquale si ritrovò in Vico Vivaldi, alzò gli occhi a raschiare i muri umidi e si accorse che all’ultimo piano alla finestra c’erano i gerani della Miriam, i gerani rossi, la passione della Miriam. Fece i gradini a tre a tre, il fiato grosso, la mano in tasca stringeva nervosamente un coltellino. Sostò davanti all’uscio. Il fiatone doveva passare: intanto sentiva appena la musichetta del transistor, il trapestìo del passi leggeri della Miriam, non poteva che essere lei.
Non avrebbero più detto Pasquale il pataccaro, ma Pasquale l’assass ... “Che fai Caccavale?” una voce dietro le sue spalle.
“Vuoi cambiare mestiere, Pasquale, non più pataccaro?” la stessa mano sulla spalla. Flores e il pataccaro ridiscesero insieme, non una parola di più. I due si infilarono nel bar del Cicca. “A me una birra” chiese il Flores.
“Un cognacchino” gli fece eco il pataccaro.
“A me invece un latte” disse ammiccando, tutto contento, Antonino il Sapiente. Pasquale il pataccaro guardò il vecchio saggio e sorrise.
“Buon Natale” era scritto sullo specchio del bar.
“Buon Natale” augurò a tutti l’appuntato Flores; pagò, si accese una nazionale e uscì alla svelta dal bar.
Edoardo Guglielmino
(da Il Medico della Mala, Genova 1971)