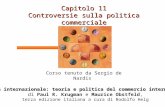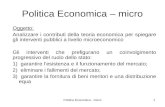RIASSUNTO-SCIENZA-POLITICA-Potere-e-teoria-politica-_Mario-Stoppino_-La-teoria-pura-della-politica-_Bertrand-De-Jouvenel_.docx...
-
Upload
lucrezia-nurra -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of RIASSUNTO-SCIENZA-POLITICA-Potere-e-teoria-politica-_Mario-Stoppino_-La-teoria-pura-della-politica-_Bertrand-De-Jouvenel_.docx...

RIASSUNTO SCIENZA POLITICA
Potere e teoria politica (Mario Stoppino)
appunti Battegazzorre
La teoria pura della politica (Bertrand De Jouvenel)
POTERE SOCIALE(cap 1)
Il potere non è una cosa o il suo possesso, è un rapporto di causazione sociale tra un uomo (o un gruppo) e un altro uomo (o gruppo). Si tratta di una relazione triadica, cioè composta da 3 elementi: condotta di A (attore attivo), condotta di B (attore passivo) e sfera d’azione in cui il potere si esprime.
DEFINIZIONE: relazione causale tra azioni o disposizioni ad agire di attori sociali diversi, in cui l’azione o la disposizione ad agire del soggetto B (azione di conformità) corrisponde all’intenzione o all’interesse che accompagna l’azione o la disposizione ad agire del soggetto A (azione potestativa).
Azione: movimento dell’organismo sempre volontario, ma non necessariamente deliberato, intenzionale o libero. Disposizione ad agire: azione potenziale.
Il potere può essere ATTUALE, detto anche esercizio del potere (rapporto tra comportamenti: la capacità di determinare la condotta di B viene messe in atto, deve essere intenzionato ma non necessariamente libero), o POTENZIALE (rapporto tra disposizioni ad agire: A ha la possibilità di tenere un comportamento mirante a modificare la condotta di B).
Non vi è potere se alle risorse di A e alle sue abilità ad impiegarle non corrisponde l’attitudine di B a lasciarsi influenzare. La probabilità che il potere si realizzi dipende in ultima analisi dalla scala di valori di B. Inoltre il potere non deriva semplicemente dal possesso e dall’uso di certe risorse ma anche dall’esistenza di certi atteggiamenti di A e B, come le percezioni e le aspettative che riguardano il potere.
Percezioni: è un’immagine di come un attore sociale crede che sia distribuito il potere nella società
Aspettative: si entra nel campo delle reazioni previste: B modifica la propria condotta nell’interesse di A, senza che quest’ultimo abbia dato un ordine diretto, in quando B prevede le reazioni spiacevoli se non lo facesse.
Il potere è STABILIZZATO quando, ad un’alta probabilità che B compia con continuità i comportamenti corrispondenti alla volontà o all’interesse di A, fa riscontro un’alta probabilità che A compia con continuità azioni dirette a modificare la condotta di B o idonee a modificare tale condotta nell’interesse di A. Quando la relazione di potere stabilizzato si articola in una pluralità di ruoli definiti e coordinati tra loro,e dura nel tempo, si parla di potere ISTITUZIONALIZZATO.
MISURAZIONE DEL POTERE
Sei dimensioni:
1 sfera in cui esso s esplica2 gerarchia di valori all’interno della sfera presa in esame3 campo del potere: xsone sottoposte al potere che stiamo analizzando4 peso del potere: grado d restrizione delle risorse di B5 efficacia: corrispondenza tra la richiesta d A e l’effettiva condotta di B

6 costi:- Per A: tempo e denaro speso con convincere B- Per B: ripercussioni nel caso in cui non s conformasse
CONFLITTUALITA’ DEL POTERE
Sulla conflittualità delle relazioni di potere il miglior contributo è stato dato da Karl Marx. Per Marx le relazioni di potere sono sempre conflittuali, il fatto che la conflittualità non si manifesti è dato dalla presenza di sovrastrutture.
Esistono due diverse concezioni del conflitto:
Come antagonismo delle volontà: il potere, nel suo momento iniziale, porta sempre con sé il conflitto tra le volontà, per definizione (è implicito nel concetto stesso). Nel momento finale, invece, la conflittualità può esserci (come nella coercizione) o non esserci (come nella persuasione), dipende dal tipo di esercizio del potere.
Come diseguaglianza delle risorse (concezione marxista): per Marx il conflitto è dato dal fatto che c’è sempre uno che sta sopra e uno che sta sotto. Quello che conta è il risentimento che scaturisce inevitabilmente di fronte a una struttura di rapporti in cui c’è sovra e sub ordinazione (è la disuguaglianza tra il controllo delle risorse che fa sì che si abbia potere). Se intendiamo quindi il conflitto come disuguaglianza delle posizioni e non solo come antagonismo delle volontà c’è sempre conflitto, ma esso è solo potenziale, non è detto che si esprima (concorderebbe anche Marx: c’è bisogno della coscienza di classe!).
Nella fase iniziale dell’esercizio di potere c’è sempre un conflitto, nella fase finale dell’esercizio dipende dal modo dell’esercizio del potere. Es con la manipolazione non c’è.
Perché il conflitto potenziale si trasformi in conflitto attuale sono necessarie quattro condizioni di B:
1. La consapevolezza della propria posizione di subordinazione.2. La percezione della propria posizione come iniqua, ingiusta (è possibile che B pur consapevole della sua
posizione la consideri buona o giusta in virtù di qualche idea).3. La capacità di rivolgere il proprio risentimento verso il bersaglio giusto (B può non imputare la sua condizione
al soggetto attivo ma a qualcos’altro, come al destino o a teorie cospiratorie). 4. La percezione della possibilità di cambiare la situazione (B può ritenere che manifestando il suo risentimento
potrebbe soltanto peggiorare la sua condizione).
Solo se tutte e quattro le condizioni sono soddisfatte si potrà passare dal conflitto potenziale al conflitto attuale. Qst funziona in ttt gli esercizi di potere tranne che con la manipolazione (intervento nascosto di A su B: A cambia la condotta di B ma B non sa che è stato A). Per far sprigionare il conflitto basta normalmente una sola condizione: che il manipolato si accorga di essere stato manipolato. In qst caso B attua il conflitto, non per il contenuto delle azioni che ha dovuto svolgere, ma per il modo in cui gli si sono imposte.
RICERCA EMPIRICA DELLA DISTRIBUZIONE DEL POTERE
Tre tecniche principali:
METODO POSIZIONALE: consiste nell’identificare le persone più potenti con coloro che hanno una posizione di vertice nelle gerarchie pubbliche e private più importanti (è una mappa della distribuzione formale del potere). Critica: semplice da realizzare ma inaffidabile, non necessariamente il potere reale coincide col potere formale.

METODO REPUTAZIONALE: si fonda sul giudizio di alcuni membri della comunità studiata, ritenuti buoni conoscitori della vita politica della comunità: i potenti della città sono le persone reputate tali dai membri scelti dal ricercatore. Critica: non necessariamente il potere reputato coincide col potere effettivo.
METODO DECISIONALE: si basa sull’osservazione dei comportamenti effettivi che si manifestano nel processo decisionale pubblico. Si procede all’accertamento di tutti gli individui che partecipano al processo decisionale. Critica: 1) può essere fatto solo a pochi settori decisionali, essendo una tecnica complessa 2) non è in grado di rilevare i poteri che non si vedono nei processi decisionali, ad es. il potere esercitato nell’impedire che una proposta entri nel processo decisionale; questo tipo di potere può essere invece rilevato dalla tecnica reputazionale, che può quindi essere usata insieme al metodo decisionale.
NESSO CAUSALE DEL POTERE
La relazione di potere che intercorre tra A e B può essere espressa dicendo che il comportamento di A è causa del comportamento di B, intesa come “causa probabilistica”. Esitono 3 tipi di causazione:
1 nesso causale è condizione necessaria (B fa solo se lo fa A)2 è condizione sufficiente (se s verifica A si verifica B)3 è condizione necessaria e sufficiente ( B si verifica quando, e sl quando, si verifica A)
Inoltre il nesso causale che collega l’azione potestativa all’azione di conformità deve essere inteso nel senso che il comportamento di A è condizione sufficiente (e non necessaria) del comportamento di B.
Perché una causazione sociale sia potere deve essere intenzionale: la causazione di un comportamento altrui contrario all’intenzione o all’interesse di chi lo causa non è potere.
POTERE POLITICO
Capacità generalizzata di assicurare l’adempimento degli obblighi vincolanti, all’interno di un sistema collettivo, in cui tali obblighi sono importanti per la comunità e quindi possono essere imposti con sanzioni negative.
INTENZIONALITA’ E INTERESSE( cap 2)
Intenzione: stato delle mente nelle causazioni sociali intenzionali, inerenti all’azione deliberata di A per ottenere la conformità di B. è definito potere solo quando intenzionale.
Il problema è che esistono causazioni sociali che pur non essendo intenzionali si avvicinano molto ad essere un esercizio di potere. Es della segretaria. While portando l’esempio dell’attore sociale che involontariamente porta alla desegregazione sociale dei neri introduce una prima definizione di potere non intenzionato: conviene parlare di es. d potere ttt le volte che A ha un atteggiamento favorevole all’esercizio/condotta di B.
Per Stoppino il concetto di atteggiamento favorevole è troppo ampio ed introduce cosi il concetto di interesse.
Imitazione: è la riproduzione di un comportamento del membro di un gruppo senza che questi lo abbia richiesto. È considerato potere solamente quando c’è interesse da parte dell’imitato

Affinché le reazioni previste siano considerate potere:
1 il comportamento di B deve essere causato da un precedente comportamento di A, non necessariamente nei suoi confronti2 deve esistere un nesso causale tra i 2 comportamenti3 il comportamento di A non deve essere mirato ad ottenere la conformità di B
Interesse: comporta un’aspettativa di una ricompensa, una domanda ed una applicazione selettiva dell’attenzione.
L’interesse in senso soggettivo si distingue dal semplice atteggiamento favorevole e può essere suddiviso in 2 parti:
1. DIMENSIONE COGNITIVA: l’interesse verso un certo oggetto comporta l’aspettativa di una gratificazione che rientra nei giudizi di fatto. Si distingue sia dal mero impulso, perché nasce dall’esperienza, sia dai bisogni generali della personalità, perché si rivolge ad un oggetto particolare.
2. DIMENSIONE DIRETTIVA: l’interesse non è solo aspettativa, ma è una disposizione ad agire in vista dell’oggetto dell’interesse stesso. Si distingue sia dalla preferenza, che è solo una disposizione a ricevere qualcosa, sia dall’atteggiamento favorevole, che è solo una disposizione a reagire in presenza di un certo oggetto.
Fanno quindi parte della nozione di potere anche quelle relazioni in cui, in mancanza dell’intenzione, sia presente, in chi provoca il comportamento altrui, un interesse per l’effetto del rapporto.
Per il ricercatore il concetto di potere allargato allo studio delle “non decisioni” può correggere i limiti gravi della tecnica decisionale, che si limita a rispondere alla domanda “chi governa?” senza chiedersi “per chi si governa?”.
PREGIUDIZI SULLA VIOLENZA (cap 3)
PREGIUDIZIO DEL CONSERVATORE
1) Se si eccettua quella “legittima” dello stato, la violenza è vista come il massimo del male perché distrugge l’ordine e la coesistenza. Da ciò scaturisce la condanna preconcetta di ogni scoppio di violenza, quali che ne siano le cause e gli scopi.
2) Vi è la minimizzazione del ruolo della violenza: essa è vista come qualcosa di estraneo alla politica che ha una funzione marginale.
PREGIUDIZIO DEL RIBELLE
1) La condanna della violenza si rovescia nella sua esaltazione e tende a essere vista come lo strumento principe che ha la virtù di creare un ordine nuovo.
2) L’affermazione della marginalità della violenza si rovescia nell’affermazione della sua onnipresenza, è vista come qualcosa che sta alla base della struttura della società.
VIOLENZA
La violenza è l’intervento fisico di un individuo o un gruppo contro un altro individuo o gruppo o contro se stesso (suicidio). Perché si abbia violenza, occorre che l’intervento fisico sia volontario (l’incidente stradale non è violenza) e che abbia lo scopo di arrecare danno a B (l’intervento chirurgico non è violenza). Violenza e forza sono sinonimi,

sebbene nel linguaggio comune con forza si intende la violenza “legittima”. Per lo scienziato politico è invece necessario distinguere tra violenza o forza “creduta legittima” e violenza o forza non creduta tale.
La violenza può essere DIRETTA (quando colpisce in modo immediato il corpo di chi la subisce) o INDIRETTA (quando opera attraverso una alterazione dell’ambiente fisico in cui la vittima si trova, ad es. sottraendogli risorse materiali o rinchiudendola in un delimitato spazio).
VIOLENZA E POTERE
La violenza in atto si distingue in modo netto dal potere: il potere opera sulla volontà dell’individuo mentre la violenza agisce sul suo stato fisico. Ciò non toglie, ovviamente, che la violenza possa essere impiegata come un mezzo per esercitare potere.
Nell’analisi di un potere coercitivo, basato sulla minaccia di sanzioni fisiche, bisogna tenere presenti sia la minaccia della violenza, sia la violenza in atto come punizione (che mostra l’inefficacia della minaccia ma che può accrescere l’efficacia della minaccia per il futuro), sia la violenza in atto come azione “dimostrativa”.
L’efficacia di una minaccia dipende dal suo grado di penosità dell’intervento fisico minacciato e dalla sua credibilità.
VIOLENZA E POLITICA
Il potere politico ha il monopolio della violenza e la violenza è un suo mezzo specifico e tendenzialmente esclusivo (ciò comunque non significa che la violenza è il fondamento esclusivo del potere politico!). Anche nelle comunità politiche contemporanee il monopolio della violenza non è mai assoluto: vi sono usi della violenza che non fanno capo ai governati e sono dichiarati “illegittimi” (rapine, gruppi armati ribelli..) e altri che invece pur non facendo capo al potere politico sono ritenuti legittimi (punizione dei figli, legittima difesa..). Un’analisi della monopolizzazione della violenza permette anche di spiegare la differenza che esiste tra politica interna e politica internazionale.
Il potere politico è sempre fondato in parte sulla violenza ed in parte sul consenso. Si distingue il relativo peso della violenza in base al tipo d governo. Un governo democratico la violenza ha un ruolo limitato al solo potere coercitivo; nelle dittature la violenza sfocia nel terrore.
DIMENSIONI DELLA VIOLENZA
Due dimensioni:I. Prevedibilità / imprevedibilità
II. Misurabilità / non misurabilità
Violenza punitiva: prevedibile e misurabile.Violenza terrorista: imprevedibile e non misurabile.Violenza di tortura: prevedibile e non misurabile (ma il torturatore deve misurarla se vuole essere un “buon torturatore”).
CAUSE DELLA VIOLENZA
Due sono le principali teorie sulle cause che determinano l’insorgere della violenza politica:
1) Teorizzata da Gurr, diceva che la violenza politica ha la sua matrice nella percezione, da parte dei membri di un gruppo, che esiste un grave divario tra le loro aspettative e la loro situazione reale. C’è privazione relativa quando esiste un tale divario tra ciò che il soggetto crede di avere diritto di ottenere e ciò che il soggetto crede di potere effettivamente ottenere. Quanto più la percezione (vera o falsa) della privazione relativa è intensa e diffusa tra i membri di un gruppo, tanto più si genererà scontento e risentimento sociale nel suo seno, e tanto più vi sarà la disponibilità dei membri del gruppo a ricorrere alla violenza collettiva contro altri gruppi sociali e/o contro il regime politico vigente. Il limite di questa teoria, oltre al fatto che riguarda esclusivamente la violenza ribelle, è che individua una matrice potenziale di violenza, non una condizione sufficiente dell’insorgenza effettiva della violenza politica.
2) Elaborata da Charles Tilly, le cause della violenza vanno ricondotte alla prassi generale della lotta per il potere . In ogni sistema politico una pluralità di gruppi è impegnata nella lotta per il potere e per le risorse sociali. Alcuni

gruppi sono membri del sistema politico vigente, nel senso che hanno una capacità stabilizzata e riconosciuta di accedere al (o di influire sul) governo e la loro posizione privilegiata è difesa dagli apparati pubblici specializzati nell’uso della violenza. Altri gruppi, invece, non fanno parte del regime politico e lottano per cercare di entrare a farne parte a pieno titolo. È in questa situazione che sorgono i conflitti violenti, visti come una modalità specifica nella lotta per il potere.
CONSEGUENZE (o FUNZIONI POLITICHE) DELLA VIOLENZA pag 87-97
Le conseguenze della violenza, che diventano scopi politici quando sono cercati in modo intenzionale, si possono distinguere a seconda che riguardino:
I gruppi che la subisconoLa violenza può essere usata per distruggere gli avversari o, molto più comunemente, per piegarne la resistenza e la volontà (cioè per esercitare potere).
I gruppi che ne sono spettatori Attivazione della attenzione: un primo notevole effetto nei riguardi dell’ambiente sociale consiste
nell’attivazione dell’attenzione (niente richiama l’attenzione come la violenza, che permette perciò di rendere visibile la rivendicazione o il risentimento).
Dimostrazione della legittimità delle rivendicazioni. Ricerca del sostegno.
I gruppi che la esercitano Coesione tra i membri: grado elevato di unità sentimentalizzata. Centralizzazione delle decisioni e del potere. Ridefinizione e irrigidimento dei confini del gruppo (né con lo Stato né con le BR era uno slogan illusorio).
Un’altra importante funzione politica della violenza, che deriva dal fatto che i conflitti violenti tendono a intensificare la compattezza del gruppo, è quella del dirottamento delle ostilità verso un capro espiatorio (ad es. una campagna propagandistica xenofoba).
AUTORITA’ (cap 4)
Due diversi modi di intendere l’autorità:
COME POTERE STABILIZZATO: L’autorità è intensa come potere stabilizzato, continuativo nel tempo, al quale i sottoposti prestano, almeno entro certi limiti, un’obbedienza incondizionata (disposizione a obbedire). È una qualsiasi relazione di potere stabilizzato in cui le azioni potestative sono richieste apodittiche e le azioni di conformità sono incondizionate.
COME POTERE LEGITTIMO: L’autorità come potere legittimo accetta tutti i caratteri definitori dell’autorità come poter stabilizzato, però non li considera sufficienti. L’autorità deve portare con se un alone di positività, deve cioè esser creduto legittimo dagli individui che partecipano alla relazione di potere. L’accettazione dell’autorità produce quindi l’attitudine all’obbedienza incondizionata entro una determinata sfera per un tempo più o meno lungo. Ma, perché il rapporto di autorità possa proseguire, occorre che di tanto in tanto venga riaffermato il valore che fonda la legittimità del potere (ad es. le elezioni).
L’autorità “pura” è quindi un rapporto di comando e obbedienza fondato esclusivamente sulla credenza nella legittimità. Si tratta di un tipo ideale raramente riscontrabile nella realtà, difficilmente la credenza nella legittimità è il fondamento esclusivo del potere: il detentore del potere pretende obbedienza non solo in forza della legittimità ma anche, per esempio, in base alla possibilità di costringere, punire o premiare.

La credenza nella legittimità di per sé non è ancora una effettiva disposizione a obbedire, ma tende a crearla: quando c’è credenza nella legittimità il potere tende a trasformarsi in autorità.
AMBIGUITA’ DELL’AUTORITA’
Tra la credenza nella legittimità e altre basi del potere possono intercorrere rapporti significativi, che alterano in modo sostanziale la portata autonoma di tale credenza, conferendo ambiguità all’autorità. Il concetto di autorità pura intesa come potere legittimo può quindi dar luogo a delle anomalie che riguardano la natura delle credenze. Identifichiamo quattro ambiguità:
Autorità che genera violenza:
La credenza di B nella legittimità del potere di A consente ad A di utilizzare violenza nei confronti di C o dello stesso B.
Falsa autorità
La credenza nella legittimità non è genuina sia quando c’è una falsa manifestazione della credenza sia quando c’è auto-inganno, cioè una falsa credenza (falsa coscienza: nucleo centrale del concetto marxista di ideologia). Spesso nei rapporti in cui la credenza nella legittimità del potere ha carattere ideologico, un ruolo importante è svolto dalla minaccia della violenza (violenza che genera autorità).
Autorità apparente
La credenza di legittimità manca o è difettosa nel lato del comando: il potere è ritenuto legittimo solo da coloro che obbediscono. Se chi comanda non crede nella legittimità del proprio potere è molto probabile che nel tempo questa realtà venga percepita da chi obbedisce. Possiamo parlare di autorità apparente anche quando il giudizio di legittimità è presente ma il titolare dell’autorità non è il titolare del potere effettivo (ad es. A è l’uomo di paglia dietro di cui si nasconde C).
Autoritarismo
La credenza nella legittimità è presente soltanto dal lato del comando e manca in coloro che obbediscono. Non si tratta di un rapporto di autorità perché al comando non segue l’obbedienza, o segue un’obbedienza non fondata sulla legittimità ma su ragioni diverse (paura, interesse..). L’autorità può quindi trasformarsi in autoritarismo senza che muti il comportamento del detentore del potere, ma solo con il venir meno della credenza dei sottoposti nella legittimità del potere (es. figlio adolescente che rigetta l’autorità paterna).
CLASSIFICAZIONE FORMALE DEL POTERE (cap 5)
Si tratta di una classificazione formale perché analizza i modi in cui il potere si esercita, cioè le forme delle relazioni potestative e non la loro sostanza. Si basa su tre parametri:
1. Modalità del rapporto in cui il potere si manifesta . Consente di distinguere tra potere “aperto” e potere “nascosto. Per potere nascosto si intende qualunque relazione di potere nella quale, da un lato, A cerca deliberatamente di nascondere a B il proprio esercizio di potere (o la sua natura) e, dall’altro lato, B resta effettivamente inconsapevole di subire il potere di A (o della sua natura). Il potere aperto è invece qualsiasi relazione in cui non vi sia il proposito deliberato di A di celare il proprio esercizio di potere.

2. Oggetto, presso B, dell’intervento mediante il quale A esercita potere e permette una quadri partizione tra le forme di potere scelte da A:1 Alternative di comportamento d B, ovvero l’intervento d A può essere mirato a modificare le alternative
d B2 A può intervenire sulle premesse di B, ovvero sulle cause che possono scatenare il comportamento d B,
quindi sulle conoscenze e credenze ->orizzonte fattoriale e valutariale di B3 A può intervenire sull’inconscio di B, in quei automatismi inconsci che possono far scattare il
comportamento di B senza che esso se ne accorga4 A può intervenire sull’ambiente di B o sulle risorse di B, modificando cosi le azioni d B
Per situazione ambientale si intende una configurazione di attori con una data distribuzione di risorse sociali e una data distribuzione di credenze e disposizioni ad agire, cioè il contesto sociale in cui B è collocato ed entro cui sceglie strategie e azioni.
3. Dimensione soggettiva dell’intervento di A . Consente di distinguere, entro l’ambito del potere aperto, le forme di potere intenzionali da quelle solo interessate.
Potere Alternative di comportamento
Conoscenze di fatto / credenze di valore
Dinamismi psicologici inconsci
Ambiente
nascosto non è possibile Manipolazione dell’informazione
Manipolazione psicologica
Manipolazione situazionale
aperto intenzionale Remunerazione / costrizione
Persuasionenon è possibile (forse in terapie psicoanalitiche)
Condizionamento
aperto soltanto interessato
Reazioni previste Imitazione Condizionamento interessato
MANIPOLAZIONE DELL’INFORMAZIONE
La manipolazione in generale, cioè il potere nascosto, consiste in rapporti di potere in cui B ignora di essere oggetto di tale potere e crede di tenere la condotta risultante in modo consapevole.
È possibile manipolare la condotta di un attore se è possibile intervenire di nascosto nella formazione del suo orizzonte fattuale e del suo orizzonte di valore, distorcendo o sopprimendo di nascosto le comunicazioni che l’attore riceve. Esistono quattro tecniche generali di manipolazione informativa:
1. Menzogna : A da a B informazioni consapevolmente false, agisce per modificare le conoscenze e credenze d B.
2. Soppressione dell’informazione : A fa in modo che a B non arrivino determinate informazioni, si opera mediante un restringimento delle conoscenze limitando così le alternative d scelta.
3. Eccesso di informazione : A inonda B di informazioni, delle più disparate, creando in B una situazione confusionale che lo rende suscettibile di un intervento guida che gli indichi la via da seguire.
4. Indottrinamento : A insegna a B credenze invece di conoscenze, ha luogo soprattutto nei contesti educativi primari. Si osserva un uso marcato delle tecniche di soppressione e distorsione delle informazioni, che sono tipiche della manipolazione informativa. La condizione che influenza nel modo più decisivo il grado e l’efficacia della manipolazione è il regime nel quale opera l’emittente.
MANIPOLAZIONE PSICOLOGICA
È un intervento nascosto mirante a stimolare gli impulsi profondi che animano la personalità (inquietudini, timori..). è un intervento nascosto mirante ad ottenere comportamenti che B crede spontanei, ma che in realtà sono dettati da A. L’appello diretto agli impulsi emotivi inconsci è particolarmente efficace quando viene indirizzato a una folla di

persone, dove l’autocontrollo razionale di un individuo tende a indebolirsi. Esempi: la pubblicità (sia subliminale che non), l’informazione sui migranti, l’incitazione di una folla.
MANIPOLAZIONE SITUAZIONALE
A modifica la condotta di B operando celatamente sulla sua situazione ambientale. Esempio: quando dei genitori, per correggere la condotta del figlio, ottengono di nascosto che parenti e amici manifestino verso il figlio un determinato atteggiamento comune.
REMUNERAZIONE
Intervenire sulle alternative di comportamento vuol dire alterare le valutazioni dei costi e dei benefici cui B subordina la selezione della condotta da seguire. L’intervento remunerativo è l’aggiunta (o la promessa) dall’esterno, da parte di A, di un ulteriore beneficio (ricompensa) a una determinata alternativa di comportamento di B.
COSTRIZIONE
È l’opposto della remunerazione: l’alterazione del calcolo comparativo di B opera non con la promessa di una ricompensa per una data conformità, ma con la minaccia di una punizione per qualsiasi non-conformità. L’intervento esterno di A, anziché accrescere il valore dell’alternativa di comportamento desiderata, diminuisce il valore di tutte le altre.
REAZIONI PREVISTE
B tiene un comportamento y, nel senso desiderato da A, senza che A esprima l’intenzione di ottenerlo, ma perché B prevede che A adotterebbe reazioni a lui spiacevoli se non tenesse il comportamento y, o perché B prevede che il comportamento y gli varrà delle reazioni per lui piacevoli da parte di A. La previsione di B deve basarsi sull’esperienza e A deve avere un interesse verso il comportamento di B. Esempio: non mettersi le dita nel naso in pubblico per evitare la reazione dei presenti.
Il rapporto delle reazioni previste è la versione soltanto “interessata” della remunerazione e della costrizione (in situazioni strutturate e durevoli nel tempo le due forme di potere sfumano l’una nell’altra).
PERSUASIONE
Rapporto nel quale A determina la condotta di B modificando le conoscenze di fatto e/o le credenze di valore che plasmano tale condotta, per mezzo di argomentazioni aperte (cioè prive di elementi manipolatori) che non contengono né promesse di ricompense né minacce di punizioni.
IMITAZIONE
L’adozione da parte di B delle credenze, degli interessi o degli stili di vita di A. Perché vi sia imitazione è necessario che l’imitato abbia interesse a essere oggetto di imitazione (se invece fosse un proposito intenzionale l’imitazione diventa una forma di persuasione).
CONDIZIONAMENTO
A interviene in modo immediato sulle “condizioni” ambientali di B. intervenire sulla situazione ambientale significa intervenire su uno o più degli elementi costitutivi della situazione, ed in particolare sulla distribuzione delle risorse, ovvero sulle credenze e disposizioni ad agire degli attori che definiscono l’ambiente sociale. Ha un carattere indiretto perché non interviene direttamente né sulle alternative di comportamento né sull’orizzonte fattuale/valoriale di B. Può essere che l’esercizio del potere di condizionamento utilizzi come mezzi altre forme di potere (ad es. A può alterare la distribuzione delle risorse ricorrendo a interventi remunerativi o costrittivi).

CONDIZIONAMENTO INTERESSATO
La condotta risultante di B è causata dal cambiamento delle condizioni ambientali provocato da A; tuttavia A, operando quel cambiamento dell’ambiente, non aveva lo scopo deliberato (intenzione) di ottenere la condotta conseguente di B ma nel suo orientamento soggettivo c’era un interesse verso quel risultato.
È spesso difficile distinguere il condizionamento dal condizionamento interessato anche perché, a differenza delle altre forme di potere, una domanda esplicita e diretta di A a B è assente sia nella forma interessata sia in quella intenzionale.
POTERE, SCAMBIO E DOMINIO (CAP 6)
CLASSIFICAZIONE SOSTANTIVA DEL POTERE
Il potere può essere classificato anche da u punto di vista sostantivo, assumendo come criterio tipologico la classe delle risorse sociali sopra le quali il potere si fonda, e per conseguenza i valori (cioè le cose desiderate) che vi sono implicati e che ne definiscono il campo sociale. La classificazione più opportuna consiste in una tripartizione delle risorse: risorse di violenza o distruttive, risorse economiche e risorse simboliche; e in una tripartizione del potere: potere coercitivo, potere economico e potere simbolico.
POTERE COERCITIVO POTERE ECONOMICO POTERE SIMBOLICOPoggia su risorse DISTRUTTIVE
Risorse di violenza come strumenti materiali di offesa e di difesa (le armi), gli uomini che li impiegano, e le tecniche di impiego.
Poggia su risorse ECONOMICHE
Strumenti materiali di produzione di beni o servizi, gli uomini che li impiegano (i lavoratori) e le tecniche di impiego
Poggia su risorse SIMBOLICHE
Coinvolgono strumenti, uomini e tecniche di impiego degli uni e degli altri, ma prima ancora che in tali componenti, esse risiedono nelle credenze in determinate dottrine, che fondano l’identità etico-sociale.
Il valore in gioco è la: SICUREZZA (in senso fisico)
L’integrità fisica, la possibilità di
Il valore in gioco è il: BENESSERE
Dai mezzi di sussistenza(cibo) ai beni di più immediata necessità
Il valore in gioco è: L’IDENTITà ETICO-SOCIALE
L’identità etico-religiosa,

usare liberamente il proprio organismo, possedere e usare liberamente strumenti materiali.
(vestiti e abitazioni), accesso ai mezzi di trasporto e di comunicazione, fino ai beni e ai servizi di confort e divertimento.
l’identità etico-politica e l’onore sociale degli attori.
Questi tre tipi di risorse e di potere sono i principali operanti nella società umana.Queste tre forme sostantive di potere hanno un importante elemento in comune, operano generalmente tramite remunerazione e/o costrizione (ad esempio nel potere coercitivo c’è remunerazione tramite la sospensione o il ritiro dell’uso della violenza e costrizione tramite la minaccia di violenza o la punizione). Remunerazione e costrizione, infatti, costituiscono la parte cruciale dei rapporti di potere in una società. Le altre forme di potere spesso fungono da elementi di rinforzo. Ad esempio persuasione e manipolazione dell’informazione rinforzano la trasmissione di messaggi contenenti minacce (costrizione) o promesse (remunerazione).
Identità etico-sociale:Etica perché richiede il sacrificio di valori ritenuti meno elevati e la genuinità del perseguimento – tramite sacrificio – dell’identità. Sociale perché presuppone la comunione delle credenze e dei valori e il riconoscimento pubblico di tale identità. La comunione delle credenze porta con se il carattere intrinseco dei benefici dei seguaci (cioè conseguenza diretta del perseguimento di scopi simbolici da parte dei capi), il carattere intrinseco del fondamento del potere dei capi (il potere simbolico si basa sulle credenze dei seguaci e non, ad esempio, su risorse distruttive) e la qualità di beni comuni dei beni simbolici prodotti (perché si godono in comune e presuppongono la partecipazione dei credenti).
DOMINIO DELLE RISORSE
Le relazioni contrassegnate da una grave disuguaglianza delle risorse remunearitve in gioco, possono essere chiamate relazioni di dominio e dipendenza.La posizione di dominio consente ad un attore sociale, in base alle risorse di cui dispone, di chiedere molto di più di quanto non sia disposto a dare.La posizione di dipendenza fa sì che l’attore sottoposto a potere, si trovi, in grado maggiore o minore, in balia della controparte.Le risorse economiche e simboliche producono benefici positivi e comportano remunerazioni.Le risorse di violenza producono danni e convogliano direttamente costrizioni.
Risorse economiche (interessi) Risorse distruttive Risorse simboliche (passioni)Disuguaglianza delle risorse
DOMINIO ECONOMICO DOMINIO COERCITIVO (soggezione)
DOMINIO SIMBOLICO (dipendenza)
Uguaglianza delle risorse
SCAMBIO DI VANTAGGI SCAMBIO DI SICUREZZA (intersoggezione)
SCAMBIO DI RICONOSCIMENTO (interdipendenza)
DOMINIO ECONOMICO
Condizioni Tecniche di emancipazione1 Le risorse economiche di A sono salienti per B B può contrapporre una ridefinizione della propria scala di
valori, in modo da rendere meno rilevanti le risorse possedute da A
2 A detiene il monopolio delle risorse economiche B può ricercare surrogati in grado di sostituire i vantaggi

salienti per B generati dalle risorse di A3 B è privo di risorse economiche salienti per A B può essere creativo e inventare nuove risorse o
adoperare in modo nuovo risorse vecchie, al fine di poter acquisire il controllo di vantaggi salienti per A
4 B è nell’impossibilità di ricorrere alla violenza o alla coercizione contro A
B può creare un mezzo con il quale estorcere le risorse di A
DOMINIO COERCITIVO
Condizioni Tecniche di emancipazione1 Le risorse di violenza detenute da A sono salienti
per B (è sempre così, non solo nel dominio)Difficilmente B può ridurre il valore dell’integrità fisica nella sua scala di valori
2 A detiene il monopolio delle risorse di violenza salienti per B
La tecnica dei surrogati è inapplicabile perché si tratta di risorse distruttive e non remunerative. Inoltre la perdita del monopolio di A non rende necessariamente migliore la condizione di B
3 B non possiede risorse di violenza che siano salienti per A
B può inventare nuove armi o nuove tecniche per il loro uso o organizzare unità disperse e limitate di capacità di combattimento (es. moltitudine di contadini con la forca)
4 B è nell’impossibilità di fare ricorso a beni economici particolarmente salienti per A
Se B possedesse semplici risorse economiche non avrebbe neanche interesse a mostrarle perché A gliele sottrarrebbe. Se però B possiede risorse economiche che generano una erogazione continua di vantaggi può instaurarsi uno scambio in cui B eroga con continuità vantaggi a A, ed A garantisce sicurezza a B
DOMINIO SIMBOLICO
Condizioni Tecniche di emancipazione1 A detiene risorse (o svolge funzioni) salienti per B È difficile ridefinire la propria scala di valori perché
contrasta con gli apparati di indottrinamento e di socializzazione simbolica che riproducono e rinforzano le credenze vigenti
2 A detiene il monopolio delle risorse (o delle funzioni) simboliche salienti per B
Si può cercare dei surrogati, ma è difficile che i beni ideologici sostitutivi mantengano una condizione di surrogati. È probabile che essi ri convertano in beni ideologici che hanno valore in se stessi
3 B non detiene risorse (né svolge funzioni) simboliche salienti per A
Difficilmente applicabile
4 B non ha accesso alla violenza nei confronti di A Difficilmente B può rapinare le risorse simboliche di A perché generalmente non sono “cose”, può però nascere uno scambio di legittimazione e protezione (o nel caso di risorse economiche: scambio di legittimazione e sostentamento)
RIEPILOGO SULLE CONDIZIONI DELLE RELAZIONI DI DOMINIO
La prima condizione riassume le condizioni 1 e 3 del libro, mentre la condizione “esterna” n° 4 diventa qui la n° 3.
DOMINIO ECONOMICO DOMINIO COERCITIVO DOMINIO SIMBOLICO1) Grave disuguaglianza, in favore di A, nella distribuzione tra A e
a) A possiede risorse economiche salienti per Bb) B non possiede risorse economiche salienti per A
a) B è vulnerabile alle risorse distruttive di Ab) A non è vulnerabile alle risorse distruttive di B
a) A possiede risorse (e/o svolge funzioni) simboliche salienti per Bb) B non possiede risorse (né

B delle risorse reciprocamente importanti in una data classe
svolge funzioni) simboliche salienti per A
2) Monopolio di A delle risorse della stessa classe importanti per B
A detiene il monopolio delle risorse economiche salienti per B
A detiene il monopolio delle risorse distruttive a cui B è vulnerabile
A detiene il monopolio delle risorse e/o delle funzioni simboliche salienti per B
3) Assenza di una disuguaglianza riequilibratrice, in favore di B, nella distribuzione di risorse reciprocamente importanti di un’altra classe
assenza di una disuguaglianza riequilibratrice in termini di risorse distruttive o simboliche
assenza di una disuguaglianza riequilibratrice in termini di risorse economiche o simboliche
assenza di una disuguaglianza riequilibratrice in termini di risorse economiche o distruttive
Esempi: clientele economiche del mondo medievale, sfruttamento capitalistico
schiavitù, lavoro forzato chiese “imperialistiche”, movimenti politici fortemente ideologici
CONTRATTAZIONE
Relazione sociale nel quale ciascun attore presenta minacce, promesse ed elaborazioni simboliche riguardanti conoscenze di fatto e credenze di valore, con lo scopo di ottenere la ragione di scambio più favorevole. La minaccia del ritiro dei beni è una delle mosse più basilari e più ricorrenti degli attori in una situazione di contrattazione. Ed è per tale motivo che la contrattazione può trasformarsi in CONFLITTO, che è la continuazione con altri mezzi della contrattazione. Nel conflitto gli attori si infliggono reciprocamente e intenzionalmente dei mali (danni emergenti: combattimento, o vantaggi cessanti: confronto).
AZIONE CONFLITTUALE
Inflizione intenzionale di mali da parte di un attore contro un altro (se reciproco: conflitto). Quattro tipologie:
Ritiro della conformità: in quanto essa produce vantaggi economici o benefici ideologici (es. sciopero)
Ostruzione: impedimento della cooperazione tra altri attori sociali (es. picchettaggio sindacale, occupazione di vie di comunicazione, di edifici o di luoghi pubblici per impedirne l’accesso.)
Violenza sulle cose: distruzione e appropriazione di risorse fisiche altrui (es. sabotaggio)
Violenza sulle persone: interventi contro una o più persone per mezzo della forza fisica (es. sequestro, reclusione o uccisione)
COOPERAZIONE (è l’opposto del conflitto)
Per cooperazione sociale si intende qualsiasi relazione tra due o più attori, nella quale le azioni (o le omissioni) delle parti sono reciprocamente e intenzionalmente vantaggiose. La cooperazione è fatta da compatibilità (scambio di sicurezza), complementarietà (scambio di vantaggi economici e/o riconoscimenti simbolici) e convergenza (due attori proseguono insieme un valore comune).

POTERE POLITICO (inteso come potere di governo)
Tre diversi tentativi di definire il potere politico:
1. BRUNO LEONI: Il potere politico è la possibilità di ottenere rispetto, tutela o garanzia dell’integrità e dell’uso di beni che ogni individuo considera fondamentali alla propria esistenza.
2. NORBERTO BOBBIO: Il potere politico è sempre collegato in ultima istanza all’uso della forza ed è inoltre 1) un potere che si esercita su un gruppo numeroso di persone; 2) ha per scopo di mantenere nel gruppo un minimo di ordine; 3) tende a essere esclusivo, cioè a eliminare o a subordinare tutte le altre situazioni di potere.
3. MARIO ALBERTINI: Il potere politico è il potere cercato per se stesso.
Il potere politico si presenta come un potere stabilizzato e generalmente istituzionalizzato in cui opera un rapporto di comando/obbedienza. Inoltre è un potere che ha normalmente come uno dei suoi scopi il mantenimento di un minimo di coesistenza pacifica almeno nei riguardi dei membri politicamente rilevanti del gruppo. Queste indicazioni non sono però sufficienti per distinguere il potere politico da ogni altro tipo di potere, dal momento che il potere di una Chiesa, ad esempio, può presentare tutte queste qualità.
IL POTERE POLITICO COME MONOPOLIO TENDENZIALE DELLA VIOLENZA
Un’altra definizione del potere politico notevolmente diffusa (trae origine da Hobbes ed è stata precisata in senso sociologico da Weber) guarda al mezzo che i detentori di tale potere impiegano, o possono impiegare, per portare a esecuzione i loro comandi. Secondo questa definizione il potere politico è sempre collegato in ultima istanza all’uso della forza e tende a essere esclusivo, a eliminare cioè tutti gli altri impieghi di violenza. Contro questa interpretazione sono state avanzate due critiche principali:
Non tutti i poteri caratterizzati da un monopolio della violenza sono poteri politici: questa critica non è vera, ad esempio una banda di gangster non ha realmente un monopolio della violenza.
Non tutti i poteri politici sono associati a un monopolio della violenza: questa critica è molto più solida: di effettivo monopolio della violenza (o della violenza “legittima”) si può parlare soltanto per gli stati moderni e contemporanei di matrice europea (“comunità politiche pienamente sviluppate” come disse Weber), ma non per le società politiche precedenti, come quelle dell’antichità e del Medio Evo (neanche nelle tribù primitive c’era il monopolio della violenza ma esse erano prive di un potere centrale di governo e quindi esulano dal nostro studio che si limita alle arene politiche dotate di governo). Solo dal Settecento gli stati europei hanno iniziato a costruire apparati di polizia che hanno dato luogo a un monopolio tendenziale della violenza. Va chiarito il carattere “tendenziale” del monopolio: continuano a esistere usi di violenza non consentiti (rapine, assassinii..) ed altri consentiti (legittima difesa, sberla dei genitori ai figli..). Questa caratteristica del potere politico, seppur valida per gli stati moderni e contemporanei di matrice europea, non può essere utilizzata per definire il potere politico in quanto il monopolio tendenziale della violenza non è mai il solo fondamento e neppure, nella maggioranza dei casi, il fondamento principale del potere politico.
IL POTERE CHE PRODUCE POTERE

Una definizione soddisfacente del potere politico deve tener conto della sua funzione, cioè ciò che esso produce:
Il potere politico è il potere garantito (sotto forma di autorità politica) che produce e distribuisce poteri garantiti (sotto forma di diritti) per un determinato campo sociale, assicurando in esso la cooperazione sociale. È inoltre un potere stabilizzato (e spesso istituzionalizzato) e generalizzato, nel senso che, in condizioni di stabilità, riceve la disposizione alla conformità della grande maggioranza dei membri della società di riferimento. Esprimendo tutto ciò in una formula abbreviata, il potere politico è il potere che produce potere per una società (questa è la differenza tra il potere politico, che produce beni strumentali, e i poteri economico simbolico e coercitivo che producono beni finali).
DIRITTI (POTERI GARANTITI) NEI SISTEMI LIBERALDEMOCRATICI (O POLIARCHICI)
I principali diritti, che richiedono conformità nel senso di non impedimento alla loro realizzazione, sono:
Libertà (es. libertà di riunione o di culto) Facoltà (es. ottenere una data quantità di cose offerte al pubblico pagando il prezzo corrispettivo) Potestà (es. potestà di un direttore di azienda sopra gli individui che prestano in essa il proprio lavoro) Spettanze (es. diritto ad ottenere determinate cifre di denaro o servizi sociali)
Ad essi poi si aggiungono i “diritti di cittadinanza” che possono suddividersi in:
Diritti civili (es. libertà individuale, di pensiero, di ottenere giustizia) Diritti politici (es. diritto di esercitare potere politico) Diritti sociali (es. diritto alla pensione, welfare state)
RELAZIONI TRA IL POTERE DI GOVERNO E I POTERI SOCIALI
Tra il potere politico e le risorse economiche, simboliche e di violenza si instaurano relazioni molto significative:
1) Il potere di governo estrae o mobilita parte di tali risorse per sostenersi e per procedere alla produzione politica. Delle risorse di violenza ha bisogno per produrre la protezione esterna e interna, delle risorse economiche ha bisogno per sostenere le istituzioni e gli apparati pubblici, delle risorse simboliche ha infine bisogno per legittimarsi. Quando hanno il sopravvento le risorse distruttive si parla di “governi militari”, quando prevalgono le risorse economiche di “governi patrimoniali” e quando invece hanno il sopravvento le risorse simboliche di “teocrazie” e “ideocrazie”.
2) I detentori delle principali risorse sociali hanno bisogno del governo per trasformare il loro possesso in diritti riconosciuti e per vedere garantito l’uso redditizio di esse, entro la generale cooperazione sociale.
PRODUZIONE POLITICA (OSSIA PRODUZIONE DI POTERI GARANTITI)
Esistono diverse forme di produzione politica, le principali sono:
o REGOLAZIONE (emanazione di regole vincolanti più o meno generali riguardanti gli intercorsi sociali e la cooperazione complessiva).
o PROTEZIONE ESTERNA e INTERNA (difesa delle persone e dei loro beni dalle aggressioni).o GIURISDIZIONE (risoluzione e moderazione dei conflitti interni alla società).o FACILITAZIONE (produzione di diritti-facoltà per agevolare la cooperazione sociale, es. ferrovie, moneta..).o ALLOCAZIONE (produzione di diritti-spettanze, sono alla base del welfare state).
Infine, perché la produzione politica possa operare con successo, debbono intervenire altre attività del potere politico, dette “attività strumentali” alla produzione politica. Le tre principali sono:

1) Organizzazione delle istituzioni e degli apparati2) Estrazione di risorse dalla società3) Alimentazione della fiducia
STRUTTURA POLITICA(cap 10)
Il potere di governo, definito come potere garantito (sotto forma di autorità) che produce potere garantito (sotto forma di diritti) è un elemento costitutivo della struttura di un sistema politico ma esso da solo non è sufficiente. Devono essere considerati anche i poteri che operano sul governo (un altro limite, che però non trattiamo, è dato dal fatto che ogni sistema politico nazionale è inserito in una arena politica interstatale). È l’insieme dei limiti e delle regole relativamente permanenti entro cui si svolge il processo politico normale.
POTERI CHE OPERANO SUL GOVERNO
POTERI POLITICAMENTE INFLUENTI
Sono i poteri che, basati sulla disponibilità di risorse materiali o anche ideali di grande importanza per il funzionamento della società, condizionano con tendenziale continuità e in modo assai rilevante, sia positivamente sia negativamente, il potere politico. Si tratta, impiegando la terminologia di Guido Dorso, della “classe dirigente”. L’importanza delle risorse disponibili, e le corrispondenti organizzazioni, collocano i gruppi dirigenti che sono al vertice di queste organizzazioni in una posizione di potere importantissimo nella società.
Si forma, di conseguenza, uno scambio o una collaborazione tra la classe politica e la classe dirigente: da una parte, i detentori del potere politico hanno bisogno del sostegno dei gruppi dirigenti per portare a termine il loro progetti politici; dall’altra parte, i gruppi dirigenti hanno bisogno del potere politico per poter impiegare pacificamente e continuativamente le risorse che hanno a disposizione.
La costellazione dei poteri politicamente influenti limita in modo relativamente stabile l’azione dei detentori del potere politico: i poteri politicamente influenti si presentato infatti come poteri stabilizzati prevalentemente negativi, cioè aventi per oggetto un non fare, che operano tramite il meccanismo delle reazioni previste. Tuttavia possono influenzare il potere politico anche in modo positivo, premendo per la produzione di nuovi diritti.
POTERI MINIMI POLITICAMENTE RILEVANTI
Sono i poteri minimi che appartengono solitamente a tutti i membri della società e condizionano con tendenziale continuità e in modo limitato il potere politico. Si tratta, per usare ancora la terminologia di Dorso, della “classe diretta” (tuttavia i poteri minimi politicamente rilevanti possono non essere omogenei per tutta la classe diretta).
I poteri della classe diretta sono prevalentemente negativi, cioè aventi per oggetto un non fare, e inoltre minimi, cioè relativi a una sfera di attività molto circoscritta. Ma sono pur sempre poteri che costituiscono un limite relativamente stabile all’azione di governo: se i governanti infrangono frequentemente questo limite, si manifesterà una reazione tendente a ristabilire quel limite (condizionamento positivo). Il fondamento di tali poteri è dovuto in ultima analisi dalla indispensabilità della collaborazione dei membri della classe diretta al funzionamento della società.
REGIME

Il regime politico è un insieme di istituzioni politiche che funzionano in un dato momento in un dato paese.
Le componenti essenziali di un regime politico sono tre:
1. I valori o principi politici dominanti che orientano l’azione di governo e delineano l’area entro la quale essa può esplicarsi e ci si aspetta che si esplichi.
2. Le regole del gioco politico che stabiliscono le modalità per la conquista del potere politico.3. La struttura organizzativa del potere politico che determina le istituzioni con cui vengono prodotti i diritti.
Un’altra importante caratteristica del regime politico sono i valori che fondano la legittimità del potere, essi sono un elemento distinto dalle tre componenti del regime stesso e, quando un regime è riconosciuto legittimo, dovrebbero essere considerati come una quarta componente del regime stesso. Ma non tutti i regimi politici sono necessariamente riconosciuti legittimi (ad es. quello instaurato in una comunità politica soggetta a dominazione straniera): la legittimità non è una componente necessaria del regime.
Maggiori sono il consolidamento e l’autonomia strutturali delle istituzioni politiche, più efficace è la capacità del regime di modellare e di incanalare la lotta per il potere, e di frapporre un filtro tra essa e l’accesso ai ruoli di governo.
SOSTEGNO STRUTTURALE DEL REGIME
Il riferimento che viene spesso fatto, per definire la legittimità del regime, alla credenza nella legittimità da parte del popolo o della grande maggioranza di esso è senza dubbio semplicistico e insufficiente. I “governati” non sono una massa amorfa nella quale ciascuno può essere considerato uguale all’altro. La base e il sostegno di un regime è quello dei gruppi dirigenti (poteri politicamente influenti) e dei gruppi politici. Soltanto in un caso la considerazione dei gruppi dirigenti e dei gruppi politici non basta ad accertare la legittimità del regime: quando sono messi in grave pericolo gli interessi fondamentali dei membri della classe diretta.
SOSTEGNO DEI POTERI POLITICAMENTE INFLUENTI
Il ruolo fondamentale dei poteri politicamente influenti non è dato solo dal loro condizionamento verso il potere politico, ma anche dal loro sostegno strutturale al regime politico. È sostegno strutturale ogni forma di conferimento di risorse sociali, sia materiali che ideali, in favore del regime politico e la loro disponibilità a obbedire con continuità alle direttive provenienti dai governanti. I principali motivi che stanno alla base della disposizione a obbedire dei gruppi dirigenti sono: 1) l’interesse, basato sul fatto che certe esigenze comuni dei gruppi dirigenti sono incorporate nel regime politico; 2) il timore della violenza che i detentori del potere potrebbero usare; 3) la credenza nella legittimità basata sul regime.
SOSTEGNO DEI GRUPPI POLITICI
La base del regime non è costituita soltanto dall’assetto stabile dei poteri politicamente influenti, ma anche dalla configurazione stabile dei gruppi politici (i partiti, le correnti in seno a un partito unico, le fazioni che in una monarchia mirano a ricoprire i posti di governo attraverso il favore del re). Il loro sostegno consiste nella disposizione a rispettare le regole del gioco relative alle condotte volte ad acquisire il potere politico. I motivi che stanno a fondamento del sostegno al regime sono gli stessi dei gruppi dirigenti ma l’interesse per i gruppi politici è l’opportunità di conquistare il potere politico.
SOSTEGNO DELLA CLASSE DIRETTA
Il sostegno strutturale della classe diretta al sistema politico si concreta, da un lato, nella disposizione alla partecipazione prevista nell’ambito del sistema; dall’altro lato, e soprattutto, nella disposizione a obbedire con continuità ai comandi e alle direttive impartite dai governanti, entro i limiti stabiliti dai poteri minimi politicamente rilevanti. I motivi che stanno a fondamento del sostegno al regime sono gli stessi dei gruppi dirigenti ma per la classe diretta l’interesse è che i governanti rispettino e facciano rispettare i beni ritenuti fondamentali, mentre la credenza

nella legittimità non è generalmente del regime ma è della comunità politica, in cui il singolo si identifica. Vi sono altri due importanti fattori che possono essere alla base dell’obbedienza della classe diretta: l’ abitudine e il conformismo.
RIEPILOGO DELLE CREDENZE NELLA LEGITTIMITA’ DEL POTERE POLITICO
1) Credenza nella legittimità personale del governanteRiguarda caratteristiche personali del leader e può essere diffusa sia nei gruppi dirigenti e politici, sia nella classe diretta.
2) Credenza nella legittimità basata sul regimeRiguarda la fonte del potere e tende a essere diffusa maggiormente nei gruppi politici e dirigenti.
3) Credenza nella legittimità fondata sulla comunitàRiguarda la comunità politica e, in una società politica stabile, assume particolare importanza soprattutto a livello della classe diretta.
PROCESSO POLITICO(cap 11)
Il processo politico è l’insieme dei comportamenti dinamici e mutevoli che modificano la struttura politica o si svolgono al suo interno. Si definisce costituente se presiede alle trasformazioni strutturali, e normale se si incanala nella struttura senza modificarla.
Il processo politico normale si può definire in base ai suoi esiti:
1. Formazione e sostituzione dei governi (riguarda il “chi” governa)2. Decisioni politiche, leggi, provvedimenti ecc. (riguarda il “che cosa” decide chi governa)
CLASSI PRESENTI NEL PROCESSO POLITICO
CLASSE POLITICA (lotta per il potere)È più ampia che nella struttura perché include qualsiasi gruppo che lotta per il potere, compresi gruppi rivoluzionari o ribelli (che però non analizziamo). Inoltre le sue condotte sono molto più ampie che nella struttura.
CLASSE DIRIGENTE (pressione sul potere)È molto più ampia che nella struttura perché entrano a far parte di essa molti gruppi che, pur non disponendo delle risorse sufficienti a mettere in atto un condizionamento strutturale, riescono a influenzare singole decisioni politiche.
CLASSE DIRETTA (partecipazione politica)Rimane uguale alla classe diretta della struttura (semmai esiste un restringimento di campo, dato che se solo una parte dei detentori dei poteri strutturali li utilizza effettivamente nel processo politico).
LOTTA PER IL POTERE
LA POSTA IN GIOCO (il potere)
Il criterio che guida l’azione dei diversi gruppi politici, cioè il senso tipico-ideale del loro agire, è costituito dalla ricerca del potere (non c‘è però una motivazione psicologica: non necessariamente gli uomini politici hanno una personalità psicologicamente orientata verso il potere). In questo caso il potere, essendo stabilizzato o istituzionalizzato, appare una specie di “cosa” (un ruolo o una posizione stabile) che si può conquistare, conservare o perdere. Si tratta di potere di comando e obbedienza nei confronti del quale è generalmente schierata la disposizione a obbedire della maggioranza della popolazione.

Un certo grado di lotta per il potere è presente anche in campi diversi da quello politico (ad es. l’elezione del capo ufficio in una azienda) ma solo in politica la lotta per il potere diviene durevole e forma una classe di persone che si impegna in modo continuativo in essa.
Il potere politico assume un ruolo centrale nella distribuzione delle diverse risorse sociali e per questa ragione la lotta per il potere, oltre a dar luogo a uno specifico sottosistema sociale, diventa la struttura fondamentale del sistema di comportamenti che nel linguaggio ordinario chiamiamo “politica”.
La posta del gioco politico si definisce in termini di “chi” e non di “che cosa” perché le strategie e le tattiche nell’uso delle risorse politiche sono relativamente indipendenti dal programma politico. Inoltre la conquista del potere politico è una condizione indispensabile per l’attuazione effettiva del proprio programma politico.
IL GIOCO (la competizione)
La lotta per il potere si instaura tra diverse fazioni della classe politica sempre sotto forma di competizione (anche se generalmente il termine competizione viene utilizzato per indicare la lotta per il potere nelle liberaldemocrazie).
Nelle liberaldemocrazie (poliarchie)La competizione è aperta e la regola del gioco, che decide chi vince e chi perde, è il voto popolare. Queste due caratteristiche rendono la competizione poliarchica espansiva (cioè capace di attrarre dentro il processo politico sempre più interessi e forze sociali) e strutturata in un quadro di aspettative relativamente stabili.
Nella politica di corteLa competizione è chiusa (poiché i gruppi politici non possono appellarsi né all’elettorato né a ampie istanze sociali) e la regola del gioco è il favore del sovrano. Ne consegue che la competizione di corte ha una bassa permeabilità verso l’esterno ed è incerta, visto che il sostegno del sovrano può cambiare da un giorno all’altro.
Nei sistemi a partito unicoLa competizione è chiusa e la regola del gioco è la ricerca del gradimento dei burocrati dirigenti. La competizione burocratica è moderatamente permeabile nei confronti dell’ambiente circostante e strutturata in un quadro di aspettative relativamente stabili e prevedibili. Se la competizione concerne il vertice della burocrazia vi è invece una situazione di incertezza.
Un carattere comune dei tre tipi di competizione politica è l’importanza primaria che riveste il sostegno delle forze sociali che hanno una elevata capacità di condizionare e di influenzare il potere di governo (classe dirigente). La ricerca del potere politico diventa essenzialmente la ricerca del sostegno politico decisivo: le contestazioni, le prese di posizione, i programmi delle diverse frazioni della classe politica vanno intrepretate come mosse per acquisire, mantenere o accrescere il sostegno politico rilevante e, in definitiva, per conquistare o conservare il potere politico.
Dalla competizione si differenzia il combattimento, che è una lotta per il potere senza regole e spesso si verifica quando l’oggetto della lotta è la conformazione del regime (processo politico costituente).
PRESSIONE SUL POTERE
Anche nel processo politico si può individuare, oltre al ruolo principale svolto dalle classi politiche nella lotta per il potere, un comportamento politicamente rilevante che corrisponde al condizionamento operato dai gruppi dirigenti.
L’attività prevalente che i gruppi dirigenti svolgono non è la politica ma un’attività produttiva, religiosa, di rappresentanza di interessi economici ecc.. Il loro interesse per la politica non è diretto, come per le classi politiche, ma indiretto perché nasce dal fatto che le decisioni prese dal governo hanno o posso avere conseguenze rilevanti sulla loro attività.
Le classi dirigenti, di cui fanno parte anche una cerchia molto vasta di organizzazioni e associazioni (a differenza quindi delle classi dirigenti strutturali), sono dei “gruppi di pressione”. Nelle prospettive dei gruppi di pressione la politica è saliente soprattutto per il “che cosa” (i contenuti delle decisioni politiche). La loro condotta consiste nella

pressione che essi esercitano sopra una o più frazioni della classe politica per ottenere o evitare determinati indirizzi politici generali o decisioni particolari di governo (cioè per promuovere o difendere diritti).
La pressione politica consiste nel porre alla classe politica determinate domande politiche accompagnate dal conferimento o il ritiro selettivo del proprio sostegno politico. Quando un gruppo di pressione presta sostegno selettivo a un gruppo politico prende forma un processo di conversione politica delle risorse sociali. Il sostegno politico selettivo è guidato dall’“aspettativa-speranza” dei contenuti desiderati delle decisioni politiche.
SCAMBIO POLITICO
La relazione tra sostegno politico e decisioni politiche assume la forma dello scambio. I gruppi politici offrono un “che cosa” (decisioni e programmi politici) per ottenere un “chi” (sostegno nella lotta per il potere) dai gruppi di pressione.
Lo scambio clientelare (scambio immediato tra favore politico e sostegno politico determinato) è solo un tipo di scambio politico, non tutti gli scambi politici sono clientelari. La corruzione invece non è uno scambio politico poiché uno dei due beni scambiati non è politico.
LA TEORIA PURA DELLA POLITICA (BERTRAND DE JOUVENEL)
L’ALCIBIADE DI PLATONE
Due lezioni:
1. La politica, se non è guidata dalla saggezza, è una attività pericolosa.2. L’attività politica non è particolarmente sensibile agli ammaestramenti della saggezza (lo dimostra il fatto che
Socrate, il più saggio degli uomini, nacque quando Atene era all’acme della prosperità e, quando fu assassinato, la città era precipitata nel disastro a causa del malgoverno).
LO PSEUDO-ALCIBIADE DI JOUVENEL
È la replica dell’uomo politico all’Alcibiade di Platone, rimarca il contrasto tra filosofia politica e attività politica. Socrate non è in grado di muovere gli uomini, lui si limita ad aiutarli singolarmente a capire cos’è il bene mentre l’uomo politico (Alcibiade) è in grado di ottenere una certa decisione da parte di un gran numero di individui, appellandosi anche alle loro opinioni del bene, così come esse sono, anche se le si vuole successivamente modificare.
L’ISTIGAZIONE
Quando A chiede a B di compiere l’azione H c’è istigazione. Se l’istigazione è efficace e B compie l’azione H c’è conformità, altrimenti non-conformità. Il rapporto di A con B non comporta necessariamente una situazione di ineguaglianza tra i due, inoltre la decisione finale spetta a B. il rapporto può essere suddiviso in 4 fasi: 1) A annuncia ciò che desidera 2) B recepisce 3) B annuisce 4) B agisce. Nell’uomo è naturalmente presente una “propensione alla conformità” e, per Jouvenel, essa è la più eccellente e fondamentale delle virtù sociali. È impossibile stabilire con certezza se una data istigazione avrà successo o no, tuttavia diversi fattori influenzano la probabilità di riuscita:
1. Il credito di cui gode A (fattore chi)2. l’attrattiva di H (fattore che cosa)3. le immagini di azione radicate nella nostra mentre (educazione, abitudini, credenze, pregiudizi..)4. gli impegni e le promesse preso in passato, concernenti azioni o impegni all’obbedienza.

LA RISPOSTA
È una caratteristica sociale che esistano “modelli di inclinazione alla risposta” sociali e individuali. Le richieste comportano per l’individuo una spesa di tempo e di attenzione, quindi una pena. L’individuo non può esaminare, in un certo lasso di tempo, più di un certo numero di decisioni; è pertanto della massima importanza che la maggior parte delle sollecitazioni che gli pervengono non diano occasione di deliberazione, e siano subito collocate nella classe Uno (da eseguire automaticamente) o nella classe Zero (da non prendere neppure in considerazione). Il carattere di un uomo è ciò che riconcilia la sua libertà con la prevedibilità delle sue azioni. Il Pregiudizio (rispondere alle sollecitazioni in base ai nostri principi) e l’Autorità (rispondere alle sollecitazioni in base alla fonte) vengono di solito contrapposti alla libera scelta individuale, in realtà la scelta è costosa in termini di tempo e attenzione e dunque non va sperperata su troppi oggetti, perciò può essere non codardia ma buona amministrazione respingere o accettare senza discussione alcune richieste.
L’AUTORITA’
L’autorità ha una dimensione estensiva (il numero di B) e una dimensione intensiva (il grado di propensione di B).
Autorità (con la A maiuscola): A ha il diritto di comandare e B il dovere di obbedire. A si trova in relazione a una pluralità di B i quali hanno una marcata propensione a conformarsi alle sue direttive. La conformità di B non è diretta ad A in quanto persona, bensì alla posizione che occupa (rentier politico).
autorità : Le disposizioni alla conformità su cui A può contare sono date solo dai suoi sforzi e sono quelle che si è guadagnato fino a quel momento (imprenditore politico).
Esistono anche forme di “quasi Autorità”, cioè autorità sussistenti, dovute a istituzioni antiche e posizioni stabilite.
L’imprenditore politico tende a guardare il titolare di posizioni di Autorità con sentimenti di invidia e disprezzo e può rappresentare una reale minaccia per l’uomo installato in una posizione di stabilità. Col tempo l’autorità emergente tende a prevalere, tuttavia non esistono situazioni nella quale non esista, accanto all’Autorità stabilita, alcuna autorità.
Quando le posizioni di autorità sono molto consolidate l’elezione può in linea di principio essere aperta a tutti, ma in pratica vi sarà sempre un certo controllo da parte di qualcuno che è più “dentro” degli altri e che selezionerà le candidature.
LA LEGGE DELL’ESCLUSIONE CONSERVATRICE
Uno stato di cose nel quale non esistesse alcuna Autorità stabilita sarebbe intollerabile. Ogni insieme di individui deve possedere dispositivi per l’eliminazione dei segnali che confliggono al livello di insieme (comunicazione-comando). Gli altri invece possono competere liberamente (comunicazione-richiesta). Questa è la Legge dell’Esclusione Conservatrice, condizione necessaria alla persistenza di un sistema politico. Ciò evidenzia tre caratteristiche fondamentali di ogni sistema politico:
1. Deve esserci una selezione tra le possibili istigazioni tutte le volte che non sia tollerabile averne più d’una tramite un processo di selezione.
2. Quando il processo di selezione è terminato, deve esserci la proclamazione del risultato mediante una maestà visibile (es. dal trono).
3. Quando il comando è stato proclamato, cessa la libertà di enunciare istigazioni che confliggano con il comando stesso (ripescare una istigazione che era stata bocciata significa fare dell’“abusivismo politico).
POTESTAS E POTENTIA
Quattro sono le procedure principali attraverso le quali le posizioni di Autorità stabilita vengono occupate:
1) l’eredità 2) la nomina dall’alto 3) la cooptazione 4) l’elezione dal basso.

Tuttavia una cosa è la procedura formale, un’altra la comprensione dei processi effettivi. Ad esempio per vincere un seggio in parlamento basta ottenere alle elezioni la maggioranza relativa entro una qualsiasi circoscrizione. Ma l’aspirante politico non può presentarsi con qualche probabilità di successo se non è stato selezionato come candidato dai principali partiti esistenti.
Quando i meccanismi di un sistema tendono a escludere personalità di spicco, queste saranno inclini a cercare di impiegare le loro capacità in altri settori oppure a lanciarsi nella lotta politica all’esterno del quadro costituito. Esclusi da una posizione di Autorità esistente, essi ne costruiscono una per conto proprio. Attraverso questo processo ogni sistema di Autorità rischia la rovina.
È generalmente più pericolosa l’autorità informale di quella formale perché può essere senza limiti (il potere consiste in tutto ciò che di fatto si è capaci di ottenere); l’autorità informale ha invece potere solamente in un sfera legittima entro confini stabiliti.
La potentia (autorità informale) è detenuta da tutti coloro che sono dotati di potere, la potestas (autorità formale), invece, è una fonte della potentia e ne confina l’uso al solo scopo riconosciuto come valido.
IL COMITATO
Sul decisore politico si esercitano normalmente pressioni provenienti dall’esterno, egli prende decisioni che provocano conseguenze su grandi numeri di individui e la maestà data dalla posizione è precaria, perché la sua autorità poggia sulle opinioni. Il magistrato politico non può quindi essere indifferente alle reazioni che suscita.
La nozione di “maggioranza” ha poco significato: pag. 206,207
ATTENZIONE E INTENZIONE
Alla base dell’uso che facciamo della nostra energia ci sono l’attenzione e l’intenzione.
L’attenzione non è mai un male, essa è intrinsecamente un bene. L’intenzione invece può non essere un bene. La differenza fondamentale sta nel fatto che le diverse attenzioni di differenti individui non possono entrare in conflitto mentre lo possono fare le loro diverse intenzioni (non a caso tutte le visioni della città ideale sono state sempre improntate al desiderio di precludere la possibilità stessa del conflitto tra le intenzioni).
Un politico animato dall’intenzione cattura più facilmente l’interesse degli uomini di quanto lo possa fare lo statista attento. Ma mentre lo statista dell’attenzione si adopera per raddrizzare qualsiasi cosa non vada per il verso giusto, il politico dell’intenzione concentra tutte le sue facoltà al fine di far avanzare unicamente il suo progetto. Questi due tipi d’uomo non possono collaborare, uno deve soppiantare l’altro.
LA SQUADRA
Se un gruppo di individui (la squadra) condivide un’intenzione per la cui realizzazione è necessaria una decisione di una autorità pubblica, tenterà di persuadere direttamente coloro che prendono la decisione (il comitato); ma se essi non possono essere persuasi direttamente la squadra adotta un’altra strategia: l’organizzazione di una pressione esterna sul comitato. Se il comitato, dopo aver esaminato la proposta del gruppo di pressione, la respinge, il sostegno raccolto può modificare la posizione del comitato soltanto in forza del suo potenziale disturbo. Esiste un’ampia gamma di tattiche di disordine, dallo sciopero della fame alla bomba.