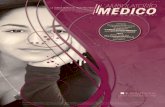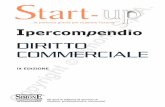RELIQUIE E RELIQUIARI ORIENTALI IN ROMA N · Non è da dubitare che lo studio del culto dei ......
Transcript of RELIQUIE E RELIQUIARI ORIENTALI IN ROMA N · Non è da dubitare che lo studio del culto dei ......
.•..
FIG. I - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO - TUNICA ORIENTALE
RELIQUIE E RELIQUIARI ORIENTALI IN ROMA
N EL CORSO degli attuali lavori di sistemazione del Museo Sacro della Biblioteca
apostolica Vaticana sono stati tolti per la prima volta dai locali di deposito alcuni reliquiari orientali, i quali invitano a riprendere in esame l'importante problema delle relazioni tra Roma e l'Oriente. Essi, anzi, valgono a illuminare quanto ancora vi è da chiarire nei riguardi di queste relazioni; ed io sono sicuro che un accurato studio delle reliquie traslate dall' Oriente a Roma, e
43
soprattutto dei reliquiari, potrà dare molti buoni contributi alla ricerca degli influssi orientali a Roma.
Non è da dubitare che lo studio del culto dei Santi nel primo Medioevo sia di una importanza fondamentale per la storia della cultura. Ed è dispiacente che le basi agiografiche delle relazioni tra Roma e l'Oriente non siano ancora sufficientemente chiarite, poichè grandissimo vantaggio ne trarrebbe lo studio della questione
337
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
Un piccolo contributo ad una fondata precisazione può dare la storia dell' arte mediante la disamina stilistica dei reliquiari.
I reliquiari orientali finora raccolti in Roma non sono numerosi ; ma bastano tuttavia a chia-
FIG. 2 - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO rire le epoche dell' influsso orientale in Roma
FRAMMENTO DI STOFFA DELLA COSIDDETTA BANDIERA DI S. GIORGIO
dal punto di vista della storia artistica. Mentre 1'indagine del culto e della venerazione dei Santi nella città di Roma ha avuto contributi della massima importanza segnatamente per merito del padre Ippolito Delehaye I) e di Pio Franchi de' Cavalieri, 2) l'analogo studio sull'arrivo delle reliquie e sul culto dei Santi orientali a Roma è tuttora nella sua fase primitiva; ed allo stesso padre Delehaye 3) son dovuti i più importanti contributi in questo campo. D'altra parte, se utilissime indicazioni sulle reliquie esistenti ci sono fornite da vari scrittori dal Rinascimento ad oggi, 4) manca tuttora un catalogo scientifico che registri per lo meno quelle conservate nei più importanti tesori delle chiese medioevali. Così, anche le reliquie appartenenti al Sancta Sanctorum, studiate dal Grisar 5) e dal Lauer,6) non furono completamente identificate; e tuttavia oggi è possibile affermare che quell'importantissimo tesoro conserva tutte le reliquie indicate da Giovanni Diacono e dall'inventario di Leone X.
È pur sempre difficile stabilire il tempo della traslazione delle reliquie dall' Oriente a Roma; ma per addivenire ad una precisazione, sia pure approssimativa, si potrà ricorrere ad uno studio accurato delle fonti letterarie, e soprattutto del Liber pontificalis, 7) alla ricerca delle iscrizioni apposte agli altari quando furono con-
e le fasi della sua maggiore intensità. Nella storia di questo influsso si distinguono con chiarezza tre grandi fasi.
Nell'età paleo-cristiana e nel primo Medioevo fino al sec. VB, soltanto poche reliquie e reliquiari pervennero dall'Oriente a Roma, in gran parte per donazione degli imperatori. Dal VII e dall' VIII secolo fino al lOOO, col rafforzato potere di Costantinopoli e con le frequenti immigrazioni di monaci, s'accresce in Roma la venerazione dei Santi orientali e delle loro reliquie. Infatti i numerosi pontefici d 'Oriente contribuirono grandemente alla creazione d'una cultura orientale in Roma, accanto alla cultura romana. 8) Non si tratta, in quest'epoca, di influssi orientali sulla civiltà romana, ma addirittura della presenza dell'Oriente a Roma. Nel
tempo delle crociate, che è la terza epoca, declina la cultura orientale in Roma; ma si procede alla conquista delle reliquie nell' Oriente. Peraltro a Roma ne giungono poche e sporadicamente, poichè i papi s'oppongono ai furti che i crociati ne fanno nelle chiese di Costantinopoli. 9) Sono quasi delle rarità, ammirate ed imitate dagli artisti, e valgono in qualche modo a trasformare il gusto e la tradizione dell 'arte a Roma.
sacrati, o alle dediche dei donatori inscritte sui reliquiari.
FIG. 3 - NEPI, CASTEL S. ELIA, MUSEO FRAMMENTO DI STOFFA
N ei primi sei secoli della Chiesa romana, furon venerati moltissimi Santi indigeni e
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
FIG. 4 - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO - RELIQUIARIO DI S. SEBASTIANO
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
Pasquale I (817-824), furono trasferiti nelle chiese di Roma.
FIG. 5 - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO - RELlQUlARIO DI S. SEBASTIANO (PARTICOLARE)
Fu infranta così la legge che vietava l'esodo dalle catacombe delle reliquie ex ossibus e permetteva solo di ritirare i brandea IO)
o altri oggetti stati a contatto dei sepolcri dei martiri. Invalse l'uso di donar reliquie anche alle chiese fuori di Roma. Ed è notevole che Roma fu nelle condizioni di far lavorare da artisti indigeni i reliquiari occorrenti alle traslazioni; ne è ottima prova la lettera scritta dal delegato papale circa le reliquie inviate a Costantinopoli da papa Ormisdas all' imperatore Giustiniano nel 519, II) dalla quale risulta che i reliqui ari contenenti quelle reliquie erano stati lavorati in Roma. Dall'Oriente invece, come appare dal Liber pontificalis, 12) provenivano a Roma, come dono degli imperatori, soltanto oggetti per la decorazione delle chiese, legature
pochi Santi orientali, come i Santi Cosma e Damiano, S. Teodoro, S. Mena, S. Nicandro. Anche in minor numero sono i ricordi di traslazioni di reliquie dall'Oriente. La testa di S. Foca, conservata e venerata a Roma, è tra i pochissimi esempi conosciuti. Roma s'accontentò dell' ingente tesoro dei suoi martiri che riposarono dapprima nelle catacombe, e che, dopo le devastazioni operate dai Goti e dai Longobardi, e specialmente al tempo di Paolo I e di
34°
di libri, lampade, piatti, vasi, e soprattutto stoffe in seta e oro. 13) Questo commercium si fece con opere di grande valore. Ma è quasi impossibile per noi avere una esatta idea di tanta ricchezza; e solo la Croce di Giustiniano a San Pietro, 14)
può darci un segno di tanto splendore passato. Il miglior esempio dei tesori medioevali ci è
dato dalla cappella del Sancta Sanctorum. Vi si trova un gran numero di stoffe orientali dal V al VII secolo; ma non è punto sicuro ch'esse
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
FIG. 6 - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO - BROCCA
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
fossero importate in Roma in quel tempo, e non dopo l' VIII secolo, allorchè venne sistematicamente composto il tesoro della cappella. Si tratta dell'importantissimo repertorio di stoffe sassanidi, siriache, egiziane, già tante volte pubblicate dal Grisar, dal Lauer, 15 dal von Falke, 16) dal Cecchelli, 17) e di altre recentemente rinvenute e pubblicate da me. 18) Nè occorre tornare ancora una volta su di esse. Queste stoffe servirono soltanto, come si deduce dal Liber pontificalis, per avvolgere le reliquie, o farne cornici; e tale è il caso di una bella stoffa copta in seta, del tipo di Achmim-Panopolis. Le altre stoffe rinvenute, e che sono precisamente reliquie, sembrano a me di origine romana. Si tratta in particolar modo di un gran numero di brandea insanguinati, tessuti in semplice lino, con la sola decorazione di croci colorate a rica-mo: cose non dissimili da quelle venute da scavi romani, come, ad esempio, il brandeum conservato nell' Antiquarium di Roma.
E si tratta precisamente di vere reliquie (cioè dei pannolini che i devoti intingevano con venerazione nel sangue dei martiri) e non dei brandea comuni, che venivano messi soltanto in contatto con le venerate reliquie, e che i papi solevano mandare in dono ai fedeli fuori di Roma.
necessità di una tale sovrapposizione a scopo di sostegno quando già la reliquia era assai logorata dal tempo. 19) Oltre questi brandea, il tesoro conserva alcuni frammenti di vesti, che gli antichi inventari riferiscono a S. Stefano, a S. Pietro e a S. Giovanni Battista. Il pezzo riferito a S. Stefano, con tracce di sangue e di balsamo, è di forma irregolare, ed è frammento di una veste non identificabile; gli altri due pezzi sono due tuniche. La tunica più grande (attribuita a S. Pietro) è di forma romana, come risulta da pitture delle catacombe e dagli studi di monsignor Giuseppe Wilpert; 20) ed è di forma rettangolare, con semplicissime linee di decorazione nel tessuto che è una mescolanza di lino e lana, non trovata finora in alcuna stoffa orientale. L'altra tunica (detta di S. Giovanni
Battista) è certamente orientale, come è dimostrato dalla scollatura che si prolunga fino alla spalla da una sola parte e dal disegno triangolare con il quale termina nel basso (fig. I). Ed è da notare che quel prolungamento della scollatura non è stato finora rinvenuto in esemplari anteriori al VI secolo, e che il disegno triangolare si trova soltanto nelle stoffe copte posteriori all' epoca paleo-cristiana. 21)
Che questi brandea insanguinati siano precisamente del tempo delle persecuzioni è provato da uno di essi, sovrapposto ad un lino di Damasco che non può essere di molto posteriore al VI secolo; ed è certo che si ebbe FIG. 7 - SIRACUSA, MUSEO - BROCCA
Tra gli altri oggetti del tesoro anteriori al VII secolo, uno solo è certamente orientale; ed è la pisside ovale in argento coi bolli bizantini del VI-VII secolo. 22)
Ma è molto probabile che essa sia venuta a Roma in epoca più tarda, forse nell' VIII-IX secolo, con gli altri oggetti orientali del tesoro.
342
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
FIG. 8 - ROMA, CHIESA DI S. BARTOLOMEO ALL'ISOLA - VASO IN BRONZO (PARTICOLARE) (Fot. R. Soprint. del Lazio)
Queste importazioni dall' Oriente sono strettamente legate alle condizioni di cultura prevalenti in Roma in quel tempo. La maggior parte dei papi furono allora greci e siriani, 23) e monasteri 25) importanti, come S. Saba, 24) vennero fondati da monaci orientali; una intera colonia orientale viveva ai piedi dell' Aventino, nella zona di S. Maria in Cosmedin; e tra gli ecclesiastici, i giuristi, i mercanti di questa colonia si trovano i cittadini più ricchi di Roma. Non è dunque da meravigliarsi se l'attività artistica di Roma aderisca alle necessità culturali
della colonia. Già nel mosaico di S. Agnese 26) si notano i primi segni sicuri dell' influsso bizantino; e gli affreschi di S. Maria Antiqua 27) riflettono le antiche forme secondo lo spirito del rinascimento bizantino. Accanto alle reminiscenze ellenistiche del meraviglioso Angelo, le scene dei Maccabei e dei Padri della Chiesa (a. 649) nel loro severo stile bizantino preannunziano i modi degli affreschi della chiesa inferiore di S. Saba. 28)
Non meno importanti della pittura monumentale sono, per la storia dell'arte in Roma, le iconi bizantine importate dall' Oriente. 29) D'una
343
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
musulmana; ma non possiamo stabilire se si tratti di un'opera eseguita in Egitto o importata dalla Persia. La finezza del tessuto si ritrova, con eguale esattezza, nel piccolo frammento conservato nel Museo di S. Elia di Nepi (fig. 3), opera musulmana della stessa epoca, con figure di bestie inscritte in piccoli cerchi.
FIG. 9 - ROMA, CHIESA DI S. BARTOLOMEO ALL'ISOLA - VASO IN BRONZO PARTICOLARE (Fot. R. Soprint. del Lazio)
Non si conosce il tempo della traslazione di altre stoffe conservate nelle chiese di Roma, a S. Anastasia e nel Laterano, che sono riferite alla SS. Vergine; ma anche per esse mi sembra sicura l'origine orientale: specialmente il frammento di velo del tesoro lateranense, ch' è un finissimo mussolino bianco
tale importazione si ha testimonianza in antichi testi. Sappiamo così che le monache basiliane 30)
portarono a Roma, con le reliquie di S. Gregorio di Nazianzo, una icone attribuita alla mano di S. Luca. Ma la Madonna oggi sopra l'altare maggiore di S. Maria in Campo Marzio non corrisponde più a questa icone. È un lavoro romano (verso il IlOO) che stava forse col Cristo benedicente della Pinacoteca Vatican a nella vecchia iconostasi. Notiamo invece che in un affresco di S. Maria Antiqua l'imagine della Madonna 31) è certamente una copia fedele di un esemplare bizantino.
Questi influssi bizantini si diffondono anche fuori di Roma, nei dintorni, come si può notare nella rappresentazione della SS. Trinità a Santa Trinità presso Cappadocia. Anche per questa epoca il catalogo più cospicuo ci è dato dal Liber pontificalis.
Sono 1 grandi papi dell'Oriente, devoti in particolar modo ai Santi delle loro terre originarie, che trasferiscono a Roma le reliquie le quali li ricordano e i reliquiari rispondenti alloro gusto. Così, si potrà riferire alla importazione di reliquie fatta da papa Zaccaria (741 -752) il frammento di stoffa della così detta Bandiera di S. Giorgio 33) (fig. 2), conservato nella chiesa di S. Giorgio in Velabro e alcuni anni or sono trasferito nel Museo Sacro Vaticano. I colori vivi (giallo, rosso, turchino) e l'ornamento trapunto con racemi rispondono esattamente ai tessuti in seta trovati negli scavi di Fostat, della prima epoca
?44
con sottili striscie in oro, simile ad alcune stoffe dell' Oriente musulmano, come la reliquia di S. Cecilia, nella cattedrale di Albi. 33) Più vivace nel colore rosso e bleu è la stoffa cosiddetta del presepe a S. Anastasia; un altro frammento di questa chiesa, attribuito a S. Domitilla, è una seta con striscia gialla e rossa di origine fatimita.
Anche nel tesoro del Sancta Sanctorum ricorderò inoltre il damasco con iscrizione greca, di ignota origine, e il pannolino con leoni, che è certamente di provenienza persiana.
Tra i numerosi reliquiari metallici del basso Medioevo, parecchi sono di origine orientale, e, come le stoffe, provengono da varie località. Il bel vaso niellato (figure 4 e 5) con coperchio, che nella chiesa dei Santi Quattro Coronati 34)
conteneva il capo di S. Sebastiano, porta l'iscrizione del donatore papa Onorio IV (827-844) . Il Liebeaert 34) l' ha attribuito al VI o VII secolo, ponendolo in relazione con un piatto niellato di Cipro che si conserva nel British Museum. 35)
Ma poichè egli decifrò come ANATOLE il monogramma inciso nel fondo del vaso, credette di poter riferire il reliquiario al mondo latino, mentre la strettissima somiglianza con l'ornamentazione niellata dei piatti bizantini di Cipro, e soprattutto con la tecnica dei piatti del VI e VII secolo trovati nella Russia meridionale, e certamente lavorati in quella provincia bizantina come dimostrarono con sicurezza lo Smirnov 36)
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
FI G. IO - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO - CALICE DI S. GIROLAMO
44
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
FIG. II - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO: COPPA DI VETRO (DA S. NICOLA DEI CESARINI)
e il Matzulewitsch, 37)
fa pensare che anch'esso sia stato portato da quei lontani paesi in Roma.
Ricorda i vasi persiani, specialmente quelli dei paesi del Caucaso, una grande brocca (fig. 6)
fusa in bronzo scuro, pesante, col manico a grossa forma serpentina, il collo lungo sfaccettato e la bocca di foggia bestiale; in essa riappaiono le forme vascolari del primo tempo musulmano con reminiscenze dell'ultima epoca sassanide, 38)
e può essere ascritta all'VIII o IX secolo, con
FIG. 12 - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO VASO RELIQUIARIO IN CERAMICA
una collocazione intermedia tre la brocca del Museo di Berlino pubblicata dal Sarre, 39)
ancora di gusto sassanide, e quella del Museo di Siracusa (fig· 7), pubblicata dall' Orsi, 40)
ma con maggiore accentuazione di forme musulmane. Si tratta molto probabilmente di un lavoro eseguito nell' Italia meridionale; ed io opinerei che questa brocca provenga da una fabbrica italiana.
Si può più sicuramente attribuire all' epoca musulmana avanzata un grande vaso in bronzo
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
FIG. 13 - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO - VASO
che si conserva a Roma, nella chiesa di S. Bartolomeo all'Isola 4') (figure 8 e 9). In esso, al tempo di Ottone III (983) furono poste le reliquie di S. Bartolomeo. La forma è semplicissima e mostra soltanto nell' interno un ornamento circolare con viticci, mantre reca applicati con chiodi intorno all'orlo quattro ornamenti a foggia di uccelli stilizzati. Il tipo della decorazione corrisponde esattamente alle decorazioni sincrone (s. ex.) e si ritrova in altre oreficerie lavorate in Egitto o in Siria.
Tra le ceramiche orientali della stessa epoca conservate a Roma, il pezzo più importante è il calice di S. Gerolamo (fig. IO) ritirato, perchè reliquia non autentica, dalla chiesa di S. Anastasia 42) e trasferito nel Museo Sacro del Vaticano.
È stato descritto finora come ceramica antica nelle vecchie guide fino al Braun, 43) perchè non si ebbe la possibilità di osservarlo con la debita attenzione. Ma si tratta di una coppa sicuramente musulmana, di forma rotonda, a smalto bianco, con ornamenti circolari a viticci rilevati contenenti uccelli. Nell'interno, in fondo, vedesi soltanto un punto turchino che forse non indicava altro che un segno augurale. Il sostegno in bronzo palesa la semplice forma d'un piede di calice quattrocentesco. La decorazione con uccelli si ritrova su stoffe musulma ne, dal X al XII secolo, ed anche la tunica a smalto con rilievi è caratteristica dell' arte musulmana della Siria e specialmente dell ' Egitto. 44)
347
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
FIG. 14 - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO COPPA IN VETRO
Tipi di ceramica VICIniSSIma a questa, con rilievi e senza smalto, sono stati rinvenuti negli scavi di Samarra del IX secolo, 45) ma rivelano una maggiore arcaicità nella fattura.
Il tesoro del Sancta Sanctorum conserva anche un piccolo vaso 46) usato come reliquiario (fig. 12), con smalto giallo e verde, che a prima vista rammenta la ceramica cinese, ma che potrebb'essere una copia da esemplari cinesi, eseguita in Persia o nell'Oriente mediterraneo fino all' Egitto, tra il IX e l' XI secolo.
In questo medesimo periodo medioevale si trovavano quali reliquiari molti vetri, 46) come dimostrerò in un altro articolo; ma, per la fragilità della materia, pochissimi son pervenuti fino a noi. E fra essi, quelli che sembrano orientali, non possono essere classificati come tali con sicurezza, poichè non abbiamo nozioni sufficienti sulle fabbriche italiane di questo genere. Il vetro che più s'assomiglia agli esemplari trovati in Oriente è, a mio giudizio, una coppa (fig. I I) venuta al Museo Sacro Vaticano
dalla chiesa di S. Nicola ai Cesarini. È di forma rotonda in vetro pressato, con un coperchio in piombo che contiene la lista delle reliquie il quale reca ornamenti in rilievo simili a quelli che si ritrovano assai spesso in Egitto. 47)
Di forma cilindrica molto slanciata e rarissima sono due vasi trovati in Roma: uno in un altare di S. Croce, l'altro nel Museo Sacro del Vaticano (fig. 13).48) Il vetro è d'una finezza che non ha riscontro alcuno in oggetti affini del Medioevo occidentale. Più caratteristico ancora è un vetro scuro tagliato (fig. 14). A questo proposito aggiungo che l'unico vetro, fra quelli trovati a Roma, pubblicato dal Lamm 49) come opera musulmana, sembra a me di origine occidentale, poichè, se la sua forma già ricorda le lampade delle moschee, la tecnica assai primitiva a filamenti colorati si riferisce strettamente ai vetri dell' epoca barbarica.
Da questa rapidissima rassegna di oggetti si può desumere che, quando esisteva una colonia orientale in Roma, tutti i paesi d'Oriente (1' Egitto, la Siria, la Mesopotamia, la Persia), forse più che Costantinopoli, mandarono oggetti nella città dei papi.
Scomparsa la colonia orientale da Roma, a cominciare dal secolo XI, le importazioni dall'Oriente non furono più connesse cogli usi comuni della vita, ma diventarono qualcosa di raro e di prezioso; e, nello stesso tempo, con la diminuzione dei residenti orientali, diventò rara la traslazione delle reliquie.
Giungono a Roma i bei reliquiàri in argento niellato o smaltato che appartengono al tesoro del Sancta Sanctorum nel Museo Sacro del Vaticano, la stauroteca del Laterano, 50) il mosaico portatile di S. Maria in Campitelli 5')
e l'altro del Museo Sacro, 52) che rammentano le più fine iconi del Monte Athos, 53) e arrivano anche (I070) i battenti dell' antica porta di S. Paolo fuori le mura, 54) lavorati con la stessa raffinata tecnica di niello e di argento usata nel IV e nel V secolo a Bisanzio, come dimostra il bel peso del Museo Sacro con le immagini dei tre imperatori Teodosio, Onorio e Arcadio (fig. 15). 55)
Ma, dopo i molti studi 56) già fatti sugli influssi dei maestri bizantini a Roma e a Montecassinot
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
,., .....
FIG. 15 - ROMA, VATICANO, MUSEO SACRO
non importa qui tornare sull'argomento. E solo occorre notare che su quelle opere di gusto straniero s'andò formando la cultura dei maestri italiani del tardo Medioevo. Si copiano allora gli smalti bizantini, come si vede nel Crocifisso di Velletri, o si traggono motivi di decorazione da stoffe orientali, come si riscontra nella pisside argentea della chiesa dei Santi Cosma e Damiano (fig. 16) donata dall'abate Desiderio di Montecassino (Il87) a Centuccio Frangipane.
I) DELEHAYE H., Méthode Hagiographique, Bruxelles 1934; Étude sur le legendier Romain, Bruxelles 1936.
2) FRANCHI DÈ' CAVALIERI P. in Riv. di arch. crist., XI, 1933, pago 235; lo. Note agiografiche, Roma 1908.
3) DELEHAYE, Les origines du eulte des Martyrs, Bruxelles 1933, pago 141.
4) PIAZZA C. B ., Emerologio di Roma cristiana, Roma 1713-19; ANFOSSI D., De sacrarum reliquiarum cultu, Brixiae 1610; PANCIROLI, Tesori nascosti dell'alma città di Roma, 1625; MORONI G., Dizionario, Venezia 1852, voI. 57, pago 106.
5) GRISAR H., Il Sancta Sanctorum, Roma 1907. 6) LAUER PH. in Monuments Pio t, 1906, XV. 7) DUCHESNE L., Le liber pontificalis, Paris 1905. 8) BRÉHIER in Byz. Zeitschr., 1903, pago I; GREGO
ROVIUS, Storia di Roma, III, 488; DE GULDENCRONE D., L' Italie byzantine, Paris 1914.
9) RIANT P., Les dépouilles relig. enlevée à Constantinopie, Paris 1875; lo., Exuviae sacrae Constantinopolitana e, Genève 1877, pago 43; SCHLUMBERGER, Epopée, II, pago 220.
FIG. 16 - ROMA, CHIESA DEI SANTI COSMA E DAMIANO PISSIDE ARGENTEA
Anche nell'arte monumentale le infiltrazioni del gusto e dello stile bizantino si palesano assai chiare, fino all'opera dell'ultimo grande maestro del Medioevo, Pietro Cavallini; e tuttavia questa ondata di bizantinismo penetra a Roma meno che in altri centri artistici (come nella Toscana e nella Campania) e vi resta attiva pur sempre come una corrente separata, appunto perchè in Roma la tradizione antica ha tanta forza da superare l'influsso delle importazioni. W. F. VOLBACH
IO) DELEHAYE, Les origines, pago 53; CABROL, Dictionnaire d'Arch. Chrét., Parigi 1907, fase. XIV, col. II32.
II) ColI. Avellana, 35, 2, Pars II, pago 680. Hormisdae epistolae.
12) BEISSEL in Zeitschrift christ/iche Kunst, 1894, pago 357.
13) SABBE in Revue beige de Phil. et d'hist., 1935, pag·5 II •
'4) EBERSOLT J., Les arts sompt. de Byzance, Paris 1923, pago 26; DE WAEL in Rom Quartalschr., 1893, pag.246.
15) GRISAR, pago 169; LAUER, pago 103. 16) VON FALKE, Kunstgeschichte der Seidensweberei,
Berlin 1921. .
17) Dedalo, 1927, pago 469. 18) Rendiconti della Pontif. Accademia Romana di
Archeologia, 1934, pago 177. 19) Rendiconti, fig. 3, pago 181. 20) WILPERT J., Die Gewandung der Christen in den
ersten jahrhunderten, Bonn 1898. 21) WULFF - VOLBACH, Spatantike und Koptische Stoffe,
Berlino, 1926, Tav. 126.
349
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte
22) GRISAR, fig. 43, 44, pago 146; MARc ROSENBERG, Goldschmiedemerkzeichen, Francoforte 1928, voI. IV, n. 9972, pago 707.
23) BRÉHIER in Byzantin. Zeitschrift, 1903, pago I.
24) GARDTHAUSEN, Byz. neugr. Iahrh., VIII, 1I4. DIEHL, Ch. Manuel d'Art byzantin, Parigi 1925, I, pago 1I4.
25) HU'LSEN C., Le Chiese di Roma, Firenze 1927, pago 429.
26) TOEsCA P., Storia dell'Arte italiana, pago 222, fig. 138.
27) MOREY in The Art Bulletin, XI, pago 49; KITZINGER E., Romische Malerei des 7-8 Iahrh. Diss., 1935.
28) WILPERT, Romische Mosaiken und Malereien, Friburgo 1916, IV, tav. 188; VAN MARLE R., Le scuole della Pittura Italiana, L 'Aja e Milano 1932, I, pago 80.
29) TOEsCA, pago 1025; HENZE C., Mater de perpetuo succursu, Bonn 1926.
30) CARUSl in Atti del I Congresso naz. di Studi Romani, pago 517.
31) WILPERT, IV, Tav. 196, come mi ha ricordato il mio amico Silla Rosa.
32) VOLBACH in Archivio della R. Deput. romana di Storia patria, 1936, pago 153.
33) B. DE MONTAULT in Rev. de l'Art chrét., 1893, pag· 376•
34) LIBAERT P. in Mélanges d'Archéol. et d'Hist., Rome 1913, XXXII, pago 479 con la vecchia bibliografia.
35) DALTON O. M., Catalogue of Early Christian Antiquities, 1901, Pl. XXIV.
36) SMIRNOV R., Argenterie orientale, Pietroburgo 1909.
37) MATZULEWITSCH, Byzantische Antike, Berlino 1929, Tav. 4 e 1I5.
38) SARRE in Ausstellung von Meisterwerken muham. Kunst, Monaco 1912, Tav. 126.
39) SARRE F., Die Kunst des alten Persien, Berlino 1925, Tav. 134.
40 ) ORSI in Byzantin. Zeitschr., XXI, 1912, pago 196, fig. 9.
41) HULSEN, pago 206 con bibliografia. 42) MABILLON I., Museum italicum, Paris 1724, I,
pago 97; GAY V., Glossaire, I, pago 252, fig. B. 43) BRAUN J., Das christliche Altargeriit, Miinchen
1932, pago 38. 44) PÉZARD, La céramique arch. de l'Islam, 1920;
F . SARRE mi afferma che crede a una origine egiziana. 45) SARRE F., Die Keramik von Samarra, Berlino 1925,
Tav. III, 5. 46) LAUER, fig. 16. Per la Germania vedi RADEMA
CHER F., Die deutschen Gliiser des Mittelalters, Berlino 1933, pago 7 e Mostra di Darmstadt 1935, Deutsches Glus, Catalogo, Tav. 40.
47) LAMM, Tav. 12. 48) FRANCHI DE' CAVALIERI in Riv. di arch. crist., XI,
pago 259. 49) LAMM, Tav. 28, n. 17, pago 93. 50) CECCHELLI in Dedalo, 1926, pago 231. 51 ) COLASSANTI in Dedalo, 1933, pago 282; cfr. il
Cristo a Galatina (Castelfranco in Boll. d'Arte, 1927, pago 289).
52) VOLBACH, Guida, I, Museo Sacro, 1935, Tav. III. 53) WULFF-ALPATOFF, Denkmaeler der Ikonenmalerei,
Hellerau 1925; DIEHL, II, pago 563. 54) PRESTON T. W., The bronze Doors of the Ab
bey of Montecassino and S. Paul, Princeton 1915; TOEscA P., Storia dell'Arte Italiana, Torino 1927, pago II05.
55) DAREMBERG-SAGLIO, Dictionnaire, II, pago 877; ORSI in Byz. Zeitschr., 1912, pago 204.
56) FROTINGHAM in American Journal of Arch., 1895, pago 152; DALTON O . M ., East christian Art, Oxford 1925, pago 57.
NOTE GIOTTESCHE: IL CROCIFISSO DI RIMINI
A LLA Mostra riminese dello scorso anno davanti un' opera che per la sua forza mo
rale, cioè, in termini artistici, intensità di commozione interiore e coerente sincerità di espressione, rivelava animo e mano di un sommo, impallidiva ancor più l'aurea mediocrità di quella scuola di eclettici raffinati e di preziosi volgarizzatori: il Cristo Crocifisso del Tempio malatestiano. I)
Un canto funebre d'una tragicità eschilea, di una grandezza beethoveniana; pur nella sua conClSlone, alla quale persino si direbbe avesse
350
giovato la mutilazione delle figure nei lobi. La Vittima divina pende chinando il capo stanco, vinto non dalla potenza esterna della morte, ma dalla propria volontà di dolore e di amore. u Fiat voluntas tua". Solo gli arti inferiori ci dànno il senso greve del corpo esanime cedente sotto il peso della materia che lo attira alla terra, con quel leggero pencolar delle ginocchia piegate, accentuato dal cader delle pieghe; ma il busto è eretto e il capo piegato, non abbandonato.
Il soffio della luce plasma di lievi increspature la sostanza eterea dell'esile corpo; ma
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte