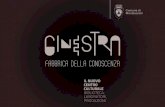Quaderni della ginestra
-
Upload
quaderni-ginestra -
Category
Documents
-
view
248 -
download
2
description
Transcript of Quaderni della ginestra
REDAZIONE
Direttore: Anna Maria Ricucci.
Vicedirettore: Corrado Piroddi.
Figure dell’individualismo: Ferruccio Andolfi, Elisa Bertolini, Simona Bertolini, Simona Del Bono, Antonio Freddi, Donatella
Gorreta, Nausicaa Milani, Giacomo Miranda.
Meditazioni filosofiche:Marco Anzalone, Elisa Bertolini, Valeria Bizzari (coordinatrice), Anna Pagliarini, Lavinia Pesci, Martino
Pesenti Gritti, Alberto Siclari, Timothy Tambassi, Roberto Venturini.
Cinema e filosofia: Marco Bigatti, Roberto Escobar, Pietro Parmeggiani, Corrado Piroddi (coordinatore).
Libri in discussione: Mara Fornari, Mirella Lucchini, Timothy Tambassi (coordinatore).
Esperienze didattiche: Teresa Paciariello (coordinatrice), Marina Savi, Chiara Tortora.
Letteratura e filosofia: Margherita Aiassa (coordinatrice), Alessandro Bonanini, Carlo Guareschi, Italo Testa.
Promozione: Marco Anzalone, Carlo Guareschi, Mirella Lucchini, Martino Pesenti Gritti, Anna Maria Ricucci.
Ricerca immagini, composizione, grafica e web: Margherita Aiassa, Marco Anzalone, Elisa Bertolini, Valeria Bizzari, Ales-
sandro Bonanini, Pietro Parmeggiani, Corrado Piroddi, Anna Maria Ricucci, Roberto Venturini.
Direttore responsabile: Ferruccio Andolfi.
SOMMARIO
Figure dell’individualismo................................................................................................................................................p. 6
Amore di sé e narcisismo nei filosofi individualisti dell’Ottocento di Ferruccio Andolfi............................................................................p. 7
Meditazioni filosofiche..................................................................................................................................................p. 22
La presenza dell’assenza. Forse di Antonio Freddi...............................................................................................................................p. 23
Il tempo e la pienezza della gioia:un confronto Nietzsche-Dostoevskij di Livio Rabboni.........................................................................p. 29
Cinema e filosofia............................................................................................................................................................p. 34
Un altro mito della caverna: la forza della legge in Batman di Federica Gregoratto...........................................................................p. 35
Letteratura e filosofia..................................................................................................................................................p. 40
George Perec e W o il ricordo dell’infanzia: l’inassumibile di Michael Archetti......................................................................................p. 41
La prova del fuoco. Sogno, rimozione e coscienza ne Le rovine circolari di J. L. Borges di Giovanni Consigli.........................................p. 48
Emendabile o incurabile? La figura del delinquente-selvaggio nella Colonia felice di Carlo Dossi di Alessio Berrè...................................p. 53
Didattica e filosofia......................................................................................................................................................p. 64
Dalla relazione tra soggetti all’intersoggettività: un percorso didattico di Marina Savi..............................................................................p. 65
Libri in discussione....................................................................................................................................................p. 70
Realmente liberi, realmente rivoluzionari di Giacomo Miranda…………..……...............................................................................p. 71
La peste tra colpa e destino di Daniele Foti…………………….......................................................................................................p. 74
Sentire e conoscere: l’uomo, “creatura emotiva” di Cristina Travanini......................................................................................................p. 76
Giorgia Zerbini, nata a Parma nel 1980. Si laurea in Architettura nel 2008,
studia e lavora a Madrid per diversi anni e dopo un’esperienza di alcuni mesi in
Australia torna a Parma dove attualmente vive. La fotografia non è un lavoro,
non è un hobby, ma è per Giorgia un modo di essere. Il mirino, il suo
personale e particolare sguardo sulla cose. L’obiettivo, tutto ciò che la
incuriosisce, che la meraviglia, che la turba: scene di strada, frammenti di città,
paesaggi sconfinati.
Figure dell’individualismo
7
AMORE DI SÉ E NARCISISMO NEI FILOSOFI INDIVIDUALISTI
DELL’OTTOCENTO1
filosofi hanno affrontato la questione del narcisismo nel quadro di
una diagnosi della modernità come epoca dell’individualismo. Essi
non hanno sempre una percezione precisa delle dinamiche psichiche in
gioco e si muovono piuttosto sul terreno dell’etica o della teoria sociale.
Di rado l’egoismo di cui parlano possiede la componente affettiva
presente nel narcisismo, per lo più indica un processo autoconservativo
dell’io. Tuttavia negli ultimi due secoli filosofi e teorici sociali hanno
fornito elementi utili per definire le condizioni di formazione di una
personalità supposta sana e indicato i rischi che corre in un ambiente
orientato verso una individualizzazione sempre più spinta e insieme,
paradossalmente, verso il conformismo sociale.
Il termine individualismo è stato utilizzato per designare quel-
l’insieme di fenomeni, di carattere sociale psicologico ed etico, che si
sono prodotti nell’età moderna, con il progressivo distacco di individui
emancipati da una matrice sociale comune, a volte indicata con il
termine forte «comunità». Più remotamente i fenomeni di quest’ordine
erano affrontati, a livello etico, ricorrendo ai concetti di «egoismo» o di
«amore di sé». Queste vecchie impostazioni sono ancora attive nella
mentalità comune e nella retorica religiosa o politica, che si limita a
condanne sommarie di ogni traccia di egoismo o di individualismo,
senza indagare le ragioni che hanno portato a riabilitare questi termini,
originariamente legati all’idea di una trasgressione colpevole dei vincoli
comunitari. Molti conflitti e malintesi nei rapporti di coppia trovano
giustificazione in un presunto mal definito «egoismo» imputato al
partner. La persistenza di questi luoghi comuni rappresenta di per sé già
una buona ragione per continuare a gettar luce sulla complessità e
ambivalenza del comportamento egoista.
Il secolo d’oro dell’individualismo è il secolo XIX. Simmel, che ha
scritto al termine di questo periodo, caratterizza l’individualismo
dell’800 come un individualismo della differenza o dell’unicità2. Vorrei
ripercorrere questo itinerario ricostruendo le posizioni di tre grandi
personalità. Un teologo luterano, Schleiermacher, esponente di rilievo
del Romanticismo, operante al principio del secolo – i suoi Monologhi
apparvero a Capodanno del 18003 – fornisce nel suo singolare
individualismo una sintesi quasi perfetta tra il raccoglimento in se stessi
e l’apertura altruistica. Un anarchico individualista, Max Stirner, a metà
secolo, radicalizza la critica della religione nell’L’unico e la sua proprietà
(1845)4, rivendicando per l’io, nella sua singolarità, l’autosufficienza
divina. A lui si deve l’esperimento più radicale di staccare l’individuo
I
Quaderni della Ginestra
8
dalla sua matrice sociale. L’unilateralità del suo punto di vista è ciò che
lo rende interessante ma insieme lo espone al fallimento. Il fallimento
discende dalla pretesa di eliminare dalla sfera dell’individualità qualsiasi
momento sacro. Qualche decade più tardi Nietzsche prende atto delle
difficoltà insuperabili che derivano dalla separazione del soggetto dal
processo storico-naturale che lo precede, e ricompone questi due
momenti nel sentimento cosmico dell’oltreuomo – che oscilla però
continuamente tra sentimento di appartenenza a una totalità più grande
e incorporazione dentro di sé di questa totalità5.
Schleiermacher e il doppio movimento dell’animo
Cominciamo dal pio Schleiermacher. Egli è un difensore della
religione dagli attacchi dei suoi detrattori illuministi. Ma la difesa
comporta una profonda reinterpretazione della religione stessa. Ogni
elemento mitico viene abbandonato, e persino dogmi che si presumono
irrinunciabili per il credente, l’esistenza di Dio e l’immortalità dell’anima,
vengono ritenuti non essenziali e, per il loro carattere trasparentemente
utilitaristico (dio esiste per rendere possibile la nostra vita immortale),
non propriamente religiosi. Ogni sentimento dell’Assoluto di cui il
singolo individuo è portatore rappresenta una forma di religiosità
legittima. Sul piano etico si verifica la stessa cosa. L’etica kantiana delle
legge universale, uguale per tutti, viene abbandonata a favore di un
dover essere fortemente individualizzato.
Schleiermacher descrive la scoperta di questa vocazione a costruire
un proprio io incomparabile attraverso una mescolanza singolarissima
degli elementi della comune umanità come un evento cruciale, una sorta
di illuminazione, che gli ha permesso di riaggregare d’allora in avanti
tutte le sue successive esperienze a questo nucleo fondamentale. Questa
scoperta, egli afferma, «mi ha elevato e separato da tutto ciò che di
comune e di informe mi circonda, facendo di me un’opera della divinità
che può rallegrarsi di avere una figura e una conformazione del tutto
speciale». La capacità di conservarsi fedele a quest’immagine di sé è
rappresentata con un certo compiacimento: «In verità mi sembra di
essere lo stesso uomo di quando cominciò la mia vita migliore, ma di
esserlo in modo più saldo e determinato»6.
In questo modello la percezione e costruzione del proprio sé più
autentico e peculiare sta in equilibrio con il sentimento della comune
umanità e con il sentimento dell’Assoluto. L’Assoluto stesso si esprime
nella forma della individualità, e l’individuo d’altra parte guadagna la
propria stessa singolarità grazie a questa sua espansione religiosa. Messa
da parte come non religiosa la fede in una durata temporale illimitata
Figure dell’individualismo
9
oltre questa vita, l’accesso a una superiore dimensione spirituale è
contemplata come possibile ad ogni istante di questa vita. Questa
tensione conferisce valore alla vita ma senza produrre gli effetti alienanti
della credenza in una figura idealizzata e onnipotente. Caratteristica di
questo individualismo etico-religioso assai originale è la convinzione che
per essere se stessi occorra trascendersi. Gli altri non rappresentano un
ostacolo alla propria formazione, che anzi si compie grazie a una
sensibilità e un amore universale.
Il compiacimento di sé che accompagna il processo di scoperta e
realizzazione di sé non sembra avere particolari implicazioni
patologiche, e consiste piuttosto in un’autostima che conferma di
continuo l’agente nella strada che sta seguendo. L’immagine di sé
ritrovata al termine di un laborioso processo di osservazione interiore
funge da ideale dell’io. Uso quest’espressione perché Schleiermacher
dice espressamente, in tacita polemica con Kant, di non conoscere più
la coscienza come istanza giudicante e punitrice (Gewissen). «Non
conosco più quel che gli uomini chiamano coscienza, nessun sentimento
mi tormenta né ho bisogno di ammonimenti». La coscienza (Bewusstsein)
dell’umanità non genera una quantità di prescrizioni di ciò che deve e
soprattutto che non deve essere compiuto ma semplicemente ispira un
agire che sia degno dell’umanità7.
Schleiermacher presenta il percorso di ricerca della propria identità
come esemplare, come una meta cioè che tutti sono in grado e
dovrebbero perseguire. La varietà delle vocazioni è ridotta nei Monologhi
a due tipi principali. C’è chi orienta la propria vita, nell’otium, alla
formazione di sé – questa è la strada che Schleiermacher rivendica
anche come propria – e chi attende piuttosto alla produzione di opere.
Mentre quest’ultimo – Schleiermacher ha in mente gli artisti dei circoli
romantici – ha bisogno di solitudine, chi sceglie di attendere alla propria
formazione non può fare a meno di rapporti socievoli.
Altrove, nel primo discorso sulla religione8, ogni vita (e anima)
umana è vista come il prodotto di due tendenze opposte. La prima
tendenza porta il vivente ad «attrarre a sé tutto ciò che lo circonda,
intrecciandolo alla propria vita, assorbendolo completamente, per
quanto possibile, nella sua realtà interiore». L’altra aspirazione mira ad
«espandere sempre più il proprio io interiore, dall’interno all’esterno (ihr
eigenes Selbst von innen heraus immer weiter auszudehnen), in modo che tutto
sia compenetrato da esso, e tutto sia partecipato». La prima è rivolta al
godimento, la seconda invece lo disprezza e mira solo a un’attività
sempre più intensa ed elevata da cui si originano le costruzioni storiche
(«forza e legge, diritto e utilità»). Ogni anima partecipa di entrambe le
tendenze, anche se in essa può essere prevalente o quasi esclusiva una di
Quaderni della Ginestra
10
esse. In questa rappresentazione ciascuna individualità comporta
sempre un bilanciamento tra due momenti opposti: quello centripeto o
autoaffermativo, per cui le cose vengono ricondotte (attratte,
incorporate) nell’ego che ne gode e si valorizza, e quello centrifugo,
orientato verso l’altro da sé, in un movimento infinito, per cui le cose
ricevono forma ad opera di un ego produttore. Schleiermacher scorge il
rischio di un isolamento sterile non solo nell’estremo del ripiegamento
passivo su di sé ma anche nel polo opposto di un vuoto darsi da fare
privo di obiettivi praticabili. Le combinazioni migliori corrispondono a
ciò che oggi chiameremmo un’identità ben riuscita: in essa l’impulso a
tener fermo il proprio sé come centro dell’esperienza si trova in perfetto
equilibrio con quello opposto ad esprimere il proprio sé all’esterno,
imprimendo una forma al mondo.
L’individualismo professato dal teologo berlinese corrisponde ben
poco all’immagine a cui esso è stato comunemente associato nelle
polemiche successive. Non ha i tratti dell’individualismo atomistico che
ritroviamo nelle teorie liberali. La condizione perché l’individuo
apprezzi la propria peculiarità è infatti una sensibilità universale che gli
permette di situarla nel contesto della infinita varietà possibile delle
espressioni di umanità. Né ha i tratti dell’individualismo possessivo: in
assenza di un atteggiamento di apertura e di donazione l’animo sarebbe
distrutto da un eccesso di passività nel ricevere.
A volte si ha l’impressione che Schleiermacher indulga a un certo
autocompiacimento dell’io che si osserva nella meditazione. Egli rico-
nosce la propria stessa vocazione in una «cultura dell’io» nello spazio
dell’otium che si oppone a quella del produttore di opere. Ma subito
precisa che l’efficacia di questa esplorazione interiore è subordinata a
una ricca frequentazione sociale, e che anzi la meditazione stessa ha una
destinazione sociale, quanto meno nel circuito dell’amicizia. Così
sarebbe errato vedere all’opera nelle pagine dei Monologhi un puro
ripiegamento narcisistico.
La matrice «religiosa» dell’individualismo di Schleiermacher pone un
interrogativo alla metapsicologia psicoanalitica, in genere piuttosto
scettica verso l’avvenire dell’illusione religiosa. Sembrerebbe che la
particolare evoluzione della religione indicata dal protestantesimo
liberale non comporti i rischi legati alla fede nell’onnipotenza del
pensiero né quelli dissolutivi del «sentimento oceanico».
Quaderni della Ginestra
12
Stirner : un solitario nemico del sacro
A metà dell’Ottocento l’individualismo di Stirner, ne L’unico e la sua
proprietà, sottolinea di nuovo il carattere incomparabile di ogni
individualità. Anche per lui, come per Schleiermacher, l’uniformarsi a
una legge generale si risolve in un rinnegamento di sé e della propria
individualità. Ma questa nuova teoria individualistica muove da
presupposti assai diversi: si situa all’interno di una critica allargata della
religione (o del sacro), che investe ogni sua trasfigurazione umanistica,
in primo luogo l’etica dell’abnegazione storicamente dominante.
Il termine «individuo» non è ritenuto anzi in grado di esprimere la
differenza, perché indica comunque l’articolazione di un «genere», e ad
esso viene preferito il termine «unico», il quale si sottrae a qualunque
definizione e rimanda solo alla descrizione di ciò che ogni singolo
diventa. Lo «stato sociale,» cioè di appartenenza di un individuo a una
comunità, biologica o civile, è considerato uno stato di natura che
l’evoluzione maturativa del vivente, come quella complessiva della
civiltà, è destinata a superare. Il punto tendenziale di arrivo è dato da
una forma di egoismo consapevole o maturo, che consiste nell’onesto
riconoscimento che qualunque azione si compia, fosse pure in nome del
più puro disinteresse, è compiuta per amore di se stessi. Non si possono
pertanto distinguere azioni egoistiche e non egoistiche; l’unica
distinzione possibile passa tra comportamenti dettati da un egoismo
«rozzo» e altre dettate da un egoismo «maturo», capace anche di
momenti di «oblio di se stessi».
In nome dell’unico Stirner conduce una polemica contro il principio
di uguaglianza che vede rappresentato a livello di generalità filosofica
nella morale kantiana e in forma politica dai movimenti liberali.
L’istanza dell’individualità (Eigenheit), ovvero la determinazione a seguire
la propria strada, rappresenta qualcosa di diverso e di assai più radicale
della libertà (Freiheit), che è un semplice sbarazzarsi di vincoli
opprimenti.
Il frutto principale che Stirner trae dal confronto con la morale
kantiana è l’idea che ciascun individuo debba seguire il proprio interesse
o quanto meno ciò che è per lui interessante. La società viene
rappresentata come uno strumento che l’unico deve utilizzare per i
propri fini. Al di fuori di questa funzione utilitaria il sociale, l’essere
legati, coincide con la sfera del sacro che Stirner intende eliminare.
Ciò spiega come mai Stirner, che pure poteva trovare nelle posizioni
di Schleiermacher la prefigurazione del carattere incomparabile
dell’unico, si guardi bene dal richiamarsi alla costellazione di idee
romantico-religiose prima illustrato. Il rapporto con l’infinito immette il
Figure dell’individualismo
13
finito in un’atmosfera sacra. L’appropriazione del sacro auspicata
dall’«unico» suppone invece che esso venga «divorato» e così eliminato.
Con questa eliminazione viene meno ogni venerazione e forma di
dipendenza – da cose, pensieri e legami sociali – che implica servilità, e a
cui Stirner oppone la grandiosità dell’individualità ribelle o peccatrice.
Il delitto non è altro che l’atto (ogni atto) mediante cui il singolo si
sottrae al potere e alla potenza delle istituzioni. Il singolo può assumere
il delitto come propria parola d’ordine in quanto lo carichi di questo
significato fondamentale di disubbidienza di fronte al prepotere dello
Stato: che tende a coincidere d’altronde con lo stato di cose esistente9. Il
delitto nasce da idee fisse, esiste solo in rapporto alla credenza in valori
sacri e assoluti. Chi si spoglia di tale credenza è innocente. Se continua a
definire la sua azione delitto lo fa solo polemicamente10. Il peccato, o la
colpa, esiste solo in rapporto a una mancanza che la coscienza religiosa
ha proclamato universale («siamo tutti peccatori»). L’eliminazione del
peccato è resa possibile dalla coscienza che non ci manca niente e che
«siamo già perfetti». Basterebbe dunque raggiungere questa coscienza
«egoista» della propria perfezione perché il peccato perda ogni senso 11.
Il processo di liberazione dal senso di colpa è rappresentato in maniera
piuttosto semplicistica, come se il senso di colpa non avesse profonde
radici nella vita interiore degli individui e derivasse solo da istanze
esterne (lo Stato, la religione), ma la direzione della terapia è indicata
correttamente: conciliarsi con la propria figura di individui che hanno
operato un distacco dalla totalità a cui appartenevano. Meno persuasiva
è la convinzione che questo distacco debba essere operato in nome della
propria perfezione.
Lo sviluppo delle individualità non è più garantito dal fatto di attuarsi
nel quadro della realizzazione simultanea di una realtà assoluta. I limiti
spaziotemporali dell’esistenza finita vengono apertamente riconosciuti.
In questo Stirner non fa che trarre le ultime conseguenze del
riconoscimento della mondanità compiuto da Feuerbach. La sua
posizione rappresenta davvero, da un certo punto di vista, l’inizio di un
modo nuovo di rapportarsi al problema del l’individualità, in un
orizzonte di piena immanenza.
Tuttavia, come egli stesso ebbe a dire, «il sacro non si lascia mettere
da parte facilmente»12. Sarebbe azzardato considerare lo spostamento
avvenuto come un processo non reversibile. Stirner si trovò di fronte al
compito storicamente urgente di una liberazione dall’autorità del sacro.
Ma una volta che fu indebolita quest’autorità, furono gli stessi individui
emancipati a voler ripensare la loro autonomia in un contesto di
appartenenze e dipendenze. L’unico fu così messo in grado di
abbandonare anche l’idea fissa del proprio vantaggio e di assumersi
Quaderni della Ginestra
14
nuove responsabilità sociali.
Questo accade un secolo più tardi in quel singolare continuatore di
Stirner che è Albert Camus, autore de L’homme revolté (1951). Il modo in
cui questi concepisce la rivolta, ancorandola a un valore umano
condiviso che si vuole proteggere, le imprime una svolta solidaristica.
L’origine della rivolta è squisitamente individuale, ma essa mette in
questione questa condizione solitaria dell’individuo e consente il
passaggio dalla tragedia individuale (l’assurdo) a una coscienza collettiva
della necessità di opporsi a condizioni inaccettabili di esistenza in nome
dei valori minacciati. Sono solo le moderne società individualistiche,
mettendo in campo questioni di diritti, con il contrasto tra l’uguaglianza
proclamata e le disuguaglianze di fatto sussistenti, ad attivare i
movimenti di rivolta, ma questi non fanno altro che mettere in risalto
una delle dimensioni essenziali dell’essere umano13.
Nietzsche: un ego che ricapitola il mondo
In Umano troppo umano Nietzsche ha mostrato come la rottura di
comunità tradizionali coese, la messa in discussione di tradizioni ritenute
sacre, ha aperto la strada a nuove possibilità di sviluppo di «spiriti liberi».
La prima condizione per il riconoscimento del valore della
individualità propria è una conciliazione con ciò che è stato sempre
vissuto con rimorso, in quanto si opponeva al valore morale centrale
dell’«essere legati» (Gebundensein). La buona coscienza con cui
l’individualità viene finalmente vissuta favorisce la formazione di
individualità forti e il compimento di grandi azioni. La moralità stessa,
opera di questo individuo cosciente di sé, si configura sempre più come
invenzione personale degli stessi criteri di valore. Attenersi a prescrizioni
morali uniformi per tutti ha senso solo per individui che «non si
riconoscono in modo rigorosamente individuale e debbono avere una
norma fuori di sé».
Questo tema di un individuo forte che si sottrae al peso della
tradizione, accentuato fortemente negli scritti del periodo intermedio
della produzione di Nietzsche (il cosiddetto periodo «illuministico»),
cede progressivamente al motivo, apparentemente opposto, secondo cui
l’individuo acquista grandezza attraverso un sentimento cosmico che gli
consente di riprendere in sé l’infinito corso degli eventi. A questa
apertura corrisponde una revisione dell’idea tradizionale del soggetto
come unità sovrana. L’io cosciente viene indebolito, dissolto in una serie
di istanze inconsce, concepito come uno strumento al servizio della
saggezza dell’organismo, che non attende questo sviluppo per svolgere
le sue funzioni autoconservative. È una finzione regolativa, che serve ad
Figure dell’individualismo
15
assicurare una certa stabilità e riconoscibilità. Nel Crepuscolo degli idoli
questo costrutto viene riportato al bisogno di indicare un responsabile
di ciò che accade, un centro di imputazione. Da questo assunto morale,
già esaminato nell’aforisma 107 di Umano troppo umano, sarà possibile
liberarsi con l’avvento della «saggezza», che rinuncia al giudizio e
riconosce l’«innocenza del divenire».
Nietzsche condivide l’obiettivo stirneriano di liberare gli individui dal
senso di colpa, e innanzitutto dalla colpa di essere se stessi. Ma per lui
questa colpa può essere superata solo a condizione di rinunciare alla
limitatezza del punto di vista dell’individuo.
Il concetto di sacro che affiora in questa ridefinizione nietzschiana
dell’individuo non implica tuttavia quel vissuto di dipendenza che
Schleiermacher aveva riconosciuto come elemento distintivo della
religione, ma che anche un critico della religione come Feuerbach aveva
riproposto in un orizzonte immanentistico come sua eredità
ineliminabile. Non è facile precisare infatti se il superamento della
prospettiva dell’individuo corrisponda a un riconoscimento di limiti o a
una più esaltata coscienza di sé, che rischia di compromettere la giusta
intuizione della necessità per l’individuo di «farsi parte». Se è vero che la
forza dell’individuo viene collegata alla sua capacità di aderire all’intero
processo del divenire, questa capacità è sempre sul punto di diventare
una capacità di appropriazione e di conseguenza il fondamento di un
sistema di differenze e preminenze gerarchiche14.
L’affermazione che l’ego rappresenta l’intera catena dell’essere fino a
lui potrebbe essere letta in senso solidaristico, come il riconoscimento di
un’affinità di fondo che unisce tutti gli esseri, malgrado le differenze, in
un destino comune. Ma Nietzsche fa valere questo carattere riassuntivo
dell’io esattamente per il motivo opposto, per rimarcare la differenza di
valore di ciascuno di questi percorsi, ciascun ego riepiloga a suo modo
l’intero cammino evolutivo che lo precede, attraverso un punto di vista
selettivo, che lo rende distante e incomparabile con qualsiasi altro. Il
generico attaccamento a sé dell’individuo non ha valore alcuno, né
merita alcuna speciale considerazione, solo l’egoismo dei grandi
individui ha interesse per l’umanità. Questo egoismo consiste nel volere
il destino del mondo, ovvero nell’inglobare in sé l’intero suo divenire. Il
senso di appartenenza, che la formula sembrava suggerire, slitta così
impercettibilmente verso l’incorporazione del mondo. Alcuni critici
hanno utilizzato, a proposito di questo «rospo gonfiato fino
all’inverosimile», proprio le metafore dell’«incorporare», del «divorare» o
del «fagocitare» il mondo15.
Figure dell’individualismo
17
Conclusioni
Vorrei spendere qualche parola finale circa gli insegnamenti che si
possono trarre dalla tradizione etico-filosofica esaminata per quanto
concerne il senso che l’amore di sé riveste nella costituzione dell’identità
personale.
La categorie utilizzate per indicare l’io e le sue vicende sono varie.
Nel caso di Schleiermacher l’io è inteso in termini di «spirito», di
«anima» o di «animo», con una enfatizzazione della sua dimensione inte-
riore, autoriflessiva, e della sua libertà nel decidere del proprio destino.
Il «mondo esterno» riflette il nostro essere interiore. Ciò deve però
essere inteso piuttosto nel senso «ermeneutico» per cui
nell’apprendimento del mondo giocano un ruolo decisivo le nostre
interpretazioni che non in quello di uno spiritualismo assoluto e
sostanzialistico. La deduzione del mondo dall’io, al modo di Fichte, non
appartiene a Schleiermacher, che anzi lamenta in Fichte la separazione
di filosofia e vita. I momenti di necessità del mondo sono riportati al
fatto che in esso, come comunità degli spiriti, interagiscono una
molteplicità di attori e si producono quindi effetti non corrispondenti
alle azioni libere di ognuno di essi. Sembra quindi scongiurato il rischio
di un assorbimento del mondo nell’io, sebbene manchi indubbiamente
una coscienza adeguata dei condizionamenti che l’io subisce da parte del
mondo reale. Dal punto di vista relazionale la priorità del proprio punto
di vista, nella scoperta e costituzione del proprio sé come nel plasmare il
mondo, è sempre bilanciata dall’insistenza sulla necessità di scambi
socievoli, ritenuti essenziali per la propria stessa identificazione.
Il soggetto in questa concezione ha una figura coerente, forte,
persino grandiosa. Intuizione e sentimento sono le sue facoltà
costitutive. L’orientamento religioso e le scelte etiche ne sono gli
elementi costitutivi. L’etica, diversamente che in Kant, non mira a
garantire la convivenza sociale attraverso regole e divieti, ma aderisce ai
progetti di vita individuali, che si suppongono dotati di una
fondamentale positività, e, grazie al radicamento in una comune
«umanità», armonizzabili. La costruzione coerente del proprio piano di
vita è la norma fondamentale o unica di una siffatta morale, che quindi
non conosce neppure una molteplicità di virtù.
L’unico di Stirner ha caratteristiche meno forti e determinate. Come
ha osservato Simmel, per il suo carattere formale è «l’io dell’egoismo
svuotato di ogni contenuto, radicale, privo di legge e di contrasto»16. La
coerenza del percorso vitale sembrerebbe disperdersi nella varietà e
momentaneità del «godimento di se stessi». Tuttavia l’egoismo si
presenta a questo soggetto come una sorta di missione, capace di
Quaderni della Ginestra
18
liberarlo dagli infiniti vincoli, istituzionali, religiosi ed etico-umanistici
che l’hanno finora condizionato. Si tratta di una via che dovrebbe
condurre all’«autenticità» e anche a rimodulare i rapporti sociali secondo
questa dimensione. Il contrasto tra individui, portato all’estremo, fino a
negare cioè gli stessi ruoli sociali che essi rivestono, dovrebbe metterli in
grado non solo di competere ma anche di avere relazioni positive faccia
a faccia. «Nella estrema separatezza si dissolve il contrasto».
La socialità viene recuperata nella forma esile del contratto, ovvero di
un’unione volontaria, che ha limitati scopi utilitaristici. Marx si
confrontò con questo modello, lamentando il carattere poco vitale di un
rapporto sociale di tipo strumentale. Egli ripropose a suo modo l’unicità
libera da ruoli sociali irrigiditi come meta dello sviluppo storico e della
stessa trasformazione rivoluzionaria. In questa critica resta dubbio però
se l’istanza dell’unicità ribelle possa essere guadagnata al termine di un
percorso di cui essa stessa non sia stata protagonista.
Preziosa appare la tesi stirneriana per cui l’altruismo può essere
ricondotto a una forma di egoismo maturo. Non esiste però alcuna
ragione per negare che un’azione da cui si ricava un senso di
soddisfazione di sé sia per ciò stesso non altruistica. Un analogo vizio di
ragionamento si può osservare nella stessa concezione antropologica di
Stirner, il quale, dopo aver giustamente affermato che gli elementi della
comune umanità acquistano una curvatura speciale in ogni singolo, non
sembra comprendere che essi, con tutta la loro peculiarità, restano
tuttavia comuni, creando quindi vincoli sociali17.
Nietzsche prospetta una concezione che lascia trasparire meglio di
quelle dei suoi precursori l’ambivalenza del soggetto e i pericoli a cui è
esposto. Permane l’ideale di un uomo grande, che si spinga anzi oltre i
limiti dell’umano, come suggerisce il termine Übermensch. Uno degli
aspetti di questa grandezza consiste nella invenzione o creazione dei
propri criteri morali di condotta. La scelta etica non ha principalmente
un orientamento sociale ma è volta all’incremento del proprio sé. Il
dovere è collegato al potere, al possesso di risorse, a un’espansione
vitale. L’individuo grande è quello che è capace di volere che la propria
vita sia ripetuta all’infinito. Resta indeterminato se l’espansione di sé sia
volta ad una auto affermazione sugli altri o possa assumere anche
l’aspetto dell’abnegazione.
L’ambivalenza di questa posizione, che alterna vissuti di superiorità e
di annullamento, può essere descritta in linguaggio religioso. Nietzsche,
come ha osservato Simmel, «vuole liberarsi dal tormento della
lontananza da Dio». Non può tollerare di non essere Dio, analogamente
ai mistici cristiani o a Spinoza. L’intollerabilità dell’opposizione tra Dio
e l’io nel caso della mistica si annulla per il fatto che cade l’io – questo è
Figure dell’individualismo
19
pure il senso dell’affermazione spinoziana omnis determinatio est negatio –,
mentre Nietzsche ottiene lo stesso risultato negando Dio. La soluzione
di Schleiermacher partiva viveversa da un presupposto di compatibilità
della particolarità con l’universalità divina. Per lui, è ancora Simmel a
notarlo, esse si escludono così poco che, al contrario, quella è soltanto la
forma in cui questa si mostra». «La personalità, l’unicità, è il modo in cui
vive l’universo». Se la scissione dei due termini decade, non c’è più
necessità di negare, in nome della sua insostenibilità, uno dei suoi lati18.
Se ci chiediamo conclusivamente per quali aspetti la linea di pensiero
che ho qui ricostruito possa contribuire, in maniera diretta o indiretta, a
illuminare la questione del narcisismo, l’attenzione può concentrarsi sui
seguenti punti:
1. il rapporto io-mondo. Nella tradizione considerata l’io ha una
sorta di priorità sul mondo. Quest’ultimo è un riflesso dell’io o dello
spirito (Schleiermacher), è uno strumento di cui l’io si serve per la
propria autoconservazione, utilità e godimento (Stirner), viene
incorporato da un io che la metapsicologia psicoanalitica definirebbe
megalomanico (Nietzsche). L’aspirazione dell’io alla grandezza è un
elemento comune, di per sé non patologico. Lo diventa quando si
realizza a spese dell’altro, asservito a strumento o addirittura inglobato
in sé.
2. l’etica. Qui la tendenza comune porta verso il superamento
dell’etica universalistica orientata alla salvaguardia della convivenza
sociale in nome di un’etica che aderisce alle specificità dell’agente
morale. Il movimento è da un’etica della prescrizione e della colpa verso
un’etica fondata su un’ideale positivo dell’io e sulla vergogna di non
corrispondere ad esso. Mentre la prima si presenta come un’etica delle
regole riferite a singole azioni da sottoporre a giudizio, l’altra assume
come referente ideale una certa immagine coerente del soggetto19. La
coscienza della propria identità, ovvero del possesso di determinate
risorse (poteri) crea la responsabilità di esercitarle, al di là di ogni
obbligo e sanzione20. La psicoanalisi, a partire da Freud, ha privilegiato il
modello superegoico di etica, la sua versione kantiana. Ora, che cosa
accadrebbe se essa assumesse un modello di etica non imperativo bensì
ottativo? E quali conseguenze ne deriverebbero per la pratica clinica?
Naturalmente il fatto solido e gravido di conseguenze del senso di
colpa non può essere accantonato con disinvoltura. Suppongo, ma qui
mi avventuro in un campo incognito, che la separazione, ogni
separazione dell’individuo dai suoi luoghi originari di appartenenza non
possa essere vissuta senza sentimento di colpa. La sua attenuazione, o
la capacità di convivere con esso, potrebbe essere favorita
dall’assunzione di un diverso modello, consapevolmente utopico, di
Quaderni della Ginestra
20
moralità come realizzazione del proprio singolare dover essere.
3. L’altruismo. Si assiste, almeno in Stirner e Nietzsche, a una
riduzione dell’altruismo a una forma di egoismo maturo. Si registra qui
qualche affinità con la posizione di Heinz Kohut, il quale contesta
anche lui l’opposizione tra quei due termini e ragiona sulla possibilità
che a partire dal narcisismo sia possibile seguire una sua linea evolutiva
per così dire autonoma che porta di in direzione dell’assunzione di cause
sovrapersonali e persino dell’eroismo.
4. La ribellione. Può essere interpretata come una dimensione
costitutiva dell’esistenza. Indicherebbe allora l’aspetto per cui ogni
individuo rifiuta le regole mortifere delle istituzioni sociali ed etiche per
assumersi, in quanto centro di iniziativa e di decisione, nuove
responsabilità proprie. Attraverso di essa l’individualismo passivo che la
società moderna induce e prescrive si trasforma in una risposta
innovativa al problema della scomparsa delle appartenenze, in un
tentativo di elaborare il lutto delle separazioni.
5. L’orizzonte religioso o postreligioso. Gli autori considerati sono i
protagonisti di una critica radicale della tradizione religiosa, da un fronte
interno ad essa (la teologia liberale di Schleiermacher) oppure esterno (la
critica di ogni varietà del sacro nel caso di Stirner, il conferimento di una
dimensione sacra a un ego grandioso nel caso di Nietzsche). Forse
l’interpretazione della religione come onnipotenza del pensiero e del
desiderio non ha tenuto nel debito conto la varietà delle espressioni
religiose e degli stessi modi d’intendere il desiderio d’immortalità.
Questo desiderio, reinterpretato in modo secolarizzato, indica una
possibilità aperta in ogni istante dell’esistenza terrena. A questo modo il
sacro perde la qualità originaria di un tremendum minaccioso per indicare,
in maniera più accogliente, quel trascendimento di sé che si richiede per
essere se stessi: una dimensione «spirituale» che elimina la piattezza del
richiamo alle rigide leggi della necessità naturale.
FERRUCCIO ANDOLFI
Figure dell’individualismo
21
1 Relazione presentata al XVI Congresso Nazionale della Società Psicoanalitica Italiana, Roma 25-27 maggio 2012. La relazione apparirà anche negli Atti del congresso. 2 G. Simmel, Forme dell’individualismo, Armando, Roma 2001. 3 F.D.E. Schleiermacher, Monologhi, Diabasis, Reggio Emilia 2011. 4 M. Stirner, L’unico e la sua proprietà, Adelphi, Milano 1979. 5 F. Nietzsche, Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1967 ss. 6 F.D.E. Schleiermacher, Monologhi, cit. p. 54. 7 Ivi, p. 50 s. È possibile che qui S. fosse memore di un osservazione simile di Goethe, che compare nelle righe conclusive delle Confessioni di un’anima bella, sesto capitolo del Wilhelm Meister: «A malapena mi ricordo di un solo comandamento; nulla mi appare sotto forma di legge; è un istinto quello che mi guida e mi conduce sempre sulla via giusta; seguo liberamente i miei sentimenti e ignoro tanto la costrizione quanto il pentimento» (trad. it. Adelphi, p. 376). 8 Sulla religione. Discorsi a quegli intellettuali che la disprezzano, Queriniana, Brescia 1989, p. 44. 9 L’unico, cit., p. 207. 10 Ivi, p. 215. 11 Ivi, pp. 373-375. 12 Ivi, p. 45. 13 A. Camus (2011), Nota sulla rivolta, in “La società degli individui”, n. 42, 2011, pp. 95-106. 14 F. Andolfi (1995) Nietzsche e i paradossi dell’individualismo. in “Segni e comprensione”, n. 25, anno IX, maggio-agosto 1995, pp. 16-31. 15 S. Giametta (1991), Nietzsche il poeta, il moralista, il filosofo, Garzanti, Milano, p. 114 s.. 16 G. Simmel, Forme dell’individualismo, cit., p. 44. 17 Per questo rilievo critico cfr. G. Simmel, La legge individuale, Armando, Roma 2001, p. 104 e F. Andolfi, Il non uomo non è un mostro. Saggi su Stirner, Guida, Napoli 2009, p. 120 s. 18G. Simmel , Friedrich Nietzsche filosofo morale, Diabasis, Reggio Emilia 2008, p. 96 s. 19 H. Merrell Lynd, On Shame and the Search for Identity, Routledge and Kegan Paul, London 1958, p. 49 s., pp. 207-209. 20 J.-M. Guyau (2009), Abbozzo di una morale senza obbligo né sanzione, Diabasis, Reggio Emilia.
Meditazioni filosofiche
23
“Questo libro nasce da un testo di Borges: dal riso che la sua lettura provoca scombussolando tutte le familiarità del pensiero – del nostro,
cioè: di quello che ha la nostra età e la nostra geografia – sconvolgendo tutte le superfici ordinate e tutti i piani che placano ai nostri occhi il
rigoglio degli esseri, facendo vacillare e rendendo a lungo inquieta la nostra pratica millenaria del Medesimo e dell’Altro. Questo testo
menziona «una certa enciclopedia cinese» in cui sta scritto che «gli animali si dividono in: a) appartenenti all’Imperatore, b) imbalsamati, c)
addomesticati, d) lattonzoli, e) sirene, f) favolosi, g) cani in libertà, h) inclusi nella presente classificazione, i) che si agitano follemente, j)
innumerevoli, k) disegnati con un pennello finissimo di peli di cammello, l) et caetera, m) che fanno l’amore, n) che da lontano
sembrano mosche». Nello stupore di questa tassonomia, ciò che balza subito alla mente, ciò che, col favore dell’apologo, ci viene indicato
come il fascino esotico d’un altro pensiero, è il limite del nostro, l’impossibilità pura e semplice di pensare tutto questo.
[…] Questo testo di Borges mi ha fatto ridere a lungo, non senza un certo
malessere difficile da superare. Forse perché sulla sua scia spuntava il sospetto di un disordine peggiore che non l’incongruo e l’accostamento di
ciò che non concorda; sarebbe il disordine che fa scintillare i frammenti di un gran numero d’ordini possibili nella dimensione, senza legge e
geometria, dell’eteroclito; e occorre intendere questa parola il più vicino possibile alla sua etimologia: nell’eteroclito le cose sono ‘coricate’, ‘posate’,
‘disposte’ in luoghi tanto diversi che è impossibile trovare per essi uno spazio che li accolga, definire sotto sotto gli uni e gli altri un luogo comune.
Le utopie consolano: se infatti non hanno luogo reale si schiudono tuttavia in uno spazio meraviglioso e liscio; aprono città dai vasti viali,
giardini ben piantati, paesi facili, anche se il loro accesso è chimerico. Le eterotopie inquietano, senz’altro perché minano segretamente il
linguaggio, perché vietano di nominare questo e quello, perché spezzano e aggrovigliano i nomi comuni, perché devastano anzitempo la ‘sintassi’
e non soltanto quella che costruisce le frasi, ma anche quella meno manifesta che fa ‘tenere insieme’ (a fianco e di fronte le une alle altre) le
parole e le cose […]. Le eterotopie […] inaridiscono il discorso, bloccano le parole su se stesse, contestano fin dalla sua radice, ogni
possibilità di grammatica […]. […]
Quando instauriamo una classificazione consapevole, quando diciamo che il gatto e il cane si somigliano meno di due levrieri, […]
qual è dunque l’elemento di base a partire dal quale possiamo sostenere questa affermazione con piena certezza. Su quale ‘tavola’, in base a
quale spazio d’identità, di similitudini, d’analogie, abbiamo preso l’abitudine di distribuire tante cose diverse e uguali? Qual è questa
coerenza – di cui è facile capire che non è né determinata da una concatenazione a priori e necessaria, né imposta da contenuti
immediatamente sensibili?”
Michel Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, RCS libri, Milano, 1998, pp. 5-8.
LA PRESENZA DELL’ASSENZA. FORSE.
Quaderni della Ginestra
24
uesta meditazione nasce da un testo di Foucault: dal riso amaro
che la sua lettura provoca scombussolando tutte le familiarità
della filosofia…
Quando ci si imbatte in Borges la tentazione di perdersi in molteplici
rimandi testuali e labirintiche auto-citazioni è davvero forte: piacevole
sarebbe cimentarsi in giochi di scatole cinesi, analoghi a quelli con cui
Calvino ci diletta in Se una notte d’inverno un viaggiatore, o in infiniti
“rimbalzi” tra spettacolo e spettatore, quali lo stesso Foucault riconosce
nel Velasquez di Las Meninas. Ma qui il testo “da meditare” è di Foucault
e io potrei al massimo compiacermi dell’idea di concepire una caotica
meta-meditazione sui “fantasmi filosofici” che esso evoca.
Il filosofo francese opta per un titolo terribilmente essenziale, Le
parole e le cose. Non gravitano forse attorno a questi due concetti tutto il
sapere umano e la sua filosofia? O meglio attorno alla ricerca dei relativi
ordini, quello in cui mettere le parole e quello che individua le cose,
nonché infine quello che lega le une alle altre? A sfidare tale ipotesi ecco
Borges con una peculiare enciclopedia di animali: come ogni tassonomia
che si rispetti essa dovrebbe mostrare un ordine delle cose attraverso
l’ordine di una serie di parole, ma in questo caso qualcosa non funziona.
Le parole falliscono il loro obiettivo e il pensiero s’arresta perplesso di
fronte ad una strana forma di impossibilità. Ciò che sembra impossibile
non è tanto pensare ciascuno di questi singoli gruppi di animali,
sebbene alcuni di essi creino, per esempio, paradossi
dell’autoreferenzialità; impossibile è pensarli come un tutto, immaginarsi
un locus dove possano incontrarsi, un ordine razionale di relazioni di
uguaglianza e differenza che li accomuni: la serie alfabetica fornisce
infatti solo un finto luogo della giustapposizione.
Eppure tutto ciò è dicibile! Il linguaggio nudo e crudo non sembra
infatti curarsi molto di certe difficoltà: lo scollamento, anzi la frequente
estraneità, tra verbum, intellectus e res non potrebbe essere più evidente. In
questo caso il linguaggio, oltre a donare presenza ad esseri fantastici
(come le sirene), fornisce uno spazio non-luogo in cui tali categorie
enciclopediche possono convivere e apparire, solo apparire, distinguibili:
le parole dividono l’indivisibile. Non diventa però lo spazio della
rappresentazione, della conoscibilità: relegato alla pagina e alla voce esso
non sembrerebbe in alcun modo collegabile alla realtà o al pensiero. Che
volesse avvertirci proprio di questo Borges collocando l’enciclopedia in
un luogo per noi alieno, l’esotico estremo oriente?
Non si può non notare come Foucault, insistendo sullo “spazio”,
sembri restare, almeno in parte, legato alla concezione visiva, platonica,
della conoscenza. Come egli suggerisce, siamo di fronte ad
un’eterotopia, il negativo inquietante delle consolatrici utopie, mostro
Q
Meditazioni filosofiche
25
linguistico che inaridisce le frasi e rende impossibili tutti i legami tra “(a
fianco e di fronte le une alle altre) le parole e le cose”. L’eterotopia non
consente discorsi, ma va ben oltre la falsità, ben oltre la classica colpa di
mal accordare le parole alla realtà di cui lo straniero accusa il sofista
nell’omonimo dialogo platonico. La scelte pseudo-sintattiche di Borges
impediscono l’auspicabile aggancio delle parole tanto con le cose
quanto soprattutto con il pensiero: neppure la fantasia riesce a gestire
tale classificazione.
Forse si potrebbe attribuire ad un ipotetico autore Foucault-Borges il
tentativo di ridicolizzare, evidenziandone la potenziale inefficacia, la
quasi maniacale ansia di trovare definizioni che pervade la filosofia
occidentale. Risulta infatti evidente come per possedere un oggetto con
il pensiero non sia sufficiente catalogare e specificare, come non basti
dare biblicamente un nome alle cose per renderle epistemologicamente
proprie. Ma ancor più interessante è notare come la sottolineatura
dell’eterotopia evidenzi una latitanza, illumini il vuoto lasciato in questa
turba di animali da un assente fondamentale, il principio d’ordine.
Ordinare significa, per Foucault, distinguere il “Medesimo” dall’“Altro”.
La classificazione di Borges rende però impossibile una simile cesura,
mostrandone al tempo stesso la necessità epistemologica. L’ovvio, il
consueto, paradossalmente si manifesta solo nel momento in cui è
sottratto alla vista: in questo caso non si scorge da nessuna parte
l’ordine in base al quale gli animali sono stati separati. È davvero
scomparso o piuttosto non c’è mai stato? Esattamente come accade nel
dipinto Las Meninas per l’oggetto-soggetto di rappresentazione, cioè i
sovrani di Spagna, il brano di Borges mette in risalto, non mostrandolo
o meglio mostrando gli effetti della sua mancanza, ciò di cui Foucault
andrà alla ricerca per le quattrocento e oltre pagine della sua opera. Sarà
“archeologia” proprio perché egli sembra voler disseppellire, far
emergere, ciò che il tempo e i sedimenti dell’abitudine, della cultura e
dell’inconscio hanno coperto: l’ordine o meglio gli ordini, le strutture
dell’episteme, del sapere, ciò senza il quale non potremmo pensare e
conoscere. La sua aspirazione è osservare l’ordine nel suo essere grezzo,
i suoi modi d’essere, i modi con cui la sua presenza si è manifestata nella
nostra cultura, in base a quali a-priori si è costituito il sapere.
Questo peculiare ruolo dell’ordine, o del principio d’ordine, richiama
almeno in parte la celebre allegoria della Repubblica: così come per
Platone non è possibile distinguere e conoscere gli oggetti del sapere
senza la “luce” del Bene, per Foucault pare essenziale la presenza
dell’ordine. L’analogia potrebbe estendersi anche a moralità ed estetica?
Forse no, ma più fondamentale mi pare chiedersi se l’ordine contenga
un barlume di valore ontologico. Pur essendo solo uno tra i possibili
Meditazioni filosofiche
27
ordini, non è casuale o arbitrario ma è “quello che ha la nostra età e
la nostra geografia”. Pare quindi qualcosa di più di un semplice schema
o categoria mentale. Non è forse la realtà in cui siamo costantemente
gettati e immersi fin dall’inizio? Non è qualcosa di paragonabile alle
aperture, alle radure dell’essere di cui parla Heidegger? Sulla scia di
quest’ultimo accostamento si potrebbe anche supporre non solo il
profondo legame dell’ordine con il linguaggio, ma addirittura la loro
fondamentale coincidenza.
Procedendo su questa via di “meditabondo travisamento” del
pensiero di Foucault posso forse azzardare anche una maggiore deriva
critica: forse il filosofo francese si inganna e la mancanza di un principio
d’ordine, che distingua differenza e uguaglianza, è solo apparente.
Possiamo noi realmente concepire discorsi senza una coerenza?
Potrebbe Borges averci trasmesso qualcosa senza un ordine? Perché ha
suddiviso gli animali in un certo modo e non altrimenti? In realtà
l’eterotopia dello scrittore argentino potrebbe essere solo il risultato di
una somma di principi d’ordine parzialmente sovrapposti,
indipendentemente dal fatto che egli ne sia stato consapevole. Forse
all’ordine non si sfugge.
Possiamo inoltre chiederci se possa esistere un discorso che non
corrisponda ad un pensiero, parole che creino l’impensabile.
Sicuramente possono creare qualcosa al di fuori del nostro attuale
concetto di razionalità, qualcosa di incommensurabile con i nostri
abituali schemi mentali, ma non credo impensabile. Siamo realmente di
fronte solo ad una relazione tra parole e parole anziché tra linguaggio e
pensiero? Ha forse Borges scritto tali definizioni a sua insaputa, senza
che il suo pensiero lucido ne costituisse il luogo comune? In ogni caso
se anche le sue parole fossero frutto dell’inconscio, ciò non
significherebbe che sono impossibili e impensabili. Chi non ha
sperimentato sogni nei quali gli abituali criteri di logica e
consequenzialità risultassero in crisi, nei quali fosse, almeno
all’apparenza, impossibile riconoscere un ordine? Credo sia riduttivo
limitare il pensiero alla razionalità accettata e condivisa, all ’ordinato o,
meglio, ordinabile. Probabilmente “ci sono più cose in cielo e in terra,
[Foucault], di quante ne sogni la tua filosofia”! Inoltre un qualche
elemento extra-testuale comune tra noi lettori, Borges e questa
enciclopedia deve pur esserci per giustificare la comunanza degli effetti,
cioè il riso o il disagio.
Proprio questi particolari “effetti” suscitano un ulteriore
interrogativo, benché forse marginale: da quale meccanismo interiore
deriva il disagio di cui parla Foucault? Dalla sorpresa o dalla necessità di
compensare una qualche profonda esigenza? Perché ne va della nostra
Quaderni della Ginestra
28
serenità se non riusciamo a scorgere l’ordine, se ci sfugge la possibilità
di distinguere il medesimo e l’altro? Perché questa anxietas definiendi
secondo un criterio preliminare? Perché risulta insopportabile il
paradosso di Menone riguardo alla ricerca della conoscenza ma non
l’altrettanto paradossale circolo ermeneutico che richiede sempre un già
compreso, un punto di partenza? Perché l’eterotopia ha effetto sulle
nostre emozioni? Mi affascina la valenza antropologica ed esistenziale di
una questione all’apparenza puramente epistemologica: ma su tutto ciò
non pare soffermarsi Foucault. Non saprei neppure decidere se questo
trapasso sia a sua volta una meta-struttura dell’episteme culturale
occidentale o caratterizzi ogni cultura.
Scusandomi per la brusca variatio mi concedo infine un ultimo
tentativo di riflessione, sollecitato da questo splendido caso di utilizzo
filosofico di opere d’arte che, nel caso di Foucault, diventa
“archeologia” culturale: le sue speculazioni procederanno infatti
attraverso Las Meninas di Velasquez e il Don Chisciotte di Cervantes. Mi
pare che tale approccio, comune anche a molti altri filosofi
contemporanei, possa essere letto come una modalità forse insolita di
avvicinare la filosofia alla scienza. Così come la scienza empirica
procede per singoli esperimenti, singoli eventi, l’arte e la letteratura
offrono alla speculazione filosofica aperture altrimenti impossibili su
vite particolari, realtà contingenti. A partire da queste individualità
filosofia e scienza possono, in un secondo momento, raggiungere il
livello teorico e generalizzante, sebbene con metodologie, almeno
all’apparenza, piuttosto differenti. Non so se questa possa essere una
strada per avvicinare o cogliere le analogie tra arte e scienza, ma
sicuramente lo è per diminuire la distanza tra la cosiddetta filosofia
ermeneutica e la filosofia analitica, così legata alla scienza. In tal modo si
spiegherebbe anche perché tale modalità speculativa, che parte da opere
d’arte, sia così cara a filosofi di formazione analitica, seppur
successivamente divenuti “eretici”, come R. Rorty o S. Cavell:
sopravvive in loro il legame con un metodo scientifico ancorché
rivisitato, dove l’arte è il laboratorio della filosofia.
ANTONIO FREDDI
Meditazioni filosofiche
29
“Davvero io cercai di aiutare in un modo o nell’altro i sofferenti: ma mi è sembrato di far cosa migliore, quando imparavo a meglio gioire. Da
quando vi sono uomini, l’uomo ha gioito troppo poco: solo questo, fra-telli, è il nostro peccato originale!”
(F. NIETZSCHE, Così parlo Zarathustra, Milano, Adelphi, 1992, p.97).
“Tutto dovrai sopportare, prima di ritornare qui. Ci sarà molto da lavo-rare. Ma io sono sicuro di te, ed è perciò che ti mando. Cristo è con te,
custodiscilo in te, ed Egli ti custodirà. Conoscerai un grande dolore e nel dolore sarai felice. Eccoti il mio testamento:nel dolore cerca la felici-
tà.”
(F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, Milano, Bompiani, 2005,
pp.169-171).
a domanda sulla felicità è, fra i temi indagati dalla riflessione filo-
sofica, una delle questioni più ricorrenti e determinanti. Non cre-
do possa essere diversamente: l'esperienza della felicità, di uno stato ori-
ginario e positivo della mente e del sentire è del resto un’ esperienza u-
niversale che, anche quando sfugge a tutti i tentativi di definizione lin-
guistica, è sempre presente ai nostri desideri, ne informa i contenuti e ne
rappresenta l' esito.
Per quanto scarna, insufficiente e pretenziosa possa essere la nostra
capacità di elaborare un sapere compiuto intorno alla felicità, e per
quanto siano diversi i beni e gli oggetti in cui crediamo di trovarla – A-
dorno, del resto, diceva che non si ha la felicità, ma ne si è immersi e
circondati- la storia del pensiero è ricca di immagini della felicità costrui-
te a partire da alcuni elementi costanti: il suo carattere transitorio, la sua
capacità – almeno nella sua forma piena ed espansiva, la gioia- di so-
spendere il fluire del tempo e la sua relazione con il sentimento oppo-
sto, il dolore.
Tra le immagini più suggestive a mio avviso rientrano quelle propo-
ste da Nietzsche e da Dostoevskiij perché, nella diversità dei contenuti,
mostrano come il tema della felicità, delle sue modalità e declinazioni
speculative sia inevitabilmente intrecciato con una presa di posizione di
fronte alla trascendenza e a alla fondazione dell'etica: mentre Nietzsche
L IL TEMPO E LA PIENEZZA DELLA GIOIA: UN CONFRONTO
NIETZSCHE-DOSTOEVSKIJ
Quaderni della Ginestra
30
tende ad affermare che la felicità sia sperimentabile solo in un orizzonte
di senso saldamente innestato nella finitezza in cui le concezioni del be-
ne e del male sono storicamente determinate, Dostoevskij, di fronte alla
presenza pervasiva del dolore, tende a risolvere la questione della felicità
nella dimensione metafisico-religiosa del rapporto con il divino. Il narra-
tore e il filosofo, con la forza del loro pensiero poetante, mettono in e-
videnza come la ricerca della felicità illumini la domanda sul significato
dell'esistenza ed offrono proposte che si impongono all'attenzione
dell'uomo contemporaneo, alla sua decisione di circoscrivere il senso del
vivere nello spazio del finito o di aprirsi ad un discorso di intonazione
religiosa. Per questo, pur tracciando direzioni opposte, le prospettive i-
naugurate da Nietzsche e Dostoevskij costituiscono una sorta di riferi-
mento obbligato per chiunque voglia seriamente interrogarsi sulla plura-
lità di significati che attribuiamo alla parola felicità e su come la nostra
idea della gioia determini le nostre convinzioni morali.
Secondo Nietzsche la beatitudine, la gioia compiuta e perfetta -die Se-
ligkeit- è qui, nello spazio del mondo vero e terreno, preparata per quanti
non pongono la vita sotto giudizio e non interrogano, né interpretano
l'esistenza secondo i criteri del bene e del male, ma si pongono in modo
attivo nei suoi confronti, ne accettano la radicale mancanza di senso e
orientano la propria ricerca della felicità nei territori finiti e disponibili
della corporeità e dell'istintualità. Un atteggiamento sano e generoso si
basa, dunque, su alcuni presupposti fondamentali:il riconoscimento del
carattere finito dell'esistenza, la capacità fondativa di creare valori basati
sulla forza e la consapevolezza che ogni attesa di compimento sia desti-
nata ad incontrare il proprio limite solo nella natura. Coloro che espri-
mono questo atteggiamento sono chiamati, nel testo, più esplicito e ri-
solutivo rispetto a Così parlò Zarathustra, della Genealogia della morale, gli
eletti, gli aristocratici: per loro la gioia è più originaria del dolore.
A tradirci, invece , a farci perdere la possibilità di conseguire una gio-
ia continua e perfetta è un'eccedenza del desiderio. Un'eccedenza che
non si esprime nei toni prevedibili dell'eccesso e della sovrabbondanza,
ma si mostra con i tratti della dismisura e del disorientamento. Un'ecce-
denza, in altri termini, che altera la direzione originaria e la destinazione
della nostra attività desiderante -naturalmente situata nel territorio della
contingenza e della finitezza- e che si rivela come tensione alla trascen-
denza o, secondo il linguaggio proprio di un sentire radicato nelle pro-
spettive e nei contenuti della teologia cristiana, come ricerca di un aldilà,
di una vita ulteriore in cui il compimento e la perfezione – altri termini
che definiscono la felicità come stato risolutivo del desiderio- sono fatti
spirituali, realizzati nelle dimensioni della contemplazione e dell'unione
con il divino. Questa declinazione del desiderio, giudicata in autentica
Meditazioni filosofiche
31
perché fondata sulla superiorità dello spirito sul corpo, del soprannatu-
rale sulla natura è considerata da Nietzsche l'espressione di un risenti-
mento e di un' impotenza nei confronti della vita che ritirano la nostra
ricerca della gioia dal contesto vitale della salute e la costringono a rifu-
giarsi nella dimensione fuorviante della salvezza. Tale patologia –dato
che i valori, gli orientamenti che definiscono il bene e il male, che rico-
noscono la gioia e il dolore sono produzioni culturali- ha una precisa o-
rigine storica nel conflitto che oppone la civiltà romana a quella ebraica
e al risultato del suo processo di universalizzazione, il cristianesimo.
Il sistema valoriale della civiltà romana consiste principalmente in un
ethos del coraggio, dell'affermazione di sé e dell'istinto di dominazione.
Il sistema valoriale ebraico insiste, invece, sulla passività, sulla quiete e
sulla compassione. Mentre l'organizzazione valoriale romana asseconda
la vita, affermandone con forza la ricchezza contraddittoria e conflittua-
le, l'organizzazione valoriale ebraica e cristiana esalta il dolore, risolven-
do le proprie istanze di realizzazione nelle prospettive di una vita ultra-
terrena.
Affermare dunque, come fa Nietzsche, che la gioia è più originaria
del dolore significa, in fondo, liberarsi della difficile eredità ebraica e cri-
stiana e riproporre un'esperienza del vivere in cui la gioia appare la tona-
lità emotiva di una istintualità in accordo con la natura.
Specularmente opposto è l'orientamento di Dostojevskij la cui narra-
zione, peraltro precedente di qualche anno rispetto alle riflessioni del fi-
losofo, si pone idealmente come voce contraria ai temi proposti da Nie-
tzsche.
E', in particolare, un dialogo dei Fratelli Karamazov sembra contrastare
le posizioni di Nietzsche: in una sorta di testamento spirituale lo starec
Zosima invita il giovane Alesa a compiere la sua opera nel mondo, a cercare,
custodito da Cristo, nel dolore la felicità.
Per Dostoevskij, che afferma un cristianesimo tragico la cui densità
PAESAGGIO DI LUCE, AUSTRALIA, 2011
Quaderni della Ginestra
32
speculativa è stata con merito indagata dalla riflessione ermeneutica del
secondo Novecento, la gioia e il dolore sono, se non cooriginari, com-
presenti e coabitano la realtà dell'uomo, riflessi di un bene e di un male
cui il narratore-filosofo assegna una dignità ontologica prioritaria.
Significativa, specie nel confronto con Nietzsche, è l'immagine che
Dostoevskij propone dell'istintualità, considerata non come luogo di li-
berazione, ma di distruzione, in cui la libertà dell'uomo è esposta al suo
precipitare, alla possibilità di scegliere il male che è, in ultima analisi, la
sofferenza inflitta ad altri. Si può dire, anzi, dei personaggi di Dostoe-
vskij – si pensi, ad esempio, a Stavrogin nei Demoni- che quanto più so-
no caratterizzati da una personalità orientata dal desiderio di autoaffer-
mazione, tanto più sono sensibili alla passione per la violenza e la cru-
deltà.
Rispetto al tema dell'istintualità, della parte naturale dell'uomo che si
esprime in via prioritaria come volontà incontrastata, appare evidente la
differenza di prospettive fra Nietzsche e Dostoevskij: per Nietzsche è
l'affermazione della vita, della sua forza rigogliosa; per Dostoevskij è
l'ambivalenza della vita che comprende lo sviluppo ipotetico della pro-
pria negazione.
Ma c'è ancora un'altra differenza, ancora più significativa, che riguar-
da le relazioni che intercorrono fra il bene e la gioia ed il male e la soffe-
renza. Se, come abbiamo visto, Nietzsche tende ad affermare l'inconsi-
stenza del bene e del male, Dostoevskij considera il male e il bene, la
gioia e il dolore come attraversati da una tensione dialettica: la sofferen-
za e il dolore che derivano dal male possono condurre al riconoscimen-
to del bene se riescono a mostrare il vincolo di solidarietà e di respon-
sabilità originaria che unisce tutti i viventi. In altri termini, all'interno di
un discorso narrativo che si svolge come approfondimento dell'espe-
rienza religiosa cristiana, Dostoevskij tende a individuare nella sofferen-
za, principalmente nella sofferenza accettata, la realizzazione di
un’esperienza di compassione e di corresponsabilità. In questo senso,
Dostoevskij articola la propria riflessione distinguendo fra la sofferenza
inutile –quella dei bambini, ad esempio- riscattabile solo in una prospet-
tiva di fede, e la sofferenza consapevole di chi vuole soffrire con altri e
al posto di altri: la gioia, in questo caso, è sperimentata nel soffrire in-
sieme e nel fare propria la sofferenza degli altri. Secondo Dostoevskij
non c’è, dunque, possibilità salvezza e di felicità che non passi attraverso
lo scontro con il male e con la sofferenza: la gioia è, comunque, come il
bene, originaria, ma è costretta, nella finitezza e nella contingenza, a mi-
surarsi con la presenza ineluttabile del male e del dolore.
Il rilievo attribuito alla trascendenza, l’adozione di un orizzonte di
senso esplicitamente cristiano –soffrire con altri è possibile nell’esempio
Meditazioni filosofiche
33
del Cristo sofferente- la coincidenza della gioia con la compassione
sembrano porre una distanza incolmabile fra la meditazione di Dostoe-
vskij e quella di Nietzsche, che,tuttavia, condividono un nucleo origina-
rio che le rende molto più vicine di quanto possa apparire superficial-
mente: la passione per l’uomo, l’attenzione alla sua costitutiva comples-
sità e la capacità di non trascurarne gli aspetti prerazionali. Ed è nel se-
gno di questa passione, che le riflessioni dei due autori si integrano reci-
procamente e stabiliscono un punto di riferimento comune sia per chi
vede esaurirsi nella natura il nostro essere persone, sia per chi colloca il
nostro abitare la terra negli spazi della trascendenza: il pensiero di Nie-
tzsche con la tematizzazione degli aspetti primitivi della nostra ricerca
della felicità, la narrazione di Dostoevskij con la rappresentazione della
dimensione relazionale in cui sperimentiamo la gioia.
LIVIO RABBONI
Cinema e filosofia
35
migliori blockbuster hollywoodiani sono quelli che contengono
pregnanti raffigurazioni e diagnosi del nostro tempo storico, sociale
e politico. La trilogia di Christopher Nolan dedicata alla leggenda di
Batman, e in particolare il suo capitolo conclusivo, può confermare di
certo questa tesi. Il momento centrale di The Dark Knight Rises, quando
tutti i prigionieri sono liberati e si apprestano a “prendersi la città”,
metterebbe addirittura in scena, secondo Zizek, potenzialità e debolezze
del movimento noto come Occupy Wall Street
(http://www.newstatesman.com/2012/08/people’s-republic-gotham).
Il suo leader, qui, è il terrorista Bane (caricatura di un black bloc
sadomaso, ma anche inguaribile romantico), che rende esplicita questa
idea di autodeterminazione democratica all’interno di uno stadio
sportivo gremito.
Come commenta giustamente Zizek, la rappresentazione di Nolan
serve a dare corpo e voce alla paura dei liberali di destra e di sinistra nei
confronti della possibilità che il tanto celebrato 99% s’impadronisca per
davvero di Manhattan. È interessante come in quest’ultima
riappropriazione del multi-rappresentato mito dell’uomo-pipistrello
l’iperbole distopica non si applichi più alle condizioni di vita di una
società ultra-capitalistica, bensì alla sua alternativa rappresentata dalla
democrazia radicale e dall’empowerment popolare. In un tratto innovativo
nella saga batmaniana, Gotham City non è più la capitale marcia fino al
midollo di un impero in piena decadenza, bensì una New York luminosa
e florida, che viene attaccata da un nemico esterno e degenera poi nel
caos anarcoide post-rivoluzionario. Ora il vero cattivo è, tra l’altro, una
donna: Miranda/Talia, la figlia del vecchio maestro di Batman Ra’s.
(Questi, come si ricorderà, era il prototipo del fanatico religioso
intellettualoide, prima legato ai cinesi e ora agli arabi.) Riappropriandosi
del progetto paterno votato alla purificazione dell’intera civiltà
occidentale, Talia si allea subdolamente sia agli emarginati del sistema sia
alle élite economiche.
OWS, terroristi mediorientali, New York come capitale
dell’Occidente, ma anche la minaccia nucleare: l’ultimo Batman non
potrebbe essere più radicato nel nostro tempo. Così radicato che, in
un’inquietante inversione tra realtà e finzione, molti osservatori hanno
paragonato la New York attuale devastata dall’uragano Sandy proprio
alla vecchia Gotham City (a quella in disfacimento del periodo pre-
nolaniano, però). Di quest’ultimo Cavaliere oscuro può essere fatta
emergere allora sia la sua funzione propagandistico-ideologica (in senso
I
UN ALTRO MITO DELLA CAVERNA: LA FORZA DELLA
LEGGE IN BATMAN
Quaderni della Ginestra
36
anti-anarchico e anti-socialista), sia il suo contenuto “realista” – lo
scenario macabro e fantastico, presente soprattutto nelle versioni di Tim
Burton (Batman, 1989, Batman Returns, 1992), ha dato il via libera alle
ansie e proiezioni del contemporaneo. Entrambi gli aspetti hanno reso
The Dark Knight Rises indigesto sia per chi è impegnato in qualche
battaglia sociale di emancipazione che per i bat-fan tradizionali. La
riflessione sulla “politica” di Batman ha però anche un altro aspetto, più
fondamentale. La questione centrale in questa saga è, infatti, quella del
fondamento del sistema socio-politico.
Una società sta in piedi e funziona in quanto ordine normativo, cioè
perché basata su un insieme di convenzioni, valori, leggi, più o meno
istituzionalizzate, che regolano e orientano la vita collettiva dicendo a
ciascuno cosa deve fare. Per svolgere la funzione normativa, l’ordine
deve essere accettato in buona parte come legittimo e giusto. Ma che
cosa legittima la legittimità? Sulla base di quale criterio, principio o
fondamento si può dire che un insieme più o meno istituzionalizzato di
norme e leggi è giusto e deve essere seguito? Risposte molto diverse
sono state date nella storia dell’umanità a tale questione. Mi sembra che
il mito di Batman si ponga in quella tradizione secondo la quale il
fondamento dell’autorità della legge è un fondamento, appunto, mitico,
o “mistico” (come direbbero Pascal o Montaigne). L’autorità dell’ordine
normativo si fonda cioè su qualcosa che non è del tutto razionale e
razionalizzabile, giustificato o giustificabile. L’ordine si regge in ultima
analisi sul credito che gli si accorda, sul fatto che vi sia una radicata
credenza nella giustizia di tale ordine, una credenza che giustifica, cioè
rende giusta, anche quella forza e quella violenza che serve a un ordine
normativo (per esempio all’ordine giuridico) per imporsi e far
funzionare la società. Significa questo forse affermare l’irrazionalità della
società, l’arbitrarietà dell’autorità, e infine il trionfo della cosiddetta
“legge del più forte”?
Secondo quanto sostenuto da Derrida nel breve saggio Force de loi
(1994), non è questa la conclusione da trarre. La “misticità” della
giustizia, ovvero il suo fondamento “senza fondamento”, deve essere
spiegato in altro modo. La giustizia è l’ordine basilare che, imponendosi,
pone i criteri stessi in base ai quali è possibile distinguere giusto da
ingiusto, legittimo da illegittimo. Di tale giustizia non si può dire se sia
giusta o meno, perché essa non è fondata su qualcos’altro, piuttosto è
fondante, fonda cioè l’ordine giusto.
Questa concezione del fondamento dell’ordine normativo in una
giustizia infondata potrebbe essere vista come una sorta di ribaltamento
del mito platonico della caverna: mentre in Platone le budella della terra
simboleggiavano l’errore e l’illusione, da illuminarsi attraverso la luce
Cinema e filosofia
37
veritiera proveniente dall’esterno, nella visione derridiana l’oscurità in
cui vero e falso, giusto e ingiusto sono indifferenziati e si confondono
assume la funzione normativa basilare. (La metafora dell’ombra come
base del politico compare esplicitamente anche nell’ultimo 007, Skyfall -
il regista Mendes si è del resto dichiaratamente ispirato a The Dark
Knight). Batman è l’allegoria di questa concezione anti-platonica, è un
altro mito della caverna. Il potere di Batman trova la sua origine
sottoterra, dove il male, la sua angoscia più profonda (i pipistrelli)
vengono fronteggiati e fatti diventare parte di sé. Tipica di Nolan la
curvatura soggettivo-psicanalitica di questo intreccio: la possibilità di
diventare un soggetto autonomo, che agisce bene per se stesso e per la
comunità ed è così capace di esercitare il suo potere, non risiede nella
rimozione del male, bensì nella sua assunzione piena e consapevole. La
“bontà” dell’eroe non è però separabile dal suo opposto. Importante
ricordare che, in Batman Begins (2005), è proprio Ra’s a insegnare come
“diventare un tutt’uno con l’oscurità” – ed è per questo che Batman
dovrà poi opporsi al suo maestro, che contrariamente all’intima essenza
dei suoi insegnamenti, crede in una “true justice” pura e incontaminata.
Batman può essere considerato come il pilastro dell’ordine sociale
cui appartiene. Un pilastro la cui ambiguità diventa evidente soprattutto
nel secondo film, The Dark Knight (2008). Si consideri soprattutto il suo
rapporto con Harvey Dent, il cavaliere speculare, biondo e idealista:
dopo un continuo e snervante scambio di ruoli tra i due, quest’ultimo
fallisce e viene ridotto alla rappresentazione corporalmente più esplicita
del doppio volto. Significativa è ovviamente anche la “fratellanza” tra
Batman e Joker, dove l’uno non sarebbe pensabile senza l’altro – anche
se Joker rappresenta l’impossibilità dell’ordine di giustizia, e Batman la
sua condizione.
È vero che, nell’ultimo film, i conflitti che hanno caratterizzato tutta
la saga si attenuano, e il confine tra bene e male appare più netto. Alla
fine, autosacrificandosi per il bene dell’umanità, Batman impone la sua
positività. Anche la polizia, ora schierata senza remore dalla sua parte,
può finalmente abbracciare il ruolo (ideologico) di difesa dell’ordine
giusto. Ma la doppiezza è ancora presente: innanzitutto, nel legame
erotico-sentimentale che lega l’uomo-pipistrello alle sue due nemiche, e
soprattutto nel fatto che non è solo Batman a mostrare un doppio volto,
ma anche Bruce Wayne. Bruce non è solo un filantropo che si allena per
diventare supereroe, è anche playboy maschilista e capitalista finanziario
a capo di una mega-corporation quotata in borsa e coinvolta nel traffico
d’armi. Il lato “oscuro” di Batman non sta dunque solo nella caverna
pullulante di pipistrelli, ma anche nelle alte vette dei suoi palazzi vetro; il
male contro cui combatte Batman è un male provocato da un sistema
Quaderni della Ginestra
38
cui lui stesso è a capo.
Ma consideriamo ancora il finale, da molti considerato un banale
happy end, in cui Batman si sacrifica per il bene dei suoi concittadini. O
forse questa è solo un’utile finzione per stabilizzare l’ordine di giustizia?
Mentre Batman, forse, si gode altrove la vita con la sua ragazza (ex
Catwoman), a Gotham City/New York viene eretta la sua statua – viene
istituita la leggenda – e contemporaneamente un nuovo giovane (ex
poliziotto) scende nelle sue caverne. È un buon finale, in effetti, perché
rimane ambiguo. Forse Batman è davvero morto, e il flash di
conciliazione romantica e individualista rimane un sogno del
maggiordomo: ma l’indecidibilità (sacrificio vero o fasullo?) è proprio
ciò che fa del fondamento dell’ordine un fondamento mistico, che si
sottrae a ogni fissazione definitiva. È un buon finale, inoltre, perché
rimane aperto: che Batman sia morto o meno, per la città e per ciascuno
dei suoi abitanti inizierà ora una nuova vita.
Ecco dunque il senso del vero happy end, cioè l’indecidibilità e
l’apertura. Come spiega Derrida in Force de loi, l’infondatezza del
fondamento è ciò che apre a un futuro imperscrutabile, dove tutto (o
quasi) è ancora possibile. L’oscurità da cui emerge l’ordine di giustizia
può avere un significato liberatorio: se ciò che vale come giusto e
legittimo non è, in fondo, fondato, esso non è neanche fissato in modo
definitivo. In questo modo si previene ogni dogmatismo, e la
mummificazione dell’ordine esistente: il futuro va verso scenari che non
sono prevedibili e immaginabili ma che racchiudono la premessa del
poter essere altrimenti.
FEDERICA GREGORATTO
Letteratura e filosofia
41
are opportuno annoverare Perec tra quegli scrittori ai quali risulta
difficile avvicinarsi prescindendo da un approccio biografico.
Quest’ultimo rivela quel fondo di continua interrogazione sull'esistenza
proprio del romanziere francese. Se le opere in quanto opere sono
tracce e, come tali, segni, nel momento in cui sono tracciate, segnate,
assumono un’esistenza autonoma e indipendente; nel nostro caso,
tuttavia, recano ancora l’impronta appassionata del loro artefice. Il tutto
si complica quando si riscontra che questi segni stanno non per una
presenza, ma per un’assenza, un vuoto che nell’arco di un’intera vita
non verrà mai colmato. La tematica del vuoto e della mancanza
appaiono fondamentali per la lettura delle opere perecchiane e
costituiscono la chiave di volta di una produzione eterogenea ma mai
totalmente altra dalla dimensione esistenziale e autobiografica.
La storia di Perec prende le mosse da uno dei drammi della storia più
struggenti e incomprensibili: la Shoah. Figlio di ebrei polacchi emigrati in
Francia, perde il padre nelle prime fasi del conflitto con la Germania e la
madre, deportata a Drancy e poi ad Auschwitz. Egli scampa al peggio: la
madre lo salva facendolo partire per la zona non occupata. Ad
aspettarlo gli zii, i convitti in cui nascondersi, lo smarrimento. E così la
perdita della memoria. Perec non ha ricordi d’infanzia. Vernichtung dei
genitori, dei nonni e di un’origine: perché i ricordi dell’infanzia sono la
sostanziazione di chi siamo. La scrittura di Perec non si allontana mai da
questo trauma infantile e muove in un cammino di ricerca identitaria in
cui ritrovare l’appartenenza, il ricordo, in cui conciliare un modo
d’essere forzatamente diasporico con un’esigenza di raccordo e di unità
destinata, tuttavia, a non trovare mai appagamento.
Con l’epilogo di una doppia sparizione, la vita di Georges Perec fu
segnata per sempre da un annientamento inutile che i cosiddetti “figli
del dopo”, gli orfani della Shoah, non furono mai in grado di superare.
Nessuno rivelò a Georges della morte del padre e dell’estrema
preoccupazione, poi tramutata in certezza, della morte della madre.
Nessuno si sentì di sottoporre il bambino all’ennesimo choc: Questo non
consentì alcuna elaborazione del lutto. I religiosi del convitto imposero
a Perec delle regole ferree: non chiedere notizie dei genitori o di parenti,
non lasciar trasparire qualsiasi riferimento all’ebraismo. In poche parole
un oblio totale, forse non necessario, comunque avvenuto. Georges
rimosse il ricordo del viso della madre. Al suo posto uno spazio vuoto.
I passi delle opere di Perec si allineano in una “contrada” di cui egli
ha cercato prima di trovare poi di depositare le tracce, la “via”. Il vuoto
P
GEORGES PEREC E W O IL RICORDO DELL’INFANZIA: L’INASSUMIBILE
Quaderni della Ginestra
42
memoriale è in questo caso la contrada del pensiero che non può
concretarsi in sistematicità e metodo ma nell'apertura in cui rispondere
affermativamente alla domanda sul linguaggio, in cui tentare di ritrovare
la via e in cui ritrovarsi attraverso la traccia, la scrittura.
A partire dalle riflessioni sull’identità all’interno del testo Soi-même
comme un autre di Paul Ricoeur, si può avanzare una proposta di categorie
interpretative, ovviamente in chiave ipotetica e problematica. Perec
manca, a causa della frattura originaria della propria biografia, della
dimensione che Ricoeur chiama medesimezza, cioè la possibilità di
individuazione di un “carattere” e di tratti riconoscibili che aprono
all’identità del sé nel senso di ripetibilità e riconoscibilità dello stesso
(même): Perec può compiere l’atto di ripetizione della ricerca di una
medesimezza, senza che l’operazione porti a qualcosa di compiuto. In
Perec vi è un ipse che promette di ri-trovare l’appartenenza e la
medesimezza ma, nel suo procedere, questo moto si risolve in una
frustrazione o in piccoli momenti di contatto subito fuggenti. Perec
interroga e si interroga in una situazione di interlocuzione (ipse) con i
propri personaggi e con l’altro uomo, che è per lui fonte di apertura nei
confronti del passato e del presente, per identificare e identificarsi (idem).
Se questa interrogazione non dà una possibilità di risposta, è comunque
un movimento etico dalla profondità salvifica in senso esistenziale: il
semplice porre una domanda sulla propria identità, unito allo sforzo
verso di essa, è un’azione “piena”; in quanto azione, è ascrivibile a un
agente. I personaggi di Perec sono un tentativo verso l’idem, la
riconoscibilità, l’appartenenza, il cogliersi come corpo tra i corpi, allo
scopo di identificare e re-identificare qualcosa di sé attraverso l’altro. In
questa prospettiva, si coglie il legame tra il sé e l’altro, tra il sé e l’identità
narrativa (il primo altro, per Perec, è il personaggio dei propri romanzi).
Nello spazio dell’identità, l’atteggiamento di Perec è consciamente più
tensivo che definitivo nei confronti della verità. L’identità narrativa è
stata una fonte di salvezza.
Silenzio… La creazione negativa di Perec scaturisce dalle ceneri di
Auschwitz e per questo fa appello a un non detto, all’indicibile
instancabilmente cercato ma inevitabilmente sfuggente. L’arte sottile di
Perec passa per questo dialogo tra il detto e l’indicibile, tra la memoria e
l’oblio, la vita e la morte, la fiducia e lo sconforto. Ci si sente coinvolti in
un percorso umano che si deve condividere.
La parola, il fare artistico non totalizzano, non esauriscono, ma
attingono a uno sfondo aperto nel quale si può per lo meno cercare di
porre delle domande; a volte un azzardo di risposta è donato. Perec
dona molto. In primo luogo, la sua Storia.
All’età di nove anni circa, a distanza quindi di tre anni dalla
Letteratura e filosofia
43
separazione della madre, la scoperta: il dramma della Shoah e la terribile
fine della madre gli sono disvelati attraverso una delle prime mostre
fotografiche sui campi di concentramento.
W o il ricordo d’infanzia rappresenta il testo più accurato e struggente
in relazione al tema della biografia, dell’infanzia e del vuoto di Perec. Il
carattere testimoniale è associato a una sorta di auto-analisi psicanalitica
che, a distanza di vent’anni dall’accaduto, offre a Perec una possibilità di
affrontare il rimosso, l’indicibile. Se da questo processo non si
otterranno grandi risultati – dalla cenere della memoria non si può
ottenere altro che cenere o poco più – ciò che conterà sarà quello
slancio in avanti, quel bisogno di fare i conti con i propri fantasmi, con
una verità celata ma presente, anche se in negativo. W lascia interdetti, il
dolore sotteso è comunicato con un distacco apparentemente
impersonale, ma è proprio questa distanza, più obbligata che frutto di
una scelta letteraria, a sottolineare il dramma, la tragedia, il naufragio
della Storia.
W o il ricordo d’infanzia è un piccolo libretto costituito da quattro parti.
La prima sezione della prima parte consiste in un romanzo di avventura:
narra di un disertore che, grazie a una sorta di società segreta, assume il
nome fittizio di Gaspard Winckler (il collegamento è al tema
dell’orfanità: il nome Gaspard è una sorta di alter ego di Perec e ricorre
più volte nelle sue opere. Il riferimento è a Kaspar Hauser, il ragazzo
selvaggio che aveva impressionato un’intera generazione di intellettuali,
in particolar modo Verlaine) e riceve l’incarico da parte di un certo Otto
von Apfelstahl di salvare il vero Gaspard Winckler, un bambino affetto
da mutismo elettivo che aveva fatto naufragio e del quale erano state
perse le tracce. Si noti come Gaspard Winckler-adulto debba salvare
Gaspard Winckler-bambino esattamente come Perec-adulto debba
salvare Perec-bambino dall’oblio e dal vuoto infantile. Inoltre si parla di
un naufragio, così come aveva fatto naufragio la storia personale di
Perec, assieme alla Storia vera e propria. Il Gaspard Winckler-bambino è
sordomuto, condizione che ricorda quella di Perec-bambino, distrutto
dalla separazione della madre, incapace e impossibilitato a comunicare
questo dolore.
La seconda sezione della prima parte si propone invece di ricostruire
l’infanzia di Perec dai primissimi ricordi o eventi fino al giorno della
partenza e della separazione definitiva dalla madre. Struggente l’incipit
di questa sezione «Non ho ricordi d’infanzia»1. La volontà
autobiografica appare dapprincipio destinata a una sconfitta. Il vuoto
non sarà colmato. Rimane tuttavia un’ostinata volontà a riempire questo
spazio. L’infanzia di Perec è un vuoto, una dimensione del tutto
sbriciolata della quale non rimangono che pochissime tracce indirette.
Letteratura e filosofia
45
Ne derivano solo ricordi lacunosi.
Nella prima e nella seconda parte, più articolata, i capitoli si
avvicendano alternandosi uno a uno a seconda dell’appartenenza alla
prima o alla seconda sezione.
Una pagina bianca solcata da tre puntini neri tra parentesi tonde
chiude la prima parte e proietta sulla seconda.
La prima sezione della seconda parte offre la cosiddetta distopia
dell’isola di W, isola retta dagli ideali olimpici che si scoprirà poi
metafora dell’universo concentrazionario nazista.
La seconda sezione della seconda parte ripercorre gli anni di Villard-
de-Lans, cioè gli anni successivi alla separazione della madre.
Il bambino scomparso nella prima parte non verrà più nominato
nella seconda: Gaspard Winckler sembra il narratore e osservatore delle
vicende che accadono sull’isola di W ma non viene mai nominato
esplicitamente. Già a questo livello riscontriamo la possibilità di una
lettura di secondo grado: la sparizione dalla narrazione del bambino
sordo-muto coincide con la sparizione del Perec-bambino e della madre
dalla sua vita.
Perec decide di aggiungere a una versione iniziale la citazione di
David Rousset che esplicita definitivamente l’associazione tra l’isola di
W e i campi di concentramento. Il processo di riesumazione di una
memoria cancellata porterà Perec a una crisi psicologica dolorosa.
L’analisi, che durò quattro anni, permise a Perec di affrontare il testo
abbandonato, il non detto, l’oblio. Si tratta più di una sottrazione di
senso che di un riempimento. È una sorta di creazione negativa.
Philippe Lejeune, esperto conoscitore dell'autobiografia e indagatore
dell'opera di Perec, insiste sull’analogia riscontrabile tra il movimento di
decostruzione che, nel corso dell’analisi, ha consentito di aver accesso
alla sua storia e alla sua voce e i gesti di semplificazione-soppressione
effettuati sul progetto complessivo di scrittura.
Leggere W può costare grandi fatiche: i rimandi tra le parti che si
alternano nelle sezioni sono sottesi e continuamente da ricostruire; nei
ricordi di infanzia sono introdotte variazioni a volte volontarie per
cifrare l’indicibile, infiltrato senza che ci si possa accorgere. È una sorta
di macchinazione orchestrata, in cui trova evidenza la difficoltà di
accesso all'insopportabile: con la spontanea fragilità del bambino e
dell’adulto, Perec rivive sensazioni ed emozioni del passato sotto forma
di cifrature volutamente disorientanti per il lettore. Il va e vieni delle due
serie sbriciola l’inerzia necessaria al piacere romanzesco, imponendo una
ginnastica mentale e psicologica. Ci si trova spaesati di fronte alla calma,
alla freddezza scientifica di questa voce narrativa apparentemente
impersonale, che descrive imperturbabilmente un sistema sempre più
Quaderni della Ginestra
46
abietto. W o il ricordo d’infanzia è una biografia psicanalitica: un
montaggio di sintomi, dovendo il lettore affrontare, da solo, il problema
dell’interpretazione. W è la parte emersa di un immenso lavorio
sotterraneo, protrattosi in silenzio per anni e ora rivendicante con
violenza la propria necessità. Perec rifiuta ogni lavoro di abbellimento o
di coloritura nei confronti dei propri ricordi. Un narratore ipercritico
bracca l’errore, l’inesattezza, l’affabulazione. Il linguaggio è comunque
indicato come il solo mezzo in grado di rivendicare l’assenza. Essa, così
evidentemente “presente” nelle pagine dedicate ai ricordi d’infanzia, fa
da contraltare al troppo-pieno della parte della fiction: in essa tutto è
sistematicamente descritto, organicamente rappresentato, strutturato nei
minimi particolari… Il movimento perpetuamente ostacolato della
memoria si oppone allo scivolamento irrefrenabile nell’incubo di W.
Nella prima parte, Perec corregge con un sistema di note e
completamenti, come se fossero redatti in un momento successivo, gli
errori più evidenti della memoria, i quali non possono essere colmati…
Appare chiaro nella redazione di due testi di apertura sulle figure dei
genitori e sulle fotografie che può solo descrivere, niente più:
Non so se non abbia niente da dire, ma so che non dico niente; non
so se quello che avrei da dire non venga detto perché indicibile
(l’indicibile non si annida nella scrittura, al contrario, è ciò che ne ha
innescato il processo); so che quanto dico è vuoto, neutro, è il segno
definitivo di un definitivo annientamento. […] Non scrivo per dire che
non dirò niente, non scrivo per dire che non ho niente da dire. Scrivo:
scrivo perché abbiamo vissuto assieme, perché sono stato uno di loro,
ombra tra le loro ombre, corpo vicino ai loro corpi; scrivo perché
hanno lasciato in me un’impronta indelebile e la scrittura ne è la traccia:
il loro ricordo muore nella scrittura; la scrittura è il ricordo della loro
morte e l’affermazione della mia vita»2.
Queste ultime parole sono la prova tangibile della possibilità di
scrivere ancora poesia dopo Auschwitz. Perché di poesia si tratta. Vi
sono passi in cui Perec sembra abbandonare la maschera, il pudore che
lo scrittore mantiene sempre nel proprio scritto. L’impossibilità di
scrivere qualcosa che non siano solo dettagli anodini sui genitori non
cancella la presenza dell’amore reciso nei primi anni di vita da una Storia
crudele, inspiegabile. Pochi récits d’enfance accumulano in maniera così
ripetitiva i segni di scrupolo e di soggettività: come una sorta di basso
continuo, Perec sfuma volutamente il senso e l’emozione in un sistema
di giustapposizione ambiguo, costringendo il lettore a farsi carico del
legame tra gli elementi, attraverso l'immaginazione.
Perec rinnova il genere autobiografico, il racconto d’infanzia nella
Letteratura e filosofia
47
fattispecie, introducendo due sostanziali novità: l’autobiografia critica e
l’integrazione di autobiografia e fiction. Nel primo caso si arresta e si
ostina sugli errori e sulle lacune per far scaturire un senso. Viene
esercitato un controllo critico non tanto sulla veridicità o meno degli
eventi descritti, quanto sulla capacità della memoria e della scrittura di
attaccare quel nucleo sottraentesi. Il secondo è evidente: la fiction è una
sorta di correttivo-integrazione per attingere, attraverso l’immaginazione
legittimata, a ciò che la memoria non può raggiungere.
Non si può prescindere nell’analisi di W o il ricordo d’infanzia da
almeno alcuni accenni al mondo di W, vero e proprio sistema
concentrazionario. Si pensi al fiero motto che domina l’entrata dei
villaggi “FORTIUS ALTIUS CITIUS” così paurosamente somigliante
ad “Arbeit macht frei”. L’ideale sportivo inoltre era davvero fondamentale
nell’universo nazista. La deviazione dello spirito sportivo, o megl io
un’accentuazione disumana del suo carattere agonistico appaiono da
numerosi segnali, lentamente e implacabilmente introdotti dall’autore. Si
pensi alla gara delle Atlantiadi: su W non esistono matrimoni o famiglie.
Gli individui non hanno nome ma soprannomi che si riferiscono alle
posizioni ottenute nelle gare sostenute. I bambini vivono fino ad una
certa età con il solo aiuto di novizi; le donne invece sono rinchiuse in un
gineceo. Nella gara delle Atlantiadi un gruppo di donne viene portato su
una pista da corsa e, sguinzagliate come prede, concesso loro un certo
vantaggio, vengono inseguite dagli uomini che fanno loro violenza.
Ogni tipo di atrocità è commesso in questo tipo di gara.
Incredibili appaiono “le piste di cenere, le camerate”. Perec si rende
conto dell’impossibilità di cambiare la Storia e di trovare conforto, pace.
Colui che entrerà un giorno nella Fortezza dapprima si troverà di
fronte a una successione di stanze vuote, lunghe, grigie. Il rumore dei
suoi passi che risuonano sotto le alte volte di cemento gli farà paura, ma
dovrà camminare a lungo prima di scoprire, nascoste nelle profondità
del sottosuolo, le vestigia di un mondo che crederà di avere dimenticato:
mucchi di denti d’oro, fedi nuziali, occhiali, migliaia e migliaia di vestiti
impilati, schedari polverosi, stock di sapone di cattiva qualità…3
Questi oggetti stanno ancora per un’assenza presente, per qualcosa di
annientato ma che continua a mormorare corrispondenze con il
presente.
La Shoah segna una rottura tra un prima e un dopo, diventando
pertanto germe di scrittura. Vi sono una storia personale e una storia
collettiva che costituiscono un tessuto di cui la scrittura cerca di
ricostruire la trama senza nessi. La memoria degli “orfani della Shoah”
non è in grado di relegare il passato nel passato, non supera il lutto e
Quaderni della Ginestra
48
non può rimuovere del tutto. La memoria non può dire la totalità, può
al più ripetere incessantemente la frantumazione di un’identità pur nella
direzione di un'integrazione. Si tratta di un’identità nomade che la
scrittura non può fissare, ma può tuttavia seguire nel suo incessante
movimento di ricerca. La Shoah è una figura in absentia, a cui
ricondurre la scissione dell’io; attraverso il linguaggio si dà avvio a
un’opera di configurazione e riconfigurazione, in cui spesso è il lettore-
fruitore ad essere coinvolto, riconoscendo l’origine della preoccupazione
identitaria degli autori. Il sé è stato offeso e minacciato dalla storia ma la
determinazione a sopravvivere, anche solo come valore di
testimonianza, rappresenta un appiglio contro un sicuro naufragio.
L’operazione-fiction può forse valicare i limiti di un realismo destinato a
lasciare vuoti insostenibili. Da testimone assente, Perec diviene
testimone scrittore.
Nei campi di concentramento si assiste alla logica di una temporalità
che sbriciola la successione di istanti: tutto è ricondotto a un unico
istante atemporale: non è passato perché non si esaurisce nel ricordo,
non è presente né futuro perché rinasce continuamente nel presente di
una memoria che non può dimenticare. La vicenda di W non è collocata
temporalmente e offre queste suggestioni; il percorso letterario e
narrativo di Perec attinge comunque all’autobiografico, in un dialogo tra
un io perduto che vuole dirigersi verso un io recuperato. Attraverso la
finzione o la narrativa si apre uno spazio, ben più vivibile, in cui l’io
perduto può finalmente muoversi ed esprimersi attraverso un io
ritrovantesi; Perec diventa un altro (le sue costruzioni immaginarie, i
suoi peripli narrativi) per ridivenire se stesso.
MICHAEL ARCHETTI
1 Perec Georges, W il ricordo d’infanzia, Torino, Einaudi, 2005, pag. 8. 2 Ibidem, pagg. 48-49 3 Ibidem, pag. 185.
Letteratura e filosofia
49
i sono numerosi aspetti, contenuti all’interno del testo, che
suggeriscono l’interpretazione del racconto Le rovine circolari,
apparso sulla rivista ‘Sur’ nel 1940 e poi definitivamente all’interno della
raccolta Ficciones del 1944, come un vero e proprio sogno, o sogno a
cornice. Il racconto potrebbe essere letto come un processo di
autoanalisi da parte del protagonista, il quale, partendo da un proposito
soprannaturale, giunge alla comprensione di sé. La narrazione presenta
essa stessa numerosi piani, concentrandosi sull’esperienza onirica del
protagonista, un mago capace di plasmare la materia dei sogni. Tuttavia,
credo, nemmeno la veglia può essere considerata tale, poiché l’uomo che
sogna è in realtà sognato a sua volta, ma senza saperlo; per questo più
sopra ho parlato di «autoanalisi», un’autoanalisi tuttavia «incosciente».
Lungo il progredire della narrazione, il mago attraversa svariati livelli di
sogno, o meta-sogno, addentrandosi sempre di più negli abissi del
proprio inconscio. Ad un occhio che ha familiarità con l’opera di Freud,
non sfuggiranno certamente alcuni evidenti caratteri fondamentali di
questo stato onirico: in primis, la descrizione del paesaggio che fa da
sfondo al racconto. Spesso nei sogni, ci dice l’inventore della
psicoanalisi, l’ambientazione presenta connotati confusi, spesso
decisamente indefiniti. È così in questo caso. L’ambientazione del
racconto è tratteggiata solo lievemente, e sfuma poi pian piano verso il
nulla: vengono menzionati due templi, uno situato a nord e un altro a
sud, entrambi in rovina, un fiume, alcune canne appena affioranti
dall’acqua, una selva; nessun elemento è delineato con nitidezza, al
contrario ogni cosa pare come avvolta da una sottile coltre di foschia.
Nemmeno il protagonista è presentato nel dettaglio. Viene descritto
come un uomo taciturno proveniente da Sud, un uomo grigio, un
forestiero, un mago. A mio parere, questa mancanza di definizione non
è soltanto in linea con l’atmosfera magica e misteriosa che pervade
l’intero racconto, ma è sintomatica di qualcosa di ancor più
straordinario. Le due vite del mago, quella della veglia e quella onirica,
sono entrambe un unico sogno, ed egli, entità di certo soprannaturale,
ha confuso il sogno con la realtà, poiché ha rimosso un evento
fondamentale della sua esistenza, ignoto a noi tutti: quello della
creazione di sé.
A questo stato prenatale egli cerca di ritornare costantemente, anche se
inconsapevolmente, tramite un proposito, cardine del racconto, attuabile
soltanto per mezzo del sonno:
V
LA PROVA DEL FUOCO. SOGNO, RIMOZIONE E COSCIENZA NE LE ROVINE
CIRCOLARI DI J. L. BORGES
Quaderni della Ginestra
50
chiuse gli occhi pallidi e dormì, non per debolezza della carne, ma
per determinazione della volontà1.
e ancora, poco più avanti:
Il proposito che lo guidava non era impossibile, anche se certamente
sovrannaturale. Voleva sognare un uomo: voleva sognarlo con minuzio-
sa completezza e imporlo alla realtà2.
Il mago, perciò, dorme per volontà propria, non per necessità o stan-
chezza, con lo scopo di plasmare un essere vivente concreto dalla mate-
ria dei sogni. Tuttavia il suo proposito, nei presupposti e nelle conse-
guenze, è colmo di richiami freudiani. Abbiamo già accennato al deside-
rio inconscio di un ritorno allo stato prenatale, il che significa in realtà
ritornare all’utero materno. Freud fa di questa affermazione un caposal-
do della propria teoria del sogno, come si può riscontrare
nell’Introduzione alla psicoanalisi del 1917:
Ci ritiriamo perciò di tanto in tanto nello stato prenatale, ossia
nell’esistenza endouterina. O almeno, ci creiamo condizioni del tutto
simili a quelle di allora: calore, oscurità e assenza di stimoli3.
In questo caso, però, il rapporto con l’utero risulta particolare e dicoto-
mico. Sembra infatti che il mago non desideri soltanto ritornare ad esse-
re inquilino dell’utero, ma diventarne anche, e soprattutto, il proprieta-
rio. Al primo aspetto fanno riferimento i primi sogni effettuati dal fore-
stiero: egli sogna se medesimo in un anfiteatro, si sogna perciò in terza e
prima persona, come oggetto e soggetto del sogno, poiché appare con-
temporaneamente come immagine dall’esterno e come «attore» princi-
pale:
Il forestiero si sognava al centro di un anfiteatro circolare che era in
qualche modo il tempio incendiato [...] L’uomo impartiva lezioni di ana-
tomia, di cosmografia, di magia4.
Il secondo aspetto, invece, riguarda i sogni avuti in seguito ad una sorta
di cesura – o censura –, frappostasi tra l’intenzionalità del sognatore e
l’incapacità da parte del sogno di creare qualcosa di conforme alle aspet-
tative. Infatti, dopo aver preso coscienza del fallimento della prima serie
di sogni, quelli aventi come oggetto il ragazzo/allievo «uscito» da quella
sorta di accademia onirica, l’uomo smette di sognare. Semplicemente
non riesce più a creare le condizioni necessarie al compimento del pro-
prio intento. Dopo un periodo di riposo il mago ricomincia a sognare, e
Letteratura e filosofia
51
sin dalla prima notte sogna un cuore fremente. Fa un sogno di cui non è
protagonista – non appare in prima persona – nel quale si comporta da
spettatore:
Quasi subito, sognò un cuore che palpitava. Lo sognò attivo, caldo,
segreto, della grandezza di un pugno chiuso, di color granata nella pe-
nombra di un corpo umano ancora senza faccia e senza sesso; con amo-
re minuzioso lo sognò, per quattordici lucide notti. Ogni notte lo per-
cepiva con maggiore evidenza. Non lo toccava; si limitava ad attestarlo,
forse a correggerlo con lo sguardo. Lo percepiva, lo viveva, da molte di-
stanze e da molte angolature5.
In questo secondo caso, il sognatore configura se stesso come «portato-
re» dell’utero materno, trascende perciò il ruolo di mero ricercatore
dell’obliterazione endouterina e la sublima, elevandosi al livello di vera e
propria ‘madre’. Freudianamente l’anfiteatro circolare della prima serie
onirica, essendo identificabile come contenitore, come stanza6, potrebbe
rappresentare appunto l’utero materno, al quale il mago ritorna da inqui-
lino. Nella seconda serie, come appena detto, l’utero materno è rappre-
sentato dal sognatore stesso, il quale vede dentro di sé il figlio, ancora
senza volto e senza sesso. È un ritorno agli abissi ancora più profondo.
Ma la discesa negli abissi non termina di certo qui. Anzi, si può dire che
prenda avvio proprio a partire da questo punto. Infatti d’ora in poi il
mago si concentrerà sulla costruzione della propria creatura, un Dr.
Frankenstein fuori dal tempo; ma la sua creatura, anche ad avvenuto
completamento, rimane inerte, priva di soffio vitale, proprio come il suo
alter-ego shelleyano. L’uomo supplica perciò un simulacro di pietra, il
quale gli si rivela in sogno come il dio del Fuoco e infonde finalmente la
vita all’essere creato dai sogni. Solamente il forestiero e il Fuoco stesso
sapranno della reale natura del figlio.
Il mago si appresta quindi ad iniziare il proprio figlio ai segreti della ma-
gia e al culto del Fuoco, inviandolo infine presso le rovine di un altro
tempio, del tutto uguale al primo. Trascorsi diversi anni, gli giungono
all’orecchio voci riguardanti un uomo che in un tempio a nord può
camminare tra le fiamme senza bruciarsi, e comincia a temere che que-
sta facoltà soprannaturale induca la sua creatura a riflettere sulla propria
natura, che, si ricordi, è di fantasma.
Il processo di autoanalisi va così dispiegandosi verso la conclusione. Il
mago, temendo per il figlio, riflette in realtà sulla propria condizione:
A volte lo inquietava l’impressione che tutto ciò fosse già accaduto7
Quaderni della Ginestra
52
Il narratore così aveva scritto poche righe più sopra, riferendosi al peri-
odo in cui l’uomo iniziava ancora il proprio figlio agli arcani della magia.
Qualcosa cominciava già a trapelare sempre più prepotentemente, fino
allo sconvolgente riconoscimento conclusivo.
In un’alba senza uccelli il mago vide abbattersi contro i muri
l’incendio concentrico. Per un istante, pensò di rifugiarsi nelle acque, ma
poi comprese che la morte veniva a coronare la sua vecchiaia e ad assol-
verlo dalle sue fatiche. Camminò contro le lingue di fuoco. Esse non
morsero la sua carne, esse lo accarezzarono e lo inondarono senza calo-
re e senza combustione. Con sollievo, con umiliazione, con terrore,
comprese che anche lui era un’apparenza, che un altro lo stava sognan-
do8.
Improvvisamente il rimosso irrompe alla coscienza. Nascostosi nelle
pieghe infinite dell’inconscio per chissà quanti anni, affiora infine pro-
prio grazie all’operato del mago – «creazione» e educazione del figlio –,
operato che potrebbe essere identificato come rimovente. Egli crede di
compiere un’azione dettata dalla propria volontà, in realtà non fa che
avvicinarsi inesorabilmente al rimosso. Ma i segni della pericolosità di
quest’intento sono disseminati lungo tutto il racconto. Freud ha teoriz-
zato una sorta di filtro, o sistema di allarme, che impedisce l’accesso alla
coscienza a ciò che è sgradito, e l’ha chiamato censura; ciò che sfugge
alla censura affiora alla coscienza, generando un’angoscia talmente in-
sopportabile – il campanello d’allarme – da svegliare il sognatore. Ora,
la censura onirica è qui rappresentata dalla prima serie di sogni, e il
campanello d’allarme (il sistema di sicurezza della censura) dal risveglio
del mago e dalla successiva incapacità di sognare. Nella prima serie di
sogni, si ricordi, il mago non aveva pieno controllo delle proprie facoltà,
non riusciva ad istruire l’allievo scelto tra tanti, e soprattutto non l’aveva
«creato»; tutto ciò aveva impedito il contatto con il dio del Fuoco, che
segna l’inizio del graduale cammino verso la coscienza. Evidentemente,
però, qualcosa era scattato: il solo proposito di plasmare un uomo dai
sogni era sufficiente per suscitare tensione, una tensione tanto grande da
suggerire alla censura il risveglio del sognatore. Tramite il risveglio e il
sonno senza sogni, il rimosso viene ancora tenuto lontano.
Il proposito, tuttavia, che in questo caso corrisponde al rimovente, con-
danna il sognatore all’intima scoperta della verità, al riaffiorare del ri-
mosso. È possibile leggere il procedere dell’impresa come processo di
disvelamento, come un’autoanalisi incosciente. L’uomo, nonostante la
censura lo metta in guardia dal procedere, persegue il proprio scopo,
supera le barriere dell’inconscio e riporta il rimosso alla coscienza.
Nemmeno la sensazione che tutto ciò fosse già accaduto riesce a frenare
Letteratura e filosofia
53
il protagonista, deciso ormai – anche se inconsciamente – a scoprire la
verità. Il rimosso riaffiora così per mezzo del rimovente. L’incendio del
tempio circolare si afferma come stato ultimo del riconoscimento; il
mago pensa in un primo tempo di cercare riparo nell’acqua, ma subito
muta il suo pensiero, non comprendendo di essere giunto alla fine della
sua vita, ma al termine della propria ricerca. Varca la soglia delle fiamme,
sicuro di andare incontro alla morte, finendo invece per comprendere
ciò che tanto tempo addietro aveva affidato all’oblio.
La sua stessa esistenza è effimera, il suo sognare non è altro che un so-
gno nel sogno.
GIOVANNI CONSIGLI
1 Borges, Jorge Luis, Las ruinas circulares, Sur, Buenos Aires 1940 in Ficciones, Editorial
Sur, Buenos Aires 1944; trad. it. di Franco Lucertini, Le rovine circolari, in Finzioni, Ei-naudi, Torino 1955, cit. p. 48. 2 Ivi, p. 49. 3 Freud, Sigmund, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1915-1917, trad. it. di Marilisa Tonin Dogana ed Ermanno Sagittario, Introduzione alla psicoanalisi, Einaudi, To-rino 2012, cit. p. 88. 4 Borges, Le rovine circolari, cit. p. 49. 5 Ivi, p. 51. 6 Freud, Introduzione alla psicoanalisi, cit. p. 148. 7 Borges, Le rovine circolari, cit. p. 52. 8 Ivi, p. 54. TROPPO UMANO, PARMA, 2012
Quaderni della Ginestra
54
ra i periodi storici in cui è possibile osservare lo svilupparsi di un
rapporto stringente tra letteratura e psichiatria in Italia, i decenni
successivi all’unificazione occupano senz’altro una posizione di rilievo.
Sin dalla pubblicazione delle prime opere di Cesare Lombroso, il fitto
dialogo tra scienze umanistiche e scienze medico-antropologiche (che di
lì a poco sottolineranno sempre più il loro carattere di scienze sociali)
appare particolarmente evidente. Si tratta, com’è noto, di un dialogo
avvenuto non solo sul versante della creazione artistica – e cioè sui
rapporti che legherebbero il genio e la follia1 – ma anche (e in misura
non certo minore) sullo studio della delinquenza. Basti pensare che
Enrico Ferri, illustre allievo dell’antropologo veronese e personalità
influente del Partito Socialista, dedicò un’intera opera allo studio de I
delinquenti nell’arte2; e che l’attenzione rivolta da Lombroso alla
letteratura, nella costruzione delle sue teorie sulla delinquenza, continua
tutt’oggi ad essere oggetto di interessanti ricerche3.
Ciò nonostante, resta piuttosto diffusa l’opinione secondo la quale
queste teorie sulla devianza siano state (loro stesse) un’anomalia,
verificatasi entro un arco cronologico piuttosto limitato, e scarsamente
influente – se non addirittura estranea – nella formazione della cultura e
dell’identità dello stato-nazione postunitario. Al contrario, si può
osservare come il processo di costruzione della figura del delinquente-
pericoloso abbia coinvolto i più diversi settori del sistema culturale; e
come esso abbia marcato con la sua presenza alcuni momenti esemplari
della storia d’Italia, come il dibattito attorno al Codice Penale unitario e
il primo colonialismo italiano nei territori del corno d’Africa. Si trattò,
inoltre, di un processo cui certamente Lombroso e i suoi allievi presero
parte, ma che non iniziò e non si esaurì con la loro ‘scuola’. Per
sostenere questa tesi si può ricorrere – inaspettatamente – anche
all’analisi di un romanzo, che si rivela particolarmente utile in questo
senso, date le sue caratteristiche testuali, il percorso editoriale e
l’entusiasmo con cui è stato recepito, anche all’interno degli ambienti
politici e diplomatici.
Nel 1883 l’editore milanese Angelo Sommaruga, che in quegli anni
andava consolidando la sua posizione all’interno del mercato editoriale
romano, diede alle stampe la quarta edizione de La Colonia felice dello
scapigliato milanese Carlo Dossi. Il romanzo, com’è noto, racconta di
come un gruppo di delinquenti, spediti su un’isola deserta, dopo
un’iniziale fase di disordini e crudeltà, si rendano conto che la legge
T
EMENDABILE O INCURABILE? LA FIGURA DEL DELINQUENTE-SELVAGGIO NELLA COLONIA FELICE DI CARLO DOSSI
Letteratura e filosofia
55
procede dall’utilità; che il rispetto del patto sociale è in ultima analisi
assai conveniente per l’individuo; che infine l’amore e la famiglia
possano trasformare il delinquente in onesto lavoratore ed emendarlo
così delle colpe commesse. «Con sei edizioni in un ventennio, La Colonia
felice è certamente l’opera del Dossi di maggior successo editoriale»4;
dopo una prima pubblicazione (di sole duecento copie stampate a spese
dell’autore nel 1874), il romanzo apparve a puntate sul quotidiano
romano la «Riforma» nel 1879 e ottenne un successo non trascurabile,
se è vero che «il rilancio romano dello scrittore prese avvio proprio da
La colonia Felice»5. Si trattò di un rilancio, allo stesso tempo, letterario e
politico6: «la Riforma» e lo «Stabilimento Tipografico Italiano» erano
infatti, rispettivamente, il quotidiano e la casa editrice del partito
crispino; e proprio quando Francesco Crispi sedette alla presidenza del
consiglio, il nostro romanziere si trovò a ricoprire rilevanti incarichi
politici e diplomatici.
L’edizione sommarughiana de La Colonia felice appare particolarmente
curata, esito di un lavoro di revisione condotto con grande precisione da
parte dell’autore. Il testo è infatti seguito da una Nota grammaticale in cui
il Dossi illustra i criteri ortografici adottati. «Sennonché, nel momento
stesso in cui veniva licenziata al pubblico, così attentamente ‘ricorretta’ e
provveduta, l’autore si premurava di sconfessare la sua opera (e non
certo per semplice umore di bizzarria contraddittoria)»7. A precedere il
testo è infatti, chiara e netta, una Diffida, che sconfessa l’immagine del
delinquente tracciata dalla narrazione romanzesca, dichiarandola ormai
insostenibile, stanti le ultime conquiste della scienza psichiatrica.
Con la Colonia felice io m’era dunque proposto […] di dimostrare
graficamente le seguenti anticipazioni delle cattedre, cioè:
1° che il male insegna il bene;
2° che la giustizia procede dall’utilità
3° che inùtile è la pena di morte, quindi ingiusta;
4° che, come rinnòvasi la materiale compàgine dell’uomo, può pa-
rimenti rifarsi quella morale; né il filo della memoria basta a congiunge-
re, in una sola, le varie individualità per cui una persona passa. Conse-
guentemente, potrebbe qualunque colpèvole riprincipiare, in tutta la vir-
tù della parola, la sua esistenza;
5° infine, che amore ha forza assai più della Forza.
Come si scorge, io era in perfetta regola con la filantropia conven-
zionale, non però con la scienza. La guancia de’ preventivi miei conti
non avrebbe potuto mostrarsi più rosata e piacente, ma avèa un piccolo
neo, quello di non segnare che un attivo ideale. Ben altre erano infatti le
cifre reali raccolte dalla psichiatria, dalla chimica organica, dalla statistica
criminale. L’uomo malvagio non è correggibile8.
Quaderni della Ginestra
56
Nel frattempo altre ‘cattedre’, non esattamente votate all’insegnamento
della filantropia, avevano iniziato a fornire le loro ‘anticipazioni’: in
particolare, da quella di medicina legale e igiene pubblica dell’Università
di Torino, l’ormai noto psichiatra e antropologo Cesare Lombroso
teneva il suo insegnamento sin dal 1876; e in quello stesso anno era stata
pubblicata per la prima volta una delle sue opere più prestigiose, L’uomo
delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle
discipline carcerarie9. Dossi ebbe modo di leggere questo studio sin da
questa prima edizione, e subito pensò di spedire all’antropologo
veronese una copia della sua Colonia felice. Da quel momento iniziò tra i
due una serie di corrispondenze epistolari che proprio attorno al 1883
era andata infittendosi, in merito a un’altra pubblicazione che il Dossi
stava portando a termine, I mattoidi al primo concorso pel monumento in Roma
a Vittorio Emanuele II. Il termine ‘mattoidi’ fu suggerito all’autore
milanese proprio da Lombroso: a lui rivolse il Dossi la dedica dell’opera;
in cambio l’antropologo inserì parte del materiale raccolto all’interno del
suo Genio e Follia10.
Sarebbe certo un grave errore ridurre la figura del Dossi letterato a
una sorta di traduttore romanzesco delle teorie lombrosiane: anzi,
dovendo scegliere se tra i due fu il romanziere a ‘usare’ lo scienziato o
piuttosto lo scienziato a servirsi del romanziere, la scelta dovrebbe certo
cadere sulla prima ipotesi 11. Eppure la sincerità con la quale il Dossi
accolse in questi anni le conclusioni della «nuova scuola positiva» non
pare possa essere messa in discussione. La medicalizzazione del
delinquente; la fusione di delitto e follia, ottenuta dichiarandone la
comune origine epilettica; la definizione della tendenza criminosa come
natura morbosa, ereditaria e incurabile, almeno nelle sue manifestazioni
più «atavistiche»; tutto ciò convinse più d’uno dei letterati italiani, e tra
essi appunto Carlo Dossi, tanto da indurlo a sconfessare un suo
romanzo nel momento stesso in cui ne licenziava l’edizione più curata.
Su tale contraddizione vale davvero la pena di interrogarsi, anche perché
le due tesi (apparentemente) opposte che la compongono – quella del
testo e quella della Diffida – corrispondono a quelle che avrebbero
diviso i penalisti dell’epoca, secondo quel paradigma dello «scontro tra
le due opposte scuole penali» tramandato da buona parte della
storiografia del diritto. Sarebbere cioè esistite, compatte e ben
riconoscibili, da una parte la «scuola classica» del diritto penale, che
individuava le sue fondamenta attorno ai concetti cardine di reato, libero
arbitrio, responsabilità; e dall’altra parte (ma su questo non c’è alcun
dubbio) la «nuova scuola positiva», che affermava la necessità di studiare
il delinquente piuttosto che il delitto, e accusava la parte avversaria di
rimanere legata ad una concezione astratta e metafisica del diritto, del
Letteratura e filosofia
57
tutto sganciata dalle reali dinamiche sociali12.
Certamente tra alcuni penalisti si accese una polemica a tratti feroce,
che animò il dibattito attorno alla stesura del nuovo Codice Penale
unitario e che si svolse tanto tra i banchi dell’accademia quanto tra quelli
del parlamento13. Tuttavia, l’adozione eccessivamente rigida di questo
modello non è in grado di sciogliere una serie di contraddizioni, alcune
delle quali risultano evidenti anche nello studio del romanzo in oggetto:
l’approvazione del Codice Zanardelli (secondo questa prospettiva, il
massimo prodotto della «scuola classica», che segnò la sconfitta dei
positivisti) avvenne sotto il governo Crispi, proprio mentre l’organo di
stampa («La Riforma») dello stesso presidente del consiglio tentava di
smuovere l’opinione pubblica in senso, verrebbe da dire, lombrosiano,
attraverso le sue firme più note già convertite alle nuove dottrine
(compreso quel Carlo Alberto Pisani Dossi che del presidente del
consiglio sarà strettissimo collaboratore e consigliere). C’è inoltre il
rischio di non cogliere quegli elementi lombrosiani che hanno
continuato a caratterizzare la criminologia e la cultura italiana anche nel
corso del Novecento14, oppure di ipotizzare una genesi improvvisa di
quegli stessi elementi: una sorta di irruzione aliena in un’Italia
caratterizzata da una cultura «classica», metafisica e «filantropica», fino a
quel momento estranea ai principi e alle pratiche del controllo sociale.
Al contrario,
non c’era bisogno dei positivisti perché il legislatore penale pensasse
a sanzioni che oggi assimileremmo alle misure di sicurezza, perché esse
erano presenti da decenni nel sistema e da più di un secolo nella cultura
della prevenzione e della pena; non è necessario evocare i positivisti o-
gni volta che appare, sia pure in trasparenza, la ‘pericolosità’ dei sogget-
ti, perché questo era il senso comune, tra la gente e per gli scienziati, nel
secolo XIX: senso comune al punto di comparire, senza contraddizione
né scandalo, nelle sentenze dei giudici, in piena vigenza del codice del
1889 che avrebbe dovuto essere incompatibile con quella prospettiva15.
Né tali sanzioni furono di fatto affievolite nel Testo Unico delle leggi
di Pubblica Sicurezza, proposto dallo stesso Crispi e approvato nello
stesso anno del «classico» Codice Zanardelli; nel corso del decennio
successivo diventeranno anzi sempre più stringenti ed esplicitamente
applicate anche alla repressione del dissenso politico, prima con le «leggi
crispine» del 1894, poi coi provvedimenti del Gabinetto Pelloux, a
seguito dei disordini del 1898.
Dal canto suo anche la letteratura, verrebbe da pensare, non dovette
attendere la «nuova» antropologia criminale tardottocentesca per
costruire, tra i suoi personaggi, le figure dei delinquenti pericolosi, se ad
Letteratura e filosofia
59
esserne già abbondantemente provvisto era proprio quel «senso
comune» che essa per prima contribuiva a costruire, data la straordinaria
fortuna di cui godette in questo secolo il genere romanzesco – e in
particolare il romanzo d’appendice. Per vedere confermata tale ipotesi
basta aprire la prima pagina del romanzo-archetipo di questo genere
popolare, I misteri di Parigi di Eugène Sue, e osservare quanto a
quell’altezza (1842-43) fosse già cristallizzata la figura del delinquente
selvaggio (metropolitano): con tanto di esplicito riferimento ai
sanguinari selvaggi di James Fenimor Cooper, che agitavano il sonno dei
coloni (e la veglia dei lettori). Anche il testo de La Colonia felice, scritto
dal Dossi prima della ‘conversione’ alle scienze positive, costituisce
un’ulteriore conferma in questo senso. La delinquenza dei suoi
personaggi non è ancora morbosa, epilettica, medicalizzata, ma è già
evidentemente ‘selvaggia’:
Quand’ecco, si udì uno stampo di un piede, e una tìnnula voce di
donna echeggiò: vili! – Una giòvane snella, dal profilo tagliente e dalla
chioma nèrissima, svolazzante, s’era piantata spavalda su di una cassa, e
lampeggiando fùlmini neri da’ suoi occhi aquilini, squillava: vili! uomini
inutilmente maschi!... volete a marito noi donne?
- Brava – rispose una voce secca al pari di nàcchere e veniva da
un magro e lungo di uno, dal ghigno nudo di peli e giallastro, e dagli
occhi – due fili di luce – che apparivano e scomparivano a tratti,
quasi tementi di essere scorti […] Il quale, facèndosi innanzi: gente!
che si sta qui a dire il rosario?... Date ascolto alla Nera! […]
L’incanto era rotto. Da ogni parte, grida che volèvano èsser parole,
parole che volèvano èssere idee: idèe e parole, che accumulàtesi da
mesi e mesi in quelli angusti cervelli, irrompèvano ora alle labbra, vi
si stipàvano per sprigionarsi, pugnando a chi primo, e a vicenda im-
pedendosi. E parlàvano tutti a una volta. Parèa che il tempo stesse
lor per fallire. Erano laidità; erano orrende bestemmie.
E intanto si sconficcàvan le casse della carne salata e del pane, e
due, ondeggiando, barellavano in mezzo un botticello pesante, sul
quale era scritto branda.
[…] Due ore dopo, leggero il barile, greve la pancia. Dal cibo, la
bestialità avèa riavuto il consueto dominio16.
Certo questo carattere selvaggio, se anche già fosse in qualche misura
costitutivo, non è ancora a questa altezza una «natura» dell’individuo
delinquente; o per lo meno non presenta ancora il suo carattere
«morboso» e incurabile (infatti l’isolamento, la famiglia e il lavoro
possono ancora cambiarne il segno). Ma a ben vedere non è nemmeno
così necessario che lo diventi: in primo luogo perché anche la figura del
‘selvaggio emendabile’ ha saputo ispirare o corroborare misure
preventive di controllo sociale. In secondo luogo perché di essa, al netto
Quaderni della Ginestra
60
delle contraddizioni apparenti, hanno potuto continuare a servirsi anche
coloro che quell’emenda non credevano più possibile. Nel 1884
Alessandro Lioy, avvocato, «uno dei più strenui campioni ed apostoli
della nuova scuola penale»17,
esponendo a Napoli, presso la Società Africana d’Italia, la proposta
di una Colonia penitenziaria ad Assab, presentava l’utopia lirica dossiana
come un’anticipazione dell’arte sulla scienza, sicchè «Gualdo – l’eroe del
Dossi – l’assassino trasformato in onesto lavoratore mercè l’isolamento,
la colonia, la famiglia, rappresenterebbe il prototipo della scienza peni-
tenziaria». Quattro anni dopo (8 novembre 1888), in una seduta del se-
nato in cui si discuteva il progetto del nuovo codice penale, Tullio Mas-
sarani, intervenendo a sostegno della deportazione («unica eventualità di
redenzione, unico spiraglio di vita nuova» per i grandi malfattori), trovò
modo di citare ai suoi colleghi una pagina della Colonia felice e di elogiar-
ne l’autore: «un giovane – un giovane di ieri (gli anni corrono così pre-
sto!) – un uomo, al quale lo strenuo ingegno conquistò un posto rag-
guardevole presso il Signor Presidente del Consiglio»18.
Si mostrano così una serie di contraddizioni apparenti: un romanzo
di successo, nella sua edizione più curata e corretta, convive con la sua
Diffida, poiché giudicato dall’autore scientificamente inattendibile; la
filantropia (penitenziaria) convive con le teorie dell’atavismo e della
degenerazione positiviste; e i sostenitori di quelle stesse teorie
scientifiche elogeranno quel romanzo (filantropico) come anticipatore
delle nuove teorie, dalle quali dovrebbe invece essere confutato. Eppure,
se si guarda a tali contraddizioni, più che come punti di blocco
dell’analisi, come pista di ricerca da seguire, si ha modo di verificarne la
frequenza e la costanza anche attraverso i decenni. La storiografia del
diritto ha già mostrato la produttività di una ricerca in questa direzione:
nonostante lo «scontro tra le scuole», un tratto permanente ha attraversato
la cultura penale dell’Italia unita, la cui continuità si è data (almeno in
parte, ma è certo una parte non trascurabile) sul terreno della difesa del
corpo sociale, attraverso le politiche adottate in materia di pubblica
sicurezza19.
Verrebbe da chiedersi se anche la critica letteraria non debba tentare
la stessa operazione, sforzandosi quindi di tenere assieme ciò che si
dimostra sempre più difficile da separare. Una separazione di questo
tipo è quella che storicamente ha caratterizzato l’atteggiamento della
critica verso l’opera di Carlo Alberto Pisani Dossi e per cui si è spesso
sostenuto che il Carlo Dossi scrittore scapigliato e l’Alberto Pisani
Dossi diplomatico, «principale artefice della politica estera crispina»20
(quindi del primo colonialismo italiano), siano state quasi due persone
persone diverse, o addirittura inconciliabili. Anche in una prospettiva
Letteratura e filosofia
61
eminentemente letteraria, invece, leggere assieme lo scrittore e il politico
si mostra essere una linea di ricerca da praticare più a fondo, come
alcuni esperti hanno già avvertito in passato21 e come recenti ricerche
continuano a dimostrare22. Tenere assieme questi due aspetti, indagare la
profondità e la solidità dell’intreccio cui diedero luogo, sembrerebbe
dunque un’iniziativa più che legittima. Una legittimità che, se possibile,
aumenta ancora di più se ci si concentra sulla sola Colonia felice. Leggerla
assieme alle politiche penali e coloniali italiane non è un azzardo
ermeneutico, ma un fatto storico. Nella quarta edizione del romanzo
facevano il loro ingresso le nuove dottrine penal-positiviste; l’anno
successivo La Colonia felice (non ostante la Diffida) diveniva il progetto
(positivista) di una colonia penitenziaria eritrea; quattro anni più tardi, il
romanzo di Dossi faceva il suo ingresso nelle aule del Senato in cui si
discuteva il progetto del nuovo codice penale («classico»). Si aggiunga
infine, dato a questo punto molto significativo, che se le terre delle
colonie italiane nel corno d’Africa vennero chiamate «Eritrea», lo si deve
proprio all’autore della Colonia felice : più di dieci anni dopo aver scritto
quel romanzo «col quale vaticinava chiaramente all’Eritrea»23, fu infatti
Carlo Dossi a coniare e suggerire a Francesco Crispi quel «nome
rubricante di una sperata porpora coloniale»24, come alcune sue lettere
pubblicate di recente dimostrano ormai con certezza25.
Si vede così quanto, pur entro continue ambiguità e contraddizioni, la
figura del delinquente e del selvaggio (interno o esterno che sia al
territorio nazionale) abbia caratterizzato con una certa costanza la storia
e la cultura dell’Italia Unita; e come le teorie di Lombroso e dei suoi
allievi abbiano piuttosto integrato che sconfessato questo tipo di
rappresentazione. L’immagine testimoniata dal romanzo dossiano e le
conquiste della psichiatria che avrebbero dovuto sconfessarlo seppero
insomma convivere a lungo, ben oltre l’approvazione del codice
Zanardelli, mostrandosi in qualche caso particolarmente collaborative:
trattando il tema della deportazione e del possibile impiego delle terre
coloniali italiane, il fondatore della «nuova scola penale» Enrico Ferri
seppe riprendere – pur senza citarlo direttamente – la stessa
rappresentazione del delinquente e le stesse misure correttive proposte
nel romanzo dossiano, saldando su di esse le nuove conquiste della
scienza positiva. Vale la pena, per concludere, di citare un ampio stralcio
di questa Sociologia criminale, anche perché l’allievo del Lombroso non
manca di citare alcuni padri della cultura umanistica occidentale a
sostegno delle sue tesi: non saranno, questa volta, i classici della
letteratura ad essere chiamati in causa, come già avvenuto in un altro
suo studio già citato, ma classici della filosofia come Platone, Aristotele
e Plutarco. Come si vedrà, il loro utilizzo appare piuttosto estemporaneo
Quaderni della Ginestra
62
e frettoloso (come spesso già nel maestro Lombroso); ma rende (forse
proprio per questo) particolarmente evidente il portato politico
dell’operazione, che mirava ad incidere il più possibile nel processo di
formazione della cultura nazionale – e che in qualche caso, come si è
visto, non mancò di raggiungere il proprio obiettivo.
Deportazione, adunque, oppure reclusione perpetua indeterminata,
come spiegherò or ora, per i più temibili delinquenti, incorreggibili, au-
tori di una qualche forma di criminalità atavica.
Sulla deportazione si è scritto molto, anche in Italia, massime alcuni
anni fa, quando vi fu polemica vivace […]. Tuttavia nella deportazione
c’è un'anima di verità indiscutibile: che cioè quando essa sia perpetua e
quindi con minime probabilità di rimpatrio, è il mezzo migliore per
purgare la società da inquilini pericolosi e sollevarla dall' obbligo di
mantenerli. Ma allora non può essere che la deportazione semplice, cio-
è, come fece da principio l'Inghilterra, l'abbandono dei deportati in
un’isola o continente (con mezzi sufficienti per vivere lavorando) od
anche il loro trasporto in paesi barbari, dove essi, che nei paesi civili so-
no semi-selvaggi, rappresenterebbero invece una mezza civiltà e per le
stesse loro qualità organiche e psichiche mentre divengono grassatori
od assassini nei paesi civili, diverrebbero discreti capi tribù o militari nei
paesi selvaggi, dove si trovano poi gente che non ricorre ai tribunali per
rintuzzare le offese.
Ma per noi italiani credo che si possa, purtroppo, fare una deporta-
zione intema, mandando certe categorie di delinquenti a risanare i paesi
incolti per malaria. Se questa per essere domata esige un’ecatombe u-
mana, molto meglio che sia di delinquenti anziché di onesti agricoltori.
Un po’ meno di riguardi ai malfattori e un po’ più agli onesti contadini
ed operai! E che i delinquenti divenuti pionieri di civiltà, si redimano
colla morte di fronte all’umanità, ch’essi hanno così crudelmente offesa.
La vera deportazione oltremarina, fino a pochi anni fa non era per
noi di pratica attuabilità […]. Ma dacchè l’Italia possiede la Colonia Er i-
trea, l’idea della deportazione ha preso vigore. Io stesso, nel maggio
1890, proposi incidentalmente alla Camera dei deputati l’esperimento di
una colonia penale nei nostri possedimenti africani. […] Ad ogni modo,
anche ammessa la deportazione dei delinquenti nati e incorreggibili, o
all’interno od oltremare, rimane il problema della forma più adatta di lo-
ro segregazione.
E si presenta allora, dapprima l’idea dello «stabilimento per incor-
reggibili» […] perché si tratta di delinquenti pei quali non vi è speranza
di correzione. La natura congenita e la trasmissibilità ereditaria delle
tendenze criminose in questi individui giustificano pienamente queste
parole del Quetelet: «Le malattie morali sono come le malattie fisiche:
ve n’è di contagiose, ve n’è di epidemiche e ve n’è di ereditarie. Il vizio
si trasmette in certe famiglie come la scrofola o la tisi». […] Così Aristo-
tele narra di un uomo, che accusato di aver battuto il padre, rispose:
«Mio padre ha battuto mio avo; mio avo ha egualmente battuto mio bi-
savo nel modo più crudele e voi vedete mio figlio: questo fanciullo non
Letteratura e filosofia
63
avrà ancora l’età di un uomo, che non mi risparmierà le sevizio e le per-
cosse» (I). E Plutarco soggiunge: «I figli degli uomini viziosi e cattivi so-
no una derivazione della natura stessa dei loro padri» (II).
Così ci spieghiamo la intuizione di Platone che, pure «ammettendo
in principio che i figli niente dovessero soffrire pei delitti dei genitori,
suppose però il caso in cui il padre, l’avo ed il bisavo fossero stati con-
dannati a morte ed allora propose che i discendenti dovessero cacciarsi
dallo stato, come appartenenti ad una razza incorreggibile» (III)26.
ALESSIO BERRÈ
1 Cesare Lombroso, Genio e follia, Milano, Brigola, 1872; ora anche in Delia Frigessi, Ferruccio Giacannelli, Luisa Mangoni (a cura di), Cesare Lombroso, Delitto, genio, follia: scritti scelti, Torino, Bollati Boringhieri, 20002. 2 Enrico Ferri, I delinquenti nell’arte, Genova, Libreria editrice ligure, 1896. 3 Vedi Delia Frigessi, Cesare Lombroso, Torino, Einaudi 2003, pp. 327-352; Andrea Righini, Cose da pazzi: Cesare Lombroso e la letteratura, Pisa, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2001; e ora Lucia Rodler, Introduzione, in Cesare Lombroso, L’uomo delinquente studiato in rapporto all’antropologia, alla medicina legale e alle discipline carcerarie [1876], Bologna, Il Mulino, 2011. 4 Dante Isella, Note ai testi, in Carlo Dossi, Opere, Milano, Adelphi, 1995, p. 1458. 5 Ivi, p. 1459. 6 Vedi Francesco Lioce, Esperienza letteraria e ideologia politica: il caso Carlo Alberto Pisani Dossi (Da una lettera dell’inedita Vita di Carlo Dossi), in http://www.italianisti.it/FileServices/Lioce%20Francesco.pdf 7 Dante Isella, Note ai testi, cit., p. 1461. 8 Carlo Dossi, Opere, cit., p. 525. 9 Cesare Lombroso, L’uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie, Milano, Hoepli, 1876.
10 Vedi Delia Frigessi, Un’amore corrisposto, in Id., Cesare Lombroso, Torino, Einaudi, 2003, pp. 327-352. 11 Ibidem. 12 Enrico Ferri, I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, Bologna, Zanichelli, 1884. 13 Mario Da Passano, Echi parlamentari di una polemica scientifica (e accademica), «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXII, 1 (2002). 14 Vedi Mary Gibson, La criminologia prima e dopo Lombroso, in Silvano Montaldo e Paolo Tappero (a cura di), Cesare Lombroso cento anni dopo, Torino, Utet, 2009. 15 Mario Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, in Luciano Violante (a cura di), Storia d’Italia. 14. Legge Diritto e Giustizia, Torino, Einaudi, 1997, pp. 486-551. 16 Carlo Dossi, La Colonia felice, cit., p. 541. 17 Cesare Lombroso, Palimsesti dal carcere, Torino, Bocca, 1888, p.109. 18 Dante Isella, Note ai testi, cit., p. 1459. 19 Mario Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti, cit. 20 Francesco Lioce, Esperienza letteraria e ideologia politica: il caso Carlo Alberto Pisani Dossi (Da una lettera dell’inedita Vita di Carlo Dossi), cit. 21 Luisa Avellini, La critica e Dossi, Bologna, Cappelli, 1978. 22 Francesco Lioce, Esperienza letteraria e ideologia politica: il caso Carlo Alberto Pisani Dossi (Da una lettera dell’inedita Vita di Carlo Dossi), cit. 23 Gian Pietro Lucini, L’ora topica di Carlo Dossi, Varese, A. Nicola & C., 1911. 24 Ibidem. 25 Francesco Lioce, Flussi migratori e politica africana: alcune lettere di Pisani Dossi a Luigi Bodio, «Rassegna Storica del Risorgimento», a. XCV, Fasc. III, Luglio-Settembre 2008, pp. 379-406. 26 Enrico Ferri, Sociologia criminale, Torino, Bocca, 19004, pp. 886-889. (I) Aristotele, Etica, VII [NdA]. (II) Plutarco, Opere, cap. 19. E così Lucas, Traité physiologique et philosophique de l’éredité naturelle, Paris 1847, I, 480 e 499: […] Lombroso, L’uomo delinquent, II e III ediz [NdA]. (III) Carrara, Programma, § 647, nota [NdA].
Didattica e filosofia
65
li argomenti didatticamente più efficaci sono quelli che
sollecitano negli studenti l’interesse culturale e li stimolano allo
stesso tempo a riflettere sulla propria esperienza, contribuendo
in tal modo alla loro formazione. L’intersoggettività è certamente uno di
quelli che meglio risponde a questi obiettivi. Nondimeno risulta difficile
trattarlo in modo incisivo, anche perché viene tematizzato
espressamente solo a partire dal Novecento, e in particolare con
Husserl, pensatore che solitamente si affronta verso la fine dell’ultimo
anno di studio della filosofia. Ma la difficoltà è soprattutto teoretica e
riguarda le grandi svolte del pensiero, di cui gli studenti devono
diventare consapevoli per assumere punti di riferimento
particolarmente significativi: in primo luogo essi dovranno riflettere
sulla svolta più importante, vale a dire il passaggio dalla concezione di
tipo “egologico” dell’ontologia moderna, per usare un’espressione di
Levinas, che tende a ricondurre l’esperienza della realtà e dunque anche
degli altri soggetti alla coscienza dell’Io - esemplificata in modo
emblematico dal Cogito cartesiano -, ad una concezione che riconosce
il carattere originario e costitutivo della relazione con l’altro. Ci riferiamo
non solo a Husserl, ma a tutta quella tradizione di pensiero che ha
riflettuto su questo argomento, da Merleau-Ponty a Edith Stein, a
Ricoeur, e che, pur declinandolo in termini molto diversi, ne
condividono l’assunto di base: la dimensione interelazionale della
soggettività. Ne consegue che l’esperienza che noi facciamo degli altri
non può essere intesa secondo il modello della conoscenza, che
presuppone un soggetto isolato che si rapporta ad un altro soggetto
isolato; il secondo importante cambiamento di paradigma deriva infatti
dalla considerazione che gli altri non ci sono dati come oggetti che
incontriamo cognitivamente. La possibilità di comprenderci dipende
piuttosto dal fatto che viviamo in un mondo condiviso.
Il tema dell’intersoggettività ha una grande rilevanza nella
formazione degli studenti, perché li mette in grado di comprendere la
cultura contemporanea e dunque di integrare i diversi saperi, in modo
specifico la filosofia con l’arte e la letteratura. Per favorirne una
comprensione efficace, è utile proporre un percorso che ricostruisca la
riflessione filosofica sulla relazione tra i soggetti secondo le differenti
modalità in cui è stata intesa dal pensiero antico e moderno fino al
Novecento, con particolare riferimento alla Fenomenologia e alle più
recenti ricerche delle neuroscienze. Ciò comporta naturalmente che il
tema venga riferito a diversi contesti: da quello morale, che riguarda il
G
DALLA RELAZIONE TRA SOGGETTI
ALL’INTERSOGGETTIVITÀ: UN PERCORSO DIDATTICO
Quaderni della Ginestra
66
nostro modo di comportarci con gli altri, a quello metafisico, che
riguarda l’esistenza degli altri soggetti, a quello cognitivo, che concerne
la nostra capacità di comprendere le loro emozioni e le loro azioni. In
queste pagine intendiamo proporre una prima fase del percorso che
sviluppa le premesse e si conclude con il riconoscimento dell’altro nella
filosofia hegeliana.
Un percorso di questo genere richiede che si chiarisca prima di tutto
che con l’espressione “intersoggettività” si indica quell’aspetto
specifico della relazione tra i soggetti, che il filosofo Husserl ha posto in
evidenza nella sua indagine sull’Io trascendentale e sul suo rischio di
caduta nel solipsismo. Nelle Idee per una fenomenologia pura e nelle
Meditazioni cartesiane egli fa dipendere l’intersoggettività dalla
consapevolezza del nostro corpo come soggetto esperienziale. Il corpo
vivo è il fondamento costitutivo di ogni percezione, inclusa quella
sociale: è il comune denominatore tra il nostro modo di intendere noi
stessi nella relazione col mondo e quello di rapportarci agli altri. Il
carattere incarnato della nostra soggettività è proprio anche delle altre
soggettività. Sulla base di un processo analogico nasce dunque un
sentire comune che diviene condivisione, a proposito del quale Husserl
parla di “enteropatia”, tradotto quasi sempre con empatia. Questa indica
senza dubbio uno stadio originario del fenomeno intersoggettivo, al
quale subentrano poi forme di intersoggettività che si strutturano a
livelli differenti, in particolare con la mediazione del linguaggio. E’
significativo però il fatto che alla luce dell’empatia, parlare di un singolo
che si pone in rapporto agli altri è un’astrazione, non presentandosi mai
secondo Husserl alcun soggetto al di fuori del contesto relazionale.
Il percorso su questo argomento non può naturalmente essere
proposto in astratto, senza il riferimento ad una situazione problematica;
d’altro canto proprio l’approccio iniziale alla filosofia, e in particolare il
suo statuto dialogico, può suggerire lo sviluppo del tema della relazione
con l’altro in un percorso monografico che segue il programma, per così
dire istituzionale, dell’insegnamento della filosofia. La
problematizzazione dell’intersoggettività può inoltre venire rinforzata
dal ricorso alla letteratura più recente; per esempio, uno dei libri più letti
dai ragazzi in questo momento è Io e te di Niccolò Ammaniti (Einaudi
2010), di cui è appena uscita la versione cinematografica di Bernardo
Bertolucci: un adolescente chiuso e introverso, al punto da rinchiudersi
in una cantina pur di sottrarsi al confronto con gli altri - mostrandosi
però agli occhi dei genitori simile a loro - , attraverso un’esperienza
drammatica si apre finalmente a una relazione che darà un impulso
decisivo al suo cambiamento. Anche l’impiego del linguaggio
cinematografico può aiutare ad impostare il problema: in questo caso
Didattica e filosofia
67
suggeriamo la visione di alcune sequenze di un film meno recente, Il
gusto degli altri di Agnès Jaoui (Francia 2000), in cui una serie di
personaggi intrecciano relazioni difficili di cui si intuisce in molti casi
l’inautenticità. Nello sviluppo del film però capita inaspettatamente ad
un personaggio di provare la motivazione a scoprire l’altro, a conoscerlo
nella sua diversità. Così, nel contesto di relazioni che si adattano al
“gusto degli altri”, si delinea un modo nuovo di rapportarsi, improntato
allo scambio e all’interazione. Ciò offre l’occasione per introdurre
l’opposizione di relazione autentica e relazione inautentica, di matrice
heideggeriana, che può fornire agli studenti una chiave di lettura per fare
ordine nella complessità del discorso.
La relazione con gli altri può essere affrontata inizialmente come
problema etico, certamente più vicino al patrimonio esistenziale degli
studenti e di più facile approccio nello studio della filosofia antica.
Come primo momento del percorso proponiamo la trattazione
aristotelica dell’amicizia. La classificazione delle diverse forme di
amicizia proposta da Aristotele nell’Etica Nicomachea prevede, come è
noto, la distinzione tra l’amicizia finalizzata all’utile, quella finalizzata al
piacere e infine l’amicizia finalizzata al bene dell’altro. Al di là
dell’intento sistematico, perseguito dal filosofo, riteniamo di particolare
interesse ai fini del nostro discorso l’indicazione di parametri per
caratterizzare le relazioni: il carattere disinteressato, la reciprocità e la
condivisione, che permettono di cogliere nell’amicizia finalizzata al bene
dell’altro un modello di rapporto con l’altro duraturo e fecondo.
Un nodo problematico che gli studenti sanno far emergere
suggerisce un ulteriore sviluppo: non persuade infatti come una
relazione per essere autentica debba essere assolutamente disinteressata,
dato che pare lecito nutrire un interesse, un’aspettativa verso l’altro,
quando lo si considera un amico. La lettura di alcuni frammenti di
Epicuro può essere utile a chiarire e completare il discorso: sebbene
LAVAPIÉS, MADRID, 2011 X
Quaderni della Ginestra
68
l’amicizia non abbia nulla a che fare con la ricerca dell’utile, è comunque
alimentata da un interesse, senza il quale non potrebbe sussistere alcuna
relazione, e contempla naturalmente anche la fiducia in un aiuto nei
momenti di maggiore difficoltà.
Disinteresse e reciprocità ritornano come componenti essenziali della
benevolenza agostiniana, che è accompagnata da carità e fratellanza.
Tutti elementi che concorrono a caratterizzare la relazione con l’altro
nei termini della misericordia, che l’uomo impara ad esercitare da Dio,
un sentimento di portata universale che vede nell’altro ‘il prossimo’ e
che si realizza a pieno solo nella condivisione della fede. La relazione
assume in primo luogo una direzione verticale - l’altro come Altro
rispetto all’uomo -, per poi consentire un modo nuovo di pensare la
relazione orizzontale con i propri simili, che si sostanzia di mutua caritas
per cui ogni uomo, sia questi uno sconosciuto o addirittura un nemico,
diventa ‘prossimo’. Il mutamento di prospettiva non potrebbe essere più
radicale rispetto alla concezione greca per la quale non solo l’eros
platonico ma, come abbiamo visto, anche l’amicizia aristotelica si
rivolgono a chi è riconosciuto come meritevole, come capace di
incarnare un valore che condividiamo e apprezziamo. Al contrario,
l’agape cristiana è spontanea; non riguarda i buoni e i meritevoli, ma
tutti. E’ un sentimento che deriva dall’amore di Dio per l’uomo e come
tale è ai nostri occhi gratuito, senza motivo.
Non meno interessante risulta mettere in evidenza il silenzio del
pensiero moderno riguardo la relazione con l’altro e guidare quindi gli
studenti a indagarne la ragione. In questa prospettiva, l’attività didattica
sarà finalizzata principalmente a rilevare come, a partire da Cartesio e
almeno fino a Kant, il soggetto costituisca l’asse centrale della filosofia,
nonché l’orizzonte trascendentale nel quale si dà accesso alla verità
Nella filosofia di Kant il tema della relazione è affrontato in ambito
etico, nella Metafisica dei costumi, dove dall’indagine fondativa dell’agire
morale si passa a esaminare l’applicazione della legge morale ai
comportamenti concreti. Qui il filosofo approfondisce due
fondamentali modalità di relazione con l’altro, parallele e
complementari: il rispetto e l’amore. Il rispetto è la massima che ci
impegna a riconoscere la dignità dell’umanità in noi stessi e negli altri.
Come tale lo dobbiamo universalmente a tutti a prescindere dai meriti.
Tanto il primo rientra nella sfera del dovere ed è universalmente
fondato, quanto il secondo non può essere comandato, né riguardare
tutti. L’amore naturalmente rifugge universalità e astrazione, sa parlare
solo il linguaggio della relazione tra singoli, ciascuno dei quali vede
nell’altro un’individualità insostituibile. La complementarietà tra amore e
rispetto delinea una relazione equilibrata tra attrazione e presa di
Didattica e filosofia
69
distanza che crea lo spazio intersoggettivo del dialogo e dello scambio.
Nella prospettiva kantiana tuttavia la modalità fondamentale di
relazione con se stessi e con gli altri è il rispetto; esso esprime il
riconoscimento di un’autorità indipendente, rintracciata nella libertà di
volere che consente a ciascuno di costituirsi come persona. La relazione
tra i soggetti viene intesa perciò sul modello del “regno dei fini” come
comunità ideale di carattere regolativo che raccoglie tutti gli esseri capaci
di agire moralmente in quanto depositari di una ragione universale, che
accomuna, conciliando le differenze. Sia in ambito etico che
cosmopolitico, il filosofo di Königsberg delinea il pluralismo dei
soggetti sullo sfondo di un’idea normativa di umanità che risponde
all’esigenza di individuare un valore incondizionato, alla luce del quale i
progetti individuali, in termini kantiani “i fini di ciascuno”, trovano la
loro condizione di validità nell’unico “fine in sé” che possiamo
universalmente accogliere.
L’idea del riconoscimento dell’altro in quanto tale invece viene
tematizzata dal pensiero hegeliano, in particolare nella celebre dialettica
servo-padrone della Fenomenologia dello Spirito, che rappresenta un
momento di svolta decisivo del nostro percorso perché mette in
discussione il carattere originario dell’autocoscienza, che presuppone
come sua condizione proprio il riconoscimento dell’altro. Prima che
questo si attivi, vi è infatti in ciascuna autocoscienza la pretesa di essere
unica. Rispetto alle modalità prese in considerazione finora dell’amicizia,
dell’amore o del rispetto, la dialettica servo-padrone insegna che
incontrare un altro individuo con la pretesa di conoscere il mondo,
soprattutto con lo stesso potere di libertà, apre uno scenario per nulla
conciliante, anzi nettamente conflittuale. Il riconoscimento reciproco
perciò, per quanto sia un’esperienza vitale, risulta tutt’altro che
rassicurante. La lotta si risolve positivamente quando il riconoscimento
si compie con l’inclusione dell’altro nella relazione e non con la sua
esclusione. Superata la conflittualità, che appartiene ancora allo stato di
natura, la dinamica del riconoscimento tra individui liberi è affidata da
Hegel al linguaggio e alla dimensione dialogica dell’intersoggettività.
Il tema hegeliano del riconoscimento è un punto di riferimento con
cui le riflessioni sull’intersoggettività si sono costantemente confrontate.
In particolare, l’eredità hegeliana raccolta sia dai pensatori
immediatamente successivi sia da quelli del Novecento, riguarda la
possibilità di pensare l’intersoggettività come un’esperienza originaria
anche rispetto alla stessa soggettività.
MARINA SAVI
Libri in discussione
71
ella realtà, l’ultimo libro di Gianni Vattimo edito da Garzanti,
riproduce le peculiari movenze speculative del ‘pensiero debole’
attraverso due momenti accademici: i corsi di Lovanio (1998), tenuti
all’ombra dell’allora recente riconoscimento degli esiti nichilistici
dell’ermeneutica, e le prestigiose Gifford Lectures di Glasgow (2010),
cornice di un confronto serrato con il ‘nuovo realismo’. La continuità
tra le due sezioni dell’opera, integrate da una terza con finalità di
approfondimento, deriva dal tema ricorrente del bisogno di realtà
contrapposto al nichilismo prospettivistico di Nietzsche, ovvero all’e-
nunciazione della tesi che nega l’esistenza dei fatti a favore delle
interpretazioni e, al contempo, attribuisce a se stessa una natura
interpretativa. Assumere che vi sia un’unica realtà, e che la dimensione
fattuale sia ontologicamente consistente e implichi una precisa nozione
di ordine, appare un’esigenza «nevrotica» e inconciliabile con
l’umanesimo vattimiano che, dalla metafisica obiettivistica, sposta il
fuoco sull’interpretante, sulla sua profondità storica, sul soggetto
heideggerianamente ‘interessato’ al commercio con il mondo.
Sottratto a una neutralità desoggettivante, l’uomo è un «punto di
vista finito e parziale» sulle cose, intreccia con esse rapporti
qualitativamente determinabili, e dunque è la sua prospettiva – o
interpretazione – finita a imporsi, non uno sguardo panoramico su
presunti fatti o su altre interpretazioni. Si tratterebbe, infatti, di una
generalizzazione al di sopra dell’interpretante che Vattimo considera
inaccettabile anche per il sapere scientifico. Il che, è evidente, finisce per
mettere in crisi il paradigma corrispondentista della verità. L’adaequatio
rei et intellectus viene respinta perché, come si desume dalle premesse, «la
realtà ‘stessa’ non parla da sé, ha bisogno di portavoce – cioè, appunto,
di interpreti motivati, che decidono come rappresentare su una mappa
un territorio a cui hanno avuto accesso attraverso mappe più antiche».
Al contempo si incrina il mito dell’oggettività, di una datità estranea e
indifferente che invece, secondo l’autore, soggiace costantemente a
interpretazione ed è perciò differente a seconda della mappatura, per
tornare all’immagine sopra evocata, del soggetto interessato. Una
mappatura storica la cui limitatezza prospettica, è bene precisare, non va
dissociata dall’idea heideggeriana, pienamente recuperata da Vattimo, del
nascondimento dell’Essere, di quel suo costitutivo rifiuto a rendersi
completamente disponibile in forme oggettivate e definitive.
Rivelato nella sua infondatezza mediante gli argomenti appena
esposti, il bisogno di realtà viene in un secondo tempo contrapposto al
bisogno di libertà, declinabile sul piano epistemologico, estetico e
D
REALMENTE LIBERI, REALMENTE RIVOLUZIONARI
Quaderni della Ginestra
72
politico. Il realismo descrittivo e rispecchiante, al riguardo, si pone agli
antipodi di una filosofia interessata (secondo il significato di ‘tesa a’, non
indifferente) e progettuale quale Vattimo intende proporre. Se da un
lato, infatti, detto realismo accoglie e legittima un ordine prestabilito, e
cioè «l’universo della organizzazione totale», dall’altro proprio per
questo è associabile alla condanna della metafisica come atto di
violenza, di prevaricazione che cristallizza il pluralismo, spegne qualsiasi
fermento rivoluzionario ed estingue la scintilla di ogni speranza di
cambiamento. Essere liberi, al contrario, «essere antirealisti», come
scrive Vattimo, «è oggi forse l’unico modo di essere, ancora,
‘rivoluzionari’», e questo non perché, rinviando allo sfociare
dell’ermeneutica nel nichilismo, si sia abdicato a qualunque criterio di
verità, bensì perché tali criteri sono stati sottratti all’estraneità della
metafisica e interiorizzati nella storicità del soggetto; sono stati resi
dinamici e malleabili, retorici, frutto di una condivisione in divenire e a
tratti conflittuale, non di un adeguamento chiuso e prestabilito. La
filosofia radicalmente depurata della metafisica, in sintesi, è quella che
«ha preso congedo da una concezione rigidamente oggettivistica della
verità, legandola invece sempre più esplicitamente al consenso di
comunità che condividono paradigmi, tradizioni, anche pregiudizi, ma
che sono consapevoli della loro storicità».
Si tratta di una filosofia ‘cristianizzatasi’, ossia discesa per effetto di
kénosis nell’umano perdendo la connotazione di ricerca impersonale di
una verità somma; essa altresì è, quasi per vocazione, apertura caritativa,
cura verso l’altro. Se quindi la verità non precede ma segue l’accordo
intersoggettivo su di essa, senza eccezione per l’episteme della scienza,
anche un absolutus tradizionale come il concetto di male è destinato a
cadere sotto i colpi della decostruzione della metafisica, in quanto
quest’ultima, secondo Vattimo, è il male: «È male il dominio scatenato
SALSEDINE, AUSTRALIA, 2011
Libri in discussione
73
della oggettività misurabile, l’ansia di non perdere questo dominio, in
tutti i molteplici sensi in cui ne facciamo esperienza, dalla pretesa di non
perdere la prestanza fisica, che ci consente di sedurre, godere, prevalere
sugli altri, alla volontà di potenza dei grandi soggetti storici, alle
molteplici forme in cui si dispiega il principio di prestazione a tutti i
livelli della nostra esistenza».
Ed è precisamente questa la nota caratterizzante della filosofia di
Vattimo quale emerge dal testo: un ricentramento dello sguardo sul
soggetto e sull’Essere, un invito al recupero dell’autenticità dell’uomo
quale essere interpretante chiamato, proprio in forza di questo statuto,
ad un esercizio di responsabilità verso i suoi simili e verso il mondo in
cui vive. Il percorso che in Della realtà giunge a siffatto esito è
consapevolmente un’interpretazione, nella quale Nietzsche, l’Heidegger
di Sein und Zeit e della controversa adesione al nazismo, Adorno, Dewey,
Tarski, Feyerabend e Rorty mescolano le loro voci generando risonanze
originali, non di rado meritevoli di essere discusse. Tuttavia l’alone
interpretativo che si estende sul testo, certamente pregevole per gli
scorci di dibattito che ancora può dischiudere, non può essere dissolto,
per esempio, invocando alla maniera girardiana un compromesso che
invalidi tanto un atteggiamento di mitizzazione del fatto quanto la
struttura portante del ‘pensiero debole’. Ammettiamo pure che queste
prese di posizione siano entrambe pseudo-radicalizzazioni, e che la
fiducia nella ragione debba evitare di trasformarsi in idolatria attraverso
un equilibrio virtuoso tra fatti e interpretazioni: semplicemente,
risponderebbe Vattimo a una tale obiezione che chiude il volume del
dialogo con Girard, anche questa è un’interpretazione.
GIACOMO MIRANDA
G. Vattimo, Della realtà, Garzanti, Milano 2012, pp. 231, € 18.
Quaderni della Ginestra
74
LA PESTE TRA COLPA E DESTINO
he cos'è la peste? E qual è il senso della vita umana di fronte a
essa? Che senso ha, in altre parole vivere in un mondo in cui
incombe la peste? Si interroga su queste (e su altre) domande Sergio
Givone ne La metafisica della peste: colpa e destino. Partendo dalla questione
ontologica della peste (che cosa è la peste) l'autore cerca di andare al
cuore della riflessione mettendo in luce quanto il terribile flagello viva e
si rifletta all'interno di una profonda dualità e, di conseguenza,
ambiguità: essa, la peste, è, allo stesso tempo, immanente e trascendente.
É immanente in quanto fatto di natura: è un'infezione del corpo, una
malattia, sia pure la più virulenta, ma non altro. Ma ha anche un lato
trascendente, perché nell'eccedenza della sua portata, nello sterminio
straordinario che compie, riaccende nell'uomo domande sul destino, il
fato e la colpa.
La peste reca in sé, qualcosa di fatale: è nella natura ma sembra
incombere esternamente (trascendenza) sul mondo come vendetta per
una colpa da espiare per mezzo della morte. Come non vedere allora
nella peste il senso di una colpa, una tanatodicea? La peste come vendetta
divina causata da un'offesa da redimere, come le frecce avvelenate che il
dio Apollo lancia nel campo degli Achei per punire una profanazione (il
rapimento del sacerdote Criseide). Se la peste è cosa di natura, la sua
virulenza straordinaria che rende impensabile il senso stesso del suo
catastrofismo (come può esistere qualcosa di così orrorifico?), vuol dire
che la natura, da sola, non basta a spiegarla. Essa è, in sensu stricto, il male
o, meglio, lo sfondo del Male in cui si staglia l'esistenza stessa dell'uomo.
Che la peste non sia solo peste ma sia il Male è facile a capirsi: essa reca,
ovunque scoppia, dolore morte e desolazione. Si abbatte
immotivatamente. Uccide i giusti quanto gli ingiusti. La sua “condotta”
non segue un senso, un disegno. La peste non ha senso. Certo, si dirà
che è solo un virus, un fatto di natura. Eppure la sua portata risulta
troppo grandiosa per risolversi in una chiave naturalistica, tanto da
domandarsi, in forma traslata, “Se Dio esiste, perché la peste?”.
Si scopre allora che tutta la riflessione di Givone sulla peste non è
altro che un pretesto per parlare dell'uomo e del senso della sua vita di
fronte al male e a una morte incolpevole e incombente. Non già la
peste, il morbo-peste, la malattia dei ratti, ma il male che affligge l'uomo,
il male verso l'uomo e il male dell'uomo, il destino che si abbatte
immotivatamente nell'uomo e la colpa che ogni uomo porta in sé in
quanto peste, in quanto male di cui ognuno fa le veci. Responsabilità
verso il destino direbbero i drammaturghi greci, peccato originale i
cristiani. Destino ed elezione direbbero i primi, caduta e salvezza i
C
Libri in discussione
75
secondi. Non dunque meditatio pestis, meditatio naturae,
quanto meditatio mortis, meditatio mali, meditatio hominis. Perché la peste,
prima di essere un fatto di natura, ordinario o straordinario che sia, è un
fatto umano, troppo umano. Basti leggere per capirlo Lucrezio, Boccaccio,
Berni, Leopardi, Manzoni, ma anche gli stranieri Defoe, Blake, Poe,
Dostoevskij, Camus, tutti autori che Givone prende in prestito per
parlare di quanto il senso, o i diversi sensi, della vita umana, ruotino
intorno al fatto più spiacevole della vita stessa: il male, la morte. Perché
non c'è vita e non c'è significato che non parta partendo dal male.
Curioso fatto: «non mortis, sed vitae meditatio», direbbe Spinoza. Ecco allora
la peste parlare della caduta nella barbarie (Cormac Mc Carthy), ma
anche della possibilità di resistere al male attraverso una nuova etica
(Camus); parlare del male come entità psichica, spirituale, quasi una
colpa essenziale alla vita (Artaud), ma anche come strumento di
misericordia divina (Manzoni); come un fatto che riduce l'umanità allo
stato di natura capace, allo stesso, tempo di aprire alla solidarietà umana
(Leopardi); la peste che tutto appesta, persino il linguaggio preparando
l'avvento di Hitler e del nazismo (Kemplerer). E se quest'ultimo male,
banale o, meglio, banalissimo, si è abbattuto sull'Europa come un
orribile destino, non di meno si è potuto parlare di una colpa di cui
l'umanità intera si trova responsabile e che va affermando: «noi siamo
vivi, è questa la nostra colpa» (Jaspers).
Colpa incolpevole dunque, colpa di destino, ciò non di meno colpa.
Perché il destino e la colpa lungi dall'escludersi a vicenda in realtà
cadono insieme. E se questa colpa, e se questo destino, in quanto banali
risultano senza senso, non sarà allora una metafisica della peste a dirci
che forse la stessa insensatezza è, in ultima analisi, il senso dell'essere?
DANIELE FOTI
Sergio Givone, Metafisica della peste: colpa e destino, Einaudi, Torino 2012,
pp. 206, € 22
Quaderni della Ginestra
76
SENTIRE E CONOSCERE: L’UOMO, “CREATURA
EMOTIVA”
ebbene inizialmente concepito come traduzione inglese de Qu’est-ce
qu’une emotion, breve saggio introduttivo sulla natura dell’emozione
apparso presso Vrin nel 2008, il testo di Deonna e Teroni in esame si
presenta essenzialmente come un testo nuovo: ampliato e modificato
rispetto all’originale, intende offrire un’introduzione alla filosofia delle
emozioni in una prosa estremamente chiara e scorrevole.
Ma in che senso l’emozione può diventare oggetto di una riflessione
filosofica? Per Deonna e Teroni si tratta innanzitutto di chiarire cosa si
debba intendere per ‘emozione’, per poi proporre una teoria originale
che renda giustizia al ruolo fondamentale delle emozioni nel nostro
valutare quotidiano.
I primi due capitoli del testo sono dedicati a rispondere alla
domanda: cos’è un’emozione? Sono presentate e valutate le principali
teorie sulla natura delle emozioni, di cui sono esposti pregi e difficoltà.
È possibile individuare tre caratteristiche essenziali delle emozioni:
hanno una certa fenomenologia, sono legate cioè a un ‘sentire’
corporeo; sono dirette verso un oggetto – godono di intenzionalità;
sono soggette a standard di correttezza (le emozioni possono essere
appropriate o inappropriate) e a standard epistemologici (le emozioni
possono essere giustificate o non-giustificate). Nel primo capitolo, in
particolare, l’emozione è distinta da altre tipologie di fenomeno
affettivo, come desideri e stati d’animo [moods]. Desideri ed emozioni si
differenziano per ‘direzione di adattamento’: mentre l’emozione ha una
direzione mente-mondo, è cioè giustificata nel momento in cui un
oggetto istanzia effettivamente la qualità presentata dall’emozione – per
esempio, la mia paura risulta legittima se l’oggetto nel mondo è di fatto
S
LE PORTE DELL’EDEN, AUSTRALIA, 2011
Libri in discussione
77
‘pericoloso’ –, il desiderio ha invece una direzione mondo-mente, ossia
tende a modificare il mondo per renderlo conforme alle aspirazioni
dell’individuo. Infine, diversamente dall’emozione, uno stato d’animo
(come ‘scontroso’) non è affatto intenzionale, non riferendosi ad alcun
oggetto specifico. Una volta differenziata l’emozione da altri fenomeni
affettivi, gli autori difendono, nel secondo capitolo, l’unità della
categoria di ‘emozione’, mettendo in luce la dipendenza di ogni
emozione, anche le più complesse (il senso di colpa, per esempio) da
stati cognitivi di base.
Tra il terzo e il sesto capitolo vengono analizzate le principali
posizioni contemporanee sulla natura delle emozioni. Nel terzo capitolo
viene confutata la teoria secondo cui le emozioni sono combinazioni di
desideri e stati cognitivi, e si difende la connessione tra emozione e
valutazione. Nel quarto e nel quinto capitolo viene invece
problematizzata la connessione tra provare un’emozione e attribuire una
certa proprietà valutativa a un oggetto, confrontando le opzioni realista-
oggettivista e disposizionalistico-soggettivista sul valore. Nel quinto
capitolo, in particolare, si confuta la ‘teoria del giudizio valutativo’,
secondo cui le emozioni vanno ridotte ai giudizi valutativi su cui si
fondano. Ma se emozione e credenza/stato cognitivo coincidono, come
spiegare che si possano attribuire emozioni anche a bambini e animali,
chiaramente estranei alla formulazione di giudizi? La sovrapposizione di
emozione e giudizio elimina erroneamente il versante fenomenologico,
del ‘provare’ fisicamente l’emozione, del ‘sentirla’ a prescindere dal
nostro padroneggiare concetti. D’altro canto, gli autori prendono
ugualmente le distanze da teorie che disconoscono la funzione
informativa dell’emozione (il suo essere diretta verso un certo oggetto),
e che si concentrano esclusivamente sul coinvolgimento corporeo che
l’emozione implica, o definiscono le emozioni in termini di percezione
di proprietà valutative. Nel sesto capitolo, inoltre, si evidenzia la natura
fuorviante dell’analogia tra percezione ed emozione, la cui
interpretazione in senso letterale è evidentemente esclusa dall’assenza di
specifici ‘organi dell’emozione’ che svolgano una funzione analoga a
quella svolta dagli organi di senso in campo percettivo. Gli autori
delineano quindi la propria proposta di una teoria ‘attitudinale’ delle
emozioni, in cui trovano conciliazione la funzione informativa
dell’emozione, il suo dirigersi verso un oggetto, e il versante
fenomenologico di un coinvolgimento corporeo. L’emozione è definita
come «attitudine verso un oggetto, appropriata quando l’oggetto
esemplifica una certa proprietà valutativa», dove per ‘attitudine’ si
intende la reazione del nostro corpo di fronte a un determinato oggetto
e alle sue proprietà.
Quaderni della Ginestra
78
Negli ultimi tre capitoli, infine, si approfondisce la questione della
giustificazione di un’emozione, indagando a quali condizioni essa possa
essere dichiarata ‘giustificata’ e sottolineando l’importanza degli stati
cognitivi di base. Si ritorna quindi sul rapporto tra emozioni, sentimenti,
stati d’animo e desideri, evidenziando il ruolo fondamentale
dell’emozione nel nostro quotidiano acquisire conoscenza del valore.
Pur presentato come introduzione alla filosofia delle emozioni, il testo
di Deonna e Teroni va al di là della semplice illustrazione del dibattito
contemporaneo sulla nozione di emozione: gli autori prendono
esplicitamente posizione contro o a favore delle teorie esposte,
avanzando una teoria originale sulla natura dell’emozione. Altro
importante pregio del testo è il suo non limitarsi all’analisi della sola
nozione di emozione, dando conto della complessità della vita affettiva,
costituita anche da stati d’animo, desideri e sentimenti. Particolarmente
utile per ottenere una visione d’insieme dello stato attuale del dibattito
sull’emozione, il testo in esame vi contribuisce in modo del tutto
originale.
CRISTINA TRAVANINI
J.A. Deonna, F. Teroni, The Emotions. A philosophical introduction, Routledge, London-New York 2012, pp. xiii+137, € 22