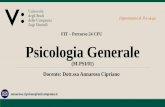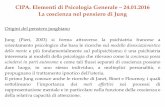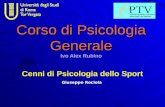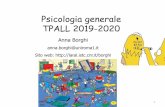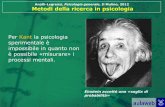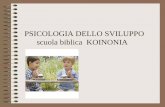Psicologia Generale
-
Upload
vincenzovitale -
Category
Documents
-
view
11 -
download
2
description
Transcript of Psicologia Generale

PSICOLOGIA GENERALETeoria ingenua: fondata sulla nostra esperienza personale, non su controlli scientifici, non si verifica l’esperimento opposto. La psicologia, concepita come insieme di teorie ingenue, esiste da quando l’uomo ha iniziato a riflettere su se stesso. La psicologia, concepita come disciplina scientifica, è iniziata poco + di un secolo fa in Germania e poi si è diffusa in tutto il mondo. La disciplina scientifica si basa principalmente sul metodo sperimentale: verifica di una relazione causa-effetto tra due variabili (var indipendente – dipendente. Es. la frequenza alle lezioni è una var indipendente, cioè controllata da colui che effettua l’esperimento x vedere l’effetto che produce sulla variabile dipendente che in questo caso potrebbe essere il grado di apprendimento. Un esperimento di questo tipo dovrebbe però tenere presente anche variabili quali lo studio con uno studente che già conosce la materia…)Gli esperimenti vengono fatti su gruppi detti GRUPPI DI CONTROLLO. In assenza dei dati del gruppo di controllo, i dati sono ARTEFATTI. Se non c’è la possibilità di eseguire un esperimento guidato, quindi non c’è un gruppo di controllo, bisognerà limitarsi ad esperimenti naturali. Perché un esperimento sia valido deve essere verificato anche il suo opposto. Metodi non sperimentali sono: questionari, interviste, colloqui clinici e metodo correlazionale. Quest’ultimo serve x stabilire una relazione tra due variabili che però non dipendono l’una dall’altraLa relazione può essere nulla (var completamente indipendenti), positiva (var in rapporto direttam proporzion) o negativa (var in rapporto inversam proporzion). Non è stato facile accettare l’idea che l’uomo facesse parte della natura e che andasse studiato con approccio scientifico. Freud stabilì 3 tappe x giungere a queste conclusioni: mortificazione cosmologica (scoperta di Copernico, la terra nn è al centro dell’universo), mortif biologica (teoria di Darwin, l’uomo nn è diverso dagli animali ma è una sua evoluzione), mortif dell’io (l’uomo nn è consapevole di quello che accade nella propria psiche). Infatti Freud critica la teoria di Descartes secondo cui si può dubitare l’esistenza del corpo ma nn della mente: secondo lui si deve dubitare anche della mente o meglio di come appare alla nostra coscienza. Per questo egli rifiuta anche il metodo introspettivo, analisi di se stessi. Il metodo introspettivo e lo strutturalismo (che studiava la struttura della mente attraverso un esame introspettivo della coscienza: l’esperienza viene frammentata in elementi distinti) viene rifiutato anche dai Gestaltisti (l’uomo osserva la globalità e non il particolare) e dai comportamentismi (l’oggetto di studio deve essere il comportamento in quanto misurabile oggettivamente, mentre i processi mentali nn si possono vedere né misurare. Tralascia tutto ciò che nn è osservabile o attinente al pensiero. Tutto è spiegabile attraverso la sequenza stimolo-risposta. Uno dei limiti è controllare e riconoscere emozioni come la paura…) PERCEZIONE: è l’elaborazione di una sensazione che a sua volta è la risposta ad uno stimolo dell’ambiente. I nostri organi nn sono in grado però di percepire tutti gli stimoli esterni, dipende dall’intensità. C’è cmq una SOGLIA ASSOLUTA INIZIALE al di sotto della quale lo stimolo nn viene avvertito. Mentre al di sopra della SOGLIA ASSOLUTA TERMINALE, la sensazione si trasforma e colpisce altri sensi. Gli stimoli recepiti sono detti sovraliminari, gli stimoli nn avvertiti sono detti infraliminari. Per cogliere una variazione di intensità tra due stimoli bisogna che ci sia un minimo di differenza di intensità detta SOGLIA DIFFERENZIALE. Per misurare l’intensità della soglia assoluta e per cogliere la variazione nella soglia differenziale, sono stati messi a punto dei metodi psicofisici e attraverso esperimenti si riusciva a stabilire una scala (es. uno stimolo doveva essere avvertito da + del 50% delle persone). Studiando le soglie ci si è accorti che la qualità delle sensazioni varia al variare degli stimoli fisici. Questo aspetto è stato studiato dalla psicofisica che stabilisce il legame tra il mondo psichico e il mondo fisico. Weber si rese conto, facendo degli esperimenti, che la soglia differenziale è una proporzione costante dell’intensità dello stimolo iniziale (legge di Weber). Più recentemente Stevens diede origine alla psicofisica soggettiva secondo la quale ogni individuo può valutare l’intensità di una sensazione associandola ad un numero (es. si fa sentire uno stimolo e si dice che ha intensità 10, poi si fa sentire il successivo e l’individuo assegnerà un numero minore o maggiore). Nella teoria della detenzione (rilevazione) del segnale viene considerato il criterio soggettivo di decisione (se uno stimolo è presente o no). La percezione focalizza la sua attenzione non sull’essere ma sull’apparire. Ciò che noi percepiamo nn è necessariamente la realtà fisica ma una realtà fenomenica: l’oggetto percepito dipenda dal soggetto che percepisce. Infatti sono 2 le fonti di informazione che possono essere utilizzate x percepire il mondo BOTTOM UP (elaborazione guidata dai sensi) o TOP DOWN (elaborazione guidata dalla conoscenza passata e dall’esperienza). È importante studiare come questi 2 processi influenzano la percezione x valutarne la rispettiva importanza.

Le principali 5 teorie:- Teoria empiristica: proposta inizialmente da Helmotz. L’esperienza con la realtà ambientale è fondamentale x la percezione degli oggetti. Attraverso l’associazione l’individuo compie una specie di ragionamento inconsapevole e quindi corregge ed integra le sensazioni.- Scuola della Gestalt: si oppongono al principio empiristico dell’esperienza passata sostenendo che la percezione è un processo primario ed immediato non dovuto al concorso di altri fattori come l’associazione e il giudizio. Si basa su una forma globale, è il risultato delle diverse componenti di uno stimolo.- Movimento del new look: nasce negli USA. La percezione dipende anche da stimoli interni, stati d’animo, aspettative e motivazioni del soggetto percepente. (esperimento di Bruner: i bambini con condizioni economiche disagiate percepivano + grande una moneta da mezzo dollaro rispetto ad un disco di cartone delle medesime dimensioni).- Teoria ecologica di Gibson: respinge la tesi cognitivista secondo la quale la percezione è il risultato di un’attività di elaborazione dello stimolo. Gibson propone un approccio ecologico della percezione: tutto ciò di cui ha bisogno l’uomo x comprendere il mondo, è già presente nel mondo; ci sono delle offerte di “possibilità” che saranno colte in base allo stato psicologico del soggetto: es. un’arancia viene percepita come qualcosa da mangiare x un affamato o un oggetto da lanciare x un arrabbiato.- Teoria computazionale di Marr: il sogg codifica le immagini in funzione delle variazioni di intensità luminosa. L’attività percettiva viene distinta in 2 fasi: uno schema primario grezzo che poi si trasforma in uno schema a 2 dimensioni e mezzo attraverso l’elaborazione delle informazioni percettive. (chiamato così xchè non vengono esaurite la totalità delle informazioni che esistono nella distanza tra 2 superfici collocate in differenti parti del campo visivo).Attraverso l’attività percettiva riusciamo a cogliere gli oggetti posti nello spazio. Secondo Rubin, nel riconoscimento d’immagine, non c’è figura senza sfondo. La figura appare in risalto rispetto allo sfondo. A volte però si creano delle condizioni x ottenere figure reversibili con contorni ambigui (candelabro-volti)oppure con contorni anomali come l’effetto Kanizsa che riguarda la percezione di figure fisicamente non presenti (figure senza contorni all’interno di altre – triangolo)Wertheimer e l’organizzazione percettiva: era un gestaltista e partendo dall’unificazione dell’unità percettiva enunciò 6 principi fondamentali che riguardavano il raggruppam percettivo:- Vicinanza: si unificano gli elementi vicini- Somiglianza: si unificano gli elementi simili- legge del destino comune: si unif gli elem che hanno lo stesso tipo e direzione di moviment- legge della continuità della buona direzione: elementi che hanno continuità di direzione- chiusura: sono percepiti come unità gli elementi che tendono a chiudersi tra loro- pregnanza: percepiamo gli elementi che tendono alla massima regolarità l’unità percettiva quindi non dipende dalle caratteristiche dei singoli elementi ma dalla proprietà del tutto secondo la quale il tutto è + della somma delle singole parti (musica è + dell’unione delle note. le costanze percettive (grandezza, forma e colore) sono processi in base ai quali gli individui percepiscono gli oggetti e gli eventi della realtà in maniera invariata e stabile nonostante ci siano stimolazioni diverse. Es. se vediamo un oggetto in lontananza tendiamo a percepirlo con la sua grandezza naturale. Es. in un salone le finestre frontali, sinistre e destre, quindi di varie forme, rettangolari, trapezoidali vengono percepite tutte rettangolari. La coscienza e l’attenzione sono attività psichiche continue e costantemente mutevoli. La coscienza consiste nella capacità di rispondere agli stimoli provenienti dall’ambiente. La coscienza esercita anche un’attività di controllo sui processi cognitivi rendendo possibile organizzare le nostre attività, interromperle o modificarle se necessario. Anche se ha una funzione autonoma, si fonda su processi inconsci come affermò Freud già alla fine dell’800 portando l’esempio dell’iceberg – la coscienza è solo la punta mentre tutto il resto rappresenta l’inconscio.ATTENZIONE: è la capacità di selezionare parte delle stimolazioni in arrivo, è sinonimo di concentrazione. È difficile orientarsi su 2 stimoli uditivi o visivi contemporaneamente. Se all’improvviso qualcosa si muove rapidamente o inizia a lampeggiare la nostra attenzione si dirige verso questo stimolo che è nuovo, sorprendente e è forte.

Aspetti dell’attenzione selettiva: integrazione (capacità di mettere in relazione diversi aspetti dello stimolo); filtraggio (ignorare informazioni non rilevanti); ricerca (capacità di individuare un oggetto presente nel campo visivo); effetto facilitazione o Priming (l’elaborazione precedente delle informazioni influenza l’elaborazione successiva. È positivo se facilita la prestazione successiva, è negativo se la peggiora).I processi dell’attenzione sono influenzati da 3 effetti:- effetto Simon: il sogg ha di fronte 3 riquadri a sx e 3 a dx nei quali scorrono in maniera casuale immagini di quadrati e rettangoli. Il sogg deve premere il pulsante sx se compare un quadrato e quello dx se compare un rettangolo. Si è osservato che i tempi di reazione sono influenzati dalla posizione dello stimolo e del pulsante se coincidono o no.- effetto Stroop: i sogg devono indicare il colore con cui è scritta una parola. La velocità è rallentata quando ci sono dei conflitti (parola ROSSO scritta in verde)- effetto Navon: ai sogg vengono presentate lettere grandi composte da lettere piccole. Si rallenta la risposta quando c’è incongruenza. È impossibile non leggere il globale.Ipotesi della selezione tardiva: il sogg tende a elaborare lo stimolo in maniera completa, solo quando deve dare la risposta interviene l’attenzione selettiva. APPRENDIMENTO: gli uomini, come tutti gli esseri viventi, ha dei comportamenti innati: in base alle nostre esperienze possiamo fare previsioni e adattarci all’ambiente. Pavlov, in un famoso esperimento con un cane, studiò la relazione stimolo-risposta nel caso del riflesso, cioè una risposta automatica del sistema nervoso. Iniziò con il far sentire un suono di campana ad un cane. Poi successivamente, dopo il suono di campana, gli portava del cibo. Il cane iniziò ad associare il suono con il cibo quindi di seguito, dopo il suono della campana e prima di vedere il cibo, il cane iniziava a salivare. Si instaura così un condizionamento. Successivamente x generalizzazione si tende a rispondere anche a stimoli simili e questo indica capacità di formare delle categorie.Il processo di categorizzazione serve xchè riducendo tutto in categorie, si possono assimilare tanti eventi simili in un’unica categoria (eventi pericolosi).Lo studioso Rosh ha evidenziato una gerarchia delle categorie da noi utilizzate:- livello sopraordinato (mobile)- livello di base (sedia). È il + usato dagli adulti e il 1° che viene appreso dai bambini- livello subordinato (sgabello)Skinner riprese le ricerche del condizionamento classico di Pavlov e introdusse la distinzione:- comportamento rispondente (derivati da riflessi innati, o tramite il condizionamento come la salivazione). Si ha quindi un condizionamento rispondente: la salivaz è inevitabile- comportamento operante (es. il gatto che impara a premere la leva x uscire dalla gabbia, è un riflesso non innato) qui abbiamo un condizionamento operante, cioè scelto liberamenteSkinner introduce anche il modellaggio. Si possono premiare certi comportamenti in modo da avere un apprendimento + veloce. Secondo lui attraverso il modellaggio era possibile creare una società ideale, dove nn erano necessarie le punizioni, ma solo un giusto dosaggio dei premi.Chomski, mette in luce però i limiti di questo sistema comportamentista dal punto di vista del linguaggio. L’apprendimento del linguaggio è troppo veloce x essere spiegato con una relazione stimolo risposta. Propone quindi il modello della grammatica generativa secondo cui il linguaggio veniva appreso quando si padroneggiavano 3 componenti:- dizionario finito (il lessico di una lingua)- un insieme di simboli iniziali (frasi)- un insieme finito di regolepartendo dai simboli iniziali, applicando le diverse regole ai termini del lessico si hanno le frasi corrette di una data lingua. Egli evidenziò la creatività del linguaggio infantile, i bambini pronunciano frasi che non hanno mai sentito. All’origine dell’acquisizione del linguaggio c’è un meccanismo innato che porta all’apprendimento.MEMORIA: è un processo complesso da cui si possono richiamare eventi trascorsi. Si distingue in struttura (organizzazione fisica della memoria) e processi (attività che si verificano all’interno della struttura). In

passato era considerata come un insieme unitario, poi Atkinson e Shiffrin la distinsero in 3 magazzini diversi x capacità, durata e funzioni:- magazzino sensoriale: conserva le info x pochi istanti ed è associato alla vista, il gusto, il tatto, l’udito, olfatto- magazzino di memoria a breve termine: ha una capacità > del primo, (mezzo minuto) ma è cmq limitato- magazzino di memoria a lungo termine: ha capacità anche illimitateIl passaggio dal magazzino sensoriale a quello a breve termine avviene attraverso l’attenzione.Il passaggio da quello a breve termine a quello a lungo termine avviene attraverso la codificazione, attraverso la ripetizione del ricordo (che è una tecnica mnemonica).Con la teoria di Baddley si è dimostrato che a sua volta la memoria a breve termine nn è un sistema unitario, ma un sistema complesso (chiamato working memory) composto da:esecutore centrale (ha capacità limitata e si utilizza nei compiti + impegnativi)circuito fonologico (l’info conservata è basata sul linguaggio e la sua capacità è determinata dalla durata temporale)taccuino visivo-spaziale (è una codificazione paragonata ad un foglio di appunti)TEORIA della MENTE: già a 3 anni i bambini sanno distinguere oggetti reali da entità mentali, ma la distinzione tra realtà e immaginazione nn è ancora netta. Anche se sappiamo che le nostre immaginazioni nn sono reali, provocano emozioni come se fossero vere. Gli adulti hanno maggiore capacità nel discriminare le false credenze xchè sono in grado di costruirsi modelli di modelli mentali altrui. (es. si scatta una foto di un vaso posto su un tavolo poi si sposta il vaso su una finestra e si domanda ad un bambino piccolo dove sarà il vaso sulla foto e lui dirà finestra xchè nn ha ancora sviluppato una teoria dei contenuti delle menti altrui.La memoria si distingue anche in- memoria episodica: contiene ciò che è relativo alle nostre esperienze (pranzo di oggi?)- memoria semantica: contiene le info relative alla nostra conoscenza (capitale Francia)- memoria esplicita: quando la prestazione richiede un ricordo consapevole delle esperienze precedenti. È sia semantica che episodica- memoria implicita: viene immagazzinata in maniera inconsapevolel’oblio è l’eliminazione volontaria o involontaria di info già memorizzate. Include anche la selezione delle info in entrata. L’oblio può essere causato dal trascorrere del tempo e da 2 interferenze: retroattiva (il nuovo materiale appreso danneggia il precedente); e proattiva (il precedente materiale interferisce nella memorizzazione del secondo) ES. in una poesia è + difficile memorizzare la parte centrale.Il metodo migliore x memorizzare un testo viene chiamato modello PQ4R:- preview: scorrere i capitoli x avere una visione degli argomenti principali- questions: porsi delle domande- read: leggere cercando di rispondere alle domande- reflecte:riflettere sulle nuove conoscenze- recite:ripetere senza guardare il testo- review: ripensare ogni capitolo nel suo insiemePENSIERO: i meccanismi del pensiero ci guidano nei processi di decisione e soluzione dei probl.È stato studiato che avendo un’info iniziale ci guida in quelle successive (es. macchina x o y).La PSEUDIAGNOSTICITA’ è il trascurare alcune info pur di formulare un’ipotesi. Questo meccanismo viene collegato ad altri fenomeni e studiati nella TEORIA DEI MODELLI MENTALI.generalmente ci accontentiamo in maniera inconsapevole di modelli semplificati della realtà che guidano il nostro modo di pensare. I modelli mentali sono rappresentazioni di situazioni reali, ipotetiche o immaginarie utilizzate x fare previsioni e ragionamenti. Componente essenziale del pensiero umano è il ragionamento. Può essere induttivo (dal particolare al generale) o deduttivo (dal generale al particolare, e si basa sul sillogismo). Per molti secoli si è ritenuto che studiare la logica servisse x ragionare in maniera corretta. I sillogismi (ragionamenti che permettono, date 2 premesse, di giungere ad una conclusione)sono di 2 tipi:- modus ponens (+ semplice – se A allora B – A – quindi B)- modus tollens (+ diff – se A allora B – non B – non A)

Naturalmente ci accorgiamo che è + scorrevole il processo di pensiero del modus ponens che è + esplicito, questo dipende dalla teoria delle regole formali che suppone che noi siamo dotati dalla nascita di una logica naturale: la mente sarebbe munita di regole di inferenza (presenti nel modus ponens) che inconsapevolmente provocano inferenze. La Teoria dei modelli mentali ritiene, invece che le regole di inferenza dipendono dall’allenamento della persona sulla logica. Inoltre la nostra mente segue il principio della verità: poiché la nostra memoria di lavoro è limitata, si scartano le informazioni false e si focalizza l’attenzione su quelle vere.Il METARAGIONAMENTO è il ragionamento che ha x ogg il ragionamento altrui ed è importante nei rapporti sociali perché si può far pensare a delle persone ciò che si vuole che pensino. La molteplicità degli schemi altrui rende a volte difficile la soluzione di problemi.Il PROBLEM SOLVING è la capacità degli esseri umani di affrontare e risolvere un problema. Se ne sono occupati i gestaltisti e poi i cognitivisti. Non i comportamentismi xchè x loro i processi mentali nn erano osservabili. Non la psicanalisi xchè riteneva i processi mentali determinati dall’inconscio.I gestaltisti però nn erano d’accordo con i cognitivisti. Koler (G) fece un esperim con scimmia chiusa in gabbia che doveva raggiungere delle banane e aveva a disposiz solo dei bastoncini. Li unì e raggiunse l’obbiettivo: attraverso un’intuizione (insight) si è risolto il problema. I cognitivisti criticano l’insight. X affrontare un probl bisogna, partendo da uno spazio problemico, distinguere lo stato iniziale, lo stato obbiettivo, lo stato intermedio e lo stato finale di risoluzione. Le strategie x ridurre il num di stati intermedi sono i metodi euristici, in contrapposiz con i gli euristici ci sono gli algoritmi che invece prevedono l’analisi di tutti gli stati fino a quello finale. Ci vuole + tempo ma si arriva quasi certamente alla soluzione. Importante nella soluzione dei problemi è anche la creatività, x soluzioni mai trovate (es. post-it – colla che non si asciuga mai)LINGUAGGIO: l’ultima cognizione è quella dei comportamenti secondo la quale esiste una relazione tra pensiero e linguaggio. La comunicazione nasce dalla necessità di comunicare a qualcuno il proprio pensiero, è quindi un processo di trasmissione di info da un’emittente ad un ricevente attraverso un trasmettitore. Le info che dal ricevente ritornano all’emittente sono dette Feed-back che è positivo se aumenta l’info in ingresso o negativo se riduce l’info.Secondo l’approccio semiotico la comunicazione affronta un processo di significazione (la proprietà di ogni messaggio di avere un significato). Il punto di vista semiotico approfondisce i processi di significazione facendo riferimento agli ambiti dei segni e dei codici. Il punto di vista pragmatico (Austin) esplora i diversi modi in cui i significati sono usati nelle varie circostanze. Distingue atto dalla forza dell’atto stesso: il modo in cui un enunciato è interpretato dipendono dalla forza illocutoria (verbi, intonazione) e effetti perlocutori (comportamenti sull’interlocutore)La pragmatica studia anche i rapporti che intercorrono tra testo e contesto (dire qualcosa è anche fare qualcosa). Il contesto va concepito come l’insieme delle condizioni spaziali, temporali, culturali in cui si verifica un atto comunicativo. Da un punto di vista psicologico la comunicazione è una relazione gioco tra individui: si distingue il piano della comunicazione (i contenuti che si scambiano) dal piano della metacomunicazione (riguarda l’interpretazione del messaggio).3 grandi filoni hanno dato una definizione alla parola significato:- secondo la semantica logico-filosofica è il rapporto tra linguaggio e realtà. Il linguaggio costituisce l’immagine e la copia del mondo.- secondo la semantica strutturale è un valore distinto dal concetto di realtà, nn bisogna fare riferimento ai termini. Non è sostenibile xchè come si possono individuare relazioni senza far riferimento ai termini?- secondo la semantica cognitiva è il modo in cui ci rappresentiamo mentalmente la realtà. Partendo dal processo di categorizzazione, definisce il significato come PROTOTIPO (all’interno di ogni categoria alcuni elementi sono + rilevabili di altri). La 1° teoria dei prototipi definisce il prototipo come il miglior esemplare della categoria. Ma poiché si può far parte di una categoria anche senza esserne l’esemplare venne formulata la 2° teoria dei prototipi. Si basa nn solo sulle proprietà essenziali ma anche su quelle tipiche: l’appartenenza di un elemento ad una certa categoria richiede la presenza di proprietà essenziali, ma la sua rappresentatività è maggiore quanto maggiore è il numero delle proprietà tipiche possedute. Ogni comportamento è comunicativo in rapporto all’intenzionalità. Distinguiamo gli atti comunicativi semplici (quando l’intenzione comunicativa è dichiarata, es. saluto) e gli atti comunicativi complessi quando l’intenzione nn corrisponde con il significato letterale es. ironia. La comunicazione è accompagnata anche da

gesti ed espressioni che compongono la comunicazione non verbale. Anche nn parlare è un comunicare. Il linguaggio nn verbale ha una propria autonomia comunicativa (linguaggio sordomuti).MOTIVAZIONE: ogni comportamento umano è motivato da una serie di cause x la soddisfazione di specifici bisogni. L’individuo è spinto sia da fattori esterni (es. incendio) che da fattori interni (fame). La motivazione prevede la presenza di livelli complessi ordinati in maniera gerarchica:- riflessi: processi genetici, innati e involontarii dell’organismo a stimoli esterni ed interni- istinti: comportamenti + articolati. Secondo Darwin assicurano agli individui di una specie maggiori possibilità di sopravvivenza. In etologia è stato elaborato il concetto diIMPRINTING, cioè la predisposizione istintiva del neonato a seguire, subito dopo la nascita, un ogg in movimento. Il primo è la madre, ma secondo Lorenz è solo una questione di tempestività. Infatti egli dimostrò con gli anatroccoli che il primo che si contatta diventa la madre.Nello studio delle motivazioni, l’istinto fu criticato xchè nn in grado di giustificare la varietà motivazionale dell’uomo. Verso la metà del 900 in psicologia furono elaborati i concetti di- bisogno: condizione fisiologica di necessità (fame, sete)- pulsione: dimensione psicologica del bisogno che esprime un disagio.Il bisogno può nn essere accompagnato dalla pulsione (esposizione ad un gas – bisogno di ossigeno ma nn pulsione) e viceversa (voglia di cibo ma non fame).Le motivazioni quindi possono essere primarie e secondarie (potere, competizione, successo) portano all’elaborazione di desideri. Il desiderio generalmente nasce da una condizione di carenza. Il concetto di desiderio è strettamente legato a quello di valore. Il valore di un oggetto è tanto + elevato quanto + è capace di soddisfare un desiderio.Esiste anche una gerarchia dei bisogni: ai primi gradini ci sono i bisogni di carenza (fame, sete) che scompaiono con il loro appagamento; poi ci sono i bisogni di crescita (stima e autorealizzazione) si sviluppano mano a mano che sono soddisfatti.Principali teorie sulla motivazione:- teoria biologica: però i processi biologici non sono suffic x spiegare le varie condotte motivazionali dell’individuo- concezione comportamentista: la pulsione fornisce la spinta x l’attivazione dell’organismo- concezione cognitivista: le motivazioni cambiano in rapporto alla qualità e quantità delle info provenienti dall’ambiente.- Punto di vista scopistico: vi è uno scopo generale che si scompone in tanti sottoscopi. Per raggiungerli l’individuo deve elaborare strategie, individuare soluzioni.- Punto di vista interazionista: le motivazioni sono suscitate e regolate dai processi relazionali.- Teoria del valore di riferimento: assunzione del cibo xchè c’è un deficit energetico- Teoria degli incentivi: contro la precedente. Noi mangiamo xchè spinti anche dall’esperienza gratificante del cibo.EMOZIONI: possono essere di varia natura e di diversa intensità. Le principali teorie:- Teoria periferica: è importante studiare i processi che determinano le emozioni. I mutamenti del corpo avvengono dietro uno stimolo e la sensazione di questi mutamenti determina l’emozione. Ciò che determina le mutazioni è il sistema periferico.- Teoria centrale: critica la periferica. I centri di attivazione delle emozioni sono localizzati nella regione talamica. Altri studiosi hanno integrato questa teoria affermando che i centri di controllo delle emozioni sono posizionati su un circuito che comprende + regioni tra cui l’ipotalamo e l’amigdala Sia la teoria periferica che la centrale trascurano la soggettività: non tutti reagiamo allo stesso modo- teorie psicoevoluzionistiche: si rifanno alla teoria evoluzionistica di Darwin, le emozioni sono strettamente legate alla sopravvivenza della specie (fuggire x paura, accoppiarsi x riprodursi. Esiste una stretta connessione tra emozione ed azione: le emozioni sorgono in conseguenza di ciò che accade dentro e fuori di noi e determinano le azioni. Inoltre le emozioni, x essere riconosciute e condivise vanno manifestate secondo degli standard culturali
PSICOLOGIA DELLO SPORT
Capitolo 1:Processi motivazionali nello sport

Alla figura dell’allenatore viene accostato lo psicologo dello sport: al fine di fornire agli allenatori e all’organizzazione sportiva informazioni precise su come costruire i loro programmi di allenamento e su come guidare gli individui in funzione dei loro bisogni. Sport è Insieme di attività (esercizi – gare) pratiche individuali o di gruppo, per divertimento o per sviluppare la forza e l’agire del corpo. Insieme di attività fisiche e mentali compiute al fine di migliorare l’apparato psico-fisico.Motivare allo sportUno degli obiettivi principali dei programmi di allenamento è di sviluppare e mantenere un livello elevato di desiderio di partecipare allo sport. Cos’è che allontana dall’attività sportiva? Noia = Causata da allenamenti ripetitivi, Ridotta interazione con l’allenatore e con gli altri compagni, La mancanza di stimoli, L’impressione di non apprendere abbastanza. I motivi che favoriscono nei giovani la persistenza nell’attività sportivaTerrini ed Occhini = 3 livelli> Scelta> Decisione> AttivazioneAlderman e Wood = Definivano 7 sistemi di motivi/incentivi che dirigono il comportamento degli esseri umani:1. Affiliazione = opportunità di stabilire relazioni interpersonali (appartenenza ad un gruppo)2. Potere = opportunità d’influenzare e controllare gli altri3. Indipendenza = opportunità di fare le cose senza l’aiuto degli altri (bimbo)4. Stress = opportunità di svolgere attività eccitanti5. Eccellenza = opportunità di acquisire abilità sportive per il proprio interesse o per primeggiare su un altro6. Successo = acquisire prestigio, approvazione sociale (vincere)7. Aggressività = opportunità di dominare gli altri (scaricare il negativo sugli altri)Motivazione alla riuscitaMotivazione a evitare l’insuccesso, interazione a 3 fattori:1. A forza dell’orientamente individuale al successo2. La probabilità percepita di aver successo3. Il valore incentivante del successo
INTERAGISCONO con gli stimoli ambientali FAVORENDO stati affettivi di orgoglio o di vergogna dell’individuo
Orientamento al compito e orientamento al se.Nickolls (1993) ha identificato 2 orientamenti motivazionali spacificiOrientamento al compito: (attenzione del soggetto focalizzata sulla competenza) Il comportamento di un giovane è teso a dimostrare un certo grado di competenza o di padronanza. I soggetti che sono orientati al compito sottolineano maggiormente le ragioni connesse alla forma fisica e allo sviluppo delle abilità sportive. Gli allievi orientati al compito ritengono che il successo nello sport sia dovuto a fattori motivazionali e all’impegno individuale e collettivo. L’orientamento al compito è correlato negativamente al desiderio di barare e di voler fornire un’immagine di se migliore di quella reale. Gli individui orientati al compito traggono soddisfazioni dallo svolgimento delle loro prestazioni, che viene vissuta come un fine valido in se stesso. Hanno maggior rilevanza le caratteristiche intrinseche dell’attività sportive ( impegno inteso a soddisfare il compito ) piuttosto che quelle estrinseche ( riconoscimenti esterni e risutlati finali ) .Orientamento al se : (attenzione del soggetto focalizzata al risultato)Dimostra il suo livello di abilità in relazione agli altri e ciò avviene tramite il confronto sociale. Il livello di maestria non è sufficiente all’individuo per sentirsi soddisfatto del proprio livello di abilità. Il sentimento di riuscita si manifesta solo se per lui è favorevole il confronto con gli altri e le competizioni sportive sono l’occasione giusta. I soggetti orientati al se fanno sport per motivi connessi al desiderio di competere, di ricevere riconoscimenti positivi per ragioni collegate all’acquisizione di status sociale. Gli atleti orientati al se attribuiscono maggiore importanza all’abilità, ai fattori esterni

e al vantaggio fornito dall’uso di sostanze illecite. I soggetti orientati al sé vivono l’attività sportiva come un mezzo per raggiungere un fine che è di dimostrare la loro superiorità sugli avversari.Motivazione alla competenzaLe valutazioni individuali sul proprio livello di comptenza influenzano le prestazioni. La motivazione alla competenza era il principale elemento determinante la condotta umana. Il sentimento di efficacia personale viene costruito attraverso continue prove delle proprie capacità e man mano che queste si affermano e si stabilizzano. Il soggetto pone ulteriori obiettivi che lo mettono nuovamente alla prova. Tre livelli di successo: Elevato, Medio e BassoTre tipi di rinforzo verbale: Incoraggiamento, Svalutazione, Assenza di commentoI feedback forniti dagli allenatori influenzano la percezione di abilità e la prestazione sportiva, L’età rappresenta un’altra variabile che influenza come i giovani percepiscono il loro livello di competenza. I giovani sportivi con un elevato livello di percezione di competenza sono quelli che partecipano in maniera regolare all’attività sportiva.Motivazione intrinseca.L’espressione dei bisogni e dei desideri dell’individuo e stimola quei comportamenti che permettono di sentirsi competenti nei confronti dell’ambiente circostante. Questo comportamento intrinsecamente motivato è alimentato dai rinforzi positivi che il soggetto fornisce a se stesso durante lo svolgimento dell’attività.Punti principali:Le attività intrinsecamente motivanti sono autonome, cioè che ogni tipo di intervento esterno tende ad incidere negativamente sulla motivazione intrinseca.Le percezioni di competenza e l’eccitamento per una sfida sono fattori che sostengono la motivazione intrinseca. La comunicazione informativa stimola la motivazione intrinseca.L’orientamento al compito favorisce l’incremento della motivazione intrinseca.L’orientamento al sé ne provoca la riduzione.Motivazione estrinseca:La motivazione estrinseca a noi, compiere un’azione per conseguire altro. (Es : ricevere un premio) AUTOREALIZZASIONE SE STESSISTIMA PRESTIGIO-RICONOSCIMENTOSOCIALI APPARTENENZA - AMORESICUREZZA PROTEZIONE-CERTEZZAPRIMARI- FISIOLOGICI SALUTE-RIPOSO-FAME SETETeoria dell’attribuzione:Le ricerche sinora condotte hanno evidenziato che le attribuzioni possono giocare un ruolo significativo nel determinare le reazioni emotive e che di grande importanza è la percezione soggettiva delle prestazioni e non solo il risultato oggettivo.Il ruolo degli allenatori nei processi motivazionali: Modello di CarronFATTORI SITUAZIONALISoggetto al controllo Non soggetto a controllo Ricompense = Gratificazione - Spettatori Goal setting = Raggiungere gli obiettivi - Concorrenti (avversari) Allenamenti = Come impostare la didattica - Clima di gruppo Rinforzi = Positivi, negativi, punizione Coerenza dell’allenatore = Giudizio imparziale.I FATTORI PERSONALISoggetto al controlloMotivazioni incentivanti - Ansia Analisi del risultato - Attenzione Interesse intrinseco - Motivazione al successo

Aspettative dell’allenatore -DIPENDONO DALL’ATLETA Fiducia in se stessi GOAL SETTING : Sistemi più efficaci di migliorare la prestazione: stabilire obiettivi specifici raggiungibili e che rappresentano una sfida. Guida l’impegno dell’atleta, costituisce uno stimolo. Tutto ciò che vuole realizzare è un obiettivo.OBIETTIVO: Si intende qualcosa che si vuole consapevolmente raggiungere gli obiettivi stimolano lo sviluppo delle strategie necessarie per raggiungere la meta finale influenzando i processi motivazionali agendo sulla direzione, la persistenza e l’intensità dei comportamenti.Obiettivi devono essere:Misurabili (perdere peso)Soggettivi non modificabili ( migliorare gesto tecnico)Outcome goalPerformance goalCaratteristiche degli obiettivi: Difficili - ma alla portata della prestazione Specifici – mai vaghi e generici Coinvolgenti – da favorire la performance Misurabili - facili da quantificare Individuali / Squadra
Dieci ipotesi relative al funzionamento goal setting.1. Obiettivi specifici2. Obiettivi quantitativi = più elevato è l’obiettivo migliore sarà la prestazione3. Obiettivi specifici e difficili miglioreranno la prestazione4. La formazione di obiettivi a breve e a lungo termine migliora la prestazione.5. Gli obiettivi agiscono migliorando l’impegno6. La definizione degli obiettivi è efficace solo in presenza di feedback che evidenziano i progressi compiuti.7. Obiettivi difficili richiedono un notevole impegno che determina prestazioni migliori.8. L’impegno puo’ essere ottenuto chiedendo all’atleta di essere più partecipativo, incentivandolo con dei premi e aiutandolo alla scelta degli obiettivi9. Il raggiungimento degli obiettivi è favorito dalla determinazione di una strategia10. La competizione migliora la prestazione.
Capitolo2Sport e personalitàIn psicologia dello sport lo studio della personalità ha avuto il compito di studiare il comportamento degli atleti al fine di fornire delle previsioni sulla qualità delle loro performance future. esistono 2 modelli di comportamento:1-modello di autoefficacia: si riferisce alle percezioni di efficacia personale2-modello di ansia:allenamento e variabile in psicologia: l'allenamento una situazione che richiedono agli atleti di effettuare le esercitazioni in modo coscienzioso e scrupoloso e di essere perseveranti nell'impegno e conseguentemente ci si aspetterebbe che gli atleti rispetto la popolazione generale si differenziano sulla base di questo variabile psicologica. interazione persona-situazione: l'azione di un soggetto deriva dall'interazione continua fra individuo e le situazioni che incontra quindi non solo le situazioni influenzano la persona, ma nel contempo, l'individuo seleziona attivamente le situazioni da affrontare e i processi cognitivi agiscono nel favorire questo tipo di attivazione. AUTOEFFICACIA:

è la fiducia che una persona ripone nella propria capacità di affrontare un compito specifico. tale modello enfatizza. Un atleta può essere oggettivamente in grado di effettuare un determinato esercizio, ma nel contempo se ritiene di non averne le capacità mostrerà un basso livello di autoefficacia. ogni individuo sceglierà di partecipare ad attività che gli garantiscono buoni margini di successo rispetto ad altre che potrebbero con più facilità sfociare in successi.Autoefficacia:capacità di capire la propria efficacia di capire le proprie capacità e i propri limitii.-ripetizione-motivazione-illusione-immagini mentalimisurazione dell'autoefficacia: per misurare si usa una tecnica che comprende 3 aspetti dell'autoefficacia:1) livello: il livello di autoefficacia viene definito dalle relazione tra i compiti tra ciò che il soggetto ritiene dii essere in grado di fare.2) forza: la forza della convinzione personale, cioè di sentirsi in grado di manifestare il comportamento derivato dalle abilità che il soggetto si riconosce.3) generalità: la generalità dell'autoefficacia fa riferimento al numero di aree che un individuo crede di poter affrontare con successo.Autoefficacia e attività fisica (fa bene al corpo e alle mente)le ricerche hanno evidenziato che l'autoefficacia nella popolazione normale sedentaria costituisce un mediatore significativo nella scelta di praticare con regolarità l'attività fisica e che uno stile di vita attivo, migliora lo stato psicofisico.ANSIA: è uno degli stati psicologici degli individui per evidenziare una condizione di agitazione indiiviiduale caratterizzata da timore, nervosismo, preoccupazione e panico.L'ansia è stato correlato al concetto di stressDISTRESS- concetto di ansiaSTRESSOR- sono stress specifici che possono essere di natura fisica psicologica o sociale.Esistono 2 tipi di Ansia:1 ansia di tratto: un soggetto percepisce come minaccia più situazioni (carattere ansioso)sii divide in 3 aspetti competitivi- valutazione oggettiva- valutazione soggettiva- reazioni2 ansia di stato: un soggetto percepisce come minaccia solo determinate situazionisi divide in 2 aspetti competitivi-cognitivo-somaticoVALUTAZIONE- svolge un ruolo decisivo, lo stesso stimolo potrà essere vissuto in modo minaccioso da un individuo, per un altro costituirà una sfida, per un altro sarà rilevanteANSIA di STATOsi manifestano con un certo grado d'intensità in relazione a specifici stimoli.i sintomi lievi: timore- tensione- preoccupazione- nervosismosintomi fisiologici: aumento frequenza cardiaca, respirazione accelerata, fasi di apnea, aumento sudorazione, aumento tensione muscolare etc.ANSIA di STATO COMPETITIVO:1)Dimensione cognitiva- una condizione di ansia dominata da aspettative negative riguardanti:la situazione, se stessi e le conseguenze.nello sport, tale stato si può manifestare in termini di aspettative negative rispetto alla propria prestazione e al risultato della gara.

2) Dimensione somatica- riguarda le modificazioni fisiologiche e affettive determinate dall'approssimarsi dell'evento sportivo.ANSIA di TRATTO: si manifesta in presenza di stimoli e sono frequentiANSIA di TRATTO COMPETITIVO:1)Valutazione oggettiva: relativa alla competizione: difficoltà del compito, caratteristiche degli avversari, condizioni di gara.2) Valutazione soggettiva: pone l'accento su come l'atleta percepisce, accetta e valuta la situazione oggettiva di gara.tale aspetto risulta mediato dall'insieme delle caratteristiche psicologiche individuali3) Reazioni individuali- possono essere di 3 tipi:-reazioni comportamentali-reazioni fisiologiche-reazioni psicologiche4) Conseguenze-positive, in caso di vittoria-negative, in caso di sconfitta. Capitolo 3PROCESSI di AUTOREGOLAZIONE E LIVELLI di ATTENZIONE.Attivazione à è difficile racchiudere in una definizione. sono state proposte alcune definizioni:1- come sinonimo di motivazione2- come sinonimo di ansia-intensità di emozioni3- come processi di recupero alternati a uno stato di prontezzaMolte sono le teorie che sono state proposte per spiegare l'interazione tra livelli di attivazione individuale e processi di autoregolazione messi in atto dai soggetti per ottimizzare le prestazioni:Teoria della pulsione-drive theorySecondo questo modello la prestazione è una funzione della pulsione per la forza dell’abitudine. La pulsione consiste nell’attivazione fisiologica che guida l’individuo al soddisfacimento dei bisogni generali e l’abitudine si riferisce alla prevalenza delle risposte corrette o di quelle scorrette.Teoria o modello della U capovoltaIdentica una relazione curvilineare tra prestazione e attivazione. L'attivazione (o stato motivazionale) raggiunge un apice o punto ottimale oltre il quale si assiste a un progressivo decadimento.Punto ottimaleIPO ATTIVAZIONE IPERLa prestazione sportiva era ottimizzata in corrispondenza di un livello di attivazione medio, al di sotto e al di sopra, la prestazione diviene progressivamente scadente.Teoria o modello delle zone di funzionamento ottimaleQuesto modello può essere considerato come un'estensione della teoria della U capovolta. Al posto di un singolo Punto ottimale(rendimento massimo), vi sarebbe un banda, una zona, la cui ampiezza dipende da ciascun atleta. Per ogni sportivo esiste una banda di livello, di ansia progressivamente superiore o inferiore condurrebbero a una proporzionale riduzione delle prestazioni. Permane l'andamento a U rovescitata, ma con l'aggiunta che il livello ottimale varia da atleta ad atleta a seconda della a seconda della misura dell'ansia di tratto.Questo modello consente di valorizzare il vissuto psicologo ed emotivo degli atleti. Infatti favorisce una o condizione di autoconsapevolezza da parte degli atleti, che li porta a scegliere automaticamente quale sia la condizione psicologica pre-gara che essi ritengono più opportuna. In tal senso, il lavoro dello psicologo è quello di affiancare l'atleta in questo processo d'intentifcazione della zona individuale di funzionamento ottimale e monitonale in modo accurato i parametri psicologici individualizzati.La regolazione dell'attivazione

Regolare il proprio livello di attivazione è uno dei fattori decisivi della prestazione. Molte strategie di attivazione o di disattivazione sono state utilizzate da allenatori, atleti e psicologi dello sport. Alcune di queste sono:-Tecniche somatiche come: 1° rilassamento neuromuscolare progressivo. 2° controllo del respiro.-Tecniche cognitive come: 1° esercizi di ripetizione mentale. 2° dialogo interno.
ATTIVAZIONE ECCESSIVA/ ATTIVAZIONE RIDOTTALa maggior parte degli allenatori e degli sono consapevoli dell'importanza che ha per la prestazione il trovarsi in una condizione di attivazione ottimale. La diffusione di preparazione psicologica per gli atleti di alto livello, realizzati allo scopo d'incrementare sempre più la loro capacità di affrontare in modo efficace gli eventi sportivi. In relazione al rapporto tra prestazione e attivazione, è necessario conoscere quali sono le cause e i segnali di attivazione eccessiva o troppo ridotta:SINTOMI di ATTIVAZIONE ECCESSIVA- possono essere distinti in:Sintomi fisici-includono uno stato di tensione muscolare-difficoltà di respirazione-difficoltà o eccesso di sudorazione-disturbi allo stomaco-sensazione di fatica-riduzione della coordinazione motoriaSintomi comportamentali-comprendono stati di agitazione-aumento di azioni irrazionali-superstizioneSintomi psicologici-comprendono un dialogo interno negativo-pensieri irrazionali-riduzione della motivazione (questi sono detti anke sintomi ansiosi)-stati d'animo negativiCAUSE DELL'ATTIVAZIONE ECCESSIVA:-Mancanza di fiducia dell'atleta-Fattori ambientali:1-luogo della competizione,2-condizioni metereologiche estremeSINTOMI di RIDOTTA ATTIVAZIONE:possono essere distinti in:Sintomi fisici-comprendono bassi livelli di frequenza cardiaca-bassi livelli di respirazione-bassi livelli di adrenalina-ridotta energia psicofisicaSintomi comportamentali- le azioni sono lente- preparazione alla gara può essere condotta in modo svogliato e impreciso- l'atleta può apparire sonnolento e facilmente distraibileSintomi psicologici-scarsa motivazione a gareggiare-difficoltà nella concentrazioneCAUSE DELLA RIDOTTA ATTIVAZIONE:-eccessiva sicurezza da parte dell'atleta(troppo sicuri di vincere)-eccessiva fatica

-gli infortuni-problemi di nutrizioneTECNICHE PER LA RIDUZIONE DELL'ATTIVAZIONENumerose sono le tecniche psicologiche che consentono di ridurre livelli eccessivi di attivazione:1°CONTROLLO DEL RESPIRO- tecnica semplice, per indurre uno stato di rilassamento in grado di eliminare una condizione dii attivazione eccessiva. il controllo del respiro favorisce il rilassamento e aumenta la qualità di ossigeno utilizzabile. Per raggiungere questo obiettivo, la semplice effettuazione di alcuni respiri profondi.2°RILASSAMENTO PROGRESSIVO NEOROMUSCOLARE- tecnica di rilassamento muscolare allo stato di rilassamento puro. Si propone di educare l'atleta alla riduzione volontaria del tono muscolare e d'indurre così uno stato di maggiore calma mentale. ciò avviene attraverso esercizi di graduale contrazione-distenzione di specifici distretti muscolari. Gli esercizi devono essere svolti tutti i giorni e coinvolgono la maggior parte dei muscoli. In questa prima fase gli esercizi sono svolti in posizione supina e l'obiettivo da raggiungere è di ottenere il rilassamento generale di tutto il corpo. La seconda fase viene fatta stando seduti su di una poltrona e tramite lo stesso tipo di esercizi consentirà al soggetto di rilassarsi. la terza fase il soggetto prende coscienza della tensione che avverte durante la sua attività quotidiana in occasione di situazione che modificano il suo stato d'animo in modo spiacevole e s'impegna a ridurre al minimo questi disturbi.3°TRAINING AUTOGENO- si basa sull'apprendimento di esercizi di difficoltà crescente che gradualmente determina il rilassamento globale del soggetto. Consiste nel far ripetere mentalmente al soggetto delle frasi affermative, che determinano questo condizione di calma.4°MEDIAZIONE- determina un abbasamento del consumo di ossigeno, della frequenza cardiaca, respiratoria.5°IMAGERY- il ricorso all'uso di immagini mentali per ripetere.6°BLOFEEDBACK- consente il controllo delle funzioni dell'organismo tramite l'uso di un apparecchio a cui il soggetto viene collegato. è stato utilizzato per ridurre stati di ansia pre-gara e per accelerare le fasi di recupero dell'energia fisica e psicologica.TECNICHE PER L'INCREMENTO DELL'ATTIVAZIONEEsistono diverse tecniche:1)controllo dell'attenzione2)tecniche di immagini mentali3)stretching- costituiscono un ottimo sistema di attivazione un solo organico, ma anche mentali.4)musica e videocassette- sono utilizzate come strumento per mobilitare l'energia5)stabilire obiettivi che siano raggiungibili, ma che rappresentano una sfida- gli atleti sono così più motivati a prescindere dagli avversari.IMMAGINI MENTALI-IMAGERYimmagini mentali- si riferisce alla capacità individuale di provare le sensazioni e di avere la percezione tipiche dell'azione reale, attuandole attraverso un processo mentale.Ripetizione- favorisce l'apprendimentoL'USO:Maggiormente in relazione alla gara, piuttosto che in allenamento incrementa la prestazione. Immaginazione di se stessi che vincono per confermare il ruolo motivazionale (sopratutto le persone a livello amatoriali)Ripetizione mentale- favorisce l'apprendimento. Maggiore è il livello di abilità degli atleti , più frequente è l'uso delle immagini mentali sia in allenamento che in gara.TEORIA PSICONEUROMUSCOLARESecondo cui la ripetizione mentale determina un moderato innalzamento del livello di attivazione del livello di attivazione dei muscoli. Un immagine mentale produce un attività muscolare simile a quella riscontrabile durante l'esecuzione dello stesso momento, ma di ampiezza inferiore.
Cap 4Attenzione: dalla teoria all’applicazione

L’attenzione, in ambito sportivo, è una delle aree di ricerca più studiate, in quanto è considerata una componente fondamentale della prestazione e dell’apprendimento delle abilità motorie e sportive .I psicologi sportivi hanno sviluppato dei programmi di preparazione psicologica, ke comprendono tecniche x migliorare la prestazione dell’atleta.Attenzione à attivazioneLa capacità attentiva disponibile in un dato momento dipende dal livello di attenzione. Risultati efficienti si hanno in presenza di un livello di attivazione in cui il soggetto restringe il focus attentivo solo agli elementi pertinenti x quel compito. Al contrario se il livello di attenzione continua a crescere, l’attenzione diventa troppo ristretta e la prestazione subisce un peggioramento. Pertanto, livelli troppo elevati di ansia e di attivazione producono un eccessivo restringimento del numero di segnali ke possono essere captati.Caratteristiche fisiologiche dell’impegno mentaleFrequenza cardiaca leggermente rallentata durante l’ impegno mentale.Costruzione di programmi di sviluppoLa necessità dei programmi di preparazione psicologica e di sviluppo delle abilità mentali, derivano dall’esigenza degli atleti di sostenere livelli elevati di tensione o di stress psico-fisico, mantenendo inalterata la qualità delle loro prestazioni sportive. Gli psicologi sportivi hanno proposto diverse metodiche:Routine pre-performanceDialoghi interniImmagini mentaliL’allenamento dell’attenzioneLo scopo delle tecniche per migliorare la capacità di focalizzazione , è di eliminare tensioni fisiche eccessive, e di orientare il focus attentivo solo su ciò ke è importante in quel momento; per eseguire al massimo delle proprie capacità la propria prestazione. Routine pre-performance. Strategie di concentrazione: un insieme di pensieri, azioni, e immagini ke si attivano prima della prestazione. Queste routine sono utili in quanto consentono di spostare l’attenzione da stimoli irrilevanti, di evitare di pensare alla prestazione da eseguire, e di stabilire un adeguato livello di attivazione mentale e fisica.Dialogo internoSpesso gli atleti attuano un intenso dialogo con se stessi. Generalmente viene considerato ke parole, frasi o immagini mentali positive possano svolgere una funzione determinante sulla prestazione di efficacia ke l’atleta ha di se stesso in una determinata situazione sportiva. Brevi frasi positive con cui l’atleta si incoraggia, stimola la fiducia, e può costituire una forma di controllo attentivo. È pertanto possibile ke affermazioni positive siano efficaci per incrementare la prestazione; mentre affermazioni negati ve e di sfiducia svolgono la funzione contraria.
Immagini mentaliLa ripetizione mentale favorisce:Processi attentivi dell’atletaAiuta l’apprendimentoContrasta i pensieri negativi
Capitolo 5Dinamiche di gruppoLo studio delle dinamiche di gruppo che consentono questo risultato di squadra non è solo d’interesse pratico per l’allenatore, che deve creare un gruppo unito e coeso, ma rappresenta un tema di base della psicologia sociale. Tipi di gruppo:Gruppi primari- Gruppi a cui appartiene senza obblighi (es. di fatto-famiglia)Gruppi secondari- Imposti con esterna- contrattuali (es. Gruppi militari)Gruppi sociali- Tipi di gruppi che condividono alcune caratteristicheSquadra sportiva- Gruppo primario volontario con connotazione secondaria e psicologia

Caratteristiche di squadraLa composizione del gruppo può essere definita come relazione tra le caratteristiche degli individui e del gruppo.
Individualecomplementarità tra gli uominiesistenza di uno scopo comunecapacità di problem-solvingcapacità decisionaliPer caratteristiche dei membri s’intende le caratteristiche fisiche, psicologiche e mentali. Le competenze specifiche e altre caratteristiche sociali, quali, l’età, gli studi compiti, il genere, la razza, l’etnia, il livello culturale, etc.
Gruppovisione comunecomplessi basati sui successi di squadra (premi)capacità leadershipCaratteristiche che influenzano i processi d’interazione tra i membri di una squadra. Capacità dei membri del gruppo di formare un gruppo coeso. Alla base di questo approccio vi è l’idea che si stabiliscono tra i membri sono di fondamentale importanza per migliorano le abilità individuali. Il lavoro dell’allenatore sarà di realizzare un programma di allenamento che consenta l’emergere di un gioco di squadra in cui ogni educatore trova la migliore utilizzare.STADI di CREAZIONE DELLA SQUADRALe reazioni tra i membri di un gruppo sono soggetti, con il trascorrere del tempo, a variazioni dipendenti da fattori situazionali e personali, dagli in ambito sportivo sono stati formulati 2 modelli situazionali:L’approccio lineareApproccio del pendolo
TEORIA LINEAREI 5 stadi sono sequenziali.Il gruppo passa alla fase successiva solo quando è stata completata quella precedente.1°FORMING= Formazione- i membri del gruppo cominciano a conoscersi e a identificare i compiti del gruppo2°STORMING= Forti conflitti- Disaccordo tra i membri del gruppo o disaccordo ai metodi dell’allenatore per raggiungere gli obiettivi3°NORMING= Normativa- risolti i conflitti, si stabilizzano i ruoli di ogni uno4°PERFONMING= Massima performance del gruppo, fase della cooperazione, massima unità del gruppo5°AUJOURNING= Raggiungimento- Gli obiettivi sono stati raggiunti, gli impegni sono stati portati a termine, si riduce il contatto tra i membri.
TEORIA DEL PENDOLOSecondo questa teoria, non è possibile che i gruppi seguano un andamento lineare; le squadre oscillano continuamente tra periodi di forte coesione e periodi di scarsa coesione.VANTAGGI: Per l’allenatore uno dei principali benefici derivati dalla conoscenza delle vari fasi di sviluppo dei gruppi. Consiste nel farsi trovare preparato ad affrontare improvvisi cambiamenti. Un ulteriore vantaggio riguarda la possibilità di modulare il suo intervento in relazione alla fase di sviluppo in cui si trova il gruppo, così da enfatizzare i comportamenti più efficaci per quel momento.
LA COESIONE DEL GRUPPOÈ un processo dinamico che riflette la forza che agisce sui membri per farli restare in gruppo.COESIONE TRA GLI ATLETI: è possibile individuare caratteristiche del gruppo sportivo che rendono coesa la squadra:

A)dimensione del gruppo ed eventuali sottogruppiB)vicinanza fisica con maggiori rapporti interpersonaliC)informazioniA)Dimensione del gruppo- in psicologia una delle aree più indagate è stata quella relativa all’individuazione delle dimensioni ideali di un gruppo, allo scopo di identificare quale sia il numero ottimale di componenti di un gruppo che evidenzia un livello elevato di produttività. I piccoli gruppi sono ottimali per proseguire obiettivi centrali sul compito, su cui si può riversare il consenso e l’impegno. I gruppi moderatamente più numerosi favoriscono la coesione sociale, attraverso lo sviluppo di forti relazioni sociali e di amicizia. I gruppi troppo numerosi tendono a favorire relazioni all’interno di sottogruppi, piuttosto che nella totalità del gruppo. I gruppi troppo piccoli mostrano una scarsa coesione sociale perché sono troppo impegnati a gareggiare o per il numero limitato di persone interessate con cui interagire.B) Vicinanza fisica à Le iterazioni si stabiliscono fra i membri con caratteristiche simili :Fisiche psicologiche e motorie, età, razza, etnia, ect. Maggiore è l’omogeneità di queste caratteristiche, migliore sarà la capacità dei membri del gruppo di formare un gruppo coeso.C) Informazioni à I processi di comunicazione migliorano ulteriormente le attitudini, le credenze, e le conoscenze del gruppo.Fattori disgreganti:Competizione interna è Tra i membri della stessa squadra, Aggressioni verbali e/o fisiche à Il gruppo deve disgregarsi, Disorganizzazione à Relativo All’allenatore, Mancanza di senso d’appartenenza à Manca il noiObiettiviFUNZIONE compitiALLENATORE ResponsabilitàÈ un formatoreLEADER diverso da LEADERSHIP1) Obiettivi = Dopo aver analizzato le risorse l’allenatore pone gli obiettivi generali e specifici, nel breve-medio- lungo periodo, individuali e di squadra.2) Compiti = Assegnazione dei compiti, da parte dell’allenatore per migliorare le competenza sportive.3) Responsabilità = Conferire, insegnare l’atleta ad essere indipendente, cioè un’atleta è maturo quando trasforma le nozioni apprese e le usa in campo.LEADER à è l’allenatore in quanto:Trasmette e sviluppa le competenza sportiveCostruisce ed organizza la squadraCompone le norme à cioè regole e disciplinaLEADERSHIP Si deve intendere il processo di guida degli individui o dei gruppi nel raggiungimento di obiettivi.(meglio se la figura del leader coincide con la leadership) . La leadership è una personalità carismatica.Efficacia del leader: Proprio ruolo è servire, Tutti sono importanti, Dare direttive chiare, Criticare l’atleta in privato e lodarlo in pubblico, Enfatizzare il gruppo, Accettare le criticheStili decisionaliPrendere una decisione è una componente del leader.Esistono 5 stili decisionali che variano in funzione del grado di partecipazione dei membri del gruppo:Stile autocratico 1 : Il leader prende personalmente le decisioni basandosi sulle informazioni ottenibili.Stile autocratico 2 : Il leader ottiene le informazioni necessarie dai membri e decide da solo .Stile consultivo 1 : Il leader condivide i problemi con i membri più influenti del gruppo, consultandoli individualmente tiene in considerazione le loro idee e prende da solo le decisioni.Stile consultivo 2: Il leader condivide i problemi con tutti i membri riuniti, tiene in considerazione le loro idee e prende da solo le decisioni.Stile di gruppo : Il leader condivide i problemi con il gruppo giunge ad una soluzione consensuale. Il ruolo del leader