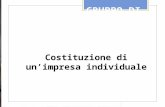Per una nuova costituzione
-
Upload
riccardo-gandolfi -
Category
News & Politics
-
view
183 -
download
0
Transcript of Per una nuova costituzione


N
NOTE NUOVA EDIZIONE IN E-BOOK
Si è ritenuto utile NON apportare alcuna modifica alla versione originale, per sottolineare come,
dopo oltre 20 anni, la situazione politica ed istituzionale non è cambiata molto.
Sicuramente sono cambiati i protagonisti, ma molte criticità che si evidenziavano oltre 20 anni fa,
che dovevano portare alla nascita della Seconda Repubblica, sono ancora lì, irrisolte.
Così, abbiamo ancora un sistema di partiti senza regolamentazione democratica, a parte alcuni
tentativi di selezione dei candidati con sistemi vicini alle primarie, un sistema di sindacatocrazia che, ancora,
ingessa il sistema delle Relazioni Industriali, un problema legato al rapporto Magistratura Politica che lascia
invariato il ruolo di Tribunale delle Virtù che si sono attribuiti molti Pubblici Ministeri.
Ora abbiamo, però, una nuova Riforma della Costituzione che, seppur perfettibile, sicuramente va
nella direzione di una semplificazione e di una Democrazia Decidente.
C’è solo da augurarsi che il referendum previsto per il 4 dicembre 2016 confermi la riforma,
che, come punto di partenza, dovrà, successivamente, dipanare i nodi irrisolti, a partire da quella riforma
della Giustizia che rappresenta, da decenni, una anomalia tutta italiana.
Altopascio, 19 novembre 2016


Premessa ........................................................................................................................................................... 5
La Costituzione Italiana ................................................................................................................................... 10
Conservazione o evoluzione ? ......................................................................................................................... 21
Stato Etico e sistema corporativo .................................................................................................................... 24
Stato di diritto e Stato Laico ............................................................................................................................ 30
I Diritti Fiscali dei Cittadini ............................................................................................................................... 34
I limiti della Costituzione ................................................................................................................................. 38
Un Regime Oligarchico .................................................................................................................................... 45
Partitocrazia..........ma non solo ....................................................................................................................... 50
Sindacatocrazia e dintorni ............................................................................................................................... 55
Le due Costituzioni .......................................................................................................................................... 62
Un sistema neocorporativo ............................................................................................................................. 67
Quale Costituzione? ........................................................................................................................................ 73
L’illusione del maggioritario ............................................................................................................................ 80
L’Illusione Referendaria ................................................................................................................................... 87
L’illusione presidenzialista ............................................................................................................................... 98
Il tempo stringe ............................................................................................................................................. 103

Premessa
L’aspro dibattito che ha animato, e tuttora anima, lo scenario politico italiano a
partire dallo scioglimento delle camere e le successive elezioni del marzo del 1994, ha
evidenziato, in tutta la sua urgenza, la questione della riforma istituzionale in Italia, sia
nella forma di stato (federale o regionale) che nella forma di governo (presidenziale,
semipresidenziale, parlamentare).
Già nelle passate legislature si erano avvicendate ben due Commissioni bicamerali,
una presieduta dall’On. Nilde Jotti e l’altra dall’On. Ciriaco De Mita, con lo scopo di
studiare ed introdurre concrete modifiche alla struttura costituzionale.
Tali tentativi sono falliti, non essendosi verificati i necessari presupposti per
l’approvazione del Parlamento.
Come avremo modo di vedere, dopo la bufera che si è abbattuta sui partiti politici
italiani, con l’arresto e la condanna di alcuni personaggi di primo piano della Repubblica,
molte voci si sono levate per reclamare la modifica costituzionale.
Alcuni, come l’on. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, puntando ad un sistema
federale molto accentuato con posizioni molto vicine ad una vera e propria secessione, con
la convocazione di un’assemblea provocatoriamente chiamata Parlamento del Nord.
Altri, come l’on. Mariotto Segni, promotore di una campagna referendaria vincente,
che ha consentito il passaggio da un sistema elettorale proporzionale ad uno
maggioritario, puntando ad un sistema di regionalismo accentuato contemperato
dall’elezione diretta del Premier.
Altri ancora, come parte del cosiddetto Polo delle Libertà, cercando di imprimere una
svolta presidenziale a tutta la struttura istituzionale.
In questo panorama babeliano, i partiti politici oggi esistenti cercano di ritagliarsi un
proprio spazio vitale, disposti a sacrificare i propri principi all’altare di mosse tattiche ed
elettorali.
Così, fra una battuta e l’altra, un insulto ed un altro, si buttano là proposte e
controproposte, proclami di guerra e calumet di pace, alimentando quello che ormai, a
buon ragione, viene definito il teatrino della politica italiana.

Come i personaggi dell’avanspettacolo, i nostri politici si alternano sulla scena,
ripetendo gag e battute ormai consunte, rubandosi a vicenda argomenti e proposte, alla
ricerca di un applauso che, ormai, tarda a venire.
Così, chi era per un sistema maggioritario, come la Lega Nord, sostiene il
ritorno al proporzionale e chi era per il proporzionale, come Alleanza Nazionale,
sostiene il maggioritario.
Chi sosteneva il maggioritario, chiede ora il doppio turno, mentre chi non era né
per l’uno né per l’altro... continua a tacere!
Nella sua schizofrenia, la politica italiana vive di messaggi mediali, di pillole da
trenta secondi, da battute alle porte degli ascensori o su palcoscenici con maghi, o davanti
alle scollature procaci di soubrette e presentatrici televisive.
Lustrini e paillettes allietano il teatrino, mentre, come ai tempi della Belle Époque,
gli eventi precipitano. Ormai nessuno è più in grado di capire cosa può accadere, quale
tendenza politica possa prevalere, con partiti di sinistra che candidano ex-missini e partiti
di centro destra che, a loro volta, sostengono candidati ex- socialisti, come è accaduto
nell’ottobre del 1995 a Napoli.
A questo punto, per chi è sensibile alle problematiche istituzionali, tutto ciò non può
che far corre brividi di freddo lungo la schiena.
Ormai siamo all’estemporaneità totale, si contratta un decreto sulla, o meglio, contro
l’immigrazione in cambio del sostegno ad una manovra finanziaria , il che, come diceva un
noto magistrato, non “c’azzecca” niente!
S'ipotizzano scambi di consensi fra doppioturnisti e presidenzialisti, premierati in
cambio di Consigli di Amministrazione radiotelevisivi, siluramenti di ministri sgraditi con
ostacoli alla realizzazione di progetti per i treni ad alta velocità.
Insomma, se prima eravamo al mercato delle vacche dei voti e delle candidature,
ormai siamo all’improvvisazione istituzionale totale.
Dunque, che fare? Se riforma istituzionale deve essere (e deve!), è opportuno che sia
realizzata con criteri di logicità, con approfondite analisi e meditate risposte politiche, non
prima di aver ascoltato il parere del popolo sovrano con l’unico strumento democratico
fino ad oggi conosciuto, ovverosia le elezioni!

Nessuno, neppure gli eletti al Parlamento, può arrogarsi il diritto di costituirsi in
corpo a se stante, a demiurgo di una Costituzione.
Da queste considerazioni nascono le pagine che seguono, poco più di un modesto
pamphlet, un istant book necessariamente conciso e, per propria natura, radicale nella
critica e nella proposta.
Ovviamente non vuole rappresentare, certo, una pietra miliare nella dottrina del
diritto pubblico e costituzionale, ben altri possono farlo.
L’unica cosa che cerca di fare, è suscitare, nei pochi lettori che avranno la voglia e la
ventura di scorrerlo, curiosità e, possibilmente, la consapevolezza del fatto che, quando si
trattano questioni costituzionali, nessuno è legittimato a cercare scorciatoie.
Il processo di creazione di un modello istituzionale richiede pazienza, ricerca, onestà
mentale e, soprattutto, idee chiare circa il modello di Stato che si vuole realizzare.
Si tenterà di dimostrare, infatti, che la concezione ideologica che sottostà al modello
di Stato progettato dalla nostra Costituzione non appartiene alla tradizione liberale e laica
dello stato di diritto, quanto, piuttosto, a quella degli Stati etici, con ribaltamento della
legittimazione; non è il cittadino che dà legittimità allo stato, ma è lo Stato che legittima o
meno il cittadino-suddito.
Anche la consapevolezza di questa impostazione di fondo è importante, non averla
chiara può comportare scompensi e profonde frustrazioni nell’elettore, il quale richiede
una cosa e, al contrario, si trova ad ottenerne un’altra.
D’altra parte, sicuramente se fra gli scarsi lettori di questo libercolo vi saranno anime
belle, plagiate dalla retorica costituzionalista, esaltatrice di una Costituzione “nata dalla
Resistenza”, non mancheranno di scandalizzarsi, dato che si cercherà di comprendere le
vere e profonde radici della nostra Carta, al di là di ogni tentativo di demagogica ricerca di
beatificazione..
Eppure, se ricordiamo il discorso con il quale l’allora presidente del Consiglio,
l’onorevole Amato, si congedò dall’incarico, non dovrebbe suonare offensivo per nessuno
se si sono rintracciate le prove dello stretto legame culturale fra la concezione gentiliana
dello stato e la previsione costituzionale.
Amato affermò, in quell’occasione, davanti ai parlamentari che attendevano le sue
dimissioni, che l’Italia vive, da settant’anni, all’ombra di un unico regime, il che
sottolineava come, passato il ventennio fascista, il cinquantennio cosiddetto democratico di
poco si fosse scostato da quello.

Un’affermazione forte, che suscitò perplessità, ma alla quale nessuno si contrappose,
forse perché non basta richiamarsi alla retorica resistenziale per negare ciò che, alla luce
della disamina che seguirà, appare cosa non del tutto errata.
L’altra finalità che questo scritto vuole perseguire è l’affermazione del diritto di ogni
singolo cittadino, sia o meno istruito alla nobile arte della politica, di dire e, soprattutto, di
pensare liberamente sull’assetto istituzionale che egli predilige.
Nessuno può arrogarsi il diritto di interpretare le nostre volontà, i nostri desideri, le
nostre speranze e le nostre volontà senza prima averci offerto la possibilità di esprimerci
attraverso i meccanismi democraticamente sanciti, ovverosia attraverso le elezioni.
Non dobbiamo lasciarci intimorire dai tanti politici che, come l’Azzeccagarbugli di
manzoniana memoria, vorrebbero confonderci le idee con un po' di latinorum .
La questione relativa alla forma costituzionale, sia che essa riguardi la forma di stato
che quella del governo, non è cosa da addetti ai lavori, da sapienti chiusi in eburnee torri,
intenti a leggere imperscrutabili disegni divini.
Tutto questo riguarda noi, la nostra vita quotidiana, la nostra capacità di spesa e di
risparmio.
Perché si tratta di decidere chi e come deve prelevare i soldi dalle nostre tasche,
attraverso quali meccanismi concedergli questo diritto, e, una volta prelevati, come devono
essere spesi.
Perché questa è la grande novità introdotto dalla concezione laica e liberale dello
stato, l’affermazione dello Stato di diritto contrapposto allo Stato etico; nessuno può
pretendere dal cittadino più di quanto quest’ultimo sia disposto a concedere, esprimendo
questa volontà attraverso la scelta di propri rappresentanti i quali liberamente e
rispondendo solo agli elettori, cercano di adoperarsi per soddisfare queste legittime attese.
Se noi, cittadini italiani, siamo legittimati ed in grado di decidere da chi e come farci
rappresentare, siamo consapevoli di ciò che vogliamo e di ciò che chiediamo.
Non importa esprimersi con parole forbite o parlare politichese per avere titolo e
diritto di affermare le nostre opinioni.
Tutti noi, cittadini dello Stato italiano, non per concessione di alcuno, ma per nostro
elementare diritto, siamo, in nuce, costituenti, perché solo da noi, non da altri, trae

legittimità lo Stato e grazie a noi, ai nostri sacrifici, ai nostri risparmi ed alle tasse che noi
paghiamo i potenti politici che, oggi, si arrogano il diritto di giudicarci possono vivere e,
aggiungerei, vivere bene!
Dunque, che nessuno si spaventi o pensi di non essere all’altezza o giudichi
presunzione la scrittura di queste note; in uno stato libero si è tutti legittimati a scrivere di
ciò che riguarda tutti, che poi lo si riesca a fare più o meno bene è un altro discorso.
Comunque, ripeto, queste scarne notazioni vogliono solo ottenere un modesto
risultato, suscitare la voglia, in altri, di uscire dalla vuota retorica e dalla demagogica
difesa di una Costituzione inadeguata; se poi la si vuole difendere, lo si faccia pure, ma
contrapponendo fatti a fatti, senza nascondersi dietro alla retorica della Costituzione
“nata dalla Resistenza!

La Costituzione Italiana
La Costituzione italiana venne approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre
del 1947 e promulgata il 27 dicembre dello stesso anno.
L’approvazione e la promulgazione giunsero al termine di un lungo processo iniziato
con il decreto del 25 giugno del 1944, il quale assicurava agli italiani, una volta liberato il
territorio nazionale dalla presenza dell’occupante tedesco, il diritto di scegliere la forma
istituzionale nonché di eleggere un’Assemblea Costituente per la definizione di nuovi
rapporti politico-istituzionali.
Il 2 giugno del 1946 gli italiani elessero l’Assemblea che avrebbe dovuto scrivere le
nuove norme costituzionali, ovvero le basi, i pilastri sul quale erigere l’intero sistema
politico-sociale nel quale si sarebbero dovuti riconoscere.
Non è difficile individuare, nell’impianto generale tracciato dalla nostra Carta, il
frutto delle paure e dei fantasmi che agitavano il mondo politico italiano, reduce da un
periodo molto cupo, iniziato con l’avvento di Mussolini e terminato con la dura sconfitta
militare.
La principale preoccupazione che emerge è, sicuramente, quella di evitare, il più
possibile, che un qualche organismo statale possa assumere un ruolo predominante.
Emblematica, in questo senso, è la scelta compiuta a proposito del modello
istituzionale, in particolare per quanto concerne la definizione del ruolo e dei metodi
elettivi relativi alla figura del Capo dello Stato.
Esclusa totalmente ogni ipotesi di Repubblica Presidenziale, il ruolo e la figura del
Presidente della repubblica appare come un semplice notaio, una figura rappresentativa, un
custode silente degli equilibri istituzionali, senza alcun potere reale1 e, conseguentemente,
alcuna responsabilità2.
1 gli articoli che riguardano il Presidente della Repubblica sono quelli che vanno dal numero 83 al numero 91.
L’articolo 87 ne elenca le potestà. Dalla lettura di questo emerge chiaramente la sua funzione di “esecutore” notarile, infatti egli può, autonomamente, inviare messaggi alle Camere, conferire onorificenze e concedere la grazia, ma, per tutto il resto agisce in conseguenza dell’azione altrui. Così:
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti Indice i referendum Nomina, nei casi previsti dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Questa volontà di limitare il potere del massimo organo istituzionale appare evidente
nel meccanismo definito per la sua elezione3.
Esclusa, infatti, la possibilità di una investitura diretta da parte del corpo elettorale,
attraverso l’elezione diretta, si è preferito il metodo indiretto, ovverosia l’investitura da
parte del Parlamento alla carica di Capo di Stato.
Per garantire un più marcato distacco da ogni ipotesi di investitura popolare, si è
inteso allargare ulteriormente il numero dei soggetti al quale affidare la possibilità di
concorrere all’elezione del Presidente.
Infatti, oltre ai membri del Parlamento, vengono chiamati a concorrere all’elezione
anche tre delegati per ogni regione, eletti in modo che venga comunque garantita la
rappresentanza delle minoranze4.
L’inserimento di questi elementi estranei al Parlamento avrebbe dovuto contribuire,
nell’intenzione del costituente, ad annacquare ancora di più l’eventuale coloritura politica
del Presidente, rendendolo tendenzialmente svincolato da legami politici troppo stretti.
Al fine di accentuare tale caratteristica, si è prevista una durata in carica del
Presidente maggiore di quella del Parlamento che lo ha eletto, dato che il Presidente resta
in carica per sette anni5, mentre la legislatura dura, ordinariamente, cinque anni
6, cosa che
tende ad aumentare il distacco fra le maggioranze politiche e la massima carica dello Stato,
proprio al fine di caratterizzarne l’indipendenza.
Ad un Capo dello Stato trasformato, dunque, in notaio, corrisponde un Presidente del
Consiglio dei Ministri di chiara estrazione parlamentare, dato che proprio dal Parlamento il Governo deve ricevere l’investitura per poter governare.
Al di fuori di questo, resta la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura ed il Comando delle Forze Armate, anche se resta ancora irrisolta la questione relativa all’effettivo comando delle Forze Armate in caso di guerra 2 L’articolo 90 recita testualmente:
“ il Presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. 3 l’articolo 83 recita:
Il presidente della repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 4 Articolo 83
5 articolo 85 comma 1
6 articolo 60 comma 1.

L’organo di massima garanzia costituzionale, dunque, appare il Parlamento, luogo di
incontro di uomini che, nella previsione costituzionale, rappresentano la Nazione,
esercitando la propria funzione senza vincolo di mandato7.
Questa alta affermazione del principio di indipendenza del singolo deputato, trova un
limite nella mancata previsione di metodi atti a garantire tale indipendenza e sovranità.
In realtà, il fatto che venga costituzionalmente previsto un particolare ruolo per i
partiti politici, chiamati a concorrere “con metodo democratico a determinare la politica
nazionale8” senza che, per questo, si preveda una regolamentazione democratica della loro
organizzazione interna, fa si che, di fatto, i veri detentori del potere siano, proprio perché
privi di ogni controllo e contrappeso, proprio i partiti politici.
Così, a partire dalla data di promulgazione della nostra Carta costituzionale, per
decenni il sistema istituzionale italiano si è retto grazie ai difficili equilibri creatisi fra
partiti politici che, seppur ideologicamente contrapposti, si sono ritrovati uniti in un
generale accordo di spartizione del potere reale, complice anche un sistema elettorale
basato sul principio proporzionale, peraltro del tutto coerente con l’impianto
costituzionale, inefficace per garantire l’efficienza ma ottimo per la sopravvivenza di
individualità e particolarità non sempre legittime e trasparenti.
Lo sfascio generalizzato provocato da questo sistema politico-elettorale, basato su un
accordo trasversale che, di fatto, ha finito per unire la maggior parte dei partiti politici in
un unico grande Partito Unico della Spesa Pubblica, ha finito per rendere palesi le crepe e
le colpevoli inefficienze della struttura statale italiana.
Applicando la previsione costituzionale contenute nel titolo III, relativo ai rapporti
economici, in particolare quelle degli articoli 419,42
10 e 43
11, si è conservato il sistema di
7 Articolo 67
8 Articolo 49
9 Articolo 41:
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 10
articolo 42 La proprietà è pubblica o privata.I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 11
Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o categorie di imprese, che si riferiscano a

economia pubblica iniziata dal regime fascista, dando ad esso impulso e spazi sempre
maggiori.
Progressivamente, con la nazionalizzazione della società di produzione ed
erogazione dell’energia elettrica, la nascita di grandi monopoli nel settore delle
comunicazioni, un uso massiccio, specie in ambito locale, dello strumento dell’esproprio
previsto dall’art. 43, lo Stato italiano è diventato sempre più proprietario e soggetto attivo
dell’economia nazionale.
Un soggetto che, peraltro, ha vissuto e vive godendo di uno status di assoluto
privilegio, eguagliando quello dei monarchi ante Rivoluzione Francese!
I cittadini italiani, infatti, teoricamente i veri proprietari dei beni pubblici, si sono
trovati a dover acquistare beni e servizi da enti nei quali organi deliberanti, organi di
controllo ed organi esecutivi si trovano, nella sostanza, a coincidere, essendo emanazione
di un’unica entità.
Il soggetto Stato, inoltre, si trova ad affrontare la concorrenza di soggetti privati
avendo la possibilità, essendo l’unico soggetto legittimato, di definire regole,
comportamenti e principi legislativi che, ovviamente, determinano i comportamenti dei
propri concorrenti.
In queste condizioni, nulla impedisce al soggetto Stato di emanare provvedimenti
ad esso favorevole, ponendo i soggetti privati in una condizione di oggettiva
inferiorità.
Questa commistione di interessi pubblici e di potere pubblico, concentrati in
un’unica entità politica, ovvero, in teoria, il Governo e, quindi, il Parlamento, ha fatto si
che su queste immense ricchezze pubbliche si scatenassero gli appetiti di chi si trova nelle
condizioni di gestire tali risorse.
Il sistema clientelare instauratosi all’ombra dei partiti, i veri padroni dei beni
pubblici, ha teso, per decenni, a premiare coloro si mostravano integrati al sistema stesso,
coloro che ad esso erano confacenti, comprimari e consapevolmente riconoscenti.
In queste condizioni, degenerando sempre più la moralità pubblica, si è arrivati ad
assicurare successo, prestigio e garanzia di impunità a coloro che agivano, in piccolo o in
grande, in maniera disonesta, non lesinando, in cambio di voti o soldi, autorizzazioni e
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

concessioni edilizie irregolari, compiacenza per evasioni fiscali o contributive, posti di
lavoro nel settore pubblico, false pensioni di invalidità.
Così, progressivamente, si è raggiunto il livello di guardia, il momento nel quale,
dopo aver sopportato per anni che i partiti politici italiani parlassero della famosa
“Questione morale”12
senza, peraltro, fare alcunché per evitare episodi di corruzione o di
mala gestione, gli italiani hanno capito che i guasti della corruzione erano più alti dei
vantaggi che, individualmente, potevano sperare.
La piena e totale disponibilità dei beni collettivi, che vanno dalle assicurazioni
agli autogrill, gestiti da un gruppo ristretto di uomini, i segretari dei partiti stessi e la
loro “corte”, non poteva che questa conseguenza.
Per poter ottenere i risultati sperati, le oligarchie partitiche potevano contare su due
potenti alleati.
Da una parte vi è un sistema legislativo arretrato che consentiva, attraverso la
gestione pubblica, di eludere ogni controllo reale, quale quello che si realizza nelle grandi
public-company della tradizione anglosassone.
In queste, infatti, dove, grazie ad un adeguato sistema di budget , con definizione e
determinazione di obiettivi certi, oggettivi e verificabili, e di controllo dei bilanci da parte
di qualificati investitori istituzionali, si attua un reale controllo del management societario.
Dall’altra una cultura, comune a larga parte della nostra classe politica, dominata
dalla concezione tipica di un certo mondo cattolico, quello, ad esempio, legato al pensiero
di Giorgio La Pira13
o a Dossetti14
, i quali hanno espresso movimenti culturali
strettamente alleati alla concezione culturale espressa dalla cultura socialcomunista della
sinistra italiana.
12
Che esistesse del marcio gli italiani se ne erano accorti in varie occasioni. Sicuramente lo scandalo di maggiori proporzioni che sconvolse l’Italia prima dell’operazione mani Pulite di Milano, fu il caso Lockeed, quando potenti uomini politici come Gui e Rumor vennero chiamati a rispondere davanti ad un tribunale delle accuse di corruzione. Ricordiamo che, anche a seguito di questi fatti, divenne segretario della DC Zaccagnini, definito “l’onesto”, e che la questione morale venne sbandierata da molti alfieri politici, da La Malfa a Berlinguer. 13 Giorgio La Pira, morto nel 1977, fu sindaco di Firenze per tre volte dal 1951 al 1964. Rappresentò il mondo cattolico militante, sia personalmente che politicamente.
Visse in una cella del Convento domenicano dei San Marco. Come sindaco, si dedicò ad un’intesa attività a favore dei poveri.
La sua concezione politico-sociale tendeva a caricare di connotati fortemente negativi la società capitalistica e, quindi, denotava una notevole ostilità verso il profitto individuale.
14 Uomo politico ed ecclesiastico, nato a Genova nel 1913, è il patriarca fondatore della ex sinistra democristiana (ex nel senso che è rimasta orfana di una DC disgregatasi sotto l’effetto dello scandalo di tangentopoli.)

Una delle massime espressioni di questa cultura cattolico-comunista si ritrova nello
scambio di lettere pubbliche che, nell’ottobre del 1979, avvenne fra l’imprenditore Carlo
de Benedetti ed il vescovo d’Ivrea, monsignor Bettazzi15
.
Uno dei passi principali, che illustra chiaramente l’idea della società prefigurata da
una certa cultura cattolica è il seguente:
Vorrei ..... considerare - scriveva mons. Bettazzi - quanta speranza e
quanta esemplarità potrebbe costituire, e non già per un piccolo gruppo di
privilegiati, ma per le grandi masse e per l'intera collettività, lo sforzo di
subordinare le esigenze della produzione a quelle della collettività,
riconoscendo nei fatti il primato dell'uomo, che pure tutti proclamano a parole.
Perché, se è ben vero che l'economia è una scienza e come tale ha le
sue leggi ineluttabili, è altrettanto vero che queste leggi possono essere
valutate, discriminate, orientate secondo finalità diverse.
La conseguenza diretta di questo insieme di fatti e di ambiti culturali, è stata che si è
negata la necessità, per le aziende pubbliche, di dover rispettare rigidi criteri di bilancio,
considerando il deficit finanziario , da ripianare attraverso la fiscalità, una forma di
redistribuzione del reddito e, quindi, di utilità sociale.
Forte di questa copertura ideologica, la nomenclatura oligarchica e partitocratica ha
avuto buon gioco nella gestione deficitaria dei beni pubblici.
15
Lettera aperta del Vescovo di Ivrea al Vice-Presidente dell’Olivetti pubblicata sul settimanale della diocesi di Ivrea Il Risveglio popolare del 10 ottobre 1979 riportata da Giorgio Invernizzi in “Casi e materiali di Strategia d’Impresa”, Etas Libri 1980 pag.53 Si riportano alcuni passi della lettera: .non potremmo ... accusare le masse operaie di aderire ad ideologie "materialiste", che per loro significano invece l'impegno realista per la sopravvivenza e la corresponsabilità sociale se chi preme sulla società dall'alto delle proprie responsabilità davvero ritenesse che il solo guadagno materiale va visto come norma delle proprie decisioni, e che il lavoro umano non è che una "merce" tra le altre merci, da comprare e da vendere secondo l'andamento del mercato. In tal caso Marx riceverebbe una puntuale conferma delle sue analisi... Quando le classi imprenditoriali prendono decisioni che colpiscono duramente le categorie dipendenti, tanto più se con effetti di intimidazione, in realtà fanno dichiarazioni di guerra, esprimono già una decisione di lotta La lotta delle classi dipendenti diventa cosi' non un'affermazione ideologica, ma una "difesa di classe", per il lavoro e la sopravvivenza, assurgendo a testimonianza efficace e a contributo indispensabile per il rinnovamento profondo di una società cosi' ingiusta e disumana. Vorrei invece considerare quanta speranza e quanta esemplarità potrebbe costituire, e non già per un piccolo gruppo di privilegiati, ma per le grandi masse e per l'intera collettività, lo sforzo di subordinare le esigenze della produzione a quelle della collettività, riconoscendo nei fatti il primato dell'uomo, che pure tutti proclamano a parole. Perché, se è ben vero che l'economia è una scienza e come tale ha le sue leggi ineluttabili, è altrettanto vero che queste leggi possono essere valutate, discriminate, orientate secondo finalità diverse.

Così nessuna rilevanza è stata data alle voragini che , anno dopo anno, si
aprivano in tutte le grandi proprietà di stato, dall’IRI all’INPS.
La cosa importante, infatti, non era garantire una corretta gestione, quanto poter
contare sulla direzione di questi enti, per potervi collocare clientes e, come dimostrano le
indagini giudiziarie tuttora in corso, per consentire gigantesche appropriazioni private di
beni pubblici attraverso tangenti e sprechi.
A partire dal 1991, con il primo referendum per eliminare la possibilità di preferenze
multiple sulla stessa scheda elettorale, il sistema dei partiti cominciava a perdere colpi16
Con il successo del referendum che aboliva la quota proporzionale nel sistema
elettorale per il Senato, veniva inferto un colpo decisivo (almeno questa era l’intenzione
dei proponenti) al sistema partitocratico.
Il soprassalto di dignità che ha pervaso la magistratura, dopo anni di quieta
accettazione dell’esistente, ha portato allo scoperto quanto era a conoscenza di tutti gli
italiani, politici e non, ovverosia un enorme sistema politico-economico basato su
corruttela e clientelismo.
L’insieme di questi avvenimenti politici e giudiziari, ha provocato un forte terremoto
nel mondo politico italiano.
Di fatto di è verificata la scomparsa di interi partiti politici, la delegittimazione di
molti potenti personaggi, a partire dall’onnipotente segretario del Partito Socialista
italiano, quel Bettino Craxi che aveva fortemente caratterizzato il mondo politico per circa
un quindicennio.
In pochi mesi, i partiti storici si sono disgregati, lasciando vuoti profondi nel
panorama sociale e politico italiano.
La Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il Partito Liberale Italiano, i
cui vertici sono stati letteralmente falcidiati dalle indagini giudiziarie, sono scomparsi.
I leader politici di maggior spessore, a partire da Andreotti e Forlani per la DC,
passando per Craxi, Martelli, De Michelis del Psi, fino ad Altissimo del PLI, sono stati
inquisiti e politicamente distrutti.
16
Attraverso il sistema della preferenza multipla, il metodo elettorale permetteva due cose.
Da una parte un controllo sul voto, realizzato assegnando alle persone combinazioni di numeri (preferenze) diversi, in modo tale da poter verificare se dall’interno delle urne tali “combinazioni” uscissero o meno. Dall’altra permetteva la realizzazione di cordate, consentendo il successo di candidati meno conosciuti che, comunque, si legavano al carro di un candidato più “quotato”.

L’unico partito che, pur avendo contato un certo numero di inquisiti, ha conservato la
propria identità è stato il Partito Comunista Italiano, che, trasformatosi nel Partito
Democratico della Sinistra (PDS) ha conservato, quasi integralmente, il proprio potenziale
sia elettorale che istituzionale17
.
A partire dal 1992, gli avvenimenti politici, caratterizzati da questi eventi, si sono
succeduti ad un ritmo incalzante, convincendo alcuni dell’esistenza di una forma di
rivoluzione strisciante, seppure incruenta; in tale un situazione alcuni hanno ipotizzato la
sostituzione della Prima repubblica con la Seconda, mentre il solo Marco Pannella,
leader dei Riformatori, ha sempre sostenuto che, tutt’al più, si tratta del secondo tempo
della prima Repubblica.
Dalle elezioni del 27 marzo 1994, conclusesi con la vittoria del Polo delle Libertà al
nord e del Polo del Buongoverno al sud, che hanno visto il nascere ed il morire del governo
del Presidente Berlusconi, è tornato alla ribalta un problema che, negli ultimi decenni, era
stato accuratamente accantonato, quello dell’equilibrio istituzionale regolato e dettato
dalla nostra Carta Costituzionale.
Tutte le vicende interne ed esterne del ministero Berlusconi, conclusesi con le
dimissioni dello stesso e la costituzione del governo Dini, hanno contribuito a rendere
surriscaldata l’atmosfera politica italiana.
Ricordiamo, a titolo d’esempio, la questione delle nomine RAI, quella del metodo
elettorale delle Regioni, le esternazioni - al limite dell’opportunità se non della legalità -
del Pool di Mani Pulite, con il loro susseguirsi d'interventi polemici e la conseguente
divisione in fazioni del mondo politico e di parte della società civile; il dibattito sulle
regole e sulla democraticità o meno della destra italiana.
Molte di queste vicende, in verità, non erano novità assolute, da sempre, ad esempio,
sono stati i partiti politici a decidere delle nomine degli Enti pubblici, RAI inclusa, né la
questione elettorale può dirsi recentissima, essendo in discussione da vari anni.
Eppure, politici scafati e mass media hanno accreditato ogni piccolo avvenimento di
un’aurea di novità, di eccezionalità, di evento inaudito, di mai visto prima, tutte espressioni
molto in auge in questo periodo!
17
Pur avendo subito una scissione, il potenziale elettorale del PCI si è suddiviso fra il PDS, maggioritario, e il Partito della Rifondazione Comunista (il quale, a sua volta, ha visto nascere la diaspora dei Comunisti Unitari), rimanendo sostanzialmente invariato.

Quali novità erano dunque state introdotte dal governo Berlusconi, tali da
suscitare tanto clamore?
In realtà, nessuna, se non il fatto che, dopo alcuni decenni, per la prima volta
arrivavano a decidere vertici e spartizione di posti coloro che, nella maggioranza dei casi,
si affacciavano per la prima volta alla ribalta del panorama politico italiano o che, come nel
caso di Alleanza Nazionale, formazione nata dopo lo scioglimento del MSI, erano state per
anni relegate in una sorta di ghetto politico.
Questa sì era una novità, ma ciò spingeva molti a confondere causa ed effetto; il fatto
che fossero nuove le facce e le persone che si proponevano come tese alla gestione di
nomine e distribuzione di cariche accreditava la tesi che fossero novità la spartizione di
queste all’interno delle aree d’influenza dei partiti che queste nomine erano chiamati a
fare.
Nulla di tutto ciò, dunque, poteva apparire come nuovo, anzi, contrariamente a
quanto molti si attendessero, rappresentava la perfetta continuità con un passato che ci si
affrettava a rimuovere.
L’unica differenza consisteva nel fatto che, ad una logica spartitoria legata ai vertici
dei principali partiti del centro sinistra e di sinistra, se ne andava sostituendo un’altra legata
ad un’area di centrodestra.
Protestando e proclamando l’inaudita novità del sistema, si cercava di dimenticare
che quello che veniva applicato era null’altro che il diritto che, di fatto, la legge prevedeva
per i detentori del potere politico.
Un diritto affermato e praticato per decenni, ratificato da un’interpretazione
costituzionale tesa a comprimere le libertà economiche individuali a vantaggio di quelle
dello Stato e di chi lo Stato regge, ovverosia i partiti politici e la loro espressione più alta,
le potentissime Segreterie politiche.
La progressiva ingerenza dei partiti politici, con la conseguente occupazione d'ogni
spazio economico, politico e sociale, dall'informazione alle USL fino alle grandi industrie
di proprietà dello stato, ha, di fatto, consentito la nascita e l’affermazione di una
Costituzione materiale che, gemmata ma profondamente diversa dall’originaria Carta
fondamentale, l’ha progressivamente sostituita e resa obsoleta, inapplicata ed
inapplicabile. La Costituzione Materiale, stravolgendo lo spirito della Carta, ha
contribuito alla nascita ed alla proliferazione di un regime politico caratterizzato da un

alto tasso di antidemocraticità, indipendentemente dalle intenzioni dei protagonisti
istituzionali, svuotando di significato buona parte della Costituzione formale.
Il sistema politico basato su questa seconda Costituzione, mai sancita dalla volontà
popolare, riconosceva il partito politico come vero ed unico organo capace di concepire
i bisogni dello Stato, quindi di tutti i cittadini.
Poiché, come vedremo, la Costituzione formale lascia ampi spazi di manovra
all’inserimento di modelli economici statalistici nel tessuto sociale italiano,
progressivamente i partiti politici si sono sostituiti agli organi amministrativi dello stato,
determinando indirizzi politici ed economici , inserendosi nella gestione diretta o mediata
di tutti gli enti che, progressivamente, venivano creati per gestire attività che, in una
corretta visione di democrazia economica, avrebbero dovuto essere gestiti da enti privati.
Questa commistione politico-economico-sociale, generando una situazione
paradossale, pre cui, alla fine, controllori e controllati finivano per coincidere e nella quale
gli interessi degli uni erano complementari e non conflittuali con gli altri, ha consentito la
degenerazione in malaffare della gestione di buona parte dell’Amministrazione pubblica.
Alla diffusa illegittimità si è risposto tardi e male, non con iniziative politiche ma
solo con indagini da parte di una magistratura che, dopo anni di latitanza, sembra aver
ricordato la propria funzione ed il proprio dovere. Purtroppo, la decadenza e
l'imbarbarimento morale che sembra aver permeato la società italiana, hanno trasformato
in eroismo ciò che era dovere.
Di pari passo, la pubblica opinione ha finito per attribuire potere legislativo a chi
rappresentava solo un ordine giudiziario, fino ad al punto di delegittimare i
rappresentanti eletti dal popolo a vantaggio di una legittimazione del tutto impropria di
singoli magistrati. In questo clima, si cerca, da alcune parti, di forzare la volontà popolare,
operando su fronti contrapposti.
Da una parte, cercando di imbalsamare lo statu quo, modificando le maggioranze
qualificate necessarie per modificare le norme costituzionali, presentando proposte come la
Bassanini-Elia18
, dall’altra, come propone il senatore Miglio, proponendo di utilizzare
18
La proposta di legge presentata da Bassanini, costituzionalista del PDS e da Elia, costituzionalista del PPI, già Presidente della Corte Costituzionale, consiste nella revisione dell’art. 138 della Costituzione, sostituendo la parte che prevede la possibilità di modificare la Costituzione stessa con maggioranza semplice. I giuristi dello schieramento di centrosinistra, infatti, propongono, in virtù dell’introduzione del sistema maggioritario, di aumentare il quorum necessario ai due terzi dei membri delle camere. Ricordiamo il testo dell’art. 138:

proprio la previsione dell’art. 138 per introdurre profonde modifiche all’assetto
istituzionale anche solo con una maggioranza semplice; proposta sicuramente legittima ma
poco opportuna, per le ragioni che vedremo, da un punto di vista politico, democratico e
costituzionale. Molte, di fatto, sono le questioni sollevate, in maniera più o meno palese, in
materia di riforma istituzionale.
A nessuno può sfuggire come la nostra Costituzione non sia più adeguata, nelle sue
previsioni di forma di stato e di governo, a regolare i rapporti sociali di una comunità
ormai alle porte del duemila e, più ancora, verso una dimensione non più nazionale, ma
europea. Troppi sono stati i mutamenti avvenuti nella società negli ultimi cinquant’anni,
rapidamente passata da una realtà contadina ad una industriale avviandosi, decisamente,
lungo una strada non di deindustrializzazione ma sicuramente di profonda ristrutturazione,
perché non si ponga mano alla riforma della nostra Carta.
Le principali questioni sono, ad oggi, quelle relative al federalismo, al metodo per
l’elezione del Presidente o, piuttosto, del Primo Ministro, la questione della legge
elettorale, la divisione o meno della carriera nell'ambito dei magistrati, la riforma del
Consiglio Superiore della Magistratura, il concetto di eleggibilità e le cause di
ineleggibilità elettive. La stessa composizione del Parlamento è oggetto di discussione,
dato che alcuni auspicano il passaggio dal bi al monocameralismo ed una riduzione del
numero dei deputati.
Tutte questioni alle quali non possiamo non aggiungere quelle relative alla politica
delle comunicazioni, del rapporto fra proprietà pubblica e proprietà privata e che implicano
un profondo ripensamento dei valori ai quali deve ispirarsi un nuovo modello istituzionale.
La realtà contemporanea impone una serie innumerevoli di sfide, sia in ambito
internazionale che in quello nazionale, alle quali nessuna nazione, men che meno la nostra,
può permettersi di sottrarsi e la nostra Carta sembra non essere adeguata per consentire di
affrontarle e vincerle. “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Conservazione o evoluzione ?
Molte voci autorevoli si levano a difesa della Carta Costituzionale, esaltandone i
valori, la genesi ed i principi ispiratori.
Molti di questi autorevoli personaggi appartengono, di fatto, alla nomenklatura,
ossia a quel gruppo di potere che, all’ombra delle regole costituzionali vigenti, è cresciuto
occupando, in maniera sempre più marcata, ogni spazio vitale della nostra società, sia a
livello politico che culturale ed economico.
Pochi, degli attuali difensori d’ufficio della nostra Carta, possono vantare una statura
morale come quella di Piero Calamandrei, il quale, in un meditato discorso tenuto a Milano
nel gennaio del 1955, sottolineò gli aspetti positivi della nostra Costituzione.
In particolare, egli sottolineò la valenza sociale dell’art. 34, nella parte in cui recita
che “ i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi”.
Egli si chiedeva:
“Eh, e se non hanno mezzi? allora nella nostra Costituzione c’è un
articolo ch’è il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto
per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi. Dice così :” è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.19
”
Calamandrei si soffermò, in quell’occasione, soprattutto sui compiti istituzionali
dello Stato, quelli di garantire a tutti i cittadini il lavoro, la giusta retribuzione, la
possibilità dell’emancipazione attraverso la pubblica istruzione.
Una cosa, però, tese a sottolineare,:
“Però, vedete - continuò - la Costituzione non è una macchina che una
volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la
lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci
19
Articolo 3 comma 2

dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà
di mantenere queste promesse, la nostra responsabilità”
Dunque, una Carta nata imperfetta, rigida nella forma, mutevole nella sostanza.
Generatrice di un sistema istituzionale che, per funzionare, richiede ai cittadini un
costante sforzo di adattamento e di costante vigilanza, che non affida ai puri meccanismi
costituzionali il proprio corretto funzionamento, ma richiede degli attori perfetti, degli
Ottimi che sopperiscano con la propria virtù e le proprie capacità alle intrinseche debolezze
delle istituzioni.
Si appella, infatti, più alla buona volontà, all’eticità dell’uomo e del politico che
alla semplicità ed all’efficienza della propria struttura, immaginando una classe politica di
ottimati, pronti a sacrificare il proprio interesse personale per il bene della nazione.
La nostra Carta è qualche cosa di ancora diverso; essa proclama una serie di alti
principi, disegna un percorso istituzionale, ma, in definitiva, è strutturata per consentire
distorsioni e omissioni.
Sostanzialmente, non si configura come una Costituzione laica, quanto, piuttosto,
come la pietra fondante di uno stato etico, del quale il singolo cittadino appare, al tempo
stesso, sacerdote e suddito.
Uno Stato, cioè, in cui il cittadino è libero ma subordinato alle esigenze collettive;
quale senso dare, infatti, alle parole dell’art. 2, nella parte in cui recita che la repubblica
“richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”?
Quale entità definisce l’inderogabilità di questi doveri? E, soprattutto, che cosa vuol
dire il richiamo alla solidarietà politica, economica e sociale?
Ancora, l’art. 4 secondo comma, prescrive che
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e
la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società”
Dunque, se una persona intende passare la propria vita pescando ed arando il proprio
campo, si può trovare in contrasto con la Costituzione, dato che non contribuisce certo al
progresso materiale o spirituale della società?
Più in generale , che cosa significa concorrere al progresso materiale o spirituale?
Come può adempiere a questo dovere, quindi obbligo, il cittadino italiano?

Quale spazio può avere, in questo contesto, la persona disabile, colui che non è
in condizione, per handicap mentale o fisico, di operare liberamente per concorrere al
progresso della società?
Può sembrare vuota e retorica polemica, in realtà questi due esempi indicano in
maniera estremamente chiara i presupposti sui quali si regge l’impianto ideologico che
sottostà alla costruzione della nostra Carta.
Inutile ricordare come la stessa Costituzione preveda un importante limite ad una
delle principali libertà individuali, quella della proprietà.
Infatti l’articolo 42 rimanda alla legge ordinaria per determinare “i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale “, arrivando all’assurdo di prevedere che, per legge, si
possa rendere accessibile a tutti la proprietà20
.
Difficilmente si può capire quale significato abbia questa norma, dato che la legge
può impedire che qualcuno privi un’altra persona della proprietà, ma come può
consentire la nascita del diritto di proprietà se ne mancano i presupposti soggettivi?
Se poi, invece, la norma intende affermare che non si possono frapporre ostacoli
legali all’acquisizione di diritti di proprietà da parte di chiunque, per ragioni politiche,
religiose, sociali o altro, si può ben dire che, nella migliore delle ipotesi, il concetto è
espresso malamente.
Appare, infatti, inutile e tautologico, essendo sufficiente, se altri non fossero i
presupposti, fermarsi alla prima dizione, ovverosia che “la proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge”.
Evidentemente si è voluto sottolineare, proseguendo, che tale libertà appare
subordinata a principi etici; gli stessi principi che hanno indotto il costituente a scrivere il
terzo comma dello stesso articolo 42, il quale recita che
la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale
Una concezione dello Stato, dunque, che, per quanto ispirata da due culture
antitetiche e complementari, come quella marxista e quella cattolica, risulta estremamente
affine alla concezione propria dell’idealismo gentiliano, ispiratore dello stato fascista e
corporativo.
20 Recita il secondo comma dell’articolo 42 “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Stato Etico e sistema corporativo
Molte volte si parla di Stato etico contrapposto allo Stato di Diritto ed alla
concezione laica dello Stato, riferendosi ad una concezione ormai superata o, semmai,
affine alle teocrazie che si sono affermate nelle cosiddette repubbliche islamiche.
In realtà, lo stato etico continua a sopravvivere in molte nazioni, colorandosi,
molte volte, di nazionalismo o, altre volte, come stato sociale.
Lo Stato assurge, in questo contesto, a valore più alto, si rivela il mezzo ed il fine, lo
strumento attraverso il quale la Nazione, intesa come unitarietà di popolo e cultura, può
raggiungere i propri obiettivi in termini di affermazione di sé, sia che si proponga il
raggiungimento di una purezza etnica - come nel caso degli Stati sorti nella ex-Jugoslavia
- sia che voglia perseguire, come fine, il raggiungimento di valori immateriali come la
felicita o la giustizia.
Interessante è riportare, a proposito del concetto di Stato elaborato dai tecnici legati
al movimento fascista, quanto scritto nell’Enciclopedia Italiana, edita dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, che ebbe Gentile come Presidente:
“Non v’è fatto grande nella vita del genere umano che esso (lo Stato
N.d.R.) ignori. Nonché indifferente nelle lotte che dilacerano la società, di
continuo prende partito, suscitando i più alti valori di umanità.
Se la precedente filosofia, soprattutto col Kant, poteva concepire uno
stato limitato ad assicurare la paritaria coesistenza esterna dei soggetti, la
esclusiva tutela giuridica, il nuovo stato il diritto vede forma del più vivo
contenuto umano e questo nelle infinite guise fa suo.
Tutti i fini divengono il fine dello Stato, il quale, trasportandosi su un
piano che travalica le generazioni, le sottrae alla contingenza.
Economia, morale, arte, religione, sono per lo Stato, sicure nello Stato.
La vita stessa nei più nobili tratti, quelli per cui l’uomo più si avvicina a
Dio, Dio può celebrare, è condizionata dalla sublime realtà dello Stato21
A proposito della concezione fascista dello Stato, si legge ancora che
21
Enciclopedia Italiana, edita dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani vol. XXXII pag.617

il fascismo ... nega esservi diritti fuori dallo Stato, che lo Stato non
configuri e renda efficienti ai fini di una vita non atomisticamente, bensì
unitariamente e organicamente intesa
Questa concezione organica confluisce poi, successivamente, nella teoria del sistema
corporativo, dato che, come si legge sempre nell’Enciclopedia Italiana
“L’individuo...viene organizzato in corpi sociali ognora più comprensivi,
come lo stato, sottratto all’isolamento del despota, è sospinto ad adeguarsi agli
scopi sociali in cui l’individuo si organizza.
L’essenza dell’individuo vuole che esso tenda alla corporazione, a
spiegarsi nell’organizzazione corporativa...
Il corporativismo fascista costituisce la più affinata coscienza di questa
essenza assoluta dello stato e lo sforzo più efficiente di una sua realizzazione
su piano storico.
Intendiamo ora perché lo stato per il fascismo è etico, etico perché
corporativo, corporativo perché etico.
Nulla di ciò che nello spirito e dallo spirito fiorisce è a lui estraneo,
dalla filosofia alla religione, all’arte, che in esso sono perché ad esse danno
coscienza e valore.
L’individuo, nello stato fascista è tutelato e protetto, elevato
dall’empiria alla sublimità dell’associazione, valorizzato.
La tutela proclamata va oltre la vita individuale e riguarda l’uomo
nella continuità della specie.
Una qualche eco del sistema corporativo si ritrova anche nella Costituzione
italiana, in particolare nella previsione dell’articolo 99, relativo al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL).
recita infatti l’articolo 99:
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Di fatto, scarsa importanza ha assunto questo istituto, prevalendo un sistema
neocorporativo che, come vedremo meglio in seguito, attraverso il sistema della
cosiddetta concertazione22
, taglia fuori gran parte dei canali istituzionali per prevedere un
accordo diretto far Governo e parti sociali (sindacati ed associazioni imprenditoriali).
Cosicché non si è avuto bisogno di ricorre ad uno strumento di compensazione come
quello previsto dalla Costituzione, potendo agire attraverso un colloquio diretto, con un
Parlamento che, di fatto, si è trovato in condizione subordinata rispetto ad accordi stipulati
al di fuori della prassi istituzionale.
L’accostamento della concezione dello Stato etico gentiliano con la nostra Carta
suscita, sicuramente, più di un risentimento, ma è indubbio che le principali componenti
dell’Assemblea Costituente, la marxista e la cattolica, si trovassero a condividere, seppure
con presupposti diversi, una comune visione dello stato.
Per entrambi, infatti, l’entità statuale non appare come un ente astratto, una mera
sovrastruttura che riceve la propria legittimità dalla comune volontà di cittadini di
investirla di un compito preciso, quanto, piuttosto, una struttura ben precisa, viva,
portatrice di valori propri.
Lo Stato, come si può capire anche dalla lettura della Costituzione, è chiamato a
svolgere una funzione di indirizzo, di salvaguardia, di controllo dell’operato dei singoli
cittadini, ai quali richiede di operare per il bene collettivo, sia materiale che morale.
Uno stato quindi che non si pone al servizio del cittadino, che non trae legittimazione
dalla volontà popolare, ma che, piuttosto, legittima con la propria esistenza e le proprie
regole, l’operato dei cittadini, ai quali richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà,
concede il privilegio della proprietà, purché subordinata ai propri interessi, garantendo, in
compenso, almeno sulla carta, lavoro e benessere.
22
Si intende definire con tale termine una prassi ormai consolidata da decenni, in virtù della quale molti importanti provvedimenti legislativi, soprattutto in campo economico ma anche politico e sociale, vengono preliminarmente discussi dal Governo con le cosiddette parti sociali, in particolare i sindacati confederali - CGIL, CISL, UIL- e le rappresentanze imprenditoriali - Confindustria, Confcommercio etc. - . Una volta definito un certo tipo di accordo, il governo emana un decreto legge o, più raramente, un disegno di legge; il Parlamento poi si troverà, di fatto, a svolgere un ruolo notarile, limitandosi, con rare e non incisive modificazioni, a prendere atto di quanto stabilito al di fuori dei normali canali istituzionali.

Dunque, uno stato etico, come concepito dall’idealismo gentiliano, dal
materialismo marxiano, dalla dottrina sociale della Chiesa.
Ben lontano da quei modelli di stato laico ai quali, secondo i proclami, si ispirerebbe
larga parte del mondo politico italiano.
Nella concezione di Stato laico, infatti, l’accento viene posto sulla libertà del singolo
cittadino, sul suo diritto all’uguaglianza giuridica, all’affermazione dei precetti dello Stato
di diritto, all’interno del quale non vi è alcun privilegio per l’Ente statale, ma esso appare
soggetto alla legge esattamente come il cittadino comune.
Lo Stato, in questa concezione, trae la propria legittimazione dai cittadini, che in esso
si riconosco ed al quale chiedono l’assolvimento di un compito preciso, quello di
amministrare i beni comuni.
Non già, quindi, lo Stato come portatore di valori, bensì come insieme di volontà,
coordinatore e gestore dei beni comuni, regolatore del mercato attraverso l’emanazione di
leggi e non come soggetto attivo.
La difesa della Carta Costituzionale è anche la difesa di una concezione etica dello
stato, magari identificando lo stato etico con lo stato sociale, assumendo come valore
assoluto, guida dell’attività statuale, la tutela del cittadino, anche a costo di gravi costi
sociali, in termini di deficit pubblico, inefficienza e disservizio.
In realtà, proprio grazie alla mistificazione dello stato etico-sociale, si è potuto
sostenere un sistema istituzionale che, andando oltre la lettera della Costituzione,
interpretandone, comunque, perfettamente lo spirito originario, ha garantito potere alle
oligarchie partitiche e finanziarie, strettamente legate in un sistema di reciproco interesse.
Da una parte un mondo politico teso a sfruttare al meglio le opportunità offerte da
uno regime di socialismo reale, dall’altro un sistema economico e finanziario legato ad una
concezione protezionista dell’economia, refrattario alle leggi di mercato, poco propenso ad
affrontare il mare aperto della concorrenza internazionale senza il paracadute offerto
dall’intervento e dal sostegno dello stato.
La convergenza di interessi fra oligarchia politica e oligarchia finanziaria ha prodotto
un sistema istituzionale apparentemente fragile, in realtà in grado di garantire una certa
stabilità, poco importa se basandosi sul disavanzo pubblico e sullo spreco sistematico di
risorse umane e finanziarie.

La difesa retorica della nostra Costituzione, contrabbandata come la più
avanzata del mondo, la più sensibile ai problemi sociali, nasce da questa comune
volontà di conservazione dello statu quo.
Così, facendo leva sulla previsione costituzionale, non si accetta che venga rimesso
in discussione l’intero impianto costituzionale, ma si pretende di far credere che si possano
risolvere le molteplici contraddizioni istituzionali attraverso semplici ritocchi, quali quelli
realizzabili con i tempi ed i modi previsti dall’articolo 138.
Ben diverso impatto potrebbe avere, al contrario, una revisione radicale e sistematica
dell’intera Costituzione; revisione realizzabile però, solo attraverso la convocazione di una
nuova Assemblea Costituente, dato che solo attraverso questo sistema si potrebbero
affrontare compiutamente tutte le problematiche fin qui esposte, a partire dalla concezione
di stato che deve sottostare alla costruzione legale.
Coloro che si trovano a difendere strenuamente la Carta si ritrovano insieme,
puntualmente, in una serrata opposizione ad ogni ipotesi di convocazione di una nuova
Assemblea Costituente.
Questa opposizione è una conseguenza logica della difesa costituzionale, dato che in
essa non vi è alcuna previsione di questo tipo, anzi, vi è una specifica previsione
procedurale nell’ipotesi in cui si dovesse provvedere ad una qualsiasi modifica.
Questa forma procedurale è quella richiamata dall'art. 138 che recita testualmente:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di
una Camera o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non
è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Al di là di questo aspetto specifico, si afferma , più in generale, che la nostra Carta
Costituzionale rappresenta il punto di arrivo delle concezioni ideali che promossero la
resistenza al regime fascista e che, all’interno dei 139 articoli dai quali è composta, vi si

ritrovano altri concetti di giustizia sociale, tutela delle libertà individuali ed una equilibrata
presenza di tutela dell’iniziativa privata senza ledere il principio solidaristico.
Oltre a questo, si dice, il meccanismo istituzionale disegnato e preordinato dalla
Carta esalta i principi democratici, regolando in maniera corretta i rapporti fra i poteri e
garantendo, quindi, ampia rappresentatività agli organi parlamentari.
Si afferma che certi principi, quali ad esempio quello stabilito dall’art. 45 - a
proposito della tutela della cooperazione - o quanto stabilito dall’art. 41- in base al quale
l’iniziativa privata viene riconosciuta libera purché non in contrasto con l’utilità sociale - ,
rappresentino un merito essenziale della nostra Carta.
Attraverso queste asserzioni i costituenti cercarono, quindi, di coniugare
l’accettazione di un sistema economico, che si preannunciava integrato con i sistemi
economici occidentali, basati su principi capitalistici, con una concezione più solidaristica,
se non addirittura anticapitalista, propria sia della dottrina sociale della Chiesa Cattolica
che dell’opposizione socialista e comunista.

Stato di diritto e Stato Laico
Lo Stato etico, dunque, viene concepito come entità che possiede un’anima ed un
pensiero proprio, al di sopra dei cittadini, i quali sono chiamati a contribuire, con le loro
forze, siano esse fisiche che economiche, al suo mantenimento, al fine di consentirgli di
raggiungere lo scopo per il quale esso esiste.
Uno scopo, un fine, che sembra sfuggire alla maggior parte di coloro che nello Stato
vivono e del quale sono, per certi aspetti, sudditi, ma del quale non possono che essere
partecipi.
All’interno di questa struttura, coloro che incarnano la missione statale, ne interpretano
il pensiero, ne coordinano le azioni, non possono che essere coloro che, al contrario della
maggioranza dei cittadini, in virtù di doti particolari, riescono ad immedesimarsi con esso, a
diventare un tutt’uno con lo spirito dello Stato, in definitiva, persone che appartengono ad
una ristretta élite di 23
inevitabilmente posti al di sopra di tutti gli altri.
Come potrebbe, altrimenti, esprimersi lo spirito dello Stato, se non attraverso dei
qualificati esegeti, dei fedeli interpreti, selezionati non già attraverso metodi di selezione
democratica, bensì con la selezione e la cooptazione dei migliori da parte dei migliori?
Per quanto tutto questo possa apparire, a prima vista, del tutto paradossale, lontano
dalla struttura politica disegnata dalla nostra Costituzione, in realtà, come i fatti degli
ultimi cinquant’anni dimostrano, proprio questo è avvenuto e proprio su questo si regge il
sistema politico italiano.
Se solo ripensiamo alle segrete ed occulte vicende che avvengono all’interno delle
stanze chiuse delle segreterie dei partiti, con l’incrociarsi di lotte sotterranee per la
conquista dei gangli vitali dei partiti, delle prebende e degli ostracismi con i quali si
premiano o si penalizzano vincitori e vinti delle cordate politiche, si può capire che la
democrazia, in effetti, non abita qui.
Quali possibilità di controllo democratico può esercitare, oggi, il singolo cittadino, l’elettore
che non può influire sulla scelta dei candidati, che non può concorrere alla formazione della
linea politica del proprio partito d’elezione, neppure iscrivendosi a questo?
23
letteralmente: Belli e buoni, come definivano gli antichi greci coloro che erano gli aristocratici, i migliori.

Già nel 1300 Marsilio da Padova scriveva che
" Noi diciamo che il legislatore, ovvero la causa effettiva, prima e
propria della legge, è il Popolo, ossia l'universalità dei cittadini o, almeno, la
maggioranza di essi"24
.
Se si pensa che questo sia vero, si comprende subito quale abisso separi lo Stato di
Diritto dallo Stato Etico, perché nel primo è il cittadino la pietra base, il principio
fondante dello stato stesso, non già un semplice orpello, il mero esecutore di una volontà
aliena che gli si sovrappone e che, in alcuni casi, gli si oppone.
Nello Stato di diritto, tutti, a partire dall’organizzazione statale, sono sottoposti
all’osservanza delle leggi e, quest’ultime, vengono emanate da rappresentanti del popolo,
in nome e per conto del popolo, al servizio del popolo.
Uno Stato di diritto non si pone come fine, non persegue il raggiungimento di ideali,
di unificare nazioni, obbedire a precetti divini.
Esso, più semplicemente, tenta di assolvere a quello che ritiene un preciso dovere,
garantire l'efficienza della macchina dello stato; efficienza necessaria soprattutto per
garantire veri servizi e, quindi, veri spazi di democrazia.
Una funzione, dunque, di pura amministrazione di quello che è l’unico patrimonio
collettivo, il benessere e la ricchezza dei singoli cittadini, la soddisfazione delle loro
richieste legittime, nel rispetto della volontà della maggioranza e della tutela delle tante
minoranze, sociali, culturali, religiose che in esso si trovano a convivere.
Dunque, non dovendo perseguire obiettivi sovrannaturali, lo stato laico non ha
bisogno di faraoniche burocrazie autoriproducentesi, di tecnostrutture spersonalizzate; ha,
piuttosto, la necessità di una struttura semplice e snella ,allo scopo di avvicinare sempre di
più lo stato al cittadino.
Il regionalismo, nel caso italiano, poteva rispondere a questa esigenza, se solo non si
fosse scelta la strada della loro burocratizzazione, la ripetizione in ambito più ristretto,
delle inefficienze centrali.
24
Marsilio di Bonmatteo Mainardini, nato a Padova tra il 1275 ed il 1280, morto tra la fine del 1342 ed i primi mesi del 1343, autore del Defensor Pacis, la maggiore opera di teoria politica scritta nel Medioevo, affondando le proprie radici nell’esperienza dei Comuni ed affermando la parità dei cittadini, senza distinzione di censo e status.

Se alle Regioni, cosa che non è stata fatta fino ad oggi, si affideranno molte delle
competenze che, attualmente, sono prerogativa dello stato, lasciando ad esso una funzione
di coordinamento e composizione di eventuali controversie su questioni ambientali o di
utilizzo di risorse comuni (vedi fiumi, laghi, strade), si potrà cominciare a parlare di vera
nuova democrazia.
In questa ottica, la democrazia dovrà essere sempre di più di base; il cittadino-
elettore dovrà essere chiamato a decidere direttamente su chi, ad esempio, dovrà gestire le
strutture sanitarie locali, chi sarà il Provveditore agli studi locali, chi dovrà gestire la
polizia comunale, e così via.
Progressivamente, così operando, si prosciugherebbero i mille rivoli che portano
acqua al fiume dell’oligarchia partitocratica, restituendo dignità ai cittadini, finalmente
liberi di scegliere e di sbagliare, ma con la certezza di correre pochi rischi, potendo
rimediare dopo pochi anni con una nuova tornata elettorale.
Per quanto riguarda la gestione dello Stato, ovverosia l'amministrazione di quanto di
residuale spetta all'ente centrale (difesa, esteri, interni, pubblica istruzione, finanza
pubblica - ovverosia gestione delle entrate e delle spese -) al fine di garantire efficienza a
questa gestione, si tratterà di valutare, in un’armonica ridefinizione della forma di stato e di
governo, quale struttura dare al sistema politico istituzionale italiano, scegliendo fra i tanti
modelli esistenti, dal parlamentarismo puro al presidenzialismo nordmericano.
Sicuramente, dato che nessuno può essere legittimato a rappresentare l’idea dello
Stato, la burocrazia statale dovrebbe subire una profonda modifica, riportando il Governo
alla sua funzione primaria, quella di responsabile della Pubblica Amministrazione.
Così i Direttori Generali dei Ministeri dovrebbero essere nominati dal governo, per
coerente gestione amministrativa e restare in carica per la durata del mandato governativo.
Il parlamento potrebbe benissimo essere monocamerale, eletto con metodo
uninominale ad un turno unico, in presenza di una normativa elettorale che imponga lo
svolgimento, con metodo predefinito ed obbligatorio, di elezioni primarie.
Dovrebbero essere eletti con metodo proporzionale, invece, i membri degli alti
organi di controllo, come ad esempio la Corte Costituzionale.
Stesso criterio potrebbe essere definito per l'elezione del presidente delle Regioni,
lasciandole libere di definire i criteri per l'elezione dei consigli regionali.

Insomma, applicando il principio caro all’ex ministro delle Finanze, l’onorevole
Tremonti, passando dal complesso al semplice, recuperando lo spirito e l’originario
compito che la concezione dello Stato di diritto affida ai governanti ed ai legislatori, l’Italia
e molte altre repubbliche, europee e non, potrebbero diventare delle vere democrazie.
Una Rivoluzione Copernicana che si affermerebbe qualora passasse il principio, già
prospettato, di una diffusione della democrazia, rendendo eleggibili molte delle cariche
che, oggi, sono affidate ai patteggiamenti fra i partiti o per iter burocratico.
Pensiamo all'elezione di un Direttore sanitario, responsabile della gestione
amministrativa e della politica sanitaria di un Comune (Area Metropolitana) o di un
Provveditore agli Studi.
Al minor tasso di clientelismo ed alla maggiore trasparenza ed efficienza nella
gestione delle risorse che potremmo avere eliminando le Provincie, i Coreco, gli organi
di controllo statali sulle regioni, i Prefetti.
Al fiorire di nuove professionalità, opportunità e mobilità territoriale, circolazione di
idee, culture ed esperienze professionali con la nascita di professionisti non più legati alle
logiche clientelari bensì alla necessità di ben operare per poter essere eletti.
Ad esempio, un Provveditore agli studi, il mandato del quale durasse 3 anni
rinnovabile al massimo per altri 3, dovrebbe ben operare perché solo così potrebbe
sperare di essere eletto in un altro Comune; lo stesso dicasi per un Dirigente
sanitario.
Periodi brevi, per impedire il radicarsi di clientele, ma sufficientemente lunghi per
impostare politiche scolastiche e sanitarie.
In quest'ottica di decentramento democratico e di reale coinvolgimento e
partecipazione dei cittadini, la paura di una figura forte, quella del Presidente, verrebbe a
perdere consistenza.
Se poi pensiamo ad organi di controllo eletti con il metodo proporzionale, con un
adeguato sistema di contrappesi, potremmo cominciare a pensare e sperare di vedere la
fine di un lungo tunnel nel quale, oggi, rischiamo tutti di morire soffocati.

I Diritti Fiscali dei Cittadini
Nell’ambito di questa rivoluzione copernicana, il cittadino si troverebbe, finalmente,
ad essere il vero motore, il fulcro dello Stato.
Non più, quindi, soggetto passivo, mezzo attraverso il quale si esprime lo spirito
dello Stato, ma causa prima di ogni azione statale.
Sicuramente si tratterebbe del ritorno all’antico, alle concezione democratiche dei
primordi, al contratto sociale di J.J Rousseau, a Montesquieu25
, fino ad Hobbes e Smith.
A chi ritenga ciò utopistico o contrario ai proclamati principi di solidarietà e di stato
sociale, tanto cari a parte delle dottrina economica e politica contemporanea, si dovrà
ricordare che, basandosi su questi principi, sono sorte le grandi democrazie moderne, con
la loro negazione si è dato vita ai mostri hitleriani, staliniani ed alle teocrazie
fondamentaliste.
In questo contesto di riappropriazione della sovranità da parte del popolo, che senso
avrebbe, ad esempio, mantenere i limiti imposti dall’attuale Costituzione ai diritti
referendari?
Ricordiamo che, a norma del comma 2 dell’articolo 75 della Costituzione, non si
possono richiedere referendum in materia di leggi tributarie e di bilancio né per
l’autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
In pratica, i cittadini sono limitati nella loro capacità di esprimersi su due materie
specifiche, quelle tributarie e quelle relative alla politica estera.
La prima limitazione poggia su di un preciso presupposto, che i cittadini siano tutti
potenzialmente contrari a contribuire, attraverso la fiscalità, al mantenimento dello Stato.
Questa impostazione negativa, rende palese la diffidenza che permea il mondo
politico italiano nei confronti dei cittadini; da anni, sistematicamente, tutti i politici hanno
bacchettato il popolo italiano, accusandolo di essere, nella propria maggioranza produttiva,
un assieme di evasori fiscali.
25
Nel suo De L’esprit des lois, Montesquier esprime il concetto di reddito dello Stato come parte del reddito privato del quale i cittadini si privano per poter godere, con sicurezza, del rimanente.

Questa accusa serviva, in pratica, a giustificare un regime fiscale dei più terroristi
che mai si siano visti, almeno da quando sono cadute le monarchie assolute e si è
sviluppato il principio dello Stato di diritto.
In nessun’altra nazione del mondo occidentale, infatti, il cittadino-contribuente è
obbligato al rispetto di regole ed adempimenti come in Italia, oltretutto senza alcuna
certezza e con pesanti sanzioni per banali errori anche solo di carattere formale.
Questa diffidenza trova la propria radice proprio nella nostra Carta, la quale,
rifiutando il diritto dei cittadini di esprimersi nei confronti delle leggi fiscali, sceglie una
filosofia di finanza pubblica molto simile a quella delle monarchie pre Rivoluzione
Francese.
Eppure, l’articolo 81, all’ultimo comma, recita che “ Ogni altra legge (al di fuori
della legge finanziaria N.d.R.) che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte”
Riecheggiando, così, quanto scritto da Wicksell26
, il quale, illustrando il principio
della volontarietà dell’approvazione delle imposte, scrisse che
“L’attuazione pratica di ciò che vorrei chiamare il principio della
volontarietà e dell’unanimità dell’approvazione delle imposte richiede
soprattutto che non venga mai votata una spesa senza che
contemporaneamente si siano decisi i mezzi necessari per la sua copertura27
”
Ancora, l’impostazione dell’articolo 53, al primo comma, recita che “ Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”,
ricalcando quanto scritto da Smith, ovverosia che
“ i sudditi di ogni Stato dovrebbero contribuire a mantenere il Governo,
in proporzione quanto più possibile stretta alle rispettive capacità: ossia in
proporzione al reddito di cui rispettivamente godono sotto la protezione dello
Stato”.
Eppure, nonostante i richiami palesi a concezioni di economia classica, il fatto stesso
che si statuisca, a livello costituzionale, che il sistema tributario debba essere informato a
criteri di progressività28
, che si preveda l’utilizzo dello strumento dell’esproprio29
, della
26 Knut Wicksell, nato a Stoccolma il 20 dicembre del 1851 e morto il 3 maggio 1926 fu economista di grande valore e prestigio.
27 Knut Wicksell “Intorno a un nuovo principio di giusta tassazione” in “Teorie della Finanza Pubblica”.a cura di Franco Volpi, Franco Angeli Editore, Milano 1975, pagg. 134 e seg.
28 articolo 53 2 comma

limitazione, per legge, ai diritti di successione consentendo allo Stato di poter vantare
diritti sugli stessi30
ed altre limitazioni ai principi di proprietà e di libertà d’impresa, ci
induce a riflettere sulla reale matrice culturale sottostante alla Carta.
Una matrice che si evidenzia proprio nel momento in cui, paradossalmente, la nostra
Carta cerca di presentarsi come tesa a tutela i diritti dei cittadini, attraverso lo strumento
referendario.
Proprio il fatto che venga negata la possibilità di sottoporre a referendum le leggi
tributarie ci dice quanto essa sia lontana dalla concezione di democrazia economica.
Il principio di volontarietà e d’unanimità delle imposte, infatti rappresenta la chiave
di volta, la cartina di tornasole del carattere di democrazia liberale o meno di una Carta
Costituzionale.
Secondo tale principio, rivoluzionario nella sua espressa semplicità, partendo dal
presupposto che, essendo l’attività dello Stato riconosciuta come di utilità generale, dunque
dovendosi confrontare l’utilità attesa, con il necessario sacrificio richiesto ai singoli
cittadini, si può sempre giungere a trovare una ripartizione dei costi
“tale da far apparire a tutti i partiti...come indubbiamente conveniente e
da farla approvare all’unanimità. Se ciò con è possibile in alcun modo, allora
c’è la dimostrazione a posteriori, anzi l’unica dimostrazione possibile, che
l’attività pubblica in questione porterebbe alla collettività solo un utile non
corrispondente al sacrificio necessario per realizzarla e quindi deve essere
razionalmente respinta.31
Secondo tale impostazione, proprio la volontaria accettazione dell’imposizione,
strettamente correlata con la convinzione che il gettito di questa vada a finanziare opere
precise e generalmente accettate, farebbe si che non mancassero mai i mezzi per la
realizzazione di tali opere.
Esattamente il contrario di quanto si sta facendo in Italia in campo fiscale, dove si ha
una pressione fiscale elevata e servizi non all’altezza di quanto il cittadino è chiamato a
contribuire.
Situazione che, di fatto, legittima il ricorso all’evasione fiscale, non percepita come
atteggiamento antisociale, bensì, quasi, come legittima difesa contro un apparato
29 articolo 43
30 articolo 42 ultimo comma
31 Knut Wicksell op.cit.

burocratico rapace, esattamente come veniva percepito dai contadini che nascondevano
grano ed animali per difenderli dalle razzie degli ufficiali e dagli sgherri dei sovrani e
feudatari medioevali32
.
Portando a termine l’auspicata rivoluzione copernicana, passando dal complesso al
semplice, consentendo ai cittadini un effettivo controllo sulle spese dello Stato, attraverso
un rafforzamento delle autonomie locali (regioni e comuni), sicuramente sarebbe molto più
agevole di quanto lo sia oggi rendere effettivi questi principi di democrazia economica.
Non è qui il caso di approfondire le teorie economiche che si possono basare sul
principio della volontaria accettazione, sicuramente, comunque, appare evidente che la
previsione costituzionale tesa a negare la possibilità, ai cittadini, di intervenire
direttamente, su questioni di bilancio e fiscali, pone il nostro sistema tributario e di finanza
pubblica al di fuori di tale previsione.
Il fatto che gli elettori non possano influire su decisioni di questa importanza,
attraverso le quali si decide della vita di tutti i cittadini, basta a farci comprendere la
struttura fortemente oligarchica, elitaria ed etica della nostra attuale Costituzione.
32
Secondo illustri opinionisti, politici e sindacalisti, l’Italia sarebbe un paradiso per gli evasori e tali sarebbero, secondo questa linea di illuminato pensiero, solo ed esclusivamente imprenditori, artigiani, commercianti e liberi professionisti in genere. Virtuosi forzati del fisco sarebbero, sempre secondo questi illuminati, i soli lavoratori dipendenti, in virtù del meccanismo delle trattenute obbligatorie sulle retribuzioni. Come molte volte accade, la realtà è ben più complessa della sua rappresentazione schematica ed ideologica. Se sicuramente si nascondo ampi spazi di evasione fra queste categorie, non si può dire che ne sia immune almeno una buona parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Troppo diffusa, infatti, appare la pratica del cosiddetto doppio lavoro, consistente nello svolgere un lavoro parallelo a quello ufficiale, rigorosamente “al nero”, così vediamo operai comunali che si improvvisano giardinieri privati, operai meccanici che imbiancano o si improvvisano idraulici, insegnanti che danno ripetizioni e così via. Per non dire, poi, che chiunque si trovi nella condizione di acquistare un immobile prova l ’irresistibile tentazione di dichiarare un minor imponibile per risparmiare sull’imposta di Registro o sull’IVA o, se dovuta, sull’INVIM. La complicata impostazione burocratica italiana, poi, rende inevitabile che una serie di piccoli lavori domestici, come ad esempio l’attività di baby-sitter, sia svolta regolarmene in nero, anche perché nessuna possibilità di detrazione viene concessa a chi tale spesa deve sostenere, dovendo lavorare o non potendo contare su famiglie estese. Il tutto, ovviamente, alla faccia dei dettati costituzionali e della tutela della famiglia! Questi commenti sono riportati nel suo libro “Come si Manda in rovina un paese” (ed. Rizzoli 1995).

I limiti della Costituzione
Prima di analizzare in dettaglio alcuni aspetti particolarmente significativi della
nostra Carta fondamentale, preme riportare alcuni commenti di Sergio Ricossa, scritti in
tempo reale, dato che egli, allora studente, fu testimone attento ed accorto dei lavori della
Costituente. Scriveva nel suo diario nel 1948:
Come si fa a prendere sul serio una costituzione che esordisce: ‘L’Italia
è una Repubblica fondata sul lavoro'? Giustamente Arturo Labriola, che ha
letto Marx, si è rifiutato di votare l’articolo. Il lavoro, se non è sfruttamento, è
pena, a parte i pochi privilegiati, che lavorano per il piacere di lavorare.
L’esaltazione del lavoro duro è solo di una certa borghesia, per lo più
cristiana. Marx e Keynes volevano la fine dell'obbligo del lavoro e l'inizio
della libertà, del lavoro puramente spontaneo.
La sinistra chiese un articolo ancora più stupido: 'L'Italia è una
repubblica di lavoratori.”
Toglieva la cittadinanza a bambini, vecchi e benestanti33
.
Proprio su questo aspetto, Piero Calamandrei, nell’intervento sopra citato, affermava:
“...dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una
scuola a tutti. Dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo
sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’articolo 1
.... corrisponderà alla realtà.
Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e
di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da
uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro,
ma non si potrà chiamare neanche democrazia”
Sicuramente un intervento apprezzabile, e tale sarebbe se solo questo sottendesse
l’articolo 1; in realtà, inserito nel contesto globale della Carta, esso richiama una ben
diversa impostazione.
Viene in mente, infatti, l’articolo 1 della Costituzione della ex URSS, approvata nel
testo definitivo dall’VIII Congresso dei Soviet del 1937, il quale recita: “La Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche, è uno stato socialista di operai e contadini...”
33
Sergio Ricossa “Come si manda in rovina un paese” Rizzoli 1995 , pag.19

Ancora riecheggiano, alla mente, le seguenti parole:
“Il lavoro con cui l’uomo vince la natura e crea il mondo umano” è
inteso come strumento di elevazione, creatore di umana dignità, via alla
morale, “valore essenziale”.
L’individuo, uomo, cittadino, lavoratore, in una sempre più concreta
qualificazione storica, viene non già annullato bensì moltiplicato nello stato
dei cittadini lavoratori”
Quanto sopra non è la prosecuzione della costituzione sovietica, né un discorso
illustrativo della Costituzione italiana, neppure un ricordo di quel “Il lavoro rende liberi”,
tragico epitaffio per i milioni di innocenti sacrificati nei lager nazisti, ma, più
semplicemente, quanto compare nell’Enciclopedia Treccani, sempre a proposito del
sistema corporativo, e le parole fra virgolette sono di Benito Mussolini, che per questa curò
le pagine dedicate all’illustrazione della dottrina del fascismo34
Se, a ciò, aggiungiamo quanto sopra ricordato a proposito dell’articolo 4 della
nostra Costituzione, si comprende che il quadro d’insieme che si vien delineando si
inserisce perfettamente in un modello culturale tipico degli anni trenta.
Da una parte, infatti, il mito di Stakanov, il minatore russo che, nel 1935, divenne
un eroe nazionale dell’Unione Sovietica per essere riuscito ad estrarre più carbone di
quanto fossero riusciti a fare altri, dall’altra l’esempio dato da Benito Mussolini, ritratto
dall’agiografia ufficiale mentre, a torso nudo, partecipa alla raccolta del grano.
Insomma, una retorica del lavoro tipica della cultura socialista, dove si afferma che
“chi non lavora non mangia” e dove l’unico lavoro concepito è quello dell’operaio e del
contadino, senza alcuna stima per quello imprenditoriale ed intellettuale, concepito come
sfruttamento l’uno e parassitario l’altro.
Ricossa proseguiva, nel 1949, con la seguente chiosa:
La costituzione italiana ammette tutto, proclama che l'iniziativa privata è
libera, ma aggiunge che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.
Poiché l'utilità sociale è ciò che vogliono i partiti al potere, l’iniziativa
privata è costituzionalmente fottuta se al governo vanno i comunisti.
Quesito: a che servono le costituzioni?
34
Enciclopedia Italiana, edita dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani vol. XXXII pag.619 a cura di F.Battaglia e vol. XIV pag. 847 e segg.

Sintesi della morale capitalistica: chi ha, è. Chi non ha, hai. Ma il bello
del capitalismo è proprio quando consente libertà avventurose, picaresche, da
gioco d'azzardo.
Le libertà della Fortuna.
Il barbone che diventa miliardario e il miliardario che diventa barbone.
Il palazzo dorato, che alla fine crollerà e la soffitta bohème.Il meglio del
capitalismo sono i suoi vizi.35
ed ancora:
Prolusione di Giuseppe Maranini all'Università di Firenze.
Mi insegna due cose. La prima è che non basta saper leggere, si rimane
analfabeti finché non si contrae il vizio di leggere.
La seconda, è che l'Italia si avvia ad essere non una democrazia, bensì
una partitocrazia.
Poscritto: Da lui sentii per la prima volta la parola 'partitocrazia', che
diverrà un luogo comune. Ora mi è chiaro che il seme della partitocrazia era
nella costituzione. La massa dei costituenti volle una 'democrazia dei partiti' ,
che implicava lottizzare le risorse e il potere politico. niente governabilità del
Paese senza coalizione di partiti cementate dall'antifascismo.
La Dc vinse le elezioni del 1948, non vinse la possibilità di governare da
sola, nemmeno per un po' di tempo. poche le scappatoie permesse dalla
costituzione: per esempio, il referendum popolare abrogativo, che infatti i
partiti odiano.36
Dunque non tutto è così perfetto come vorrebbero gli apologhi costituzionali; alcune
crepe nell’impianto generale della Carta sono emerse con il tempo, lasciando intravedere,
dietro una facciata dall’apparenza perfetta, una grande quantità di lati oscuri, impalcature
mal disposte, strutture portanti mal costruite.
Di fronte a simili obiezioni, di solito gli affezionati costituzionalisti ribattono con un
secco: “ La colpa non è della nostra Costituzione, ma dei nostri politici: la Carta è rimasta
per larga parte inattuata”.
35 ibidem pag. 21
36 ibidem pag. 23

Ma può dirsi valida una Carta Costituzionale che si presta e consente tali
inadempienze?
Soprattutto, è ancora valida una Costituzione che riporta, in maniera così vistosa, i
segni di una sedimentazione di concezioni illiberali dello stato, siano esse mutuate dalla
dottrina fascista, comunista o cattolica?
Una Costituzione che, oltretutto, vive di proprie contraddizioni, palesi
anacronismi, poco comprensibili distorsioni.
Ricordiamo che, a distanza di cinquant’anni, una Costituzione che afferma la
responsabilità soggettiva e non oggettiva in campo penale, lascia sopravvivere una
norma, la XIII disposizione transitoria e finale, la quale priva ab aeterno dei diritti civili
tutti i membri ed i discendenti di Casa Savoia37
.
Cosa sarebbe successo se, come rischiò di accadere, il referendum istituzionale
avesse avuto un esito favorevole alla Monarchia?
Cosa si direbbe di una norma che, al contrario dell’attuale, avesse previsto l’esilio
per i repubblicani proponenti il referendum e per i loro figli?
Sicuramente la Monarchia aveva grosse responsabilità nell’avventura fascista, prima,
e bellica successivamente; ma questo non giustificava l’esilio eterno per tutti i componenti
la famiglia reale, la loro incapacità elettorale, dato che tale sanzione poteva benissimo
colpire il Re direttamente coinvolto, ma non i suoi figli.
Almeno così vorrebbe la concezione laica, repubblicana dello Stato di diritto!
Ma ancora, mentre l’articolo 3 proclama l’uguaglianza di tutti i cittadini “senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali” e l’articolo 8, al primo comma, proclama che “tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, l’articolo 7 concede alla religione
cattolica uno status privilegiato.
Infatti, dopo un pleonastico riconoscimento del fatto che “lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, concede ai patti
37
Recita la XIII disposizione:
“i membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.

Lateranensi, firmati da Mussolini nel 1929, una valenza costituzionale, affermando che i
rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati da questi e che loro eventuali modifiche non
richiedono un procedimento di revisione costituzionale, purché siano accettate dalle due
parti.
Un modo per affermare che, di fatto, i rapporti fra Stato e Chiesa sono
costituzionalmente tutelati, dato che solo il reciproco accordo può evitare il ricorso alle
necessarie revisioni costituzionali.
Per rimediare, al secondo comma del sopracitato articolo 8, sottolinea il fatto che le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i loro
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.”
In definitiva, nella prospettiva di una società italiana improntata ad una sempre
maggiore apertura agli interscambi culturali, sociali ed umani, in rapporto ai sempre più
massicci flussi migratori, l’articolo 7 e lo stesso articolo 8 rappresentano due ostacoli
non indifferenti all’equilibrato sviluppo di una società multietnica, multiraziale e,
soprattutto, multireligiosa.
A riequilibrare tale scompenso, non valgono le previsioni dell’articolo 1938
, relativo
alla libertà di professione della fede e l’articolo 20, secondo il quale “Il carattere
ecclesiastico e il fine religioso o di culto d’una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”
Se, infatti, occorre tenere conto della tradizione culturale italiana che affonda le
proprie radici in quella cattolica, è necessario ricordare che non spetta allo Stato tutelare
questa, ma semplicemente far sì che essa, come altre tradizioni, possano armonicamente
convivere e prosperare.
Istituire meccanismi di regolamentazioni soggettivi, ad personam, in virtù dei quali lo
stato, attraverso patti o accordi, concede o nega privilegi o parificazioni, rappresenta la via
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali su beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. 38
Articolo 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” Resta fuori dalla previsione costituzionale la definizione di ciò che è buon costume, formula estremamente vaga e che potrebbe valere, ad esempio, per impedire battesimi pubblici di certe religioni di matrice gnostica, con immersione in acqua nudi o per altri riti. Come sempre, la nostra Costituzione si preoccupa di tutelare sempre un certo tipo di cultura ed un certo tipo di religione, pur dando l’impressione di essere libera e democratica.

principale per l’istituzione di uno stato potenzialmente confessionale o, altrettanto
potenzialmente, antireligioso.
Se non esistessero, nelle attuali articolazioni, né l’articolo 7 né l’articolo 8, ma in
aggiunta al primo comma dell’articolo 3 fosse stato aggiunto, semplicemente che “tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, il costituente avrebbe
compiuto un passo avanti non indifferente.
Essendo tutte uguali alla legge, non sarebbe stato necessario fare accordi
separati con ogni confessione religiosa, essendo sufficiente una regolamentazione
generale.
Così, ad esempio, nell’assegnazione dell’otto per mille, i cittadini non si
troverebbero più a dover operare una scelta limitata, ma potrebbero scegliere liberamente
la chiesa o il movimento religioso al quale far confluire questo finanziamento.
Ancora, la norma che regola la deducibilità fiscale per i contributi al sostentamento
del clero avrebbe automaticamente valore generale, per tutte le confessioni.
Né si porrebbe il problema dell’ora di religione, con le immancabili polemiche e
discriminazioni fra chi può restare in aula a seguire la lezione di religione cattolica e chi,
non essendo cattolico, si trova a doverla abbandonare senza poter seguire, ad esempio,
un’ora di religione buddista, mussulmana o induista.
Insomma, anche considerando l’aspetto delle libertà fondamentali del cittadino, fra le
quali la libertà di religione rappresenta una delle principali, la nostra Carta appare
lacunosa, insensibile, sostanzialmente e al di là delle proclamazioni, alla tutela delle
minoranze e, potenzialmente, foriera di notevoli conflitti di carattere religioso..
Infatti, rimandando alla legge ordinaria o ad un rapporto contrattualistico ad hoc fra
Stato e Confessioni, consente, potenzialmente, il sorgere di rapporti preferenziali a favore
di una di queste.
Il richiamo, generico, che fa l’articolo 19 al concetto di buon costume rappresenta
una potenziale mina vagante proprio per tutte le religioni, a partire, paradossalmente,
proprio da quella cattolica.
Teniamo conto del fatto che vi sarà un sempre maggiore afflusso di extracomunitari,
la maggior parte dei quali di religione mussulmana, che si troveranno appoggiati,
corteggiati e coccolati da coloro che, in base ad un puro calcolo di egoismo elettoralistico
ed utilitaristico nonché di miopia, vedono nel fondamentalismo islamico una barriera

contro il cosiddetto imperialismo occidentale e la cultura borghese, come fa tanta parte
dell’intellighentia di sinistra.
Questa situazione, progressivamente, anche in virtù di un andamento demografico
a forbice, con il calo delle nascite degli italiani del centro-nord ed una maggiore
prolificità degli extracomunitari, potrebbe portare l’Italia ad essere popolata da una
maggioranza di fede islamica.
Se così fosse, in virtù del generico richiamo al concetto di “buon costume”, quello
stesso che ha consentito a certi sindaci nostrani, in cerca di facile pubblicità estiva, di
inventarsi le cose più strane, come le ordinanze anti-brutte39
, se si addivenisse nella
convinzione che, per la maggioranza della popolazione, il fatto che le donne non indossino
lo Chador rappresenti un’offesa a questo buon costume, non si potrebbe giungere a
dichiarare fuori legge quelle religioni che non prevedano tale obbligo?
Se dovesse essere applicato questo principio in un contesto islamico, chi
garantirebbe i cattolici da eventuali sanzioni per il fatto, ad esempio, che durante il
rito della Santa Messa il sacerdote beve il vino, simbolo del sangue del Cristo, poiché
è noto che per i mussulmani tale assunzione rappresenta un divieto assoluto?
Tale assunzione non potrebbe, a ragione, essere giudicato contrario al buon costume?
Se riusciamo a guardare le cose da un punto di vista diverso, ponendoci dall’altra
parte, da quella che oggi è minoranza, ben possiamo comprendere il grande limite che si
nasconde in questi articoli costituzionali, i quali, quando vennero scritti, certo non si
potevano porre tali problematiche, dato che allora l’Italia era una nazione di emigranti e
non di emigrati e le grandi masse diseredate non bussavano certo alle nostre porte.
Ma oggi così è, ed è necessario riflettere e, per quanto possibile, prevenire.
39
Ricordiamo, solo per inciso, che alcuni comuni liguri hanno emanato ordinanze nelle quali si proibiva il passeggio in bikini alle donne “Brutte”, arrivando addirittura ad istituire una commissione per la definizione dei criteri di “Donna Bella”. Per non parlare dei blitz anti-topless e di altre amenità, fino ai divieti assurdi di fare castelli di sabbia in spiaggia, di sostare la notte in riva a l mare eccetera eccetera, tanto per dire che, se lasciamo i nostri legislatori liberi di legiferare, sono in grado di partorire qualsiasi amenità, più o meno dannosa.

Un Regime Oligarchico
Il principale difetto della nostra Carta Costituzionale, al di là di quanto sopra esposto,
è che essa risulta priva di ogni difesa contro eventuali usi distorti che possano essere
fatti dei suoi principi basilari.
La struttura dell’ordinamento costituzionale riflette la classica ripartizione fra
potere legislativo ed esecutivo.
L’art. 70 prescrive, infatti, che l’esercizio della funzione legislativa venga esercitata,
collettivamente, dalle due Camere.
Gli artt. 76 e 77 prescrivono i limiti della funzione legislativa delegata al governo.
Il primo, l’art. 76, chiarisce che il Governo può emanare leggi solo se il Parlamento
lo ha delegato “con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
delimitato e per oggetti definiti”
Il secondo, l’art.77, al secondo comma, prevede la possibilità, per il Governo, di
emanare decreti con valore di legge ordinaria, purché dettati da necessità ed urgenza e
vengano successivamente convertiti in legge dalla Camere entro sessanta giorni.
Questi articoli, inseriti nel contesto generale dell’ordinamento costituzionale, insieme
agli artt. 83-91 che definiscono i poteri del Presidente della Repubblica, chiariscono che la
Costituzione prevede per il Parlamento un ruolo centrale.
Ricordiamo solo l’art. 67, il quale recita testualmente:
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
A nessuno, quindi, può sfuggire l’alto ruolo che, ad ogni singolo componente delle
due Camere, la Costituzione assegna.
A fronte di tanta investitura di importanza e, quindi, di responsabilità, nessuna
norma della nostra Carta si preoccupa di chiarire lo status ed i criteri di selezione di
questi importanti soggetti istituzionali.
L’unico riferimento all’esistenza di forme organizzate per influire sulla scelta ed il
coordinamento dei membri delle assemblee parlamentari lo ritroviamo all’art. 49, il quale,
laconicamente, si limita a recitare:

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Il riferimento al metodo democratico sembra limitarsi al confronto elettorale ed al
criterio al quale deve ispirarsi la legge elettorale.
Nulla si prevede a proposito del metodo democratico che, al contrario, dovrebbe
regolare anche la vita di questi organismi così essenziali per l’equilibrio istituzionale.
Che l’osservazione non sia peregrina lo dimostra l’art. 39, il quale, al secondo e terzo
comma recita testualmente:
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
Al comma successivo, recita, in maniera ancora più esplicito:
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente, in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.
Quindi, quando la Costituzione vuole richiamarsi a criteri di democraticità interna di
associazioni che rivestano particolare importanza, lo esplicita chiaramente.
Il fatto che taccia, a proposito dell’organizzazione dei partiti, organismi ed
associazioni al quale viene affidato un compito non secondario, cioè la determinazione
della politica nazionale, lascia intendere che i costituenti si trovarono d’accordo nel
lasciare liberi questi organismi di gestirsi come meglio credevano.
Da qui le radici della partitocrazia, ovverosia di un sistema politico di fatto dominato
dalle segreterie dei partiti.
Una vera e propria oligarchia che vede arrivare al proprio vertice soggetti non
sempre e non chiaramente rappresentativi della volontà della totalità degli iscritti.
La nostra Costituzione, quindi, non detta regole per la democrazia interna dei Partiti
politici, neppure richiamandosi ad una affermazione di principio, come, invece, fa a
proposito dell’organizzazione sindacale.

Interessante, a questo punto, è riportare le argute riflessioni di Pietro Zullino40
sulla
molteplicità dei metodi elettorali, sulle loro conseguenze, nonché sulle controversie che
sorsero intorno al testo costituzionale
In una formulazione dell’articolo 49 precedente all’attuale - ricorda Zullino -, in una
proposta dalla Dc, tutte le parole erano uguali meno il verbo associarsi, al cui posto si
leggeva organizzarsi.
Di fronte al fuoco di sbarramento delle sinistre (che guidate dall'azionista
Calamandrei, non accettarono assolutamente organizzarsi e difesero con accanimento
associarsi) il giurista Mortati decise di proporre un testo capace di far emergere la
differenza e smascherare il pensiero recondito di chi si opponeva:
"tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al
metodo democratico nell'organizzazione interna e nell'azione diretta alla determinazione
della politica nazionale.41
"
Questa formulazione incontrò la strenua opposizione delle sinistre, dato che,
caratterizzate da partiti legati alla concezione del cosiddetto Centralismo democratico,
questi partiti compreso che nella frase di Mortati :"partiti che si uniformino al metodo
democratico nell'organizzazione interna" c’era una trappola.
In questa versione, infatti, si metteva in chiaro ciò che si intendeva con il già
aborrito verbo organizzarsi, con in più la possibilità che, un domani, qualche organismo
pubblico potesse avere titolo per intervenire nelle private e segrete faccende d'un partito,
magari con il pretesto di dover accertare se rispondente o meno al criterio "democratico".
I politici compresero immediatamente che qualche parola dall'apparenza innocente
può compromettere ogni loro possibilità di dominare in concreto la repubblica.
Sottoporsi a una inquisizione, ad un esame di democrazia interna? L'idea non
piacque, ovviamente, al PCI, in quegli anni fortissimamente legato all'imperialismo
sovietico.
Ma il bello è , come sottolinea Zullino, che per qualche altra e più misteriosa
ragione non piacque neppure ai democristiani.
Un giovanissimo Aldo Moro afferma che sarebbe sommamente pericoloso stabilire
norme o procedimenti volti ad accertare il carattere democratico o antidemocratico di un
partito: “Va escluso ogni controllo attorno ai programmi ed alle mire remote dei partiti,
perché ciò darebbe luogo a pericoli che vogliamo evitare42
."
Non va bene dunque Mortati e non va bene neppure organizzarsi, verbo pesante che
lascia supporre esistenza di regole cogenti atte a suscitare qualche indebita curiosità.
I cittadini non si organizzeranno in partiti, tutt'al più potranno associarsi, dando
luogo a club privati che fino a notitia criminis non dovranno rendere conto a nessuno.
Come disse Tristano Codignola del partito d'Azione:
40
Pietro Zullino "Forza, riscopriamo l'acqua calda" Il Carabiniere maggio 1995
41 ibidem
42 ibidem

"Se in sede costituzionale si dovesse entrare nel merito del problema, allora la
discussione dovrebbe essere molto più ampia: dovremmo stabilire i limiti di attività dei
partiti e i loro poteri, dovremmo porre la questione del riconoscimento della loro
personalità giuridica e tutta una serie di altre questioni... se questo non si fa, allora è
meglio astenersi..."
Nacquero in quei giorni le arroganze di varie obbedienza, i genitori del
consociativismo e la nonna di Tangentopoli.
Dal combinato disposto di due omissioni, l’una relativa all’affermazione di un
principio di democrazia interna dei partiti, l’altra alla definizione dello status del membro
parlamentare, con conseguente regolamentazione dei criteri di selezione e scelta dei
candidati, discende un controllo ferreo e soffocante delle segreterie dei partiti sull’attività
dei singoli parlamentari.
Il fatto che la scelta dei candidati da presentare nelle liste elettorali sia diventata
prerogativa delle segreterie dei partiti, rende subordinati, come vassalli, gli eletti alle
cariche parlamentari.
Solo coloro che obbediscono ai comandi delle segreterie possono sperare di avere la
possibilità di essere rieletti, perché saranno questi vertici oligarchici che decideranno se il
singolo deputato o senatore potranno essere inseriti di nuovo in lista.
Da qui discendono le forti influenze delle stesse correnti che, all’interno dei partiti, si
creano e proliferano.
Infatti, se da una parte vi è l’obbedienza come primo requisito del membro
parlamentare, dall’altra vi è la capacità del candidato di attirare voti.
Questa capacità, molte volte frutto di una gestione clientelare del collegio elettorale,
viene potenziata dalla coesione di alcuni personaggi, i quali, sfruttando la popolarità una
persona particolarmente nota, si alleano, dando vita ad una cordata che, sfruttando le
opportunità offerte dalla legge elettorale proporzionale, quando prevede la possibilità di
fare scelte di preferenza multiple, può consentire loro di essere eletti, anche se poco
conosciuti e, molte volte, ancor meno stimati.
La necessità di crearsi una certa autonomia, un proprio potere contrattuale nei
confronti delle segreterie, induce il membro del Parlamento a cercare di ottenere, nel
proprio collegio elettorale, quante più preferenze possibili, in modo da poterle “spendere”
nelle trattative per l’eventuale rielezione.
I Signori delle Preferenze si trovano, quindi, di fronte a due necessità, da una parte
quella di avere sufficienti fondi per poter organizzare adeguate campagne elettorali,

dall’altra creare una rete di collegamenti, all’interno del collegio, tale da consentir loro di
poter contare su persone inserite nella Pubblica Amministrazione per dispensare quei
favori essenziali per poter accontentare la propria clientela.
Queste due esigenze confluiscono, quindi, nell’organizzazione di una struttura che
possa garantire, al tempo stesso, un costante afflusso di denaro per l’organizzazione delle
campagne elettorali e la possibilità di gestione del Potere.
Un potere che consenta di assegnare appalti agli amici, collocare clientes all'interno
degli apparati pubblici, siano essi Comuni, Provincie, Regioni, USL e quant’altro la
fantasia dei politici possa creare, passando per fantomatiche ed inutili Comunità Montane,
Associazioni Intercomunali, Consorzi più o meno inefficienti e così via.
Unico limite l'illimitata capacità di indebitarsi, cosa nella quale, in definitiva, la
nostra classe politica ha eccelso.

Partitocrazia..........ma non solo
Abbiamo visto come, di fatto, la nostra Carta nulla abbia fatto per impedire che ,
progressivamente, l’organo istituzionale al quale doveva essere assegnato un ruolo
centrale, il Parlamento, si ritrovasse a svolgere un ruolo sempre più marginale, di notaio
certificatore di accordi che venivano presi altrove.
Le segreterie dei partiti hanno potuto assumere un ruolo debordante, al di fuori di
ogni previsione istituzionale.
Questi organismi privati, non vincolati ad alcun tipo di controllo istituzionale,
regolamentati da semplici statuti di carattere privatistico all’interno dei quali può essere
esclusa, di fatto, ogni autentica procedura democratica, si ritrovano ad avere il potere di
decidere i candidati da inserire o escludere.
In questo modo, di fatto, hanno svolto una funzione di surroga della stessa volontà
popolare, la quale è chiamata ad esprimersi solo sulla base di programmi generici, non
vincolanti, molte volte raffazzonati all’ultim’ora, perfino scopiazzati far le varie forze
politiche.
Il collante fra di queste aggregazioni posticcie e l’elettorato è stato, in genere, il voto
negativo, il voto “contro”.
D’altra parte, è molto più semplice ricorrere alla demolizione dell’avversario,
assurto al ruolo strategico di “nemico”, piuttosto che ricercare proposte in positivo, per
mettere i cittadini nella condizione di poter scegliere, senza terrorismi o ricatti.
Per anni l’elettorato ha votato per la Democrazia Cristiana, magari turandosi il naso,
non perché ne condividesse la politica, quanto, piuttosto, perché non condivideva i
programmi dei suoi avversari.
Libere da ogni sia pur minimo vincolo o controllo democratico, le segreterie dei
partiti hanno potuto organizzare un immenso network del potere, travalicando i limiti
costituzionalmente attribuiti, impossessandosi, de facto, della ricchezza nazionale.
Questa situazione di progressivo depauperamento della ricchezza democratica, oltre
a contribuire al rafforzamento dell’oligarchia dominante, ha consentito, grazie ad evidenti
lacune e crepe dell’impianto costituzionale, il degrado dei partiti stessi.

Da organi politici, si sono andati trasformando i macchine burocratiche e
burocratizzanti, tese ad un unico obiettivo: il controllo globale della società, soffocando
ogni minimo accenno di indipendenza e responsabilità individuale.
Arroccando la società in tante associazioni, alcune obbligatorie, si è indotto il
cittadino a pensare che egli, come singola entità, valesse solo come elettore semiattivo.
Si è dato potere alle corporazione, agli ordini professionali, limitando, di fatto, i
diritti costituzionalmente protetti, come quello del diritto di manifestazione del pensiero
sancito dall’art. 21, nel momento in cui si è creata la corporazione dell’Ordine dei Giornalisti.
Attraverso questa corporazione, si è, di fatto, introdotto un limite alla previsione
costituzionale.
A questo Ordine corporativo, infatti, si è delegato il potere di legittimare il singolo al
sacro livello di Giornalista, con la “G” maiuscola.
Solo chi viene assurto all’Olimpo dell’Ordine può fregiarsi del Titolo di Giornalista,
può scrivere, dunque, ma, ancora di più, può consentire che si scriva.
Infatti, chiunque voglia pubblicare un notiziario, un quotidiano, un periodico,
foss’anche parrocchiale, foss’anche per pochi numeri e pochi lettori, deve sottostare ad una
serie di regole che nulla hanno a che vedere con la democratica espressione del proprio
pensiero.
La regola delle regole è, comunque, che questo periodico possa essere pubblicato se
e solo se vi è un direttore responsabile accreditato dalla somma casta giornalistica.
Non contento di questo, insoddisfatto di aver irreggimentato avvocati, medici,
commercialisti ed ogni altro esercente un’arte liberale, sotto la falsa dichiarazione di una
tutela del consumatore, il legislatore partitocratico ha studiato come avviluppare nelle reti
del potere burocratico anche i commercianti.
Dal suo cilindro fantasioso, molto più di quello di un banale prestidigitatore, il nostro
legislatore si è inventato il REC, ovvero il registro degli Esercenti il commercio.
Un registro al quale è obbligatorio iscriversi, se si vuole poter aprire un negozio
qualsiasi per la vendita al dettaglio, dalla carne ai cosmetici.
Poco male se fosse una semplice duplicazione dell’obbligo imposto dalla Camera di
Commercio, la cosa peggiore è che, per potervi essere iscritti, i cittadini devono sottostare

ad un esame, nel corso del quale, in teoria e forse anche in pratica, all’aspirante esercente
vengono poste domande su tutto lo scibile umano, a carattere commerciale.
Si spazia dalle domande di merceologia a quelle di carattere fiscale, dirette ed
indirette, contabilità.... insomma, si richiede che, quanto meno, alla fine dell’esame, il
verduraio possa competere con il commercialista!
In realtà, se tutti sanno che ben difficilmente un professionista riesce a sapere tutto
della intricata giungla fiscale italiana, altrettanto sanno che un esercente non potrà che
affidarsi ad un terzo per tutto ciò che concerne le normative fiscali, del lavoro,
burocratiche e quant’altro.
Allora, a cosa serve il REC? A tutelare il consumatore da venditori non adeguati o
disonesti? Non è certo un esame che può certificare la qualità del servizio offerto dal futuro
esercente!
Così come non sono gli Ordini professionali che possono garantire la deontologia
professionale di molti loro iscritti, vincolati come sono da logiche di comparaggio,
inevitabili ed umanamente comprensibili, ma giuridicamente inaccettabili.
In realtà la funzione del REC, dei corsi preparatori organizzati dalle varie
associazioni di categoria, è quella di consentire a queste stesse associazioni di controllare e
gestire, fin dall’inizio, il commerciante.
Ogni Ordine Professionale, ogni pubblico registro, come il REC, ogni altra
associazione più o meno pubblica, più o meno volontaria, rappresentavano e rappresentano
un feudo, con tanto di contese per il possesso, suddivisione di territorio, di competenze di
clientes.
Sottostante a questa congerie di categorie e di corporazioni, di controlli che non
controllano ma riescono ad essere funzionali ad un sistema di irretimento dell’individuo, vi è la concezione del cittadino-suddito, imbelle e , potenzialmente, incapace di intendere,
quindi da sottoporre a rigida tutela statale e sociale.
Così, il suddito non è libero di fare lo zapping, se vuole, per evitare spot pubblicitari,
ma occorre che la legge gli dica come, quando, perché e dove prendersi la sua razione
giornaliera di spot, né lo si ritiene sufficientemente preparato per decidere se ascoltare o
meno il politico che più gli aggrada e così via proibendo.

Il totalitarismo, in fondo, si presenta sempre sotto maschere , metodi e meccanismi
differenti, ma il risultato rimane sempre uno ed uno solo: la limitazione della legittima libertà dell’individuo!
In fondo, la stessa introduzione, nell’ambiente scolastico, dei cosiddetti Organi
Collegiali ha rappresentato, a dispetto e al di là delle pretese affermazioni di democrazia,
un ulteriore passo avanti verso una vera e propria sovietizzazione corporativistica della
società italiana.
Questi Organi Collegiali vennero introdotti nel 197443
, al culmine del periodo della
contestazione scolastica, che contribuirono, in maniera determinante, a ricondurre
nell’alveo di una pseudo democrazia rappresentativa, frustrandone aspirazioni e principi,
fingendo di rispettarli, tanto che, a partire da quella data, in concomitanza con
l’inasprimento della lotta armata portata avanti dalle Brigate Rosse e da altre associazioni
minori, iniziò quella fase che venne battezzata come “Il Riflusso”.
In realtà, attraverso il meccanismo perverso imposto attraverso questi decreti, si è
ottenuto un duplice risultato.
Da una parte si è imposto agli studenti di accettare una logica di parlamentini sterili e
sostanzialmente inutili, dove può essere esercitata una notevole intimidazione grazie alla
presenza dei rappresentanti dei genitori.
Dall’altra si è riusciti, in dispregio all’articolo 3344
, a vincolare gli insegnanti,
limitandone, di fatto, la libertà.
Infatti, nessun insegnante è libero di decidere, autonomamente e liberamente, le
proprie linee di condotta, sia in materia di insegnamento che di punizione o premio degli
studenti.
Le bocciature e le promozioni vengono deliberate dal collegio dei docenti, a
maggioranza; gli stessi genitori potrebbero, più teoricamente che praticamente,
determinare le linee d’insegnamento, approvando o censurando un insegnante.
43 Il 30 giugno del 1973 il parlamento concesse la delega la Governo per l’emanazione di decreti legge per regolamentare i rapporti fra scuola e società.
Questi decreti videro la luce il 31 maggio del 1974 (nn. 416-420).
Prevedevano la costituzione di organi collegiali a livello di circolo e d’istituto, distrettuale, provinciale e nazionale finalizzati a realizzare la partecipazione, nella gestione della scuola, di genitori e studenti, pur nel rispetto degli ordinamenti statali e delle competenze del personale docente, ispettivo e direttivo.
44 Il primo comma dell’articolo 33 recita, testualmente, che “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

Insomma, un sistema dove persone incompetenti, per il solo fatto di svolgere il ruolo
di genitore momentaneamente interessato all’andamento scolastico, si possono trovare a
giudicare e dirigere chi, al contrario, alla scuola si dedica per scelta e con grande
professionalità.
Cosa che ha, gradualmente, portato ad una grave crisi d’identità del corpo insegnante,
frustrato nelle proprie aspettative economiche, svilito nel proprio rango professionale e di
status, delegittimato di fronte agli studenti, i quali, ormai, sanno che basta piangere sulla
spalla compiacente di mamma e babbo perché l’insegnante “cattivo” venga ghettizzato ed
emarginato.
Così, progressivamente, si è socializzata la scuola, si sono creati tanti piccoli soviet
fatti da studenti, genitori ed insegnanti, dove conta la maggioranza e non la professionalità,
fino a poter calpestare l’individualità prima e la cultura dopo.
Anche questo, in fondo, è autoritarismo, populismo, decadenza!

Sindacatocrazia e dintorni
Alla burocrazia partitica ed alla oligarchia costituita dai segretari di partito, si è poi
aggiunta un'altra grande forza oligarchica, quella sindacale.
Progressivamente, stravolgendo ed impedendo, di fatto, l’attuazione dell’art. 39, i
principali sindacati, patrocinati dai partiti al potere, hanno finito per svolgere, sempre più,
un ruolo politico più che di tutela dell’interesse contrattuale dei lavoratori.
Pur senza aver rispettato le previsioni costituzionali, non essendo mai stati istituiti i
previsti registri, mentre si moltiplicavano gli adempimenti ai quali erano e sono tenuti i
comuni cittadini, imprenditori e non, neppure nella parte in cui viene stabilita la
rappresentanza in proporzione al numero degli iscritti, i grandi sindacati confederali, oltre
a stipulare contratti collettivi di lavoro, hanno trattato con i governi per l’emanazione di
decreti e di norme sia in campo normativo ma, ancor di più, finanziario e previdenziale.
In base ad un distorto concetto di rappresentatività dei lavoratori - tutto da
dimostrare perché, non essendo organi rappresentativi, possono rappresentare solo i
propri iscritti e non la totalità dei lavoratori - , i sindacati confederali hanno, di fatto,
gestito l’INPS ed imposto propri rappresentati nelle aziende pubbliche e private, attraverso
il meccanismo delle RSA, metodo sancito dallo Statuto dei Lavoratori, in base al quale non
sono i lavoratori delle aziende, attraverso il meccanismo elettorale, a scegliere i propri
rappresentanti, ma le segreterie dei sindacati stessi ad imporre, di fatto, la propria volontà.
Né, sostanzialmente, ha innovato la nuova disciplina delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU), dato che, pur avendo fatto un passo avanti consentendo anche la
presentazione di liste non sindacali, continua a prevedere una riserva di un terzo a favore
dei sindacati “maggiormente rappresentativi”
La rete del cosiddetto collateralismo si è andata sempre più allargando,
aggiungendosi alla struttura sindacale quella di una serie di circuiti culturali e non che,
usufruendo di particolari agevolazioni normative, anche di carattere fiscale, hanno
cementato un accordo fra i grandi padrini, le burocrazie partitiche , di queste associazioni.
Così abbiamo il circuito dei circoli ARCI, ACLI, MCL, che godono di una totale
esenzione fiscale, le cooperative, bianche e rosse, che, pur essendo dei colossi economici,
tendono ad utilizzare una normativa fiscale , basata sull’art. 45 della Costituzione, nata per

favorire l’iniziativa di chi volesse intraprendere una piccola attività sotto questa particolare
forma di società.
Un reticolo, quello del collateralismo e delle clientele, che non presenta grosse
smagliature e che si salda con l’esigenza e la giusta volontà di molti di operare a favore
degli altri attraverso strutture di volontariato.
In 45 anni di blocco di potere, di oligarchia stagnante, ogni associazione è stata vista
come punto di incontro e di sviluppo dell’interesse partitico, sindacale, burocratico.
Le agevolazioni fiscali di cui godono le associazioni ed i circoli culturali legati ai
partiti, nonché le cooperative, rappresentano, peraltro, una grave stortura del sistema
economico italiano.
Infatti, senza tener in alcuna considerazione l’articolo 5345
, ai circoli legati ai partiti
viene concessa, come detto, una esenzione fiscale totale, mentre alle cooperative vengono
concessi sconti fiscali di notevole impatto46
.
Operando in queste condizioni di oggettivo privilegio, circoli e cooperative si
trovano in una situazione di oggettiva concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori
economici.
Infatti, quest’ultimi, si trovano gravati da notevoli oneri fiscali e parafiscali, da
norme sulla tenuta della contabilità, sul rispetto di termini ed adempimenti sempre più
gravosi, mentre i loro concorrenti godono di uno status di privilegiati.
Così, al danno, molti devono aggiungere la beffa; infatti, le cooperative, specie di
distribuzione, possono assommare un duplice vantaggio, quello derivante dall’economie di
scala sugli acquisti e quello di una minore incidenza tributaria47
, potendo vendere, quindi, a
prezzi minori dei concorrenti, godendo di un sicuro utile e qualificando i concorrenti come
45 articolo 53: “ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”
46 Varie sono le agevolazioni di cui godono le cooperative, senza limite né di dipendenti né di fatturarlo. Così, le norme valgono per il colosso CMC come per la piccola cooperative di pulizie condominiali! Così, non concorre alla base imponibile quanto accantonato a titolo di riserva indivisibile.
Vi è una esenzione totale da IRPEG e ILOR per tutte le cooperative nelle quali l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci rappresentano almeno il 60% del totale delle spese, mentre tali imposte sono ridotte al 50% se l’ammontare di quanto corrisposto ai soci a titolo di retribuzione è inferiore al 60% ma superiore al 40% del totale delle spese.
47 Per non parlare dei vantaggi finanziari, dato che alle cooperative è concesso remunerare i prestiti dei propri soci godendo di una ritenuta fiscale secca che, fino all’ottobre del 1994, era del 12,5%, mentre sia i depositi bancari che le obbligazioni societarie scontavano il 30%.
Da tale data anche le ritenute per i crediti presso Cooperative sono state equiparate a tale importo.
Così queste società possono pagare i propri debiti finanziari a percentuali sicuramente più basse di quanto devono fare, in analoghe situazioni, i commercianti o, comunque, gli imprenditori concorrenti che devono rivolgersi alle strutture finanziarie bancarie.

disonesti profittatori, dato che praticano prezzi mediamente superiori... e si lamentano
anche!
Così è la struttura fiscale in Italia; oltre che oppressiva ed esosa, è anche ingiusta ed
eticamente selettiva, dato che definisce, in base a criteri morali, chi è meritevole di
sostegno ed appoggio e chi non lo è.
Ma la sindacatocrazia è qualche cosa di ancora più pericoloso.
Intanto vi è una situazione di palese inosservanza della norma Costituzionale.
Come ha argutamente sottolineato Marco Ventura dalle colonne de Il Giornale,
proprio per il mancato rispetto di questa esplicita prescrizione costituzionale i sindacati "si
trovano ... fuori dalla Costituzione, perché gli articoli che li riguardano, il 39 ed il 40, non
sono mai stati applicati.48
"
Quali sono i privilegi di cui godono, in contrasto con la previsione costituzionale, le
confederazioni sindacali?
Intanto di carattere amministrativo, dato che non vige alcun obbligo, pur in
presenza di entrate per circa 1.700 miliardi, di redigere rendiconti e bilanci49
.
Poi, cosa ancor più grave, ma strettamente connessa alla prima, non esiste alcuna
verifica della democrazia interna, nonostante la precisa previsione Costituzionale di cui
abbiamo parlato.
Marco Papaleoni, titolare di Diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa sostiene che i Sindacati " in quanto associazioni non riconosciute ... non sono tenuti a rendere pubblici i bilanci, né ad avere i libri contabili o a presentare
denunce dei redditi particolari."
La Costituzione è rimasta lettera morta, dato che le Confederazioni non si sono mai
sottoposti a registrazione, quindi non sono entrati in possesso, come previsto dal dettato
della nostra carta, di personalità giuridica.
Oltre all'aspetto economico, come sopra detto, vi è il grave problema
dell’ordinamento democratico interno.
Prosegue, infatti, Ventura: “..chi ne stabilisce la democraticità? Nessuno! Quindi
nessun controllo esterno, e in teoria nessuna certezza di garanzie interne. Anche il
patrimonio, formalmente, appartiene agli iscritti, ma a risponderne illimitatamente è il
Presidente.50
"
Di fatto, questa situazione comporta che non vi sia nessuna garanzia per l'iscritto
dissidente, "..nel sindacato vige l’ unanimismo: i contrasti vengono gelosamente
Lo spreed di tasso fra un ipotetico 9% a carico delle Cooperative e il 15% dei concorrenti non è certo cosa da poco! 48
MARCO VENTURA “DIFFICILE INTERVENIRE SUI PRIVILEGI DELLE CONFEDERAZIONI” in IL GIORNALE 30/10/95 n. 43 49
ibidem
50 ibidem

conservati all'interno.....Tutto il contrario -prosegue Papaleoni - degli ordinamenti
stranieri, nei quali è tipico il caso del socio sindacale espulso"
Aspetto di non poco conto, poi, anche alla luce dei risultati referendari dell'11
giugno del 1995, è quello legato al concetto di rappresentatività.
La previsione costituzionale, in maniera chiara, prevede che i sindacati,
regolarmente registrati, possano stipulare contratti collettivi di lavoro " con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce" alla
precisa condizione, però, che essi siano "rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti".
Tutt'altra è la prassi istituzionale praticata dalla data di approvazione della carta ad oggi.
Papaleoni sottolinea che al concetto di unitarietà si è sostituito "..quello di maggiore
rappresentatività, definita non tanto in base al numero degli iscritti, quanto in base
all'attività negoziale ed alla storia sindacale maturata nel movimento partigiano.
Di qui la tutela privilegiata delle tre confederazioni CGIL, CISL, UIL." Privilegio
che è stato determinante al momento dell'assegnazione ai sindacati dell'eredità
patrimoniale delle confederazioni corporative fasciste, dato che alla Trimurti
"democratica spettò il 97 per cento di tale patrimonio.
In base a questo principio, poi, la CGIL è potuta entrare in gioco anche per quanto
riguarda la contrattazione nel settore del pubblico impiego, dove sicuramente più
importanti e determinanti sono i cosiddetti sindacati autonomi.
I sindacati, dunque, come detto incamerano, grazie al meccanismo delle trattenute
sindacali, circa 1.700 miliardi.
Ma questo non è l'unico meccanismo attraverso il quale le confederazioni ottengono
finanziamenti.
A questi, infatti, occorre aggiungere centinaia di miliardi che, seppur in maniera
"virtuale", come sottolineare ancora Ventura51
, affluiscono sotto forma di stipendi pagati
da enti pubblici a favore di impiegati in aspettativa o in permesso i quali, anziché prestare
la propria opera presso l'ente d'origine, sono inseriti in pianta stabile nell'organizzazione
sindacale.
Solo nel 1994, a seguito dei provvedimenti adottati da Urbani, ministro del
Governo Berlusconi, ci si è decisi a guardare anche a questo spreco di denaro pubblico.
Le nuove norme introdotte dal ministro Urbani avrebbero dovuto comportare un
risparmio, per l'Erario, di circa 100 miliardi l'anno, riducendo della metà aspettative e
permessi.
Però, anziché entrare in vigore, come previsto, alla fine del 1994, è stata prorogata
di sei mesi, all'insaputa di tutti.
Il ministro Frattini, successore di Urbani, ministro del Governo Dini, ha reso noti i
risultati della Relazione sullo stato della Pubblica Amministrazione voluta dal suo
predecessore.
51
MARCO VENTURA “BUTTATI 1.200 MILIARDI PER I SINDACATI “ in IL GIORNALE del 30/10/95 n. 43

Da questa Relazione risulta che nel triennio 1992-1994 lo Stato "ha regalato ai
sindacati la bellezza di 1.200 miliardi di lire in distacchi e permessi retribuiti".
Secondo la relazione, nel corso del 1994 ben 3.996 dipendenti pubblici hanno
usufruito dell'aspettativa annuale, lavorando per il sindacato un totale di 819.643 giornate.
"Se si aggiungono - sottolinea Ventura - i 93.524 dipendenti che hanno usufruito di
permessi sindacali ... coloro che in parte o per tutto l'anno si sono spesi per il sindacato
invece di stare allo sportello delle Poste o dei ministeri, o nella miriade di enti, sfiorano i
100 mila su poco più di 3 milioni, equivalenti a 7.481 anni/uomo, gentilmente concessi da
Pantalone"
Indubbio il vantaggio del sindacato, che ammonta, nel solo 1994, a circa 416
miliardi di lire.
Da sottolineare il fatto, poi, che le cifre sono comunque errate per difetto, dato che
molte amministrazioni non hanno ottemperato all'obbligo di fornire i dati.
Ma anche questo non basta ad evidenziare in tutta la sua gravità la commistione
sindacato-potere politico; sicuramente la parte da leone il sindacato la recita nella gestione
degli enti assistenziali e previdenziali.
Non solo grazie alla gestione diretta dell’INPS, che ha visto succedersi ai propri
massimi vertici esponenti sindacali, basti ricordare Militello e Colombo, o in virtù della
gestione dei Patronati, altra fonte di introito per i sindacati e spreco per lo stato.
Ma anche usufruendo, insieme a molti appartenenti all’oligarchia partitocratica, di
privilegi negati alla maggioranza dei cittadini, ancora più gravi nel momento in cui proprio
sulla previdenza si addensano le maggiori preoccupazioni di tanti lavoratori; proprio di
quei lavoratori che, teoricamente, i sindacati sarebbero chiamati a tutelare.
Una delle tante leggine, la numero 252 del 1974, emanata in piena solidarietà
nazionale, consente "a uomini dei partiti e dei sindacati condizioni di favore non concesse
agli altri lavoratori".52
Privilegi che vanno a gravare, come detto, sui già disastrati conti dell'INPS.
Socci sottolinea come il fenomeno risulti illuminante dell'esistenza di una volontà
trasversale di soddisfazione delle proprie clientele e delle esigenze di sistemazione dei
propri uomini da parte di tutti i partiti politici e dei sindacati, a dimostrazione che "nel
partito unico della spesa pubblica stavano a pieno titolo anche i sindacati ed i partiti di
opposizione53
".
E' grazie a questa banda del buco - come la definisce Socci - che, progressivamente,
si è arrivati ad accumulare 2 milioni di miliardi di debito!
Sicuramente la 252 rappresenta solo uno dei tanti episodi che, legalmente, hanno
contributo a far crescere questo buco, a poco rilevando che, fra quanti abbiano usufruito di
questi vantaggi, qualcuno abbia fatto ricorso a stratagemmi e falsità.
52
ANTONIO SOCCI “NELLA LEGGE IL "MARCIO DEI 40MILA" in IL GIORNALE del 30/10/95 n.43
53 ibidem

"Ce ne sono molti altri - prosegue Socci -. Tutti hanno fatto del loro peggio, come
si è visto anche per la gestione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici"54
.
Che la cosa non sia di poco conto e che questo non rappresenti una semplice ubbia
di Feltri e dei suoi redattori lo dimostrano i conti, dato che lo Stato, a fronte di un
patrimonio immobiliare stimato in circa 1 milione di miliardi (valori del 1991), riesce a
ricavare solo 150 miliardi l'anno.
La legge 252 , scrive Feltri, "doveva servire ad un numero ristretto di persone che,
avendo lavorato come abusivi alle dipendenze di partiti, sindacati e cooperative,
desideravano mettersi in regola con i contributi previdenziali ed avere dunque i requisiti
per riscuotere, a suo tempo, la pensione"55
Oltre agli aventi diritto, però, come testimonia l'indagine intrapresa da un
magistrato di Grosseto, Pietro Federico, vi è il fondato sospetto che abbiano approfittato di
questa legge molte persone.
Queste , contando su complicità di partiti, sindacati e cooperative, "hanno
presentato agli sportelli INPS false dichiarazioni attestanti che avevano prestato la loro
opera in qualità di dipendenti....in concreto, pagando poche lire, hanno riscattato anni e
danni di lavoro mai prestato, garantendosi un vitalizio che non spetta loro."56
Anche questo raggiro, ovviamente, comporta, per l'INPS, migliaia di miliardi di
perdita.
I Sindacati, dunque, appaiono, sempre più, come soggetti politici, anziché semplici
organizzazioni preposte a regolamentare il rapporto economico e giuridico fra dipendenti e
datore di lavoro.
Proprio la parziale rinuncia a svolgere, sotto certi aspetti, questo ruolo,
privilegiando l’aspetto politico, ha fatto si che, negli ultimi anni, sorgessero nuove istanza
sindacali canalizzate da Comitati di Base o, nel settore pubblico, dai cosiddetti sindacati
autonomi.
Queste ultime istanze sindacali si sono proposte, come unico fine, la discussione
degli aspetti normativi ed economici dei contratti di lavoro, avanzando richieste
sicuramente più radicali di quelle sostenute dai sindacati confederali.
Questo fatto ha comportato che, da parte delle Confederazioni, si sottolineasse il
pericolo rappresentato dal sorgere di un sindacalismo meno “politico” e più economico,
meno sensibile, in una parola, alla responsabilità che deriverebbe dalla cogestione del
potere politico.
In realtà, se da una parte il radicalismo rivendicazionista dei sindacati autonomi e
dei comitati di base può rappresentare un rischio per le relazioni industriali, d’altra parte
54 ibidem. Socci si riferisce alla campagna condotta da Il Giornale e, soprattutto, dal suo direttore, Vittorio Feltri, per denunciare uno scandalo tutto italiano, partitocratico e sindacatocratico.
La consolidata prassi adottata dalla maggior parte degli enti pubblici, previdenziali e non, di concedere in affitto a molti uomini dell’oligarchia, sia appartenenti a partiti politici che ai sindacati, appartamenti a prezzi molto inferiori a quelli di mercato.
Sicuramente in linea con quanto previsto dalla legge sul cosiddetto equo canone, ma certo non congrui con le entrate di cui questi personaggi possono godere, né con le finalità sociali per le quali questi appartamenti, con questi canoni, sono stati acquistati o costruiti! 55
VITTORIO FELTRI “SOLITI SCROCCONI E SOLITI COMPLICI” in IL GIORNALE del 14/10/95 n. 242
56 ibidem

non si può nascondere che , ancor più grave, appare il rischio istituzionale rappresentato da
un soggetto giuridico abnorme, come quello sindacale, chiamato a cogestire indirizzi
politici e sociali generali che esulano totalmente dalla sua capacità e, soprattutto, dalla sua
sfera di rappresentatività.
Forse, se i sindacati si fossero meno occupati della gestione di parti importanti dello
Stato, partecipando, a pieno titolo, ad importanti Consigli di Amministrazione di Enti
pubblici, a partire dall’INPS e lo Stato avesse gestito in maniera più oculata il patrimonio
sociale, oggi il costo del lavoro indiretto, rappresentato da carico contributivo ed oneri
fiscali, potrebbe essere più basso, con maggiore soddisfazione sia per gli imprenditori che
per i lavoratori.
Insomma, il panorama sindacale in Italia si presenta estremamente confuso,
disegnandosi una situazione nella quale, ormai, appare difficile comprendere quali siano
gli atti legali e quelli illegali, quale confini separino la prassi semplicemente
ultracostituzionale da una puramente e semplicemente contra legem.
Ma, cosa ancora più grave, dopo cinquant’anni, siamo ancora a chiederci quale sia
la vera Costituzione che regola i nostri rapporti istituzionali.

Le due Costituzioni
Da quanto sin qui detto, emerge chiaramente quella realtà che, alcuni
costituzionalisti, hanno più volte sottolineato, ovverosia la contemporanea esistenza di due
Costituzioni, una formale, quella approvata nel 1947, l’altra materiale, derivante da
progressivi atti concreti di potere che, di fatto, hanno sostituito una struttura ordinamentale
formale e democraticamente promulgata, con un’altra.
Molti sono gli atti concreti che dimostrano l’esistenza di questa Costituzione occulta,
che dalla prima costituzione ha tratto forza e vigore.
Certo non fa parte della struttura dell’ordinamento istituzionale della nostra
costituzione l’impianto oligarchico che si è instaurato, alle spalle ed a dispetto dei cittadini
italiani.
Progressivamente, la nostra repubblica parlamentare si è trasformata in un qualche
cosa di non ben definibile.
Il Parlamento è risultato sempre più incapace ed impossibilitato, per i veti incrociati e
le politiche partitiche imposte dalle segreterie dei partiti, a legiferare con serenità e
consapevolezza.
Troppe volte si è trasformato in funzione notarile quella che è la funzione legislativa.
La consuetudine dei cosiddetti “vertici di maggioranza”, ovverosia l’incontro dei
vertici delle oligarchie politiche che si trovavano, quasi casualmente, a sostenere i vari
governi di questa nostra repubblica, ha contribuito non poco allo svilimento del
Parlamento.
L’inefficienza del Parlamento nell’assolvere alla funzione legislativa, abbinata ad
una volontà di regolamentazione ossessiva ed ossessionante che, in cinquant’anni di
pseudodemocrazia, ha prodotto ben duecentocinquantamila leggi, oltre ad un numero non
ben definito di regolamenti, ha finito per contribuire ad una sempre maggiore ingerenza
della funzione propria del governo in quella legislativa.

Tutto questo proliferare contribuisce a qualificare lo Stato italiano come uno stato
arcaico, se solo ricordiamo ciò che scriveva Knut Wicksell57
in un saggio del 189658
, a
proposito dei compiti e delle finalità del Parlamento in un moderno sistema democratico:
“La regolazione pedante, la fastidiosa intromissione in tutti i rapporti
della vita privata sono per lo più scomparse o sussistono ancora solo come
ricordi, come resti morenti di epoche passate59
”
A rendere ancora più arcaica la struttura legislativa del sistema pseudodemocratico
italiano concorre il fatto che, come sottolineato, non è tanto il Parlamento che va
legiferando, bensì il governo, titolare della funzione esecutiva e non legislativa.
Di fatto, grazie alla prassi, non costituzionalmente prevista, dei vertici dei segretari
dei partiti di maggioranza, il governo si è trovato legittimato ad emanare un numero
notevole di decreti legge, ben al di là delle previsioni costituzionali.
Però, dato il ferreo controllo esercitato sui parlamentari dalle oligarchie partitiche
che avevano, direttamente o indirettamente autorizzato il governo ad emettere questi
decreti, raramente si sono negati i caratteri di costituzionalità di questi.
Anche quando, poi, si è provveduto, seppur in ritardo, a dare attuazione alle norme
costituzionali se ne è verificata l’inefficacia e la inadeguatezza.
Basti, per esempio, pensare all’iter che ha portato alla istituzione delle Regioni,
previste dal titolo V, dall’articolo 114 al 133, con l’approvazione della legge del 16
maggio del 1970, la numero 281.
L’istituzione delle Regioni, ben lungi dal creare quello snellimento burocratico nel
quale credevano gli assertori del regionalismo, ha finito per riprodurre, a livello locale, i
vizi propri del governo centrale.
Al di là di questo, con il definitivo affermarsi, in occasione della trattativa Governo-
Sindacati per la riforma delle pensioni, della prassi neocorporativa, si è raggiunto il livello
più alto di stravolgimento dell’impianto costituzionale.
57 Knut Wicksell, nato a Stoccolma nel 1851, morto nel 1926, fu un importante economista monetarista e teorico della scuola marginalista.
58 K.Wicksell “Ein neues Prinzip der gerechten Besteuerung” in Finanztheoretische Untersuchungen,
G.Fischer Jena 1896
59 Knut Wicksell “Intorno a un nuovo principio di giusta tassazione” in “Teorie della Finanza Pubblica”.a cura di Franco Volpi, Franco Angeli Editore, Milano 1975, pagg. 134 e seg.

Anziché seguire la strada maestra che la Costituzione formale indicava, si è preferito
seguire , ancora una volta, la strada indicata dalla prassi propria della costituzione
materiale, quella, appunto, di una trattativa privata fra governo e sindacati.
Una prassi costituzionalmente corretta avrebbe richiesto un dibattito parlamentare sul
tema della riforma delle pensioni, il confronto parlamentare su eventuali disegni di legge di
riforma alternativi, la stesura e l’approvazione di una legge che definisse i principi
ispiratori della riforma stessa, la definizione dei limiti minimi e massimi per la pensione
d’anzianità, i rendimenti, la struttura dei fondi pensione.
All’interno di questo dibattito, coloro che rappresentano non una parte, ma la totalità
della Nazione, ovverosia i deputati ed i senatori, avrebbero dovuto tenere conto delle
legittime aspettative dei lavoratori dipendenti, contemperandole con le necessità dello Stato, dell’andamento demografico, delle aumentate aspettative di vita nonché della
necessità di restituire libertà di scelta ad ogni cittadino, compreso i dipendenti pubblici e
privati.
Il dibattito sulle pensioni non poteva che incidere sulla struttura del deficit dello
Stato, del quale la voce previdenziale rappresenta una parte considerevole.
Né poteva non incidere sulle prerogative dell’individuo, dato che si sarebbero dovute
confrontare le posizioni di chi chiede, fermo restando una garanzia minima dello Stato, una
libertà di scelta fra varie opzioni per ogni dipendente, con quelle di chi sostiene la
centralità dell’ente pubblico.
Definito l’ambito di queste importanti questioni, la legge che il Parlamento avrebbe
dovuto approvare poteva contenere, ai sensi del sopracitato art. 76, deleghe al governo per
la definizione di alcuni aspetti tecnici, anche di impatto quantitativo.
Nell’ambito dell’esercizio di questo potere di delega, il Governo ben avrebbe potuto
consultare le parti sociali, gli esperti del settore assicurativo e previdenziale i vertici dell' INPS e quant’altri avesse ritenuto utile consultare per definire i termini di una materia
sicuramente non facile.
Al contrario, anziché seguire questa strada, lineare e costituzionalmente corretta, si è
preferito seguire quella di una prassi costantemente extracostituzionale, accentuata da ben
altre considerazioni, relative alla particolare composizione dell’esecutivo che ha condotto
la trattativa.

Occorre premettere che la nostra Carta nulla prevede circa la composizione degli organi
governativi, per i criteri di nomina e di rapporto intercorrente fra governo e parlamento,
eccezion fatta per la necessità del voto di fiducia, e che, sempre la nostra Carta , poco dispone
circa i poteri del capo dello Stato, specie in tema di nomina del Governo.
La prassi propria della Costituzione materiale, consolidatasi nel cinquantennio, ha
provveduto a metterci, per così dire, una pezza.
Così, dato che il potere legislativo, esecutivo ed amministrativo si è sempre più
configurato come proprietà delle oligarchie costituite dai vertici dei partiti, la prassi
costituzionale è diventata quella che prevede, di fatto, la designazione del Capo del
Governo e dei suoi ministri direttamente da parte dei segretari dei partiti, tenuto conto
degli equilibri interni sia delle coalizioni sia degli stessi partiti.
In parole povere, la vera costituzione è diventata, con il passar del tempo, il manuale
Cencelli!
Ma, ancora una volta, nel periodo che va dal marzo del 1994 alla fine del 1995, si è
andati ancora oltre, senza che nessun meccanismo istituzionale si attivasse per verificare la
costituzionalità o meno di quanto istituzionalmente si stava verificando.
Venuti a mancare, a causa del fenomeno di tangentopoli e delle elezioni a carattere
maggioritario del 27 marzo del 1994, molti punti di riferimento del regime partitocratico, il
Presidente della Repubblica, usando il proprio potere di nomina previsto dal secondo
comma dell’art. 92, ha chiamato a presiedere il governo un tecnico, il quale ha scelto - non
si sa quanto liberamente o meno - una serie di ministri cosiddetti tecnici, ovverosia non
parlamentari.
Formalmente la prassi può apparire corretta, così come può apparire tale che il
Governo si presenti alle camere senza contare su di una maggioranza certa.
Quando si dice formalmente, si fa riferimento alla Costituzione Italiana scritta, dato
che, questa, nulla di più dice circa i metodi di scelta del capo del Governo né sui rapporti
che devono intercorrere fra Parlamento, Governo, Partiti politici.
Sostanzialmente, ovvero facendo riferimento alla Costituzione materiale, quella che
veramente regola la nostra vita politica e sociale, è indubbio che la nomina di un governo
che, aprioristicamente, esclude ogni rappresentante della massima ed unica autorità
legislativa democraticamente eletta, perlopiù sotto forte tutela del capo dello Stato, anziché
del Parlamento, evidenzia non pochi problemi di carattere istituzionale.

Questa lunga premessa è stata necessaria per due motivi.
Il primo è che appare evidente l’incompletezza del dettato costituzionale a proposito
dei rapporti fra i poteri e gli organi che la Costituzione stessa prevede.
Sembra, infatti, che i nostri costituenti si siano preoccupati molto più di disegnare i
limiti della libertà individuale e delle regole dei rapporti economici che delle regole
dell’ordinamento istituzionale, come si è evidenziato a proposito della scarna normativa
relativa all’associazione democratica per antonomasia, ovvero il Partito politico.
L’altra ragione di questa premessa è che si è assistito, nel breve tempo che va dal 27
marzo del 1994 al dicembre del 1995, ad una serie di fatti del tutto anomali, sia nell’ambito
dell’una che dell’altra Costituzione, quasi si fosse instaurata una terza via regolatrice dei
rapporti istituzionali.
Una via carica di una forte eccentricità rispetto a tutti i vari modelli di democrazia
conosciuti, tanto da far sorgere il legittimo dubbio se, questa prassi innovativa, possegga
ancora i tratti tipici di una democrazia o, piuttosto, configuri qualche cosa di diverso.
Un governo formalmente espressione del parlamento, in realtà chiamato ad assolvere
ad una funzione di commissariamento, ha discusso per molto tempo con i sindacati non
riconosciuti, ai sensi costituzionali, su di una materia sulla quale il Parlamento non può
non esprimersi.
A questa trattativa, quasi privatistica, da una parte vi erano i rappresentanti sindacali
, i quali, come abbiamo visto, sono privi di ogni investitura e, quindi, rappresentano solo i
propri iscritti, dall’altra un ministro del lavoro che figura, oltre a tutto, fra i consulenti di
uno di questi stessi sindacati!
A prescindere da queste notazioni che, ormai, sono più di colore che d’altro, quello
che è necessario domandarsi è: a questo punto, il Parlamento che cosa deve fare?
Ha ancora senso che si pronunci, visto che, come hanno più volte proclamato gli
stessi sindacati, la riforma concordata fra Confederazione sindacali e governo, peraltro con
l’opposizione delle altre parti sociali, cioè le confederazione imprenditoriali, verrà difesa
utilizzando tutti i metodi di pressione tipici della lotta sindacale, come gli scioperi e che
tale difesa consiste nel far pressione sul governo affinché, quest’ultimo, limiti, di fatto, la
discussione parlamentare facendo ricorso, ai limiti della correttezza istituzionale, dello
strumento della richiesta di fiducia?

Un sistema neocorporativo
La trattativa governo-sindacati sulla riforma delle pensioni, ha formalizzato, ancora
una volta extracostituzionalmente, ciò che nella costituzione materiale è stato
pacificamente affermato, ovvero l’esistenza di una terza camera, quella delle corporazioni.
Direttamente mutuata dalla dottrina dello stato fascista, questa terza camera presenta
una grave anomalia sia che si pensi in termini formali che in termini sostanziali.
Infatti, mentre la camera delle Corporazioni prevista dall’ordinamento istituzionale
fascista presentava, comunque, una propria organicità, una propria regolamentazione anche
democratica, essendovi rappresentate, almeno formalmente, tutte le componenti produttive,
nel neo sistema corporativo istituzionalizzato dal regime partitocratico non vi è traccia
alcuna di tale rappresentatività.
Un’ approfondita analisi di questo sistema neocorporativo è stata tracciata, sulle
colonne de Il Sole-24 ore, da Giovanni Bognetti60
.
Nel suo articolo Brognetti prende atto del fatto che, nella teoria dello stato
costituzionale moderno, la legge idealmente dovrebbe essere fatta in funzione della
promozione dei valori costituzionali e degli interessi generali del Paese, senza interferenze
pervertitrici di interessi particolari.
Di fatto, sottolinea Brognetti, la "pressione" di interessi frazionati organizzati si è
sempre in qualche modo fatta sentire sui legislatori.
Lo Stato liberale classico considerava tali pressioni cosa pericolosa e sconveniente
e si adoperava, per questo, a prevenirle.
Ma con l'avvento dello Stato democratico attuale, interventista e sociale, dove la
redistribuzione dei redditi si è estesa a livelli oscillanti tra il 35% ed il 50% del Pil, le
pressioni hanno preso ad esercitarsi un po’ da tutte le parti della società ed in forma
sistematicamente organizzata.
Dando segno di realismo, almeno secondo il parere dell’autore dell’articolo, lo
Stato contemporaneo ammette, più o meno dappertutto, che i suoi poteri politici consultino
in varie guise, formali ed informali, i rappresentanti delle organizzazioni di interessi, e che
questi accostino uomini di governo e parlamentari per far valere le proprie ragioni.
In paesi come gli Stati Uniti le forme di legittima pressione degli interessi
organizzati (lobbies) sono state disciplinate per legge.
In altri Paesi, sotto l'influenza di ideali vagamente organicistici, si sono creati
appositi organi statali di rappresentanti degli interessi del mondo della produzione e del 60
Giovanni Bognetti "Quando lo Stato contratta" Il Sole 24 ore, 9/6/1995 n 152

lavoro (così l'Italia con il CNEL); organi di scarsa efficacia e meno utilizzati, come
abbiamo avuto modo di sottolineare, delle vie informali.
Lo Stato democratico contemporaneo mette sempre gran cura nel mantenere una
netta distanza istituzionale fra contatti e consultazioni e successiva deliberazione,
riservando quest'ultima alle indipendenti procedure dei suoi organismi.
“Di maniera che.- scrive Brognetti -.. gli atti normativi e decisionali dello Stato
filtrino ed autonomamente aggiustino le istanze degli interessi frazionari in una
composizione che risponda a preminenti interessi generali.”
Nel corso degli anni 70 - prosegue Bognetti - , in non pochi ordinamenti lo Stato è
intervenuto come mediatore nelle controversie economico-sociali tra imprese e sindacati
dei lavoratori, favorendo accordi giovevoli all'economia e promettendo in cambio alle parti
coinvolte misure legislative vantaggiose per gli interessi da esse rappresentati.
Là dove queste prassi sfociavano regolarmente e sistematicamente in veri e propri
accordi triangolari formalizzati (Austria, Svezia etc.) si è parlato dell'affermarsi di un
nuovo corporativismo, diverso da quello degli Stati autoritari del primo dopoguerra, ma
implicante anch'esso, in qualche maniera, una effettiva diretta partecipazione di organismi
corporativi alle decisioni di importantissime politiche statali.
Quest’ultime nascevano, in quei casi, non da una finale, dinamica interazione tra
governo e parlamento, sibbene da accordi definitivi tra governo e parti sociali che poi Il
Parlamento era chiamato solo a ratificare.
Le prassi neocorporative si sovrapponevano dunque alle astratte forme ideali del
modello democratico ed in qualche misura le spiazzavano.
A pare di Bognetti, al contrario di ciò che, a tutta evidenza appare, ciò non vuol dire
che il neocorporativismo andasse contro l'ordine costituzionale per due ragioni:
a) La Costituzione economica delle nostre democrazie esige che lo Stato si adoperi
a sostenere uno sviluppo equilibrato dell'economia, tutelando la stabilità dei prezzi e
l'occupazione
b) il potere statale la cui autonoma funzione più appariva più sacrificata era, a tutta
evidenza, il Parlamento.
Tale sacrificio veniva denunciato da taluni come incostituzionale...sennonché
questa denuncia si ispirava ad una concezione del parlamento come vera, unica fucina delle
leggi nel sistema della divisione dei poteri: una concezione di marca ottocentesca che -
secondo l’autore ma, evidentemente, anche secondo molti potenti politici attuali - non ha
più valore attuale.
Secondo i teorici del neocorporativismo, che poco separa dai massimi teorici del
corporativismo fascista, al Parlamento spetta di convalidare solennemente ovvero di
bloccare l'indirizzo politico prescelto da Governo, ma col potere di integrarlo e di
correggerlo solo nella misura in cui il governo stesso lo consenta.
Così nel modello-tipo della democrazia contemporanea, se il governo fa rientrare
gli accordi neocorporativi da esso conclusi nell'ambito irrinunciabile del suo indirizzo
politico, il Parlamento non viene privato di essenziali funzioni che gli appartengono.

In pratica avrà solo la scelta di approvare o smentire il Governo provocandone la crisi.
Ma questa solo facoltà non contrasta col ruolo che la divisione dei poteri gli
assegna.
In Italia - scrive Bognelli - non si pervenne mai, tra gli anni 70 e 80, a rendere
permanenti e sistematiche, come accadde in altri paesi, le prassi triangolari della
determinazione congiunta di politiche salariali e di politiche statali sociali.
Non si pervenne ad instaurare un vero e proprio regime neocorporativo, ma le
concertazioni coi sindacati per il varo delle leggi dello Stato furono frequentissime.
La cosa che Bognetti evita di sottolineare, nella sua disamina del sistema
neocorporativo informale che si è andato sovrapponendosi al sistema democratico
parlamentare classico, è che, al di là di ogni altra considerazione, il Governo, nello
scegliere con chi condurre la concertazione, ha omesso di applicare i criteri previsti
dall’ordinamento costituzionale.
Le grandi organizzazioni sindacali, la stessa Confindustria e le altre associazioni di
categoria non rappresentano che i propri iscritti, sono dunque privi di quei requisiti di
rappresentatività che, al contrario, sarebbero richiesti anche in un sistema corporativo puro.
Ma i sindacati confederali, negli ultimi tempi, si sono ancora prepotentemente
inserito nel gioco democratico, arrivando a minacciare lo sciopero generale qualora il
governo Berlusconi avesse posto la fiducia sul tema della riforma previdenziale.
Questa pretesa non sarebbe comprensibile né accettabile in alcun regime
parlamentare, se non fosse palese che, in questo caso, i sindacati operano, appunto, da terza
camera legislativa, godendo di un potere molto maggiore di quello ufficialmente
riconosciute, dato che essa può operare al di fuori di norme regolamentari, utilizzare
tranquillamente strumenti che non possono certo essere utilizzati dal Parlamento, quale lo
sciopero.
Tale superiorità è dimostrata dal fatto che, a questo punto, il Parlamento, eletto ai
sensi della Costituzione, viene ridotto a puro notaio legislativo, dovendo approvare una
legge sotto dettatura del sindacato, stretto fra la pressione del governo e di quella delle
piazze.
Nel caso specifico della cosiddetta riforma delle pensioni, la sindacatocrazia ha ricercato
una qualche legittimazione indicendo una sorta di referendum, al fine di verificare il grado di
consenso attorno all’ipotesi sottoscritta dai sindacati confederali ed il governo.
Ovviamente questo tipo di consultazione appare immediatamente un’operazione
fittizia.

Difficilmente potrebbe essere riconosciuto un qualsiasi valore ad una consultazione
siffatta.
Intanto perché sono stati chiamati ad esprimersi solo coloro che sono iscritti al
sindacato, poi perché, di fatto, solo una parte degli iscritti vi ha partecipato, dato che molti,
soprattutto pensionati, grazie ai meccanismi occulti di iscrizione, ignorano di contribuire al
mantenimento della struttura sindacale e, quindi, di esservi stati iscritti, diciamo così,
d’ufficio.
Infine, perché nessuna garanzia è stata offerta per evitare brogli e manipolazioni sia
del voto che dei risultati.
I sindacati confederali, quindi, quando vogliono, si dichiarano rappresentanti di tutti i
lavoratori, millantando un’adesione sicuramente superiore a quella effettiva, se solo si
considera che, di fatto, il numero dei pensionati iscritti equivale agli iscritti in attività, cosa
che appare ancora più vera se solo si consideri il fatto che, come sopra detto, molti
pensionati ignorano di essersi iscritti nel momento in cui hanno dato una delega ad un
patronato per disbrigare la propria pratica pensionistica!
Salvo pretendere, come è stato fatto nel caso dei CNL dei metalmeccanici o d’altri,
un rimborso spese di trentamila lire da parte di tutti i dipendenti non iscritti!61
Verrebbe da dire, in definitiva, che chi non voglia aderire ad un sindacato che ritiene
non rappresentativo - perché verticista e privo di una vera regolamentazione democratica
del proprio apparato, senza quella trasparenza necessaria sia per quanto concerne i
finanziamenti, che per la gestione delle immense risorse finanziarie di cui questa struttura
può godere - si trova penalizzato due volte.
La prima perché deve a dover subire le conseguenze di accordi che non ha voluto e
dei quali può non condividere i contenuti.
La seconda perché viene comunque chiamato a contribuire al mantenimento di una
struttura della quale è al di fuori e sulla quale non potrebbe, anche se fosse iscritto,
esercitare alcuna forma di controllo.
Qualcuno potrebbe sostenere che la tesi oligarchica appare esagerata, che esistono
meccanismi democratici sia all’interno dei partiti che dei sindacati, essendo previste
elezioni per gli organi dirigenti, attraverso, in genere, il meccanismo dei congressi dei
delegati.

In realtà questi sono metodi pseudodemocratici, dato che non vi possono partecipare,
in concreto, tutti gli iscritti e, candidati per l’elezione, sono solo persone legate alla
struttura burocratica, che vivono di politica e riescono ad emergere solo grazie ad una
perfetta conoscenza dei meccanismi burocratici dei propri apparati.
L’oligarchia tende, di fatto, ad autoperpetuarsi, cooptando, di volta in volta, i propri
delfini, coloro che saranno chiamati a succedere a chi si ritira.
Gli iscritti possono solo aderire alle proposte delle segretari uscenti o, in alternativa,
promuovere il gioco delle correnti interne, sfruttando gli stessi meccanismi.
Quando, poi, gli spazi si chiudono troppo, non resta che la strada della scissione, in
modo da ricreare quegli spazi di potere che, all’interno del gruppo principale, sarebbero
stati preclusi.
Oltre a questo, Brognetti e gli altri entusiasti sostenitori del metodo neo, o paleo,
corporativo, dovrebbero spiegare il motivo per il quale, se ritengono superato il sistema
rappresentativo classico, non si ha il coraggio di esplicitarlo, magari proponendo una
modifica costituzionale che lo regolamenti e lo legalizzi.
Così, con maggior coerenza, fecero Mussolini ed il Parlamento controllato dal Partito
Nazionale Fascista.
Evidentemente essi ritengono che sia più opportuno mantenere una parvenza di
democrazia rappresentativa classica, da aggirare attraverso vari espedienti dialettici, quali
quello rappresentato dall’esaltazione della cosiddetta Concertazione con le forze sociali.
Così facendo, essi ottengono, indubbiamente, un risultato: quello di lasciare i
cittadini italiani nella convinzione di vivere in uno stato di diritto e di rappresentatività
classica, mentre, in realtà, si trovano a convivere in un sistema diverso, imposto dall’alto di
una volontà oligarchica e mai sottoposto ad un pubblico dibattito.
Forse, verrebbe da pensare, essi temono che, di fronte ad un ampio e palese dibattito,
la maggioranza della popolazione italiana non approverebbe l’instaurararsi di una
democrazia corporativa o che, dovendo approvarla, preferirebbe che a gestirla fosse una
formazione da sempre corporativa, come la destra legata all’ex-Movimento Sociale
piuttosto che dei neoconvertiti come le sinistre italiane!
Comunque sia, tutto questo contribuisce a rendere palese il fatto che, a fronte di una
Carta Costituzionale apparentemente tesa alla difesa della democrazia rappresentativa
61
Marco Ventura “E sulle trattenute << tradito>> il voto”, Il Giornale 30/10/1995 n. 43

parlamentare, si è andata erigendo, fino a sostituirsi a quella formale, una Costituzione
materiale che, di fatto, ha stravolto tutti i principi costituzionalmente sanciti.
A criteri democratici sono state sostituite prassi oligarchiche, ad un sistema
parlamentare è stato sostituito un regime che ha visto prevalere l’esecutivo sul potere
legislativo, sia attraverso il continuo ricorso alla decretazione d’urgenza, sia attraverso un
ferreo controllo del comportamento dei singoli parlamentari anche attraverso la richiesta di
voti di fiducia a voto palese, metodo ai limiti della costituzionalità.
Il capo del Governo, specie negli ultimi anni, è apparso sempre più uomo del
Presidente della Repubblica che del Parlamento, inaugurando una stagione di
presidenzialismo strisciante, non definito né punteggiato da quei contrappesi che sono
necessari in questo caso.
Il regime si è retto, in pratica, attraverso un metodo di accordo sotterraneo fra forze
di maggioranza e di opposizione, creando un sistema definito consociativo, nel quale si
veniva a creare un unico grande fronte governativo, comprendente quasi tutte le forze
politiche presenti in parlamento, con grande confusione dei ruoli, senza distinzioni fra
maggioranza ed opposizione.
Tutto ciò rendendo inutile ogni tentativo di proposta alternativa, dato che il blocco di
potere che deteneva le leve di comando non mostrava alcuna intenzione di lasciarle andare,
in nome di un sistema dell’alternanza che poteva risultare scomoda e quindi sgradita, per
tutti.
Si è così preferito la certezza della gestione del potere, seppure in condominio,
all’alea della gestione, con assunzione di responsabilità diretta, del diritto-dovere di
governare!
Nulla, d’altra parte, ha opposto la nostra Carta al fine di evitare questa
degenerazione, anzi, grazie alla sue parti più ideologicamente caratterizzate, ha legittimato
ed incoraggiato la propria apparente degenerazione!
Ma, a questo punto, a senso parlare di degenerazione o, piuttosto, dobbiamo parlare
di attuazione di un sistema che, sostanzialmente, era sottinteso già nel retroterra culturale e
politico di questa, ovverosia un universo collettivista e, sostanzialmente, elitario?

Quale Costituzione?
A questo punto nessuno può sottrarsi dal chiedere:
Oggi, qual è la costituzione vigente? Quale dobbiamo modificare, se riteniamo
che sia necessario un cambiamento o, viceversa, quale vogliamo rispettare, se
vogliamo conservare il regime attuale?
Come abbiamo avuto modo di esporre, coloro che ritengono superfluo pensare ad
una modifica radicale della Carta fondamentale sostengono che essa, oggi, è ancora attuale
e valida.
Le cause di un cattivo funzionamento istituzionale, secondo questa corrente di
pensiero, sarebbero dovute alla mancata integrale attuazione della Costituzione stessa.
La terapia proposta consisterebbe, dunque, nel ripristinare l’impianto originario della
Carta, applicandone integralmente principi e disposizioni.
Come sopra esposto, risulta difficile credere alla bontà di un impianto costituzionale
che, di fatto, non è riuscito ad imporsi in quasi cinquant’anni di validità, proprio nelle sue
proclamate ispirazioni democratiche!
Che certi principi possano avere, ancor oggi un loro significato ed una loro valenza,
può essere, ma che l’impianto generale dell’architettura istituzionale sia vacillante, quindi
mal costruito è altrettanto fuori di discussione.
Pensiamo ad un problema quanto mai sentito, quello del conflitto d’interesse fra la
figura di premier e quella di imprenditore, specie se operante in un settore come quello
delle telecomunicazioni.
Su questo tema, la nostra Costituzione tace, limitandosi a recitare, all’articolo 56,
secondo comma, che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che abbiano compiuto l’età
di venticinque anni, mentre l’art. 58, secondo comma, prescrive che possano essere eletti
alla carica di senatore coloro che abbiano compiuto quarant’anni.
Riguardo all’ineleggibilità, l’art. 65 rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda
casi di ineleggibilità e di incompatibilità, nulla prescrivendo, anche solo a livello di
indicazione generale.

Un silenzio totale, colpevole di aver permesso il verificarsi di molti casi, meno
eclatanti di quello legato al nome di Silvio Berlusconi, ma certo non meno gravi, anche se
passati sotto silenzio.
Ricordiamo, a titolo di esempio, il caso del defunto senatore Visentini, più volte
ministro delle Finanze, pur essendo presidente dell’Olivetti, società non certo marginale
per l’economia italiana.
Fra l’altro, proprio nell’assolvimento del compito di ministro delle finanze, egli fu
uno strenuo sostenitore dell’introduzione dell’obbligo dell’uso dei registratori di cassa per i
commercianti, mentre l’Olivetti si presentava come uno dei principali fornitori di tali
apparecchiature.
Sempre al gruppo Olivetti era legato, ad esempio, anche il ministro Spaventa del
gabinetto Ciampi, senza che ciò suscitasse particolari obbiezioni.
Né può essere sottovalutato il ruolo della signora Susanna Agnelli, appartenente alla
famiglia che, attraverso il controllo del sistema FIAT, detiene un indubbio potere ed una
ancor meno dubbia capacità di condizionamento della vita politica e sociale italiana.
Nessuno, però, a trovato nulla da obbiettare alla sua nomina a Ministro degli Esteri,
né la si è criticata in occasione delle numerose gaffes che ne hanno caratterizzato il
mandato.
Eppure, il peso di un Ministro degli Esteri non appare secondario all’interno di un
Gabinetto governativo e gli interessi del gruppo FIAT non si fermano certo ai confini
italiani; oltre al fatto che, partecipando ad un governo di presunti tecnici, non si conoscono
le doti che hanno indotto il premier Dini a scegliere proprio lei e non, ad esempio, un
Sergio Romano o altri.
Pensiamo al ruolo anomalo svolto dai sindacati, nella loro duplice veste di gestore, di
fatto, dell’INPS e promotori dei patronati, i quali sono chiamati a svolgere dei compiti di
informazione e di sussidio burocratico che dovrebbero spettare proprio all’INPS.
Oltretutto, in questo caso, abbiamo un esempio notevole di scarsa trasparenza ai
danni del consumatore.
Infatti l’utente che si rivolge al patronato per chiederne l’assistenza ritiene che questa
prestazione sia gratuita, ignorando che, al contrario, egli la paga indirettamente, dato che ai

patronati viene riconosciuto un rimborso per ogni pratica che svolgono, solo che questo
rimborso lo percepiscono dallo Stato62
!
Per tacere del fatto che, molte volte, vi è, per il pensionando, un onere aggiuntivo
consistente nell’iscrizione automatica ad un sindacato, cosa che non sempre viene ben
spiegata a colui che si accinge a sottoscrivere il mandato al patronato stesso.
Parlando poi di grandi concentrazioni finanziarie, dovrebbero essere ben approfonditi
i rapporti intercorrenti fra il mondo della cooperazione ed i partiti politici ai quali queste
realtà fanno riferimento, analizzando gli interscambi di personale e vari altri tipi di
transazioni che non sempre risultano chiare, almeno per chi si pone all’esterno da semplice
cittadino, mentre, al contrario, proprio questi rapporti dovrebbero essere estremamente
chiari e pubblici.
Ma un’altra grande insidia si nasconde dietro ed oltre l’impianto sociale della
Costituzione, ed è quella di un peronismo63
strisciante, una larvata sudamericanizzazione
della società italiana.
Ricordiamo, a titolo di esempio il caso del ministro del lavoro Marini, il quale, fino a
poco prima della sua nomina era il segretario generale del sindacato cattolico, la CISL.
Diventato Ministro del Lavoro, egli si è trovato a concludere accordi, a condurre
trattative avendo come contropartita i propri compagni di ieri.
Certo non è facile, per le associazioni di categoria degli imprenditori richiedere la
mediazione di un Ministro del lavoro così fortemente caratterizzato!
Eppure questo è successo, tant’è che fu con l’intervento del ministro Marini che
venne concluso l’accordo fra sindacati ed Olivetti, accordo con il quale lo Stato si
assumeva l’onere di assumere mille dipendenti che l’Olivetti era costretta a licenziare.
A commento di questo accordo, scalpore suscitarono le parole, riportate dalla stampa,
con il quale l’allora presidente della repubblica, Francesco Cossiga, apostrofò il ministro
Marini chiedendogli:
62 Secondo un’inchiesta condotta da Il Giornale, i patronati costano, mediamente, circa 500 miliardi l’anno allo Stato.
63 Il termine “Peronismo” viene evocato, in molte occasioni, nei dibattiti politici italiani.
Solitamente si tende ad identificarlo con una concezione paternalistico-populista, caratterizzata dalla presenza di un leader carismatico, autoritario ma non dittatoriale. Il termine viene mutuato dal movimento politico-sociale argentino, a forte caratterizzazione nazionalistica e populista che aveva, quale proprio leader il presidente Peron. In questo caso, si tende ad identificarlo con altre caratteristiche proprie del peronismo, quali, ad esempio, il coinvolgimento di vertici sindacali - di regime - nella gestione del potere; cosa, a ben vedere, molto assimilabile ai concetti neo e paleo-corporativi, siano essi di espressione fascista o di derivazione cattolica e comunista.

“Ma almeno, vi siete fatti pagare bene?”
Il caso del Ministro Marini, comunque, non è il solo, basti pensare al ministro
Giugni, con il governo Ciampi; egli era consulente della CGIL come era consulente della
CISL il ministro TREU del governo Dini.
Da notare un’altra questioni non di poco conto; la Carta Costituzionale sottintende,
seppur mai esplicitandolo, un sistema elettorale proporzionale, perché altrimenti non si
capirebbero certi meccanismi di elezioni di certi organi di garanzia e di controllo, come ad
esempio la Corte Costituzionale, per la quale l’art. 135 si limita a dire che il Parlamento
elegge, in seduta comune, un terzo dei componenti.
Lo stesso dicasi per il Consiglio Superiore della Magistratura, quando, all’art. 14,
terzo comma, si dice che un terzo dei componenti del Consiglio sono eletti dal parlamento
in seduta comune.
Così può dirsi per l’elezione del Presidente della Repubblica, quando si prevede che,
a partire dal terzo scrutinio, possa essere eletto Presidente chi abbia raccolto la
maggioranza assoluta dell’Assemblea, che, per l’occasione, come già ricordato64
, deve
comprendere, in seduta unica, sia deputati che senatori, rinforzati da una pattuglia di
delegati in rappresentanza delle regioni.
Solo nella scelta di questi delegati vi è una prescrizione garantista nei confronti delle
minoranze, dato che si prevede che i Consigli regionali, nella scelta dei tre delegati che li
dovranno rappresentare, facciano in modo di assicurare la rappresentazione delle
minoranze.
E’ facile comprendere come, innestando un sistema elettorale maggioritario in un
contesto costituzionale proporzionalistico, sia necessario creare un sistema di adeguate
contromisure.
Purtroppo, però, la Costituzione nulla prevede e chi si richiama a prassi o a regole
non scritte ma da tutti accettate, non fa che confermare l’esistenza di una Costituzione
materiale sovrappostasi a quella originaria, forse più flessibile ed aggiornabile, certo non
legittimata da alcuna votazione consapevole del popolo sovrano.
Se la fine dei blocchi impone un nuovo ruolo dell'ONU e dell'Unione Europea, i
flussi migratori, con il conseguente confronto di culture e di religioni differenti, richiedono
il ripensamento delle regole civili, la predisposizione di un sistema in grado di garantire

oggi e domani sia i diritti della maggioranza che delle minoranze, tanto più se pensiamo
che la maggioranza di oggi può essere la minoranza di domani.
Tutte ciò comporta che diventa essenziale la riscrittura di una Carta Costituzionale
che, sebbene in larga parte non attuata, non sembra comunque in grado di offrire strumenti
validi per affrontare una sfida cosi' globale, mostrando tutte le crepe di una costruzione
nata sotto l'ancor troppo recente e bruciante ricordo di una dittatura e di una guerra
disastrosa.
I tempi sono maturi, quindi, per una profonda riforma della Costituzione e dello
Stato; quale direzione, pero', debba prendere questa riforma non può' essere decisa, oggi,
da un'Assemblea parlamentare che, pur nel pieno dei propri poteri e perfettamente
legittimata dalla volontà popolare, non ha ricevuto il mandato per una riforma globale della
Carta Costituzionale.
D'altra parte lo strumento previsto dalla Costituzione, l'art. 138, prevede si' un
metodo per la revisione di singoli articoli, ma certo sembra insufficiente per garantire la
legittimità di una radicale e profonda riforma istituzionale.
Una inadeguatezza sicuramente più sostanziale che formale, più legata al senso
dell’opportunità che dal punto di vista strettamente giuridico, però comunque di
inadeguatezza si tratta!
Per questo si ritiene necessario proporre la convocazione di un'Assemblea
Costituente che, eletta con il metodo elettorale proporzionale, abbia il compito specifico ed
esclusivo di provvedere alla stesura ed all'approvazione di una nuova Carta Costituzionale
che dovrà essere promulgata dal Capo dello Stato in carica.
Sara' in occasione della campagna elettorale che i singoli partiti o movimenti avranno
occasione di presentare all'elettorato le linee direttrici della riforma istituzionale che essi
propongono e saranno gli elettori, eleggendo o non eleggendo i candidati dei singoli partiti,
che daranno una forte indicazione della propria volontà.
Le osservazioni relative al ruolo del Referendum ed alla procedura dettata
dall'art.138, che da più parti vengono contrapposte a chi chiede la convocazione di
un’Assemblea Costituente, hanno profonde ragioni d’essere.
Certo è che la nostra Costituzione prevede un unico sistema di modifica, ed è quello
stabilito dall’art. 138.
64
articolo 83 della Costituzione

Ma questa obbiezione di carattere formale avrebbe senso e ragione di essere se, oggi,
vivessimo nell’ambito della Costituzione così come è stata scritta e promulgata e se,
soprattutto, vivessimo in tempi “normali”.
Come è stato recentemente sottolineato dall’ex Presidente Cossiga, la situazione non
è così, non viviamo in tempi normali.
Anche chi non ama il richiamo a momento straordinari, ad emergenze, perché sa che
troppe volte una legislazione d’emergenza ha finito per aggravare i problemi di
democrazia, senza, molte volte, risolvere i problemi per i quali era stata approvata, non può
disconoscere la realtà italiana di oggi.
Di fatto l’introduzione del sistema elettorale maggioritario, ma, ancora di più, lo
sconvolgimento causato dall’esplosione del bubbone di tangentopoli, con la conseguente
scomparsa di interi partiti politici, il conseguente scardinamento di equilibri istituzionali
precari, retti da un tacito accordo di non belligeranza fra maggioranza ed opposizione, han
fatto sì che la situazione politica italiana cadesse in uno stato di profonda crisi.
L’alternativa istituzionale all’art. 138 potrebbe essere rappresentato dall’utilizzo
dello strumento referendario.
Certamente i referendum sono strumenti di democrazia diretta, ma possono solo dire
cosa il popolo sovrano non vuole, non CIO' che vuole; ad esempio, i referendum per il
sistema elettorale hanno determinato la caduta del sistema elettorale proporzionale puro,
ma non hanno determinato, a livello legislativo, un sistema elettorale maggioritario puro,
tant'è che sarebbe stato un nuovo referendum per ottenere questo.
D'altra parte, anche lo svolgimento, ipotetico, vista la sentenza della Corte
Costituzionale, di un nuovo referendum ed anche in presenza di una vittoria dei Si, nulla
potrà garantire che l'eventuale metodo elettorale maggioritario sia ad un turno unico
piuttosto che a due o a canguro65
!
Alcuni, quindi, propongono un referendum propositivo, che peraltro richiederebbe
un'ulteriore modifica costituzionale e sarebbe comunque limitativo, perché richiederebbe
di rispondere si o no, senza margini per il ni o per il si a quest'articolo ed il no ad un altro.
L'art.138, di contro, è il meccanismo previsto dalla Costituzione per potervi
apportare delle modifiche; ma anche qui si hanno dei problemi.
65
La proposta del metodo elettorale cosiddetto “a canguro”, è stata avanzata dall’ex ministro delle riforme istituzionali, l’on. Speroni, il quale prese ad esempio il sistema elettorale australiano consistente in un particolare tipo di doppio turno.

Intanto il meccanismo era nato sempre sul presupposto di un sistema elettorale
proporzionale, quindi largamente rappresentativo - seppur inefficiente come abbiamo
avuto modo di sperimentare -, poi e' adatto per modifiche parziali, non totali.
Il passaggio da un sistema centralizzato ad uno federale, la definizione di un sistema
Presidenziale piuttosto che parlamentare, la ristrutturazione del sistema delle autonomie locali,
ad esempio con la soppressione delle provincie, la stessa ridiscussione dell'art. 7, per adeguare
la realtà italiana ad una società sempre più' multietnica e multireligiosa, come la questione del
diritto di voto a persone che, a tutti gli effetti, non possono essere considerati cittadini italiani,
ovverosia gli immigrati, cosa che pure deve essere quantomeno discussa, per non dimenticare
la ridefinizione del ruolo dell'Unione Europea e la gestione degli interventi umanitari
nell'ambito ONU nonché le problematiche relative all'organizzazione dell'ordinamento
giudiziario, la riforma del CSM, la divisione o meno delle carriere per i magistrati; tutte
questioni che comportano, di fatto, un reale stravolgimento delle due costituzioni oggi vigenti,
sia di quella formale che di quella materiale.
E' opportuno puntare sul solo utilizzo dell'art. 138, in una fase di transizione da un
sistema istituzionale ad un altro ancora tutto da mettere a punto?
Ancora: quando si parla di seconda Repubblica, si parla, soprattutto, di una nuova
Costituzione, che, in definitiva, e' un nuovo accordo fra i cittadini di uno Stato, una
ridefinizione delle regole e degli equilibri di poteri, tesi a garantire sia la maggioranza che
la minoranza.
Esistono i presupposti politici giuridici per mettere mano a questo argomento?
In definitiva, è giusto e legittimo che a decidere dell’assetto futuro dell’Italia sia
chiamato un parlamento scarsamente rappresentativo - per le ragioni sopraddette -
anziché il Popolo Sovrano?
E’ accettabile che in virtù di un articolo di una Costituzione non attuata, lacunosa
e, nella sostanza, modificata nei fatti, possano essere legittimati a far questo Senatori e
deputati vincolati alle oligarchie partitiche più che al rispetto della volontà dei propri
elettori?

L’illusione del maggioritario
Molte speranze e molte illusioni hanno accompagnato, in Italia, il passaggio dal
sistema elettorale basato sul metodo proporzionale a quello basato sul metodo
maggioritario.
Al sistema proporzionale, infatti, preferito dai costituenti per la sua maggiore
propensione a meglio garantire e rappresentare tutte le istanze della società, viene imputata
una endemica capacità di generare ingovernabilità e, soprattutto, di rappresentare lo
strumento principe attraverso il quale si conserva il potere delle segreterie partitiche.
Al contrario, al sistema maggioritario, specie se basato sul turno unico, si dà credito
di garantire, portando, tendenzialmente, ad un bi o massimo tri partitismo, la governabilità.
Come è stato argutamente sottolineato da Geronimo66
, le cose non sono state
proprio così.
L’autore che in questa occasione si cela sotto lo pseudonimo del grande ribelle
indiano, trae lo spunto dall'analisi dello scontro frontale che ha visto, negli USA,
contrapposti i due poteri, quello governativo e quello parlamentare, a proposito
dell’approvazione del bilancio federale 1996.
In quell’occasione, di fronte al blocco compatto del parlamento, il presidente
Clinton ha usato il proprio potere di veto, causando, quindi, la paralisi quasi totale
dell’intero sistema statale americano.
Geronimo, quindi, afferma che "anche nel decantato sistema maggioritario e
presidenziale si può giungere a pericolose fasi di stallo con uno scontro fortissimo fra
potere legislativo ed esecutivo aggravato dal fatto che in quel sistema entrambi i poteri
affondano la propria legittimità nel voto popolare67
".
L’autore prosegue nella propria disamina partendo dall'analisi delle tre principali
finalità proposte dai sostenitori del sistema maggioritario, ovverosia la stabilità, la
limitazione dello strapotere dei partiti nonché la riduzione del numero degli stessi.
Geronimo sottolinea i seguenti aspetti:
a) proprio il nuovo sistema uninominale causa instabilità, perché tutti i partiti sono
costretti a fare alleanze per vincere, ma queste alleanze non si rivelano utili per governare,
in quanto disomogenee.
A riprova di questo, l’autore sottolinea il risultato di stabilità ottenuto con il sistema
elettorale utilizzato per le regionali, dove al sistema proporzionale è stato applicato un
correttivo che assegna un premio di maggioranza ai partiti collegati al Presidente designato.
66
Geronimo, come ha avuto modo di spiegare Vittorio Feltri, direttore de Il Giornale, è lo pseudonimo utilizzato da vari osservatori politici ed economici collaboratori, in incognito, del quotidiano feltriano. Fra i vari commentatori, come ha rivelato sempre Feltri, figura anche l’ex ministro democristiano Paolo Cirino Pomicino. 67
Geronimo “Perché il maggioritario non ci ha salvati dal caos” in Il Giornale 20/11/95 n. 46

b) Alle oligarchie partitiche è demandato il potere di scegliere l'unico candidato da
presentare nei collegi uninominali, togliendo cosi' all'elettore la possibilità di scegliere tra
più candidati.
c) In un sistema maggioritario ciascuna forza politica, per piccola che sia, mantiene
il proprio potere di ricatto, perché in quel sistema si vince o si perde per una manciata di
voti.
"L'unico strumento - scrive Geronimo - per fare strage delle piccole formazioni
politiche senza essere costretti a pagare prezzi di alcun tipo resta solo il sistema
proporzionale con lo sbarramento al 5%. Il sistema , cioè, della grande democrazia
tedesca.”
Per quanto concerne il Presidenzialismo, esso appare il logico complemento di un
sistema uninominale maggioritario.
Ma questo, sempre secondo l’autore, vista la grande forza che tuttora possiedono i
partiti politici e le distorsioni del Sistema Italia, può portare al peronismo, anche in
considerazione di come vengono presentate certe candidature a Premier, sia che si tratti di
Prodi che di Di Pietro.
“ Tutti i governanti delle grandi democrazie - conclude Geronimo - sono leader
politici e non ex presidenti di società pubbliche o ex magistrati chiamati a ruoli politici di
primo piano solo per la loro professionalità manageriale o per la popolarità".
Quindi l’autore auspica una ordinata democrazia parlamentare fondata su pochi
partiti piuttosto che una mitica democrazia maggioritaria.
L’autore omette, in questo caso, di rilevare che l’attuale legge elettorale per la
scelta di deputati e senatori non è compiutamente maggioritaria, essendovi una riserva del
25% a carattere proporzionale e con uno sbarramento del 4%.
Vero è, comunque, che una riforma strutturale dell’assetto istituzionale non può
partire dalla riforma della semplice legge elettorale, dato che questa può essere solo un
mezzo per ottenere un qualche risultato, non già un fine assoluto, valido in sé e per sé.
A dimostrazione che non è sufficiente la semplice modifica del sistema elettorale
per incidere sulla struttura del potere, basta ricordare, come giustamente sottolineava
Geronimo, i metodi utilizzati dai raggruppamenti politici che si sono presentati alle
elezioni del 27 marzo del 1994.
I tre poli che si contrapponevano, quello progressista, centrista e del polo della
libertà e del buongoverno, si sono logorati in lunghe trattative intorno a “tavoli”
interminabili, dove ogni singola componente cercava di trattare al meglio le proprie
candidature nei collegi uninominali, facendosi forte delle proprie capacità di ricatto.
Così si è scatenata una vera e propria battaglia alla ricerca dei migliori piazzamenti
nei collegi considerati, da ogni polo, sicuri; quelli cioè dove, per tradizione, l’elettorato
tende a premiare certe tendenze politiche anziché altre.
Le compagini che si sono presentate, erano, sostanzialmente, disomogenee e gli
elettori, al contrario di quelle che erano le premesse del sistema elettorale, si trovavano,

ancora una volta, a dover scegliere fra candidati imposti, eterodiretti, sicuramente più
propensi a rispettare la volontà delle forze politiche che quella degli elettori.
Questa disomogeneità è emersa subito, fin dal momento in cui, insediato il
Parlamento, le coalizioni si sono subito disgregate, andando, ogni singola componente, a
costituire un proprio gruppo parlamentare autonomo.
Così, mentre gli elettori, nei collegi uninominali, avevano dato un mandato univoco
al rappresentante di un’unica coalizione, i singoli parlamentari ritenevano più opportuno,
in nome della “visibilità” della propria fazione politica, non tenere conto di questa
unitarietà, rivendicando autonomia e libertà.
Tale frammentazione, peraltro, trova una propria giustificazione anche nei
regolamenti parlamentari, dato che particolare rilevanza viene attribuita ai gruppi
parlamentari.
La possibilità di poter avere un maggior numero di gruppi comporta, infatti, la
possibilità, per ogni rassemblement, di avere un maggior numero di capigruppo, cosa che
ha una propria rilevanza in sede di conferenza di capigruppo, convocata dalla presidenza di Camera e Senato per decidere varie questioni legate alla vita parlamentare, dall’ordine dei
lavori a certe decisioni in merito al calendario ed all’agenda parlamentare.
La cosiddetta visibilità, inoltre, diventa un fattore importante anche in altri momenti
istituzionali, specie quando si tratta di dover decidere su nomine particolarmente
importanti, siano esse relative ai tanti consigli di amministrazione di enti pubblici che per
incarichi governativi e non.
Troppi, dunque, appaiono gli incentivi a far sì che si conservi la consuetudine della
cordata politica, l’uso di un sistema lobbistico teso non già a tutela interessi particolari ma,
comunque, di interesse generale, quanto a garantire il potere a chi il potere detiene.
Se la frase che meglio sintetizza lo spirito della cosiddetta Prima Repubblica è
quella del senatore Giulio Andreotti secondo il quale “Il potere logora chi non ce l’ha”, ben
si comprende quale sistema di potere sia sorto e prosperato grazie al sistema politico-
istituzionale disegnato dalla Carta Costituzionale.
Restando in piedi questo sistema, il quale richiede e garantisce numerose possibilità
di collocamento in quello che viene definito il sottobosco68
del potere, si perpetua la
necessità di disporre di corti popolose e fidate, costituite da personaggi non sempre
limpidi, non necessariamente intelligenti ma dalla marcata capacità di agire con lo scopo di
garantire l’afflusso di voti e, ove possibile, di sempre graditi finanziamenti. 68
Il sottobosco del potere è sicuramente molto ricco, vi abbondano posti poco appariscenti ma redditizi e, soprattutto, capaci di garantire il collocamento o il soddisfacimento delle esigenze delle varie clientele elettorali. E’ costituito dalla miriadi di enti, più o meno inutili, che ancora, nonostante la decennale esistenza di una legge che avrebbe dovuti sopprimerli, mostrano una ben determinata volontà di sopravvivere; sicuramente più ambio è il collocamento nella struttura i uno dei tanti enti pubblici di maggior prestigio; dal collocamento in un ente di serie A o di serie B si determina il potere del padrino politico del raccomandato ed è attraverso la capacità di gestire le clientele attraverso l’ente, più ancora che dell’ente, che si acquisiscono quei meriti che, se apprezzati e riconosciuti, possono aprire le porte del Parlamento o di qualche grosso Consiglio di Amministrazione.

La semplice riforma elettorale non appare certo sufficiente per poter scardinare un
sistema di potere che appare incancrenito nella difesa ad oltranza di non giustificate
condizioni di privilegio.
Tanto più se, come in Italia, il metodo elettorale scelto non intacca minimamente il
potere di condizionamento e di ricatto che, di fatto, le segreterie dei partiti detengono ed
esercitano nei confronti dei singoli parlamentari.
Le critiche mosse da Geronimo, dunque, non appaiono del tutto infondate, dato che
non è sufficiente l’elezione con metodo maggioritario per scardinare la partitocrazia, né per
garantire la governabilità.
Ben potrebbe affermarsi che, al contrario, si è sacrificata la rappresentatività senza
acquistare in efficienza e stabilità.
Ma, anche in questo caso, Geronimo e, in generale, i sostenitori del metodo
proporzionale, omettono di ricordare che il sistema maggioritario, per essere completo, ha
necessità di poter contare su di una regolamentazione del metodo di scelta dei singoli
candidati.
Il problema, infatti, al di là del metodo elettorale proporzionale con sbarramento,
maggioritario ad un turno piuttosto che a due, resta sempre questo: che il parlamentare non
è libero di rappresentare la totalità della Nazione e la particolarità del proprio collegio
elettorale perché la sua candidatura non è legata ai suoi risultati elettorali, quanto, piuttosto,
agli accordi segreti che intercorrono fra le segreterie dei partiti.
Proprio per limitare questo strapotere e per liberare i parlamentari, molti sostengono
la necessità di un sistema di elezioni primarie, ovverosia una sorta di preconsultazione
elettorale che consenta, agli elettori di ogni singolo schieramento o partito, di scegliere il
candidato migliore69
.
69
Primarie: si propone la sintesi del testo di un disegno di legge di iniziativa popolare proposto dalla lega per le Primarie. Tale testo appare come una bozza indicativa, utile per avere un esempio di come potrebbero essere strutturate delle elezioni primarie; le percentuali indicate, quindi, dovrebbero essere oggetto di maggiori approfondimenti. Art. 1) La nomina dei candidati alle elezioni della camera dei deputati e del Senato avviene tramite elezioni primarie che si tengono immediatamente dopo il decreto di scioglimento delle Camere emanato dal Presidente della repubblica Art. 2 ) A partire dalle 24 ore successive.....in ogni Ufficio elettorale dei Comuni si apre l'Ufficio Elettorale Primario sotto la responsabilità del Sindaco o del Commissario Prefettizio facente funzione. All'Ufficio Elettorale Primario compete l'obbligo di accettare le candidature e redarre apposite liste di candidati che verranno esposti in tabelloni ben visibili all'interno ed all'esterno del Comune. Art. 3) Tutti i cittadini italiani residenti... nel collegio elettorale.....hanno diritto di proporsi come candidati alle Elezioni primarie. A tal fine ogni cittadino deve presentarsi all'U.E del proprio Comune di residenza e dichiarare per iscritto la propria volontà di presentarsi come candidato, tale dichiarazione essendo controfirmata da cinque testimoni e accompagnata da un versamento in contanti di lire 500.000. L'U.E. ...(rilascia il certificato etc.) Art. 4) Non è obbligatoria l'iscrizione a qualsivoglia partito politico per la partecipazione alle E.P.. Purtuttavia i citttadini che intendessero candidarsi in partiti rappresentati in parlamento, dovranno accompagnare la dichiarazione di cui all'art. 3, da una approvazione scritta e firmata dal capo gruppo parlamentare del partito scelto...

Alcuni sostengono che il persistere di una quota proporzionale70
induce i partiti a
sottolineare la propria peculiarità, impedendo, di fatto, il costituirsi di due veri partiti in
sostituzione degli attuali due poli.
Questo può essere anche vero, ma è comunque da sottolineare come non esista
alcuna norma che possa, concretamente, definire, aprioristicamente, il numero massimo di
partiti legittimati a concorrere alla definizione della politica dello Stato, né si può
realisticamente accettare che una tale norma venga proposta o, tanto meno, accettata,
essendo sicuramente lesiva dei diritti civili dei cittadini.
Né si può pensare che si possa porre in essere un sistema istituzionale garantito
dalla cosiddetta norma “antiribaltone71
”, in sintonia con quanto stabilito dalla legge
elettorale che, dopo la riforma del 1995, regola le elezioni per gli organi regionali e, più in
particolare, la designazione del presidente delle Regioni72
.
Nel caso di partiti non rappresentati in Parlamento, la dichiarazione deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta e firmata dal responsabile legale del partito, così definito dal registro delle Associazioni presso i Tribunali di Corte d'Appello.
Art. 5) Il periodo di accettazione delle dichiarazioni di cui al'art. si protrae di 15 gg solari...3 gg dopo iniziano le elezioni primarie, che si protraggono per 7 gg solari. (o 24 ore - variante). Art. 6) L’Elezioni Primarie si svolgono negli UE comunali. Ogni cittadino può votare per un unico candidato, rispettivamente per la Camera e per il senato... A tale fine il cittadino riceverà, all'atto della votazione, il proprio certificato elettorale su cui apporrà, a votazione avvenuta la propria firma e la dicitura Ho Votato. Il voto viene espresso su scheda intestata del comune...mediante scrittura del nome e cognome del candidato prescelto. Art. 7 ) Lo spoglio delle schede delle EP avviene a cura dell'UE comunale sotto il controllo del sindaco o suo delegato..... Art. 8) Vengono proclamati candidati alle elezioni politiche generali: a) all'interno di un partito politico già presente in Parlamento... il candidato primario che ha ricevuto la maggioranza relativa dei voti espressi per la totalità dei candidati di quel partito. In caso di candidatura unica il candidato deve ricevere almeno il 10% del totale dei voti espressi nel collegio per essere proclamato.
b) All'interno di un partito non rappresentato... viene proclamato candidato.... chi ha ricevuto la maggioranza relativa dei voti espressi per la totalità di quel partito, ma solo nel caso che la totalità di tali voti sia almeno il 10% del totale dei voti espressi nel collegio.
c) per le candidature indipendenti vengono proclamati... tutti coloro che abbiano ricevuto almeno il 10% del totale dei voti del collegio. 70 Ricordiamo infatti che il metodo elettorale scelto dal Parlamento e che ha regolato le elezioni politiche del
27 marzo 1994, prevede che il 25% dei deputati venga eletto attraverso il sistema elettorale proporzionale con uno sbarramento del 4%. 71 Ricordiamo che il termine “Ribaltone” è entrato di diritto nel lessico politico italiano allorquando la Lega Nord, guidata da Umberto Bossi, dopo aver dato vita ad un’alleanza elettorale con Forza Italia, riunitisi, nel nord Italia, sotto il simbolo del Polo delle Libertà, si è defilata dalla maggioranza parlamentare uscita vincitrice dalle elezioni del 27/3/1994, presentando una mozione di sfiducia firmata insieme a PDS e PPI proprio contro il governo Berlusconi al quale partecipavano alcuni ministri leghisti.
Il termine ribaltone tendeva a qualificare negativamente la nascita di una nuova maggioranza di governo che comprendesse la Lega e le forze politiche uscite sconfitte dalle elezioni, dopo aver relegato all’opposizione i partiti politici che, al contrario, le elezioni avevano vinto.
72 Nel caso del Presidente delle regioni, infatti, si è creato un meccanismo che, oltre a premiare la coalizione vincente, assicurandole comunque la maggioranza assoluta nell’Assemblea Regionale, si è stabilito il principio del simul stabunt, simul cadunt; ovverosia se cade il Presidente cade anche l’intera giunta ed il
Consiglio, così da dover tornare alle elezioni,.

Infatti questo metodo, che può essere accettabile in un organo che, almeno allo stato
attuale, ha solo una funzione amministrativa, non può essere accettato per il principale
organo di espressione popolare, l’Assemblea Parlamentare.
Quest’ultima non può essere legata al vincolo personale di un uomo, per quanto
scelto direttamente dai cittadini, poiché essa rappresenta, comunque, la totalità della
nazione, sia nelle sue espressioni maggioritarie che minoritarie, né può prescindere dalla
tutela delle minoranze che, diversamente, potrebbero venire travolte da un troppo
accentuato potere individuale.
Insomma, nessun metodo elettorale, da solo, può garantire governabilità e
rappresentatività; occorre che tutto l’impianto costituzionale sia scritto in questa ottica, e il
nostro, evidentemente, non appare scritto per questo.
Come ricorda Zullino, nell’articolo già citato73
, in quasi centoquarant'anni di storia
unitaria, tutti i modelli elettorali siano già stati abbondantemente provati.
All'inizio dei tempi - ricorda l’autore - quando le donne non votavano ed anche gli
elettori maschi erano pochissimi, si andò alle urne con un sistema uninominale
maggioritario a doppio turno molto simile a quello odierno francese; un candidato,
ottenendo al primo turno almeno il 33% era eletto, altrimenti vi era il ballottaggio.
Nel 1882 si passò ad un sistema plurinominale molto caratteristico, addirittura
spassoso: l'elettore non disponeva di un voto soltanto, ma di tanti voti quanti erano i seggi
in palio in quel collegio: e poteva assegnarli a piacimento ai vari candidati, secondo una
sua personalissima classifica di meriti e demeriti.
All 'indomani della prima guerra mondiale...i due principali partiti di massa (il
cattolico di Sturzo ed il socialista di Turati e Matteotti) riuscirono ad imporre il metodo
proporzionale.
Quando l’assemblea Costituente del 46 si trovò a decidere se la proporzionale
andasse conservata o meno, molti erano convinti che non dovesse esserlo dato che proprio
questo metodo elettorale era stato all'origine di quell'insanabile frantumazione del
Parlamento che aveva aperto la strada al fascismo.
Alcuni, specie vecchi liberali e massoni, erano contrari anche per un'altra ragione:
con il suffragio universale la proporzionale poteva diventare un terribile strumento nelle
mani di partiti che puntassero ad egemonizzare le Camere avendo alle spalle potenze
definite "illiberali" (l’URSS o la Chiesa).
Se ne discusse fino alla nausea. La proporzionale aveva i suoi irremovibili e ben
motivati difensori. Poi, naturalmente, c'era chi esaltava il maggioritario uninominale di
marca anglosassone e chi proponeva le alternative o varianti più strane.
I tre partiti di massa (DC+PCI+PSI usciti vincitori dalla competizione del 2 giugno
volevano mantenere la proporzionale perché più democratica. A poco valsero le obiezioni
di liberali autorevoli come Einaudi e Porzio, basate sull'evidenza che nelle più antiche e
mature democrazie del mondo si adoperava, invece, il maggioritario. 73 73
Pietro Zullino "Forza, riscopriamo l'acqua calda" Il Carabiniere maggio 1995

A nulla valse la proposta del socialdemocratico Rossi, per il quale la proporzionale
andava bene ma a condizione che il sistema fosse perfezionato assegnando un premio di
maggioranza al partito o alla coalizione di partiti che avessero riportato il maggior numero
di voti.
I proporzionalisti, inoltre, volevano che il sistema elettorale venisse sancito dalla
Costituzione.
Ciò avrebbe acceso un'ipoteca sullo stato a favore di quegli oggetti ancora
misteriosissimi che erano i partiti; fortuna volle che tale manovra non riuscisse, ma certo
l’impianto istituzionale ne venne pesantemente condizionato, al punto che, ormai, non si
può modificare il metodo elettorale senza modificare larga parte della Costituzione stessa.
Insomma, la battaglia per il maggioritario può essere una battaglia vincente per la
trasparenza e la modernizzazione politica, ma certo, da sola, non può essere in grado di
ribaltare un sistema partitocratico consolidato e radicato.
Il metodo elettorale, come già ricordato, non può rappresentare la panacea, l’elisir
di lunga vita della democrazia, certo è, comunque, che in un quadro istituzionale
rivoluzionato, anche il sistema elettorale di tipo maggioritario può presentare degli indubbi
vantaggi.

L’Illusione Referendaria
Il sistema parlamentare italiano si trova, dunque, a dibattersi all’interno di due
problemi che risultano essere potenzialmente esiziali per le istituzioni politiche e
costituzionali.
Come abbiamo visto, da una parte vi è lo strapotere dei partiti politici, con i loro
pesanti condizionamenti, la loro capacità di ricatto nei confronti dei singoli parlamentari,
ridotti al ruolo di comprimari, soggetti al ricatto della sudditanza per avere la garanzia di
una ricandidatura che possa loro assicurare la rielezione74
.
Dall’altra vi è la paralisi di un Parlamento vincolato, in virtù di un difetto genetico
d’impianto, ad un bicameralismo perfetto75
che, di fatto, obbliga le forze politiche a
lunghe ed estenuanti maratone per l’approvazione di leggi che vanno e vengono fra i due
rami del parlamento76
Ogni tentativo di rendere più snelli ed agevoli i lavori delle aule parlamentari è
naufragato.
Alcune volte, specie in campagna elettorale, alcuni partiti politici cercano di
cavalcare lo scontento popolare, emotivamente teso ad accusare i parlamentari a causa
delle presunte alte indennità77
.
Da qui la richiesta di una diminuzione del numero dei deputati o la proposta
dell’abbandono del bicameralismo sostituendolo con un monocameralismo.
Proposte legittime e , molto probabilmente, valide ma che richiedono un vaglio e
una motivazione molto più approfondite del semplice e demagogico richiamo al risparmio
economico ed alla fine del mantenimento di “tanti parassiti”78
.
74 Per indicare sia la scarsa considerazione in cui è tenuta la larga maggioranza dei deputati e dei senatori nonché la loro ininfluenza sulle sorti reali delle principali norme legislative, molti anni fa venne coniato il termine di “Peones”.
Un termine preso a prestito dallo spagnolo per indicare sia la precarietà di questi parlamentari, che, come i peones indios vanno mendicando un posto di lavoro per l’oggi, senza certezze per il futuro, sia la totale sudditanza al vero potere che sovrasta il Parlamento, quello delle segreterie politiche dei partiti. 75
L’art. 70 della Costituzione recita: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente delle due Camere”
76 I due rami del Parlamento sono chiamati ad esprimersi sulla stessa disposizione legislativa fino a quando il testo licenziato dall’uno non sia identico a quello dell’altro.
Questo comporta che, a fronte di una seppur minima differenza fra il testo approvato dalla Camera e quello del Senato, la Camera sia costretta a mettere in calendario il riesame di tutto il testo normativo, senza la certezza che, a sua volta, introduca altre variazioni che comportino un riesame del senato.
Per questa particolare prassi è stato coniato il termine di “navetta”, per indicare proprio il continuo viaggio compiuto da ogni disposizione legislativa fra l’uno e l’altro ramo.
77 La demagogia imperante impedisce a molti illustri politici di difendere la dignità ed i costi della politica, quasi che giustificando il diritto del parlamentare ad una giusta mercede si legittimino prassi e meccanismi perversi di finanziamento fraudolento.
In realtà la necessità di una lauta retribuzione per il cittadino che operi, da deputato o senatore, al servizio della nazione, appare come una conquista dei sistemi democratici.
Se così non fosse, com’era nell’Italia dei primi anni unitari, solo chi dispone di laute entrate economiche potrebbe permettersi di concorre all’elezione.
In realtà, proprio una più che elevata remunerazione del singolo deputato o senatore, limitando, al contrario, il finanziamento ai partiti, potrebbe, progressivamente, garantire indipendenza ed autonomia al singolo parlamentare, affrancandolo dalla schiavitù del partito politico; ciò consentirebbe al cittadino deputato di poter rispettare l’art. 67, rappresentando liberamente e compiutamente la Nazione e non il partito.

Progressivamente, dunque, il ruolo del Parlamento come organo legislativo, titolare
anche del potere di iniziativa legislativa, è andato scemando.
Le proposte di legge presentate dai singoli deputati, il più delle volte ai limiti
dell’inutilità79
, si accumulano negli archivi delle due Camere e solo poche di queste,
prevalentemente quelle sponsorizzate da politici di maggior peso, hanno speranza di
vedersi iscritte nel calendario dei lavori parlamentari.
Il peone, frustrato dalla consapevolezza della propria inanità, preoccupato di una
ricandidatura che sa essere legata esclusivamente alla propria capacità di obbedienza e di
fiuto delle correnti vincenti, si sfoga cercando notorietà, almeno nel proprio collegio
elettorale.
Da qui nascono le famose leggine, termine molto in auge ai tempi d’oro della
politica della spesa dissennata.
Si tratta di leggi studiate apposta per favorire un certo interesse particolare
all’interno di un collegio o di un ambito territoriale più ampio, in genere prevedenti
finanziamenti o sgravi fiscali o riconoscimento di status per comuni, provincie, comunità
montane o quant’altro sia mai venuto alla mente di un legislatore contorto e frustrato.
La possibilità di approvazione di questa normativa legislativa restava legata
all’accettazione della stessa nell’ambito delle singole commissioni del Parlamento, dotate,
in certe materie ed occasioni, di potere non già referente ma legiferante.
Qui, allora, si creavano le famose alleanze trasversali dei peones dei vari partiti.
In cambio dell’approvazione di una leggina proposta per un collegio democristiano
o socialista, i deputati ufficialmente all’opposizione si vedevano approvate altre loro
proposte per soddisfare le proprie clientele locali.
Qualcuno potrebbe obbiettare che questo, in realtà, non rappresentava un male,
poiché, essendo il Parlamento a livello nazionale, difficilmente può conoscere le singole
legittime attese di particolari settori economici o locali, pre cui ben operano i singoli
deputati che portano all’attenzione dell’intera collettività nazionale problemi locali. 78
Il fatto che, nella coscienza popolare, i politici siano considerati parassiti e che ben poca stima vi sia dell’uomo politico, mentre, in maniera inversamente proporzionale, vi è una grande considerazione del presunto potere che costui viene accredito di possedere, evidenzia il grave stato di crisi nella quale versa la politica e la democrazia italiana. 79
La struttura politica ed organizzativa dello stato accentrato, come è quello italiano, con scarsa disponibilità ad una effettiva delega locale, fa sì che, di fatto, ogni singolo provvedimento debba passare al vaglio delle due camere. In sede di approvazione della finanziaria, ad esempio, ogni deputato finisce per portare all’attenzione di un consesso nazionale singole esigenze che, bene e meglio, sarebbero trattate in ambito regionale o, addirittura, comunale. In occasione del dibattito sulla finanziaria per il 1995, ad esempio, vi furono episodi al limite del grottesco. La Camera discusse per oltre mezz’ora sulla decisione di stanziare o meno la cifra di un miliardo per affrontate il problema degli animali selvatici (cani e gatti, non certo leoni o pantere), animali che si trovano ad aggirarsi per città e paesi “senza fissa dimora”. L’opposizione dei deputati di Rifondazione Comunista, parlò per loro l’on. Rossana Moroni, fu dettata dal fatto che uno stanziamento di pari importo per l’acquisto di preservativi da destinare alla lotta contro l’AIDS era stato bocciato il giorno prima (sic!).

Questo discorso, che è alla base della legittimazione delle lobby80
, ha una logica ed
un senso se il problema fosse circoscritto e limitato alle questioni essenziali di uno stato
moderno.
In tal caso le legittime attese di una lobby, ad esempio quella dei consumatori,
potrebbe ben esercitare una pressione per l’approvazione di una normativa particolare su
temi di interesse limitato.
A queste pressioni si potrebbero contrapporre quelle esercitate, sempre restando
all’esempio, da un gruppo di produttori che si potrebbero ritenere danneggiati
dall’approvazione di tale iniziativa legislativa.
A questo punto, il Parlamento sovrano diventa arbitro e moderatore dei contrapposti
interessi, emettendo una norma che soddisfi gli uni danneggiando il meno possibile gli altri,
secondo il principio di salvaguardia della maggioranza dei cittadini dello Stato.
Ma questo meccanismo diventa perverso quando un sistema politico ed
istituzionale si trova a dover legiferare su tutte le sfere della vita sociale, in presenza di uno
Stato che ha forti interessi e poteri decisionali totali in tutti i comparti economici e sociali
di una Nazione.
Lo Stato italiano detiene le quote di maggioranza di società in tutti i settori
economici, dall’assicurazioni alle banche, dalla produzione di biscotti a quella di carri
armati, dalle fonderie all’energia elettrica, dai trasporti alle telecomunicazioni.
Lo Stato italiano gestisce Ospedali, dai più piccoli ai più grandi, determina, di fatto,
le politiche economiche di Regioni, provincie, comuni; provvede, attraverso propri capitoli
di spesa, al mantenimento di una moltitudine infinita di enti pubblici, comunità montane,
enti teatrali ed altro ancora.
Con questo tipo di struttura, la spesa pubblica non può che diventare ingovernabile,
l’attività lobbistica si frantuma in mille rivoli, nascono migliaia di occasioni per ricercare,
attraverso i meccanismi di spesa, la soddisfazione di singoli clientes politici.
Questa ricerca della soddisfazione clientelare, poi, comporta un ulteriore grave
danno alla collettività.
La presentazione di decine di provvedimenti, la necessità di dover sempre e per
forza dover ricorrere ad un decreto legislativo parlamentare per regolamentare ogni singolo
atto che abbia una propria influenza sulla vita sociale, finisce per creare un vero ingorgo
legislativo.
Le proposte di legge, come già detto, si accumulano negli archivi delle due camere,
iniziative urgenti ed importanti rischiano di vedersi superate da altre, meno importanti ma
più facilmente discutibili e licenziabili, vista la trasversalità di interessi particolari.
80
Il termine lobby è di chiara origine anglosassone, identifica il raggruppamento di più persone portatrici di un interesse particolare che, attraverso un’azione di pressione, tendono ad influenzare le scelte politiche delle assemblee parlamentari. Nell’ambiente costituzionale anglosassone la pratica lobbistica è regolamentata ed accettata, mentre in Italia, seppur esistendo una qualche forma di regolamentazione, non esistono garanzie di adeguata trasparenza sull’attività delle singole lobby. Molte delle quali, peraltro, non risultano palesate.

Da tutto questo deriva, progressivamente, la paralisi che attanaglia l’attività
legislativa italiana, la quale, poi, crea un ulteriore paradosso.
Di fronte ad una provata incapacità di licenziare norme di largo respiro, risolutive
dei tanti problemi che travagliano il Paese, si ha una produzione normativa smisurata, tanto
che il cittadino italiano è chiamato a rispettare un numero di leggi spropositato, decine di
volte superiore a quelle che è chiamato a rispettare un cittadino francese o inglese.
Quindi, si ha un parlamento incapace di legiferare in maniera organica su temi
come quelli fiscali, giudiziari, scolastici, sanitari, di politica estera, di difesa e di tutela
reale dell’ambiente, mentre riesce a produrre una smisurata mole di piccole norme.
L’unico risultato concreto è, così, un accavallarsi di norme a getto continuo in tutti i
settori, senza organicità, raccordo con norme esistenti, leggibilità ed interpretabilità delle
norme stesse.
A questa incapacità congenita del parlamento, i governi che si sono succeduti nei
primi 50 anni di vita della Costituzione hanno ovviato ricorrendo in maniera massiccia, ai
limiti dell’incostituzionalità, ai decreti legge previsti dall’art. 77 2 comma della
Costituzione81
.
Di fronte ad una previsione logica, chiara ed esplicita della Costituzione, si è
affermata una prassi del tutto illogica, per niente chiara ed ambigua.
La previsione costituzionale non lascia dubbi: il Governo può ricorrere a
provvedimenti provvisori solo in casi di necessità ed urgenza e sotto la propria
responsabilità.
Questo carattere di necessità ed urgenza appare chiaro anche per il limite temporale
imposto dalla Costituzione, i sessanta giorni entro i quali il testo legislativo deve essere
convertito in legge, ovverosia fatto proprio dal Parlamento, unico organo
costituzionalmente preposto a svolgere la funzione legislativa.
Dopo sessanta giorni, in genere, si prevede che l’urgenza sia superata!
Qualora, poi, il decreto non venga approvato dalle Camere, queste potrebbero,
come giustizia vorrebbe, emanare una norma che tuteli i rapporti giuridici sorti in virtù di
una disposizione di legge che, di fatto, non è mai esistita ma che ha consentito il sorgere di
fatti ed atti precisi, legittimamente posti in essere, perché in quel momento regolati da una
precisa norma, seppur transitoria.
Fatto questo, però, il Governo dovrebbe trarne le debite conseguenze, almeno
secondo il dettato costituzionale nella sua lettera, dato che, come esplicitamente affermato,
il provvedimento legislativo provvisorio viene emanato sotto la responsabilità del
governo stesso.
81
Recita l’art. 77 2 comma: “Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

Se decade, vuoi perché non rispondente a criteri di necessità e di urgenza, vuoi per
una diversa valutazione di merito del Parlamento, il Governo non può che assumersene le
responsabilità e dimettersi.
Non in altro modo, infatti, potrebbe assumersi la responsabilità di un
provvedimento non necessario né urgente e , per di più, non idoneo, a parere del
Parlamento, massimo organo rappresentativo della volontà popolare, a risolvere il
problema che voleva affrontare.
In realtà, nel processo di progressiva sostituzione di una Costituzione materiale a
quella formale, si è affermata e consolidata una prassi totalmente diversa, senza che si
potesse attivare alcun meccanismo istituzionale per la tutela della previsione legittima, ad
ulteriore dimostrazione della carente capacità di questa Costituzione di garantire il rispetto
della legittimità e della correttezza istituzionale.
I governi degli ultimi anni si sono sostituiti, di fatto, al Parlamento, utilizzando il
potere di emanare decreti legge per esercitare una propria autonoma potestà legislativa.
Da qui la prassi Costituzionalmente non corretta della reiterazione, ovverosia della
emanazione di un nuovo decreto, identico a quello non convertito, alla data di scadenza dei
sessanta giorni.
Vi sono decreti che rischiano di entrare nei guinness dei primati, soprannominati
decreti milleproroghe, dato che, puntualmente decadono ed altrettanto puntualmente
vengono reiterati.
Durante questa reiterazione, poi, vi si introducono modifiche e variazioni, in parte
recependo, se il Parlamento ha fatto in tempo a prenderli i considerazione, alcune
modifiche da questo proposte, in parte aggiungendo norme del tutto nuove, diventando dei
veri e propri decreti omnibus82
.
Così facendo il governo causa , ancora una volta, un duplice danno all’attività
legislativa.
Da una parte contribuendo a rendere ancora più intensa l’agenda dei lavori
parlamentari, obbligando, di fatto, la presidenza delle camere ad una calendarizzazione
sempre affannosa, dettata dall’esigenza di rispettare, per quanto possibile, l’impegno
dell’approvazione o del rigetto del decreto nei sessanta giorni.
Dall’altra aumentando la confusione legislativa, quella giungla normativa nella
quale rischia di perdere la bussola qualsiasi cittadino che voglia essere rispettoso delle
norme.
Molte volte norme in vigore vengono superate o disattese da decreti che, pur
essendo immediatamente capaci di autonoma validità, non hanno garanzia di durata,
essendo sospesi fino alla conversione in legge, magari con modificazioni, da parte del
Parlamento. 82
Questa prassi dell’emanazione del decreto omnibus, benché contrario anche a certe norme introdotte dai regolamenti parlamentari, resta, comunque, una cattiva abitudine della decretazione ministeriale.

Gli stessi decreti, poi, passando al vaglio dell’organo legislativo, possono subire,
come di norma accade, notevoli mutamenti, talché si pone la necessità, da parte del
Parlamento, di emanare norme ad hoc per la regolamentazione e la sanatoria di atti o
comportamenti posti in essere a seguito di norme non approvate.
Cosicché la chiarezza necessaria della legge si perde, il disorientamento del
cittadino aumenta, immerso in una palude di norme sempre più complesse, nelle quali
rischia di annegare lo stesso legislatore.
Non per niente lo stesso legislatore ha sentito l’esigenza di emanare una legge per
dettare le regole di una buona prassi legislativa; inutile dire che anche questa legge, come
tante in Italia, è stata prontamente disattesa e dimenticata!
Cosa che appare enormemente più grave, se solo si considera il fatto che, in questo
caso, l’organo che disattende ad una precisa norma di legge è lo stesso che tale norme ha
voluto e che, secondo logica, dovrebbe dare l’esempio; ma questo non suscita molta
meraviglia, dato che anche questa norma, come tante altre, risulta emanata per pura
demagogia e non per reale consapevolezza della necessità di norme chiare, precise e non
discutibili.
Così accade che un principio basilare dell’ordinamento giuridico, quello secondo il
quale Ignorantia legem non excusat possa, nella patria del diritto, essere messo in
discussione, tanto che, alcuni anni fa, un giudice assolse un imputato proprio motivando
che, pur essendosi verificata l’infrazione in materia fiscale, questa poteva essere scusata
proprio per l’impossibilità, da parte del semplice cittadino, di poter rispettare norme troppo
complicate e non alla conoscenza di tutti.
Sicuramente a molti verranno in mente le parole del Manzoni a proposito delle
Grida, concetto ripreso ed espresso da Sebastiano Vassalli, il quale scrive, a proposito della
legislazione italiana ai tempi della dominazione spagnola, che
...era una precisa tecnica di governo ...... questa di costringere i sudditi
a convivere con leggi inapplicabili e di fatto inapplicate, restando sempre un
poco fuori dalla legge: per poterli poi cogliere in fallo ogni volta che si voleva
riscuotere da loro un contributo straordinario, o intimidirli, o trovare una
giustificazione per nuove e più gravi irregolarità
Così è nata l’Italia moderna, nel Seicento: ma può essere forse motivo
di conforto, per noi, sapere che il malcostume ci è venuto da fuori, e che è più
recente di quanto comunemente si creda.83
Dunque, non molta strada è stata fatta da quel seicento controriformatore, dove
trionfava la Sacra Inquisizione ed al luminoso Ariosto si sostituiva il cupo romanzo del
Tasso!
Il caos legislativo appare, dunque, totale; l’unico dubbio rimane la causa, insipienza
legislativa o volontà di dominio su una massa di sudditi prostrati e proni alla volontà del
moderno principe?
83
Sebastiano Vassalli “La Chimera” Einaudi 1992, pag. 44

Di fronte a questo scenario estremamente preoccupante e desolante, da alcune parti,
specie nelle fila dei militanti del movimento radicale84
, riuniti sotto la leadership di marco Pannella, si è cercato di creare un’alternativa a quello che appariva un gulag
dell’intelligenza e delle possibilità della società civile italiana.
Forte della previsione dell’art 75 della Costituzione85
, questo movimento ha inteso
sostituirsi al Parlamento, giudicato immobile e troppo attento agli interessi oligarchici,
chiamando il Popolo sovrano a dire, direttamente, la sua su molte questioni che da anni,
stancamente, si trascinano in lunghi e sterili dibattiti parlamentari.
A partire dal 1974 gli italiani sono stati chiamati a dire la loro su svariati temi, dalla
legge sul divorzio a quella sull’aborto, dalla scelta dell’installazione delle centrali nucleari
alla legge elettorale, dalla responsabilità civile dei magistrati all’orario dei negozi.
Il popolo, chiamato alle urne su temi specifici e, alcune volte, anche complessi, ha
sempre risposto positivamente alla chiamata alle urne, tranne in alcuni casi isolati86
.
Alcune volte ha dato ragione hai promotori, altre volte ha confermato la propria
fiducia nelle norme emanate dal Parlamento.
Una nuova campagna per la raccolta di firme su 20 referendum è stata lanciata
nell’autunno del 1995.
La scelta di lanciare una massiccia campagna referendaria trova molti oppositori,
specie in quei partiti, come il PDS, che, per tradizione storica, meno sono propensi ad
accettare un confronto franco ed immediato con la base popolare.
La motivazione che molte volte viene proposta è che, di fronte a tanti problemi, il
cittadino comune non è in grado di decidere, perché non conosce, non può capire.
In realtà, se questo fosse il problema, facile sarebbe la soluzione; sarebbe
sufficiente dedicare un maggior spazio all’informazione sui temi referendari, attraverso la
trasmissione di pubblici dibattiti ed adeguati spazi di approfondimento.
Né, d’altra parte, convince la tesi secondo la quale, visto che vi è un Parlamento
eletto apposta per la composizione e la mediazione di contrapposti interessi, spetta al
parlamento, organo sovrano perché rappresentativo della volontà degli elettori, emanare
leggi e, se del caso, modificare quelle che possono essere oggetto di critica popolare. 84 A partire dal 1994 coloro che si riconoscono nella leadership dell’on. Marco Pannella si sono costituiti in
Movimento dei Club Marco Pannella, dato che il Partito Radicale si è trasformato in partito transnazionale, ovverosia in partito che accoglie, al proprio interno, militanti di tutto il mondo e che si occupa di questioni politiche internazionali.
Le ultime battaglie politiche sono state quelle per l’istituzione di un Tribunale permanente Internazionale per i crimini di guerra, base per una solida giurisdizione internazionale sotto le bandire dell’ONU e l’impegno per la sospensione della pena di morte entro il duemila in tutto il mondo.
Nel corso del 1995 l’ONU ha riconosciuto il PR come organismo consultivo non governativo.
85 L’art. 75 recita: “ E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. 86
Ricordiamo il mancato raggiungimento del quorum per il referendum sulla caccia.

Agli occhi di tutti, ormai, appare, in tutta la sua evidenza, la cronica incapacità del
Parlamento di mantenere fede ai propri diritti e, soprattutto, ai propri doveri.
Dunque, non possono certo essere queste le critiche da opporre a chi ritiene,
legittimamente, di utilizzare uno strumento costituzionalmente corretto come quello dei
referendum; se vogliamo, viste le profonde modificazioni implicite e non palesi introdotte
alla Costituzione formale, lo strumento referendario sembra l’unico in perfetta sintonia con
la lettera e lo spirito dei costituenti.
Però, indubbiamente, lo strumento scelto presenta molte crepe e, alla distanza, si
può trasformare in un boomerang proprio per chi lo ritiene uno strumento di garanzia
democratica.
I difetti principali che si possono imputare, allo stato attuale, al referendum sono
due, uno di carattere procedurale ed uno di carattere sostanziale.
Il primo, quello procedurale, riguarda la caratteristica propria dell’istituto previsto
dalla Costituzione, ovverosia il suo carattere puramente negativo, essendo uno strumento
abrogativo e non potendo, quindi, determinare l’indirizzo legislativo in senso positivo.
L’altro, quello sostanziale, riguarda la tutela delle minoranze; a nessuno può
sfuggire, infatti, che l’eccesso di ricorso a metodi referendari può tradursi, qualora fossero
posti in questione norme poste a tutela di particolari settori della società, in uno strumento
di oppressione, non già di democrazia.
Per quanto riguarda il primo tema, quello procedurale, il fatto che lo strumento
referendario si limiti alla semplice richiesta di un Si o di un No, impedisce, nel caso di
vittoria della volontà abrogatrice, una corretta interpretazione univoca della volontà
popolare.
Infatti, come insegna il referendum promosso dall’onorevole Segni
sull’abrogazione del sistema elettorale proporzionale per il Senato, una volta che il popolo
si è espresso a maggioranza, non per questo il Parlamento ha un’indicazione precisa circa
l’effettiva volontà popolare.
Infatti, dovendosi limitare ad una scelta estrema, non avendo la possibilità di
scegliere le eventuali soluzioni alternative che sorgono in conseguenza di un si o di un no,
l’elettorato può solo dire, chiaramente, ciò che non vuole, lasciando all’interpretazione
libera dei politici la decisione circa il modo in cui regolamentare ciò che è stato oggetto di
referendum.
Così, ad esempio, a seguito di un referendum che consentiva di abolire il metodo
proporzionale in un sistema elettorale, nulla ha impedito al Parlamento di approvare una
legge elettorale che conserva una quota proporzionale; né esistono indicazioni in merito al
tipo di maggioritario voluto dagli italiani, tant’è che alcuni vorrebbero un sistema
maggioritario a due turni mentre altri sostengono che la volontà degli elettori si è espressa
nel senso di indicare una preferenza per un sistema maggioritario ad un turno.
Questo pone un problema di esplicitamento e di difesa dell’interpretazione che al
quesito referendario danno i promotori.

Infatti, pur essendo un sistema dicotomico, non sfugge all’osservatore attento che,
dietro alla semplice richiesta di un si o di un no, esiste una molteplicità di motivazioni ed
indicazioni.
Nel caso in esame, ad esempio, coloro che sostenevano la validità del referendum
potevano avere, come di fatto avevano, intenzioni diverse sul dopo referendum.
Infatti, se Segni poteva essere favorevole ad un sistema maggioritario a due turni,
Marco Pannella era favorevole ad un sistema maggioritario ad un turno.
Sul fronte opposto, vi poteva essere chi era fermamente favorevole al sistema
proporzionale puro, ma anche chi poteva ritenere preferibile un sistema proporzionale con
elementi di maggioritario, come premi di maggioranza o cose simili.
Significative sfumature che, per quanto avvertibili e di non trascurabile entità, non
potevano risultare evidenti dalla semplice conta dei Si e dei No.
Dunque, poiché non era esplicito il pensiero positivo dei proponenti, mentre
risultava chiaro quello che essi non volevano, qualunque fosse il risultato del referendum
ognuno avrebbe potuto, con minori o maggiori difficoltà, sostenere di essere il più fedele
interprete della volontà popolare.
Di fatto, solo nel caso in cui i promotori avessero potuto contare su adeguate forze
parlamentari avrebbero potuto sperare di vedere difeso il risultato elettorale per il quale si
erano battuti.
Va da sé, peraltro, che se gli stessi promotori avessero potuto contare su tali forze,
il ricorso alla volontà popolare sarebbe stato inutile.
Così come, di fatto, è stato un referendum inutile quello sulla sospensione della
ricerca nucleare in Italia, dato che tale posizione risultava già maggioritaria in Parlamento.
Ma proprio questo particolare, la necessità, cioè, di un’adeguata forza parlamentare
per poter difendere, diciamo così, i risultati referendari dimostra che, ancora una volta, la
Costituzione italiana mostra un proprio limite essenziale.
Infatti, nella previsione dei costituenti, si è prefigurato un sistema alternativo di
legificazione, seppure dotato solo dell’opzione negativa; ma non si è pensato di dotarlo di
quegli strumenti idonei a renderlo veramente efficace e realmente interpretativo della
volontà popolare.
Ritenere dunque, come vorrebbe il movimento referendario legato ai club Pannella,
di poter introdurre modifiche istituzionali o, comunque, essenziali facendo ricorso a questo
strumento appare, tutto sommato, abbastanza illusorio.
Comunque, anche se così non fosse, sarebbe, forse, anche più preoccupante.
Infatti è insito nel meccanismo referendario, come già sottolineato, la necessità di
doversi esprimere in termini dicotomici, o Si o No, senza spazio per posizioni intermedie.

Non solo, il meccanismo dell’appello diretto al popolo si basa, per propria natura,
sulla vittoria della quantità, ovverosia, secondo la prima regola della democrazia, con la
vittoria delle proposte che raggiungono il 51% dei voti.
Dunque, si hanno due elementi, l’estrema semplificazione delle risposte e la vittoria
della maggioranza.
Appare dunque evidente la difficoltà di utilizzare lo strumenti su questioni
particolarmente complesse.
Se, ad esempio, qualcuno si ponesse l’obiettivo di risolvere il problema
dell’immigrazione attraverso il ricorso al referendum, potrebbe chiedere l’abolizione della
legge Martelli.
I cittadini sarebbero chiamati a dire si o no al mantenimento della normativa,
dunque, coloro che sono contrari alla Martelli, magari per motivazioni differenziate o
contrapposte, si troverebbero nella difficile scelta di distinguersi e di far correttamente
interpretare la propria volontà.
Sicuramente voterebbe SI chi è animato da spirito razzista, intendendo, con questo,
mettere una pietra sopra ad ogni possibile sviluppo della società aperta, multietnica e
multiculturale che si presenta all’orizzonte dell’Italia.
Altrettanto voterebbe Si chi, pur essendo rassegnato, se non favorevole, all’ipotesi
di una società diversa, ritiene, comunque, che la Martelli sia troppo blanda nei controlli e
che debba essere posto comunque un freno all’immigrazione.
Ma come voterebbero coloro che, favorevoli ad una cultura della cosiddetta
accoglienza, ritengono la Martelli troppo restrittiva e, quindi, comunque da modificare?
Si stringeranno a difesa di questa legge, pur criticandola, per non mischiare il
proprio voto con coloro che appartengono alle due categorie sopraddette, oppure voteranno
contro la Martelli?
Questa seconda ipotesi potrebbe risultare meno peregrina di quello che possa
sembrare a prima vista, infatti, utilizzando il referendum abrogativo in maniera un po'
disinvolta, quest’ultimi potrebbero fare il seguente ragionamento:
noi, insieme agli altri, contribuiamo all’abrogazione della legge Martelli, così, una
volta abrogata, si ha un vuoto legislativo in virtù del quale si crea, di fatto, una possibilità
per gli immigrati di entrare in Italia senza correre troppi rischi, dato che le norme
restrittive sono decadute per effetto dei referendum.
Fatto questo, poiché non è possibile quantificare quanti hanno votato SI per motivi
razzisti e quanti per motivi umanitari, di fronte ad una difficile interpretazione della
volontà popolare inespressa, dovendo il Parlamento elaborare ed approvare una nuova
legge, vi è tutto il tempo per far sì che si crei di fatto, al di là delle intenzioni di coloro che
hanno promosso il referendum e di coloro che lo hanno sostenuto per motivi opposti, la
possibilità, per un tempo ragionevolmente lungo, di avere frontiere aperte in modo tale di
mettere il Parlamento di fronte ad un fatto compiuto e, di conseguenza, di doversi adeguare
allo statu quo.

In questo caso, dunque, l’estrema semplificazione del quesito e la richiesta di una
semplice maggioranza numerica convergono a far sì che, di fatto, non emerga la reale
volontà popolare ma, piuttosto, attraverso un meccanismo distorto, estrapolativo insito nel
sistema referendario, prevalga il calcolo politico di una parte sulla volontà dell’altra; lascio
immaginare le drammatiche conseguenze di un tale evento.
Peggio ancora sarebbe se venisse proposto il referendum per abolire una qualche
tutela a favore di una minoranza; in tal caso le motivazioni egoistiche della maggioranza
potrebbero prevalere con conseguenze disastrose per la convivenza civile della Nazione.
Quanto sopra detto non vuole apparire come una presa di distanza o, peggio ancora,
un attacco allo strumento referendario, tutt’altro.
Vuole solo costituire uno stimolo al ripensamento ed alla riformulazione del
meccanismo che, oggi lo regola; vuole altresì essere, comunque, un invito a non
considerare questo strumento di democrazia diretta come un feticcio, un mito.
Esso rappresenta uno dei tanti strumenti attraverso i quali può esprimersi la volontà
e la sovranità popolare; non può però essere sovraccaricato di compiti e di attese.
Resta il fatto che, sicuramente, lo strumento rappresenta un profondo elemento di
disturbo per le oligarchie, perché ne ritarda il programmato ed ordinato cammino, le
obbliga ad occuparsi di questioni che preferirebbero restassero appannaggio di pochi, da
discutere in ambiti ristretti, dove sono possibili accordi sotterranei e indecenti proposte di
commercio d’anime.
Ben vengano, dunque, le campagne referendarie, anche per rendere partecipi i
cittadini di molte scelte e soprattutto, per verificare con mano l’operato dei propri eletti,
con la piena consapevolezza, comunque, che non può essere il solo meccanismo
referendario a rendere possibile la caduta di un regime oligarchico come quello che, grazie
alle profonde lacune proprie della Costituzione italiana, si è instaurato e che domina lo
Stato.
Non è attraverso referendum che si possono modificare la forma di Stato o quella di
Governo, dato che per modificarli occorre intervenire sulla Costituzione, utilizzando,
quindi, i meccanismi ordinari previsti dall’art. 138, già più volte citato.
Tutto sommato, visti i limiti, si può anche essere soddisfatti del fatto che non si
debba ricorrere alla roulette del Si e del No in una materia delicata come quella
Costituzionale.
Ma appare chiaro che non vi può essere vera riforma morale, civile e culturale in
Italia senza coinvolgere una profonda modifica alla nostra Costituzione, e, dunque, non si
può pensare di agire attraverso i soli referendum ed il ricorso diretto al popolo

L’illusione presidenzialista
Molte autorevoli personalità politiche sostengono che, per risolvere il disequilibrio
istituzionale ed il caos politico nel quale si dibatte l’Italia, occorra mutare la forma di
governo, passando da un sistema parlamentare ad uno di tipo presidenziale.
Così, si ritiene che il trinomio Presidenzialismo, federalismo e maggioritario
rappresenti per l’Italia ciò che il più famoso trinomio, Libertà, Uguaglianza e Fratellanza
rappresentò per la Francia e l’Europa intera a partire dalla Rivoluzione Francese in poi.
Abbiamo sopra visto i limiti dell’opzione maggioritaria, così come sono stati
indicati i difetti del parziale federalismo realizzato con l’istituzione delle Regioni.
Né l’una né l’altro hanno, di fatto, concorso migliorare granché la vita politica,
economica ed istituzionale italiana.
La cappa partitocratica, senza un grimaldello in grado di schiudere la porta della
cella nella quale sono rinchiusi milioni di italiani, si mantiene ben stretta attorno agli
elettori, sequestrandone, di fatto, la volontà.
Una riforma in senso presidenziale potrebbe rappresentare questo grimaldello?
La risposta non può essere né un si convinto né un no altrettanto convinto; si può
solo dire: Dipende!
Quando si parla di presidenzialismo, infatti, non si è fatto altro che esprimere un
concetto che, senza ulteriori specifiche, resta privo di ogni reale significato.
L’unica cosa chiara che tale concetto rende palese è questa, che in un sistema
presidenziale il Presidente della repubblica viene eletto direttamente dal popolo sovrano.
Al di fuori di questo nessun altra cosa appare certa!
I modelli presidenziali, infatti, sono vari e variegato appare il panorama dei poteri
concessi al Presidente.
Nella prospettiva francese, ad esempio, il Presidente della Repubblica non è,
contemporaneamente, capo del Governo.
Egli, dunque, deve nominare il capo dell’esecutivo, il quale deve ricevere la fiducia
operativa del Parlamento, al quale spetta il compito di approvare o meno le proposte del
governo.
Poiché la durata del mandato presidenziale non coincide con quello parlamentare,
può accadere, come è accaduto, che un presidente socialista come Mitterand abbia dovuto
convivere con un capo dell’esecutivo gaullista come Balladur.
Di fatto, dunque, questo comporta una serie di inconvenienti non indifferenti, anche
perché la Costituzione Francese, nata sotto la rigida direzione del presidente De Gaulle,
poco prevede in tema di conflitti di competenze.
Così molti problemi hanno afflitto i nostri cugini d’oltralpe, mancando una figura
carismatica come quella del Generale per antonomasia, il quale poteva catalizzare voti sia
su di sé che sul proprio partito, garantendo, dunque, una stabilità politica del tutto
particolare.

Altri, poi, preferirebbero una forma di presidenzialismo annacquato, dove, al posto
del Presidente della repubblica, si proceda all’elezione o all’indicazione del Premier.
Anche qui, poi, ci si rifà o al modello tedesco oppure a quello inglese, omettendo,
in quest’ultimo caso, di precisare che trattasi di Monarchia e non di repubblica e che,
quindi, l’elezione di un Premier, in questo caso, assurge quasi alla scelta di un Presidente,
dato che i Reali non sono oggetto di scelta elettorale, piuttosto di vaglio giornalistico e
scandalistico!
Altri ancora, poi, vorrebbero l’elezione contemporanea di un Presidente della
repubblica e la scelta di un Premier, affidando al Capo dello Stato compiti poco più che di
rappresentanza e di garanzia, più o meno sulla falsa riga di quanto già previsto dalla nostra
Carta.
Chi ritiene i modelli sopracitati inadeguati e, sostanzialmente, causa più di
inefficienze che di organica soluzioni di problemi, sostiene la cosiddetta opzione
americana.
Fra i più strenui sostenitori di tale soluzione troviamo Marco Pannella e,
attualmente, alcuni leader del cosiddetto Polo delle Libertà, a partire da Berlusconi e Fini.
Secondo tale ipotesi, il Presidente della repubblica, eletto dai cittadini, dovrebbe
essere anche capo dell’Esecutivo, avendone ricevuto il mandato dagli elettori e
dovendosene assumere, dunque, anche l’onere, accettando il loro giudizio, critico o
favorevole, al momento della candidatura per la rielezione.
Secondo i sostenitori di tale ipotesi, questa scelta contribuisce ad una
semplificazione, dunque ad una chiarificazione, del quadro politico, essendo evidente, agli
occhi di tutti, i compiti e le responsabilità affidate ad una precisa persona.
Il Presidente, in questo caso, è direttamente responsabile degli atti dei propri
ministri, avendoli liberamente scelti, nonché della politica generale dell’esecutivo: egli può
fare o non fare, e sulla base delle sue libere scelte sarà chiamato a rispondere davanti agli
elettori.
Il Parlamento, in questo caso, è chiamato a controllare l’operato del governo, nel
rispetto della classica ripartizione dei poteri.
Il Governo è il titolare del potere esecutivo, sommo responsabile
dell’organizzazione della macchina burocratica statale e, quindi, sceglie liberamente i
dirigenti dei singoli ministeri, divenendone, dunque, direttamente responsabile.
Il Parlamento è titolare del potere legislativo e controlla, attraverso atti autonomi,
l’operato del governo.
Governo e Presidente traggono legittimazione dalla volontà popolare, al popolo
sono chiamati a rispondere, in un sistema nel quale scarso potere è delegato ai Partiti
politici, dato che i candidati vengono selezionati attraverso l’utilizzo dello strumento delle
elezioni primarie.

Ma proprio questa unicità di legittimazione genera, come è stato ricordato da
Geronimo87
, potenzialmente un conflitto se, come nel caso della Presidenza Clinton,
Parlamento e presidenza esprimono forze politiche contrapposte.
Ma il sistema americano evidenzia anche un’altra peculiarità, rappresentata dalla
costituzione e dalla struttura del Parlamento americano.
Come ricorda Mauro Calamandrei in un suo articolo apparso su Mondo
Economico88
, quello che sembrava essere un rullo compressore, quella dei repubblicani
contro i democratici; appare, al contrario, come uno scontro frontale fra repubblicani e
repubblicani e più specificamente fra repubblicani della Camera dei Rappresentanti e quelli
del Senato.
Infatti, nonostante che i deputati repubblicani, abbiano introdotto molti
cambiamenti, nel rispetto del Contratto per l’America , da loro stipulato al momento delle
elezioni, al Senato si vive come se la maggioranza nella Camera alta appartenesse ad un
altro partito.
Calamandrei scrive che
"negli anni in cui i repubblicani controllavano la Casa Bianca e i
democratici il Congresso spesso si aveva l'impressione che in America le due
Camere fossero istituzioni gemelle; il terremoto elettorale dell'anno scorso ha
avuto l'effetto di riportare alla luce, accentuandole, le profonde differenze che
in America hanno sempre diviso le due camere .
Contrariamente ai Paesi a sistema parlamentare maggioritario... negli
USA Senato e Camera hanno non solo regolamenti interni differenti, ma anche
differente composizione e differenti sistemi di elezioni. Col passare del tempo
sono diventati l'espressione anche di diverse culture."
L’attuale maggioranza dei senatori repubblicani non ha particolari simpatie per
l'orientamento ideologico e per molte proposte specifiche del "Contratto con l'America",
dato che molti pensano più alle elezioni presidenziali del 1996....
Ma, continua l’autore, indipendentemente da fattori contingenti, le due Camere
sono radicalmente diverse ed indipendenti e le differenze che stanno producendo forti
tensioni negli USA meritano l'attenzione di chi è alla ricerca di riforme istituzionali.
I poteri legislativi che detengono le due camere non sono sostanzialmente diversi.
La Camera dei rappresentanti ha la priorità nell'iniziare qualsiasi legge finanziaria
ed il Senato ha speciali poteri nella ratifica dei trattati e nella conferma della nomina del
Presidente, ma altrimenti i poteri effettivi sono quasi uguali.
La differenza riguarda sia la composizione che il metodo elettorale.
La Camera dei rappresentanti è composta da 435 deputati eletti ogni 2 anni in
circoscrizioni di pari abitanti.
87
Geronimo “Perché il maggioritario non ci ha salvati dal caos” in Il Giornale del 20/11/95 n. 46
88 Mauro Calamandrei “Camere non comunicanti” in Mondo Economico del 5/6/1995

Il Senato è composto da 100 eletti in rappresentanza dei 50 stati che compongono la
federazione, i quali durano in carica 6 anni, e sono eletti su base statale; ogni Stato elegge
2 senatori, a prescindere dal numero degli abitanti.
I conservatori, ricorda ancora Calamandrei. non si sono mai stancati di ripetere che
gli USA sono una repubblica piuttosto che una democrazia; un sistema politico, cioè, in cui
la libertà dei cittadini è più importante dell'efficienza del Governo.
Spetta alla camera rispecchiare gli umori della maggioranza di un certo momento;
tra le funzioni del Senato c'è invece la difesa degli interessi della comunità a più lunga
scadenza e la protezione delle minoranze, anche settoriali, dai pericoli della dittatura della
maggioranza.
Il Senato legifera, però si vuole che si preoccupi ancor più di proteggere il paese da
cattive leggi.
Per ridurre al minimo le pressioni degli elettori, mai più di un terzo è impegnato in
campagne per la rielezione.(da notare che prima venivano eletti in secondo grado dalle
assemblee parlamentari dei singoli stati, dal 1913 a suffragio diretto).
Il Senato, in definitiva, appare come il salotto buono, ristretto, della democrazia
americana, mentre la Camera è paragonabile ad una vera Arena.
Lo speaker e gli altri leader della camera sono potenti e le regole del dibattito
rigide: in certi casi leggi molto importanti possono essere approvate senza diritto di
emendamento dopo qualche ora di dibattito.
I senatori, al contrario, hanno un diritto illimitato di parola: nel corso del 1994, ad
esempio. repubblicani usarono il filibustering per bloccare buona parte del programma
legislativo di Clinton e quest'anno i democratici stanno facendo lo stesso col programma
repubblicano, approfittando del fatto che per porre fine all'ostruzionismo occorrono 61 voti
su 100.
Nel sistema americano è frequente il caso che leggi anche importanti non vengano
approvate o lo siano con ritardo a causa del sistema di pesi e contrappesi esistenti.
Ma, data la profonda sfiducia nella classe politica che ha sempre caratterizzato lo
spirito della società americana, raramente c'è la convinzione che i freni imposti ai
legislatori siano troppi.
La forza e l'unicità del Senato americano stanno nel fatto che i senatori
rappresentano la popolazione dello Stato e solo secondariamente il partito al quale
nominalmente appartengono.
In Italia, si è pronti per adottare una filosofia di questo tipo?
Considerato che il sistema economico e sociale italiano è riuscito a sopravvivere a
decenni di malagestione, di assenza costruttiva dello Stato, di concreti incentivi, forse si!
Però, al contrario degli Stati Uniti, la nostra democrazia non affonda salde radici su
una storia centenaria, né esiste un qualche cosa di simile al cosiddetto spirito americano.
Comunque, non a questo si riferiscono coloro che si richiamano al modello
americano, del quale viene privilegiata la capacità organizzativa e la presunta efficienza.

Come si vede, invece, anche il sistema istituzionale americano mostra alcune
discrepanze, non laceranti per una nazione che, come giustamente sottolinea Calamandrei,
ama la libertà individuale tanto quanto detesta l’attività legislativa, sicuramente da evitare
in una fase de jure condendo.
Dunque, pensare che si possa risolvere il problema istituzionale semplicemente
facendo ricorso alla formula magica del presidenzialismo appare, di per se stesso, una pura
illusione.
A meno di concepire come presidenzialismo un regime autoritario dove l’Uomo
della Provvidenza, Console e demiurgo, dotato di capacità carismatiche e politiche fuori
dal comune, estragga dal proprio cappello magico la soluzione facile ed ideale ai tanti
problemi pratici e concreti tipici di una società evoluta e complessa.
Se così non è, occorre chiedersi quale sia la struttura consona di un sistema
presidenziale, quali siano i pesi ed i contrappesi più idonei per consentire un equilibrato
rapporto fra efficienza dell’esecutivo e rappresentatività parlamentare.
Insomma, un problema complesso non liquidabile in poche battute da 30 secondi,
tipiche di un approccio televisivo dei problemi, né con demagogiche filippiche a favore o
contro.
Il futuro delle istituzioni italiane passa attraverso la decisione centrale della forma
di governo, e questa non può che essere affrontata che nell’ambito di un acceso ma sereno
dibattito costituente.

Il tempo stringe
Nuvole preoccupanti si stanno addensando all'orizzonte della democrazia italiana
(democrazia?)
Sempre più, vista la rassegnazione di quanti sostengono l'idea dell'Assemblea
Costituente e la loro sostanziale incapacità di iniziativa politica, si profila il rischio di una
manovra oligarchica di riforma istituzionale.
Fra tavoli e consulte di saggi, proposte di premierato e compromessi sui metodi
elettorali, il tema del movimento costituente, rilanciato anche da Tremonti dalle pagine del
Corriere della Sera, sembra sfumare.
Ci manca solo che questo parlamento sconclusionato, senza capo ne' coda, senza una
vera maggioranza, tutto teso nella guerra di tutti contro tutti, metta mano in maniera
tragicamente ultimativa alle riforme istituzionali, che richiedono, invece, chiari rapporti fra
le forze politiche, un clima di costruttivo rapporto maggioranza/opposizione e, soprattutto,
idee chiare ed il più possibile vicine alla sensibilità dei cittadini-elettori e non sudditi.
Nel paese esiste una diffusa volta' di riforma istituzionale, da più' parti, nei bar, nei
circoli, nei dialoghi di strada, si percepisce la necessità di un definitivo cambiamento delle
Istituzioni, quindi della Costituzione.
Molte volte questo desiderio e' confuso, i concetti nebulosi, quindi più' pericolosi: si
chiede, ad esempio, il presidenzialismo scambiandolo per l'affidamento ad un uomo 'forte',
surrogato dell'Uomo della Provvidenza, la soluzione dei problemi, senza aver chiaro in
testa cosa, al contrario, il passaggio ad una repubblica presidenziale comporti in termine di
architettura costituzionale, in termini di pesi e contrappesi.
Lo stesso dicasi sui temi più' propriamente legati al dibattito politico, dalla (im)par
condicio, ai problemi dell'antitrust, alle riforme pensionistiche etc.
L'esigenza di una riforma istituzionale e' diffusa e sentita dalla popolazione.
Perché l'Assemblea Costituente piuttosto che un Referendum o l’ applicazione
dell’art. 138?
Perché la campagna elettorale che necessariamente comporterebbe un'elezione
plenaria proporzionale, introdurrebbe nel paese un dibattito approfondito su temi di vitale
importanza.

L'Assemblea Costituente, proprio per la sua caratteristica, avrebbe una funzione
politica di mediazione fra posizioni diverse, il che non vuol dire necessariamente
consociativismo, ma ricerca di largo consenso sulle regole che, partire dalla promulgazione
della nuova Costituzione, presiederebbero al comportamento di ognuno di noi.
Una Costituzione uscita dalla volontà di un'assise costituente avrebbe comunque un
valore morale, etico e politico decisamente superiore ad ogni modifica istituzionale
imposta da una oligarchia politica e partitica, comunque eletta.
Se perdiamo questo momento, ci aspettano decenni di nuovo grigiore, conformismo
e disastri economici, politici, morali ed etici.
D’altra parte, dobbiamo tenere conto del fatto che una Costituzione, come diceva
Calamandrei, è solo un pezzo di carta, un accordo, un patto sancito fra i cittadini di uno
Stato al fine di regolarne i rapporti.
Ma questo pezzo di carta, assume un valore essenziale per la convivenza civile ed
affinché così sia, occorre che venga espresso un unanime consenso nel riconoscerne validi
i principi.
In momenti di aspro conflitto sociale, nella travagliata fase di transizione da una
struttura socioeconomica ad un’altra, il modo migliore per evitare aspri scontri sociali,
aperte crisi istituzionali è ricorrere ad una nuova fase costituente, in modo da spostare ,
l’attenzione dei cittadini, in maniera palese e dichiarata, dalle piccole beghe di breve
respiro a temi di maggior impegno e consistenza.
Anche coloro che ritengono validi i principi e le forme istituzionali dovrebbero
essere favorevoli a questo, perché, molte volte, si viene criticando un metodo elettorale o
un sistema istituzionale più per sentito dire, per insoddisfazione dell’esistente più che per
riflettuta e meditata convinzione.
Aprire un franco, anche aspro, dibattito costituente vuol dire porre al centro
dell’attenzione dei cittadini le regole fondamentali con le quali essi si trovano a dover
convivere e che costituiranno le basi della successiva convivenza.
Al di là di quanto possa prevedere una Costituzione formale, ogni popolo deve
rivendicare il proprio diritto a ridiscutere le basi fondanti della propria vita sociale.
Al di sopra delle Costituzioni nazionali, deve esistere una Carta Internazionale che
determini i requisiti minimi in termini di riconoscimento dei diritti civili, delle libertà e

della tutela delle minoranze affinché uno Stato possa essere definito democratico ed
ammesso al consesso internazionale delle Nazioni.
Solo se si riuscirà ad affermare il diritto dell’ONU, o di altro organismo
sovranazionale, ad esercitare una effettiva giurisdizione internazionale, eliminando la
clausola che, ancor oggi, impedisce la cosiddetta ingerenza negli affari interni dei paesi
membri, si sarà fatto quel passo avanti decisivo per l’instaurarsi di una effettiva
democrazia.
La salvaguardia dei diritti civili deve essere posta al vertice dell’attenzione generale,
non essendo concepibile che, ancora oggi, possano far parte del consesso civile ed avere
forza e prestigio, all’interno dell’ONU, stati dove si pratica, nell’indifferenza generale, la
peggiore strage degli innocenti come avviene in Cina89
, dove, peraltro, si continua a
praticare un brutale ed assoluto dominio sopra un altro stato come il Tibet.
Né, alcuni anni fa, si sarebbe dovuto accettare il Cile del generale Pinochet, assunto
al potere grazie ai lager ed alla strage degli oppositori, o i tanti regimi ai limiti dello
sfruttamento feudale come gli stati emergenti dell’estremo oriente, dove, anche grazie a
capitali occidentali, si pratica una forma violenta e cieca di brutale schiavitù.
La diffusione della ricchezza e del benessere è la maggiore garanzia di sviluppo
democratico e liberale; che ciò avvenga armonicamente e pacificamente deve essere
interesse di tutti i cittadini, specie di quelli che hanno la fortuna di abitare in Occidente90
.
Per questo, oggi più che mai, occorre ripensare la nostra Costituzione nazionale,
affinché possa recepire quanto necessario per armonizzarsi con un progetto veramente
federalista, europeista e di integrazione democratica internazionale, decretando che la
nostra nazione non possa avere scambi economici stabili con Nazioni che non rispettino i
diritti civili, almeno quelli definiti dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Uomo.
89
Poiché, in virtù delle rigide norme imposta dallo stato cinese al fine di limitare la proliferazione delle nascite, le coppie possono avere un numero limitato di figli, dato che la mentalità contadina esalta la nascita di un figlio maschio tanto quanto depreca quella di una femmina, nell’assoluta mancanza di proteste ufficiali e senza alcun tentativo di intervento statale, nelle campagne cinesi moltissimi neonati vengono uccisi avendo la cola colpa di essere femmine. 90
Nell’ambito dei tanti trattati sul commercio internazionale, dal GATT all’Uruguay Round, si dovrebbero
inserire clausole di tutela e salvaguardia dei diritti dei lavoratori, in modo da debellare la piaga della riduzione in schiavitù che, di fatto, continua a mietere vittime in tanti paesi, dalle miniere d’oro dell’Amazzonia alle fabbriche di bambole della Thailandia, senza dimenticare quelle realtà extraterritoriali che, anche in Italia, sono rappresentati dai quartieri cinesi. A questo proposito basti ricordare le condizioni di vita spaventose nelle quali vivono e lavorano decine di persone nella civile S.Donnino, alle porte di Firenze; nonostante l’esistenza di leggi e strutture di controllo, un malinteso politico, quello di un solidarismo cieco ed ottuso, si lascia fare, si evita di intervenire essendo incapaci di capire che un intervento per ripristinare la legalità non rappresenterebbe un atto di razzismo ma solo un dovere giuridico ed una salvaguardia di chi, oggi, lavora in condizioni di semi se non totale schiavitù.

Di fronte a tanti problemi, l’unica prospettiva che appare come potenzialmente
foriera di una vera svolta è la convocazione, dunque, di una nuova Assemblea Costituente,
in grado di redigere una Costituzione meditata, ispirata ai principi che oggi prevalgono
nella società italiana e sufficientemente rispettosa della tutela delle sensibilità e delle
istanze minoritarie.
Un’assemblea Costituente, dunque, ampia, con membri eletti con metodo
proporzionale, aperta il più possibile anche a gruppi minoritari, dalla quale, dopo ampio,
esauriente, anche vigoroso, dibattito possa scaturire una nuova Carta, in grado di
accompagnare l’Italia ad affrontare degnamente le sfide del prossimo millennio.

Una proposta di Legge per una nuova
Assemblea Costituente
Assemblea Costituente: legge di iniziativa popolare
Quella che segue rappresenta una bozza di articolato, un esempio di come potrebbe
svilupparsi un progetto di legge teso a rendere possibile la convocazione di una nuova
Assemblea Costituente.
Al di là di alcune questioni tecniche, quali, ad esempio, il numero dei membri
dell’Assemblea, le maggioranze necessarie o altre questioni similari, preme sottolineare le
seguenti caratteristiche proprie di questa proposta:
a) La ricerca di una effettiva par condicio, sia attiva che passiva; punti
qualificanti, in questo senso, sono
a1) la previsione di un contributo straordinario a favore dei soggetti proponenti al
fine di consentire un fondo spese per la pubblicazione delle proposte di Costituzione e la
diffusione delle stesse.
Questo aspetto, anche da parte di chi è contrario al finanziamento pubblico dei
partiti, dovrebbe essere valutato positivamente, in quanto va nella direzione di consentire
ai promotori, anche economicamente svantaggiati, di poter competere ed ai cittadini di
essere adeguatamente informati al fine di poter scegliere secondo scienza e coscienza.
La materia è troppo delicata ed importante per consentire legittimi dubbi o
recriminazioni da parte di chi si ritenesse indebitamente danneggiato dalla mancanza di
fondi.
a2) la previsione di un preciso obbligo cogente, per l’emittente radiotelevisiva
pubblica, di trasmettere le necessarie informazioni e gli spazi opportuni a tutte le proposte
politiche.
Al contrario delle norme imposte dal Governo Dini, il ripristino della par condicio
avviene estendendo gli spazi di libera circolazione delle idee e delle notizie, non attraverso
la salomonica riduzione al silenzio delle parti contendentisi l’elettorato.
Altri aspetti importanti riguardano

- l’incompatibilità dello status di membro con qualsiasi altra carica elettiva , nonché
la previsione di un divieto assoluto di concorrere a qualsiasi carica per i tre ani successivi
alla promulgazione definitiva della nuova Costituzione.
Ciò al fine di rendere più indipendenti e distaccati dall’agone politico tutti i membri
dell’Assemblea Costituente.
- il limite della durata in carica dell’Assemblea
L’articolato proposto potrebbe essere il seguente:
Premessa:
Vista la necessità , avvertita da più parti, di procedere ad un’ approfondita revisione
della Costituzione della repubblica promulgata il 27 dicembre del 1947
Visto il nuovo sistema elettorale vigente per la composizione della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, caratterizzati da un alto tasso di regime
maggioritario
Visto che, allo stato attuale dei fatti, tale metodo elettorale appare idoneo a garantire
stabilità ai governi con sacrificio della rappresentatività delle minoranze nazionali
Ritenuto che un processo di profonda revisione della Costituzione non possa che
scaturire da un ampio dibattito all'interno di tutte le componenti del popolo sovrano
Ritenuto che a seguito di tale dibattito debba scaturire una nuova Assemblea
Costituente, eletta su base proporzionale, in grado di deliberare garantendo ampie
garanzie di democrazia e rappresentatività
Premesso quanto sopra si delibera
Art. 1 - (Abrogazione dell’Art. 138)
E’ abrogato l’art. 138 della Costituzione Italiana
Art. 2 (Convocazione Assemblea Costituente)
E' convocata un'Assemblea Costituente al fine di redigere ed approvare la nuova
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 3 - (Sede)
L’assemblea Costituente avrà sede in una città italiana, diversa da Roma, che rivesta
particolare importanza per la storia dello Stato Italiano, sia come antica Capitale che per
altri motivi storici, culturali e politici.

Spetta al Governo, di concerto con il Presidente della Repubblica, di individuare la
sede più idonea, anche per le necessarie esigenze logistiche, ad ospitare i lavori
dell’Assemblea stessa.
Art. 4 - (Durata)
L'Assemblea Costituente, di seguito definita Costituente, durerà in carica 12 mesi,
salvo prorogatio per un massimo di 6 mesi.
Tale prorogatio sarà deliberata dalla Costituente stessa qualora lo reputino necessario
almeno 1/3 dei componenti.
Art. 5 - (Finalità)
La Costituente dovrà, nel termine massimo di 18 mesi dall'insediamento, provvedere
alla stesura ed approvazione della nuova Carta Costituzionale e deliberare tutte le norme
integrative che la nuova formulazione del dettato costituzionale dovesse richiedere.
In particolare potrà emanare leggi in materia elettorale e norme per il funzionamento
dei principali organi costituzionali.
Art. 6 - (Composizione)
L'Assemblea Costituente sarà composta da (50/75/100/...) membri.
La carica di membro della Costituente è incompatibile con ogni tipo di carica elettiva
pubblica di qualsiasi ordine e grado.
I membri della Costituente non potranno partecipare a competizioni elettorali di
nessun ordine e grado nazionale o internazionale per almeno un triennio né, per lo stesso
termine, potranno essere chiamati a far parte di alcun organismo istituzionale nazionale o
internazionale
Art. 7 - (Metodo elettorale)
I membri saranno eletti con metodo proporzionale puro su base nazionale.
La scheda elettorale presenterà il simbolo della lista ed una riga sulla quale sarà
possibile indicare il nome del candidato preferito.
Saranno considerate valide sia le schede che riporteranno la croce sul simbolo del
partito sia quelle che evidenzieranno la croce sul simbolo e l'indicazione del candidato sia
quelle che conterranno la sola indicazione del candidato.
E' concesso di indicare, in alternativa al nome del candidato il relativo numero di
graduatoria all'interno della lista.

Le liste dovranno avere un minimo di 30 candidati ed un massimo di 200.
Art. 8 - (Presentazione delle Liste concorrenti)
Potranno concorre all'elezione tutti i partiti ed i movimenti che, avendo raccolto
3.000 firme in almeno il 50% delle Regioni Italiane, depositeranno le liste corredate delle
certificazioni al Ministero dell'Interno.
Potranno presentare proprie liste e concorrere all’elezione nell’ambito dei collegi
proporzionali le liste di movimenti o partiti legati a particolari realtà di minoranza etnica e
culturale operanti nelle regioni a Statuto Speciale.
Potranno, altresì, essere presentate liste che abbiano raccolto un numero di 30.000
firme anche se non distribuite all’interno di tutto il territorio nazionale.
La consegna delle liste potrà avvenire anche tramite posta celere o corriere espresso,
facendo fede la data di spedizione e non quella di ricezione.
Il termine ultimo per la consegna delle liste sarà di 75 giorni prima
dell'appuntamento elettorale.
Art. 9 - (Contestazioni)
A partire dal 15 giorno successivo alla scadenza del termine per la spedizione o
consegna delle liste e dei relativi simboli, inizierà la campagna elettorale
Eventuali contestazioni per questioni relative a similitudini troppo accentuate dei vari
simboli elettorali dovranno essere notificate entro 5 giorni dalla ricezione.
i simboli contestati potranno essere sostituiti entro 5 giorni dalla comunicazione della
contestazione.
Art. 10 - (Dovere di informazione)
Dal momento in cui inizia la campagna elettorale, è fatto obbligo all'emittente
pubblica di fornire l'adeguata informazione relativamente ai simboli concorrenti
all'elezione, ai capilista e, soprattutto, alle differenti proposte di riforma costituzionale.
Per far questo, il C.d.A. dell'emittente pubblica, in accordo con la Commissione
parlamentare di vigilanza, stabilirà un calendario di trasmissioni di informazione,
concedendo pari tempo e pari opportunità a tutte le liste concorrenti.
In particolare dovrà essere garantito a tutte le liste un tempo minimo di 90 minuti
continuativi nelle ore di massimo ascolto per consentire l'esposizione dettagliata delle

proposte costituzionali e delle leggi complementari, in particolare quelle relative al sistema
elettorale ed agli organi di garanzia costituzionale.
Negli ultimi 5 giorni precedenti il voto, l'emittente pubblica dovrà garantire il
massimo di informazione sia nei notiziari sia incrementando gli spazi a disposizione,
rispettando i principi di equal time e di par condicio.
Qualora l'emittente radiotelevisiva pubblica ritardasse ad adeguarsi a tali disposizioni
e non fornisse il palinsesto di massima entro l'inizio della campagna elettorale, sono
previste le seguenti sanzioni:
a) rimozione dall'incarico del Consiglio di Amministrazione, del Direttore
Generale e dei direttori delle reti televisive.
b) Immediato Commissariamento della società per garantire l'immediata
attuazione della legge con ripristino dei nuovi organi amministrativi ed organizzativi
entro 10 giorni dalla sostituzione dei precedenti.
Tutte le emittenti private, titolari di una concessione pubblica, saranno tenute a
fornire spazi di informazione sui temi costituzionali ed elettorali.
Dovranno essere rispettati i criteri di equal time, diritto di rettifica, ripristino di pari
opportunità qualora alcuni soggetti concorrenti si ritenessero danneggiati o oggetto di
discriminazione.
Potrà essere predisposto un palinsesto generale che, presentando la programmazione
dei 45 giorni dei campagna elettorale, garantisca i principi più volte citati di equal time.
Art. 11 - ( Finanziamento della campagna elettorale)
Al fine di garantire la pari opportunità di circolazione delle proposte, quindi la
pubblicazione dei testi di costituzione proposta, verrà concesso un contributo massimo, una
tantum, di 1.500.000.000 (unmiliardo e cinquecentomilioni) ad ogni lista concorrente
dietro presentazione della documentazione relativa al costo di stampa e di spedizione delle
proposte elettorali.
Potranno essere utilizzati spot televisivi, radiofonici e messaggi promozionali su
carta stampata.
Le emittenti televisive, radiofoniche e le testate giornalistiche dovranno rendere
pubbliche le tariffe e garantirne l'applicazione a tutti i concorrenti senza possibilità di
scelta.

Sarà concesso un credito d'imposta del 20% del mancato introito alle emittenti
televisive e radiofoniche avente caratteristica di emittente locale e non nazionale che
concederanno uno sconto minimo del 30% sulle tariffe medie nazionali.
Saranno applicate sanzioni pecuniarie alle emittenti che non si atterranno a tali
disposizioni.
Organo incaricato di garantire il rispetto di tali disposizioni è la Commissione
parlamentare di Vigilanza in collaborazione con l'Ufficio del garante per l'editoria.
Art. 12 - (Indizione delle Elezioni)
Le elezioni avverranno entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Le elezioni si svolgeranno in un'unica giornata festiva.
Il Governo indicherà la data delle elezioni non oltre 10 giorni successivi la
pubblicazione sulla G.U. della legge
Le liste interessate a partecipare alla consultazione popolare per la riforma della
Costituzione, potranno iniziare a raccogliere le firme, necessarie per partecipare alla
competizione elettorale, a partire dal 120ò giorno prima della data delle elezioni.
L'emittente radiotelevisiva pubblica è tenuta a dare ampio risalto e la dovuta
informazione sia sulla necessità di firmare per la presentazione delle liste, sia per illustrare
le posizioni dei singoli partiti e movimenti.
Qualora si verifichino episodi di disinformazione o di scarsa attenzione, potranno
scattare le sanzioni previste dall'art. 7 comma 5.
Art. 13 - (Prima convocazione dell’Assemblea Costituente ed organi di gestione)
L'Assemblea Costituente sarà riunita 5 giorni dopo il termine le operazioni di
scrutinio e la convalida dei risultati elettorali.
Sarà chiamato a presiederla il membro più anziano.
L'Assemblea nominerà immediatamente i propri Presidente e gli organi di controllo.
Potranno essere costituite sottocommissione per settori e problematiche, le quali
avranno sempre compiti referenti e mai deliberanti.
Le sedute sono valide se è presente almeno il 50% dei membri.
Decadono dall'incarico coloro che sono assenti non giustificati per più di 5 giorni
consecutivi o per un totale di 20 giorni.

In sede regolamentare potranno essere adottati opportuni provvedimenti contro
pratiche ostruzionistiche e fraudolente.
Art. 14 - (Modalità di delibera)
I singoli articoli saranno discussi ed approvati a maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto.
La votazione finale per deliberare l'approvazione definitiva della nuova Costituzione
richiede la maggioranza di 2/3 dei componenti.
Qualora non sia possibile ottenere tale maggioranza qualificata, la nuova carta
Costituzionale verrà comunque approvata con la maggioranza del 51% del aventi diritto.
In tal caso sarà possibile indire un referendum popolare per la convalida o meno
della nuova Carta qualora lo richiedano 500 mila cittadini, 5 consigli regionali o 1/3 dei
membri del Parlamento.
L'Assemblea Costituente potrà prevedere regimi transitori, gradi d'attuazione e
politiche di raccordo fra le situazioni vigenti e quelle in fieri.