Lezione 05 (27-11-06) Immunologia
-
Upload
manuela-orani -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Lezione 05 (27-11-06) Immunologia
-
8/7/2019 Lezione 05 (27-11-06) Immunologia
1/8
Lezione del 27-11-2006 [ I ora ] fatta da Giuseppina Giau
Abbiamo fatto una panoramica generale del sistema immunitario, delle sue componenti, in particolare di quelle
specifiche, linfociti T, linfociti B, immunoglobuline e delle modalit di risposta.
Le modalit di risposta sono una immunizzazione attiva e una passiva, e in base alla qualit della risposta pu essere
prevalentemente umorale, cio mediata da anticorpi, oppure prevalentemente cellulare.
Lunica componente solubile molecolare e specifica del sistema immunitario sono le immunoglobuline cherappresentano delle glicoproteine presenti nel sangue circolante, negli interstizi e, a seconda della classe, anche nelle
secrezioni e che mediano degli effetti di risposta nei confronti di un antigene a cui esse si legano per riconoscimento
specifico.
Le immunoglobuline rappresentano, anche nella variante di membrana, il recettore per lantigene dei linfociti B.
Quindi le immunoglobuline possono essere o recettori di membrana (sulla membrana dei linfociti T il loro compito
principale quello di riconoscimento specifico), oppure molecole solubili effettrici che mediano la risposta di difesa.
Abbiamo visto come sia possibile avere tanti cloni linfocitari B dotati ciascuno di una propria specificit per un
antigene distinto, e come questo fenomeno nasca dal fatto che per una catena polipeptidica, non c un unico gene che
codifica, ma c un gene che codifica per la parte costante della catena; tre segmenti genici che ricombinati vanno a
formare un unico segmento genico che codifica per la parte variabile della catena pesante; e naturalmente un altro gene
per la catena leggera.
La generazione di diversit che caratterizza la specificit del sistema immunitario. quindi resa possibile dalla presenzadi numerosi segmenti genici che si ricombinano tra di loro in modo variabile e random, dallaggiunta o eliminazione di
nucleotidi nei punti di ricombinazione, dalla combinazione tra la variabilit che si crea con la catena pesante e quella
leggera che si combinano tra di loro.
Per i linfociti T il problema analogo, infatti anche i T hanno dei recettori di membrana formati da un eterodimero alfa-
beta o gamma-delta, e anche nellambito di queste catene abbiamo una parte costante e una parte variabile. La parte
variabile quella che insieme alla parte variabile della seconda catena forma il sito di combinazione dove per il
ligando non semplicemente lantigene o il peptide, ma il peptide pi una molecola definita HLA, posta sulla
superficie della cellula che presenta lantigene.
La generazione di diversit per quanto riguarda il recettore dei T analoga a quella dei B, segue gli stessi meccanismi,
la differenza st nel fatto che non esiste un recettore dei T solubile, quindi solo recettore di membrana e ha solo
funzione di riconoscimento.
I recettori dei B, quindi le immunoglobuline di membrana, una volta lasciato lorgano linfatico primario, se incontrano
lantigene specifico, danno luogo allattivazione del linfocita e nellorgano linfatico secondario si hanno dei fenomenidi ipermutazione somatica che ne aumentano laffinit.
Questo per i T non avviene ed infatti rimane identico a quello che era presente quando il T stesso aveva lasciato il timo.
Arrivati a questo punto, abbiamo visto che c una differenza sostanziale nella modalit di attivazione dei B e dei T, il B
infatti pu riconoscere molecole di natura chimica variabile, molecole NAIV, molecole non processate libere nel
contesto e, soprattutto molecole che mantengono una loro conformazione sterica; il T invece pu essere attivato e pu
riconoscere il proprio antigene solo come oligopeptide lineare, posto nel contesto delle molecole di istocompatibilit di
prima e seconda classe, molecole di superficie cellulare.
Le molecole MHC, sono codificate da geni presenti nella linea germinativa; ci sono geni che codificano per lMHC di
classe prima e geni che codificano per lMHC di classe seconda.
Sia le molecole di classe prima che le molecole di classe seconda sono presenti sulla membrana cellulare. Esiste una
terza classe di geni MHC che codifica invece per delle molecole solubili, che quindi non sono coinvolte nella
comunicazione cellula-cellula, e nel riconoscimento-presentazione dellantigene.
Molecole di I e di II classe.
I geni di classe 1 sono geni che codificano per una catena alfa, la quale formata da tre domini, (alfa1, alfa2, alfa3) e
che, assemblata alla beta 2 microglobulina, d luogo alla molecola di prima classe.
I geni di seconda classe invece danno luogo a molecole alfa e a molecole beta, quindi catene polipeptidiche alfa e beta,
che assemblate tra di loro formano leterodimero che caratterizza la molecola HLA di seconda classe.
Le molecole di prima classe sono formate da due catene polipeptidiche, una catena alfa, codificata da un gene del
sistema MHC, e una beta 2 microglobulina (questa sempre uguale in tutte le molecole HLA di prima classe e non
codificata da geni MHC); mentre ambedue le molecole che costituiscono i geni di seconda classe, sono codificate da
geni MHC di seconda classe per lappunto.
Si arrivati ad identificare il sistema MHC attraverso lo studio del rigetto dei trapianti. Il trapianto non qualcosa di
fisiologico. La funzione del sistema non quella di determinare il rigetto dei trapianti, ma quella di consentire la
comunicazione tra le varie strutture dellorganismo e le cellule T, quindi cellule specifiche.
Nelluomo il locus MHC situato sul cromosoma 6, nel quale c unamplificazione, e si pu vedere la disposizione dei
geni di classe seconda, geni di classe terza e geni di classe prima.
-
8/7/2019 Lezione 05 (27-11-06) Immunologia
2/8
Per quanto riguarda la classe prima ci sono una variet di geni, anche di pseudogeni che non vengono espressi, o di geni
che vengono espressi solo in fasi particolari.
I geni classici, che danno luogo alle molecole classiche HLA di prima classe sono rappresentati dallHLA-A, lHLA-B
e lHLA-C. Qui presente un altro gene e cio il gene dellemocromatosi. Abbiamo altre molecole non classiche, per
esempio lHLA-G che viene espressa solo sulla faccia materna della placenta, quindi durante la gravidanza ed ha una
sua funzione particolare.
Questi geni codificano per delle molecole che sono formate da una catena alfa e una beta 2 microglobulina, e questemolecole sono espresse su tutte le cellule nucleate. Quindi tutte le nostre cellule, eccettuati gli eritrociti, hanno sulla loro
membrana, sia pure con densit diversa, le molecole di prima classe.
Il locus per le molecole di seconda classe presenta vari tipi di geni, alcuni che codificano per le molecole espresse sulla
superficie come lHLA DP; per avere la molecola completa dobbiamo avere il prodotto di due geni (un gene codifica
per una sola catena) che codificano per due catene: DP alfa e DP beta che si combinano a formare lantigene. Abbiamo i
geni HLA-DP, HLA-DQ e HLA-DR, ricordando che ciascuno di questi esiste come gene che codifica per la catena alfa
e come gene che codifica per la catena beta. Ci sono altri geni che hanno importanza non come codificatori di molecole
di membrana, ma come geni che codificano per molecole che sono importanti nel complessivo processo che porta alla
degradazione dellantigene e poi alla sua esposizione sulla membrana nellambito delle molecole. Tra queste abbiamo
ad esempio i TAP 1 e 2 e i TM(?).
Quindi sono presenti molecole di membrana e molecole importanti per il complessivo funzionamento del sistema di
processazione ed esposizione.
Molecole di III classe.
Sono molecole solubili, quindi non coinvolte nella comunicazione cellula-cellula, ma sono comunque molecole che
hanno il loro rilievo nel sistema immunitario perch alcuni geni codificano per degli enzimi.
Nel sistema MHC sono presenti i geni che codificano per la frazione C4 del complemento, per quella C2, per il fattore
B, un fattore del complemento della via alternativa; quindi per componenti che entrano nella risposta immunitaria.
Abbiamo ancora geni che codificano per varie hot shock protein, per il tumor necrosis factor alfa e per le linfotossine A
e B.
Caratteristica di questo locus genico che viene ereditato in blocco, in pratica a questo livello non c crossing over tra
i cromatidi materno e paterno e quindi ciascuno di noi eredita senza modifiche, il locus paterno sul cromatide paterno e
quello materno sul cromatide materno, senza che vi sia stato scambio di materiale tra i due. Questo comporta,
rifacendoci per esempio allHLA di prima classe, che il pi semplice, che ciascuno di noi ha geni che codificano per
HLA-A, HLA-B e HLA-C, sul cromatide di origine paterna e su quello di origine materna, quindi ciascuno di noi
identificato da sei geni HLA, due HLA-A, due HLA.B, due HLA-C.Per i DP, DQ e DR un po pi complesso e il numero va anche moltiplicato per le possibili combinazioni tra catena
alfa e catena beta, per cui alla fine ognuno di noi identificabile attraverso una ventina di molecole HLA di seconda
classe.
Se andiamo a vedere lincrocio madre-padre ed le possibili risultanti nella prole, vediamo che c il 25% di possibilit
che due fratelli siano HLA identici, naturalmente non solo per un HLA ma per tutti i geni che sono contenuti nel locus
MHC, prima, seconda e terza classe. Quindi in base alla combinazione dei cromatidi si possono avere due fratelli(che
non sono gemelli monozigoti), che siano perfettamente identici. Questo di fatto un fenomeno random, non
programmabile, e viene talvolta sfruttato nel caso uno dei due fratelli necessiti di trapianto.
Una caratteristica del sistema HLA lelevato polimorfismo dei suoi geni, cio per ciascun locus genico, si possono
avere molti alleli. Il massimo di polimorfismo si ha per la catena beta del DR, per lHLA-B e anche per lHLA-A.
In realt non che cambi tutta la catena, non c una differenza totale tra un allele e laltro, ma le differenze si limitano
a delle zone critiche.
Queste zone critiche sono rappresentate fondamentalmente dalla parte della molecola che accoglie e presenta il peptidee che viene riconosciuta anche dai recettori dei T. Se consideriamo le molecole di prima classe, la parte che rappresenta
la catena alfa, con i suoi domini alfa 1 e alfa 2, accoglie il peptide, quindi la parte che varia tra lHLA-A1 o A7 e A13,
non tutta la catena, ma sono solo alcuni aminoacidi coinvolti in un caso nellaggancio del peptide, e nellaltro nel
riconoscimento da parte dei T. Idem per le due molecole che formano la molecola di classe seconda.
Quindi il grosso della variabilit la avremo a livello dei domini beta1 e alfa1, in modo particolare nelle zone che
formano la zona di aggancio del peptide e la zona di riconoscimento per i T.
Le molecole di prima e seconda classe fanno parte della superfamiglia delle immunoglobuline, abbiamo gi visto le Ig,
TCR e stiamo vedendo MHC.
Stiamo parlando di una molecola di prima classe e la zona colorata in rosso quella che cambia da un allele allaltro
nella singola molecola, che sia A, che sia B, che sia C ed quella che serve che cambi perch consente una grossa
differenziazione tra un individuo e laltro e garantisce che a livello di specie ci sia una tale diversit nella molecola che
accoglie e presenta il peptide, in modo da assicurare comunque una buona risposta a tutti gli antigeni.
E importante non confondere le molecole HLA con le molecole recettoriali specifiche dei T e dei B. E vero che queste
hanno una maggiore o minore capacit di legare alcuni peptidi rispetto ad altri, per anche vero che ciascuna di queste
molecole pu accogliere in tempi successivi peptidi diversi tra di loro esponendoli in modo pi o meno efficace, quindi
-
8/7/2019 Lezione 05 (27-11-06) Immunologia
3/8
non si deve confondere con il TCR. Stesso discorso si pu fare per le catene, in modo particolare le beta, che presentano
il polimorfismo maggiore; i puntini rossi sui foglietti beta che formano il pavimento della zona che accoglie il peptide,
rappresentano gli aminoacidi chiave per laggancio del peptide, mentre i puntini rossi che sono posti sulle alfa eliche
che delimitano lateralmente e superiormente la tasca di accoglimento del peptide, rappresentano le zone che sono
riconosciute dal recettore dei T.
La variabilit allelica quindi legata soprattutto alla zona critica della molecola.
Daltra parte ci sono degli alleli dove lunica variazione legata ad un singolo aminoacido, il quale pu per fare unagrossa differenza. Ecco questa la molecola HLA, e questi sono i punti dove viene agganciato in pratica il peptide
grazie ad una interazione tra aminoacidi dellHLA e residui di aminoacidi del peptide stesso. Il riconoscimento avviene
su questi aminoacidi esposti verso lalto e su quelli laterali dellHLA stesso.
Quindi per le molecole di prima classe abbiamo: un riconoscimento da parte del T che va su nelle pareti laterali, ai bordi
della tasca che accoglie il peptide ed il peptide stesso in esso contenuto. Nell antigene di prima classe il peptide di
otto/dieci aminoacidi, quindi abbastanza piccolo ed contenuto interamente allinterno della tasca stessa; in quello di
seconda classe, il peptide pu arrivare anche a trenta aminoacidi quindi, essendo decisamente pi voluminoso, spesso le
sue estremit fuoriescono dalla tasca stessa.
Ricapitolando: le molecole di prima classe (HLA-A, HLA-B, HLA-C) sono presenti su tutte le cellule nucleate; le
molecole di seconda classe (HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR) sono costitutivamente espressi su cellule professionali
presentanti lantigene. Queste cellule sono tre: linfociti B, cellule dendritiche e macrofagi/ monociti; questi
costitutivamente esprimono anche le molecole di seconda classe.
Altre linee cellulari possono essere indotte a trascrivere e quindi a sintetizzare le molecole ed esprimerle, percostitutivamente questa una prerogativa solo di queste tre line cellulari.
Struttura.
La catena alfa codificata da un gene dellMHC pi la beta 2 microglobulina, sia la catena alfa che la beta sono tutte e
due codificate da geni MHC; il peptide presenta in un caso fino 8-11 aminoacidi, in un altro fino a trenta;
Presentazione.
Gli MHC di prima classe presentano ai linfociti T CD8 positivi; quelli di seconda classe ai linfociti T CD4 positivi.
Durante la maturazione a livello del timo dei linfociti T, man mano che progredisce la sintesi e lespressione del
recettore dei linfociti T si ha anche la trascrizione di geni che codificano per altre molecole e nella maturazione di
queste cellule possibile identificare per quanto riguarda i CD4 e i CD8 una fase doppio negativa, quando la cellula
molto immatura, e successivamente una fase doppio positiva cio CD4+, CD8+ .Solo alla fine la cellula matura
sopprime la trascrizione di uno dei due geni e si ha o una cellula T CD4+, o alternativamente una cellula T CD8+.
Questa differenza si rispecchia anche funzionalmente nel fatto che le cellule CD8+ sono quelle che riconosconolantigene nel contesto della molecola di prima classe, mentre le cellule CD4+ sono quelle che sono in grado di
riconoscere lantigene nel contesto delle molecole di seconda classe.
Le molecole di prima classe vengono espresse in pratica in tutte le cellule meno gli eritrociti, mentre le molecole di
seconda classe sono presenti costitutivamente ad alta densit sui linfociti B, sulle cellule dendritiche, sulle cellule
epiteliali del timo e sui macrofagi. Possono essere indotte nel linfocita T attivato o anche su altre cellule. Indotte
significa che arriva uno stimolo alla cellula (per esempio determinate interleuchine, citochine), che a livello nucleare
attiva la trascrizione del gene per lHLA di seconda classe, anche in cellule normali (ad esempio in cellule epiteliali).
27 NOVEMBRE 2006 2 ora
Ripartiamo da questa tabellina sulle caratteristiche delle molecole di 1 e di 2 classe e andiamo al 4 punto, cio il
legame del peptide; non solo ci sono delle differenze nella dimensione del peptide che viene legato ma soprattutto, ciche fa differenza la provenienza del peptide che viene esposto,nella molecola di 1classe,quella che espone un peptide
che viene riconosciuto dal CD8; il peptide di origine endogena cio un peptide che deriva da una proteina
sintetizzata allinterno della cellula; non dovete confondere endogeno con self ed esogeno con non-self.
Endogeno ed esogeno si riferiscono solo al limite della membrana cellulare,linterno e lesterno alla cellula poi
una proteina endogena pu essere self e non-self e lo stesso vale per una proteina esogena. Questo un concetto
da chiarire.
Per quanto riguarda lMHC di 2 classe invece sono peptidi che derivano da proteine esterne alla cellula che sono state
endocitate dallesterno,che sono state degradate e poi, i peptidi derivati sono stati caricati sulle molecole di 2classe.
Quindi:
-differenza di struttura tra molecole di 1 e di 2 classe
-
8/7/2019 Lezione 05 (27-11-06) Immunologia
4/8
-
8/7/2019 Lezione 05 (27-11-06) Immunologia
5/8
Si ha:
-captazione delle proteine extracellulari nei compartimenti vescicolari;
i macrofagi sono cellule fagocitiche,le cellule dendritiche sono dotate di recettori di vario tipo che consentono la
captazione del materiale pur non avendo esse attivit fagocitarla e i linfociti B captano attraverso le molecole
immunoglobuliniche,quindi il loro campionamento dallesterno un campionamento specifico cio, le Ig una voltalegato lantigene attivano un processo di endocitosi che include le Ig con lantigene ad essa legato e che d origine
quindi a questa processazione e le trasforma infine in cellule presentanti lantigene linfociti T.
Questo il meccanismo:
processazione della proteina internalizzata, biosintesi e trasporto delle molecole MHC,catene ALFA e
BETA,assemblaggio delle 2 catene e caricamento della catena invariante (che nellimmagine ha il colore violetto) infine
trasporto attraverso il Golgi e poi si ha la fusione del vacuolo lisosomiale e lesposizione della catena invariante agli
enzimi proteolitici che scindono la parte esposta,rimane il CLIP che viene praticamente sottratto grazie al (colpo di
tosse non si sentito) e viene sostituito col peptide cosiddetto IMMUNODOMINANTE che deriva da uno dei peptidi
che derivano dalla proteina iniziale.
A questo punto si pu avere lesposizione e il riconoscimento da parte del linfocita T CD4 POSITIVO.
Mostra unaltra immagine che un dettaglio sul meccanismo attraverso cui lHLADL riesce a rimuovere il CLIP e a
permettere il caricamento dei peptidi.
Mostra unaltra immagine che riguarda il processing di antigeni endogeni,qui viene proposto un esempio di antigene,di
proteina endogena che non self, non pu penetrare nella cellula neanche fagocitato da una cellula per il suo
genoma,una volta integrato nel genoma della cellula codificher per proteine che non sono self, sono proteine virali,
per sono codificate dallapparato protido-sintetico della cellula.
Le proteine, in parte vengono targate(si mette unetichetta,target) con delle proteine dette UBIQUITINE che permettono
la loro localizzazione,cio praticamente da proteina tridimensionale viene trasformata in una proteina lineare ed avviataa strutture citoplasmatiche chiamate PROTEOSOMI.
Il proteosoma campiona e scinde enzimaticamente sia le proteine normali che quelle anormali:quelle self e quelle non-
self e la finalit ultima quella di avere il materiale proteico che viene sintetizzato dalla cellula sempre esposto al
controllo dei linfociti T CD8 POSITIVI.
Una cellula che muta il suo DNA potr produrre una proteina che non pi self perch una proteina codificata da geni
mutati quindi sia che ci sia la penetrazione di materiale genico esterno siaINTERRUZIONE PER RIMPROVERARE
GENTE
Il punto chiave del processo che: i peptidi che escono dal proteosoma sono nel citoplasma e devono entrare nel
reticolo endoplasmico dove vengono sintetizzate le molecole di 1 classe.
Questo possibile perch ci sono delle strutture che sono chiamate TAP, sono delle proteine che attivano il trasporto
dal citoplasma verso il reticolo endoplasmico quindi consentono lingresso dei peptidi stessi,il caricamento sulle
molecole nel Golgi e il solito vacuolo e la solita esposizione quindi in questo caso PROTEINE DI SINTESI
CELLULARE che potevano essere self e non-self.
Voi dovete immaginarvi il sistema immunitario, come tutti i sistemi biologici, come qualcosa di dinamico,di
continuo,che continuamente sintetizza,sostituisce,si adatta e NON come una fotografia.
Tutte le nostre cellule sintetizzano continuamente proteine che vengono campionate,linearizzate,caricate ed esposte; se
le proteine sono normali non c nessun attivazione, se la proteina non normale c lattivazione.
-
8/7/2019 Lezione 05 (27-11-06) Immunologia
6/8
Poi lanormalit pu essere legata ad una mutazione neoplastica a a un virus; quindi un sistema di controllo costante
viene effettuato su tutte le cellule dellorganismo perch tutte espongono lHLA di 1 classe e tutte sono ispezionabili
da parte del CD8.
Le proteine TAP sono codificate da geni presenti nel sistema HLA(NHC per gli altri animali) e non codificate permolecole di superficie ma per molecole che sono comunque fondamentali nel processing e nella disposizione dellHLA
per il peptide.
Adesso iniziamo a parlare partendo non pi dalla molecola di 1 o di 2 classe ma possiamo vedere il processo
partendo dal COMPARTIMENTO CELLULARE che da un punto di vista finalistico anche pi logico cio se
lantigene,il peptide antigenico, presente nel citoplasma allora la molecola deputata a legarla quella di 1 classe e la
cellula deputata a rispondere quella CD8, il cosiddetto citokiller, immediatamente(dopo il riconoscimento) ha la
funzione effettrice che quella di uccidere la celllula infetta o mutata.
Se lantigene arriva attraverso le vescicole fagocitiche alcuni di questi patogeni che vengono fagocitati non solo non
muoiono, ma sopravvivono allinterno dei fagociti e li sfruttano per difendersi dai meccanismi di difesa, per esempio il
Mycobatterio uno di questi;
Questi peptidi vengono intercettati e presentati tramite molecole di 2 classe e le cellule deputate alla loro
identificazione e alla risposta sono le cellule CD4 POSITIVE .
Il tipo di risposta che il CD4 d in questi casi prevalentemente cellulo-mediato e utilizza i macrofagi che quindi
fagocitano,presentano e a loro volta vengono attivati dalla cellula a cui hanno presentato, quindi si completa un circuito
di difesa; il macrofago attivato che viene detto anche armato o corazzato dallinterazione con il Linfocita T migliora le
proprie capacit di killing cos pu provvedere(quando ci riesce) alleliminazione del patogeno; poi ci sono le vescicole
endocitiche, per esempio quelle che si creano quando il linfocita B capta lantigene e lo porta allinterno insieme al
recettore, sono proteine extracellulari captate per endocitosi e vengono caricate su molecole di 2classe e anche queste
derivano dallesterno per vengono riconosciute dal CD4,questo per seleziona un meccanismo diverso di risposta che
quello che potenzia e attiva la risposta attraverso i linfocitiB, quindi la sintesi di anticorpi; daltra parte se il patogeno
extracellulare gli anticorpi non servono a niente, c la finalit,la selezione di un tipo di risposta rispetto ad unaltra,
funzionale alle esigenze di mantenimento dellomeostasi.
Riassunto di ci che abbiamo visto:
attivazione dei macrofagi,distruzione dei microbi fagocitati quando abbiamo antigeni peptici che derivano dalla
fagocitosi, una presentazione da parte del macrofago(in questo caso come cellula presentante lantigene) al TCD4 che
seleziona un tipo di risposta che porta allattivazione di ulteriori macrofagi e quindi la distruzione dei microbi fagocitati
mentre nel caso dei linfociti T lesposizione ai TCD4 si traduce nella produzione di altre citochine in modo che vengano
attivati i linfociti B stessi che vanno a produrre anticorpi di varie classi a seconda delle citochine prodotte.
In un caso o nellaltro c una fase di attivazione del linfocita T CD4 da parte della cellula presentante lantigene, per
poi c un circuito per cui il linfocita T che stato attivato a sua volta attiva la cellula che gliel ha presentato:ilmacrofago, potenziandone le sue capacit di killing pr il B,indirizzandolo verso la sintesi anticorpale di classe diversa a
seconda delle esigenze.
Infine, per quanto riguarda invece la 1classe tutte le cellule sono presentanti lantigene perch tutti noi abbiamo le
molecole di 1classe sulle nostre cellule e tutti noi esponiamo continuamente i peptici delle proteine che devono essere
sintetizzate, quindi tutte sono suscettibili di determinare,nel caso dellattivazione di CD8, la risposta effettrice del CD8
cio leliminazione della cellula bersaglio se viene riconosciuto un antigene non-self.
Molti patogeni hanno trovato il modo per sottrarsi a questo meccanismo di controllo che in qualche modo sfrutta la
molecola HLA; in questo caso(mostra immagine) per esempio i virus possono agire in vari modi cio un virus pu
cercare di evadere (ESCAPE) i meccanismi di difesa dellorganismo bloccando la sintesi,la trascrizione della molecola
di 1classe, quelle che espongono le proteine virali e che quindi consentono il riconoscimento della cellula infettata dalvirus da parte dei CD8; questo meccanismo pu avvenire a vari livelli, per esempio pu essere bloccato il trasporto dal
citoplasma al reticolo endoteliale, pu essere bloccata la formazione delle vescicole di trasporto o addirittura del
trasporto dal Golgi fino alla superficie; in tutti questi casi il sistema immunitario diventa cieco, non c pi la possibilit
-
8/7/2019 Lezione 05 (27-11-06) Immunologia
7/8
di vedere la proteina virale espressa nella sua cornice cio lHLA di 1classe; questo rappresenta un meccanismo di
evasione da parte del virus che per antagonizzato dal fatto che nel nostro organismo esiste un altro sistema di
riconoscimento aspecifico fatto dalle cellule natural killer che hanno tipi di recettori:
un recettore di attivazione che riconosce i pattern molecolari che sono presenti in tutte le cellule dei mammiferi, e
anche sulle nostre cellule, e quindi queste cellule impegnano questo loro recettore di attivazione con queste molecole
che sono ubiquitarie (ci sono infatti anche nelle nostre cellule normali) per anche dei recettori di inibizione chevengono impegnati contemporaneamente: il segnale che prevale quello di inibizione quindi i natural killer non si
attivano; il ligando con i recettori di inibizione sono le molecole HLA di 1classe quindi, se ci sono le molecole HLA di
1classe sulla superficie di una cellula, sono ispezionabili dal CD8 ma non sono aggredibili dai Natural killer; se, per un
fenomeno di mutazione neoplastica o di evasione attivato da un virus (o altro) la cellula non esprime pi a una densit
soglia le molecole di 1classe, non impegnano quelle di inibizione.
Anche i batteri hanno fenomeni di evasione.
Ora la prof ha detto che nelle diapositive c in piccolo anche la legenda della figura e che si pu espandere.
In questo caso, (mostra una figura) si pu avere innanzitutto un blocco dellacidificazione,poi si pu avere levasione
del vacuolo e il passaggio nel citoplasma,questi sono dei meccanismi(es.Listeria ha questo sistema) che possono portaread un sovvertimento dei normali meccanismi di risposta.
A parte questi fenomeni di fisiologia del sistema immunitario ora parliamo di qualcosa che invece di
FISIOPATOLOGIA, cio, progredendo gli studi sullHLA,facendo gli studi epidemiologici e andando a vedere i vari
aplotipi nelle varie popolazioni si vide che cerano degli aplotipi HLA che erano associati con un maggiore rischio di
contrarre e di sviluppare determinate malattie in particolare malattie autoimmuni mentre altri aplotipi di HLA sono
associati ad una protezione,quindi un rischio minore rispetto a quello della popolazione generale di sviluppare
determinate malattie; ma delle prime, tra quelle identificate, e che tuttora rimane quella pi impressionante quella tra
lHLAB27 e la SPONDILITE ANCHILOPOIETICA che una malattia reumatologica (che farete pi avanti).
L87,4 % dei soggetti che hanno lHLAB27 sviluppano la malattia per c sempre una quota negativa quindi
sicuramente non lunico fattore; unaltra associazione importante quella tra diabete mellito insulino-dipendente di
1tipo e lHLA DR4 e DQbeta1, queste sono singole variazioni amminoacidiche, comunque arriva ad avere un 9,5 di
fattore di rischio.
La Sardegna particolarmente colpita da questi fenomeni, una questione di isolamento geo-politico, in certe zone la
popolazione un po segregata geneticamente e quindi c un elevata prevalenza di certi aplotipi rispetto ad altre zone
della stessa Sardegna e soprattutto dellItalia continentale,questo si associa ad unaumentata prevalenza di malattia
come il diabete mellito insulino-dipendente di 1tipo, la malattia celiaca,la sclerosi multipla..
Come mai questa associazione?
Queste molecole sono la cornice,il mezzo, attraverso cui vengono attivate le cellule chiave del sistema
immunitario,soprattutto il CD4 quindi se io ho una cornice che mi presenta lo stesso quadro ma questa cornice pi
stretta,pi luminosa o pi nera la lettura complessiva sar diversa da un soggetto allaltro; se io ho il DR3 e non ho ilDR4, il peptide che deriva dalla stessa proteina sar un po diverso come complesso di DR3 peptide rispetto a
DR4peptide; il problema sta sempre nella modalit di riconoscimento, daltra parte in certi soggetti che hanno
determinate molecole soprattutto di 2classe,il complesso molecola di 2classe-peptide pu anche determinare delle
situazioni di mimica molecolare tra peptici self e non-self ed MHC e quindi innescare una reazione autoimmune,
comunque la vedrete pi avanti in profondit;questo un aspetto molto interessante legato alla funzione fisiologica
delle molecole HLA.
Qui c un po una sintesi(mostra immagine),ogni molecola MHC,ricordatevi, un peptide alla volta per in tempi
successivi una singola molecola MHC presenta diversi peptidi,(cio peptidi diversi tra loro);sulla superficie di una
cellula le nostre molecole di 1 e di 2 classe (che tappezzano questa superficie) presentano grande variet di peptidi per
cui siamo un mosaico di antigeni che sono presentati ai CD8 e ai CD4 dalle molecole di 1 e di 2 classe.
Lampia specificit consiste nel fatto che possano legare i vari tipi,hanno un tasso di dissociazione abbastanza
lento,questo importante perch il fatto che il peptide venga tenuto in sede per un tempo sufficiente garantisce che il T
una volta che incontra il suo antigene specifico possa essere attivato.
-
8/7/2019 Lezione 05 (27-11-06) Immunologia
8/8
Le molecole MHC legano solo peptidi,le molecole classiche.
Andiamo agli aspetti di tipo genetico,sono ovviamente co-dominanti,vengono espressi sia gli alleli presenti su un
cromosoma e sia quelli presenti sullaltro cromosoma,sono polimorfi,presenza di molti alleli; la variabilit fra gli alleli
legata soprattutto a variazioni della sequenza a livello della zona del peptide che viene a contatto con il TDC3 e infine i
tipi cellulari che esprimono lMHC: tutte le cellule nucleate, quelle di 1classe, poi costitutivamente solo le APC
professionali cio macrofagi,linfociti B e cellule dendritiche.
I linfociti GAMMA-DELTA:
anche a livello del timo questi riescono a sintetizzare e esprimere il loro recettore DELTA e il recettore
GAMMADELTA, non esprimono di norma n CD4 e n CD8, hanno una linea di maturazione che a s stante. Sono il
50% dei linfociti e sono distribuiti soprattutto verso le superfici di contatto con lesterno:mucosa per esempio e anche
cute.
I linfociti T GAMMA DELTA non riconoscono lantigene nel contesto di molecole HLA, n di 1 n di 2 classe ,ecco
perch non hanno n CD4 e n CD8, (per stabilizzare il legame con la molecola di 1 o di 2 classe) riconoscono
almeno, per quello che si sa al momento, degli antigeni lipidici, almeno nel contesto di una molecola non classica
(HLA) che viene definita CD1.
La struttura ricorda la famiglia delle Ig (nellimmagine le mostra) con un piano sagittale e con un piano
trasversale,mostra la zona dove viene accolto il lipide o il glicolipide e si visto che comunque il recettore dei
GAMMADELTA un recettore che ha una terza variabilit cio quella tipica degli ALFABETA, si considera cos
come una classe di linfociti s specifica, per deputata a un primo intervento in attesa che possano essere
attivati(attraverso la processazione dellantigene che comunque richiede tempo) direttamente anche attraverso delle
strutture non proteiche che vengono captate e caricate sul CD1 e poste allinterno, questo sembra confermato dal fatto
che sono soprattutto sistemati nelle zone di 1contatto con lesterno.
Mostra immagine
Il CD4 serve a stabilizzare il legame TCR e MHC e il complesso recettoriale con CD3 serve per la produzione delsegnale allinterno della cellula.
Nel CD8 c una situazione analoga nella molecola di 1classe, il legame stabilizzato dal CD8.
CONCETTO DI SINAPSI IMMUNOLOGICA:
per avere unattivazione non basta questo riconoscimento,anzi se questo riconoscimento avviene isolatamente,senza
queste contestuali interazioni cellulari il risultato una risposta di tipo negativo detta TOLLERANZA, per poter avere
unattivazione,una risposta positiva, necessario questo per necessario anche che ci sia un 2 segnale cellula-cellula
dato dallinterazione fra il CD8 sul linfocita T (sia 8 che 4) e il suo ligando che il D71 D72 sulla cellula che presenta
lantigene,sia essa professionale o sia una qualsiasi cellula.
Il punto sta nel fatto che il CD28 i nostri linfociti lo esprimono sempre invece il D71-2 non lo esprimono sempre,anzi,di
norma non lo esprimono proprio:lo esprimono quando arriva materiale microbico,necrosi o altro che attiva, a livello
nucleare delle cellule, la trascrizione e poi la sintesi di questa molecola quindi questo un meccanismo di controllo
sullattivazione dei T.







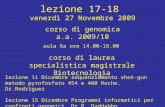

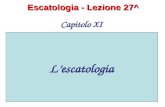






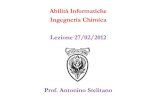

![Lezione 27 Ponti (Pile).ppt [modalità compatibilità] Ponti 2014-15/Lezione 27... · costituita da pila, plinto e pali.](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c65c41209d3f2826e8d1608/lezione-27-ponti-pileppt-modalita-compatibilita-ponti-2014-15lezione-27.jpg)

