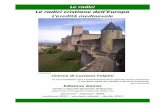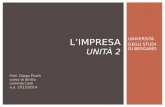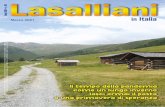Le radici cristiane negli statuti delle regioni italiane
-
Upload
daniele-darpizio -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Le radici cristiane negli statuti delle regioni italiane
97
ETIC
A p
er le
pro
fessio
ni •
3/2
010
Gli Statuti delle Regioni italiane, in seguito all’approvazione delle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del
2001, hanno conosciuto negli ultimi anni una fase di profonda revisione, che non è ancora terminata: a fronte dei dodici testi emanati dalle Regioni ordinarie mancano infatti ancora all’appello quelli di Basili-cata, Molise e Veneto, dove continuano a vigere le carte emanate nel 1971.
Un discorso a parte meritano ovviamente le cinque Regioni a Statuto speciale, il cui procedimento di revisione statutaria pre-vede ancora l’approvazione da parte del Parlamento con legge costituzionale.
Radici, tRadizioni e “cRistianesimi” Regionali
Tra le tante novità che caratterizza-no le nuove normative, una importan-te è che tutte, a differenza di quelle ap-provate dai primi Consigli regionali, ci-tano il fatto religioso e/o spirituale: chi come un bisogno essenziale e come li-bertà dell’uomo che anche la Regione, nell’àmbito delle proprie competenze, è chiamata a facilitare nella sua realizza-zione effettiva (Lombardia) o in qualche modo a preservare e a trasmettere (Um-bria); chi, la maggior parte, nel senso di elemento culturale da riconoscere e va-
lorizzare: rientrano in quest’ultima cate-goria i riferimenti diretti al Cristianesi-mo (Abruzzo, Campania, Liguria, Lom-bardia, Marche, Piemonte e Puglia), e al Cattolicesimo (Lazio).
Lo Statuto che forse dedica lo spazio piú angusto al fatto religioso è quello to-scano che, ponendo tra le proprie “fina-lità prioritarie” «la promozione dei valo-ri della pace, della solidarietà, del dialo-go tra popoli, culture e religioni» (art. 4, lett. r), sembra concepire le religioni co-me fattori di divisione da ricomporre o compensare, piuttosto che beni in sé po-sitivi, da riconoscere e da tutelare giuri-dicamente.
Gli Statuti di Abruzzo e Campania, ema-nati rispettivamente alla fine del 2006 e nel 2009, sono gli unici a parlare espres-samente di “radici cristiane”: lo Statuto abruzzese nell’art. 2 (dedicato ai “Prin-cípi”), ove dichiara che la Regione «rico-nosce i valori delle sue radici cristiane»; la Campania ospita il riferimento nell’art. 4, co. 3 (“Principio di uguaglianza”): «La Re-gione riconosce l’apporto derivante dal-le diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comu-nità campane».
Di tenore analogo lo Statuto lombardo all’art. 2, co. 4, lett. f (“Elementi qualifica-tivi della Regione”), nel quale la Regione
Rispettati i diritti inalienabili garantiti dalla Costituzione nulla vieta che vengano valorizzate le radici culturali, comprese quelle religiose, delle comunità regionali, come già accade nell’ordinamento italiano
Le radici cristianenegli Statuti delle Regioni Italiane
• Daniele Mont D’ArpizioDottore di ricerca in Giurisprudenza
Spazio aperto • Statuti regionali: identità e valori
98
ETIC
A p
er le
pro
fess
ioni
•
3/2
010
La redazione dei nuovi Statuti è stata interpretata dalle Regioni come occasione per riflettere sulla propria identità, colta come imprescindibile dalla fondazione non solo politica, ma anche giuridica dell’ordinamento regionale
Le RaDiCi CRiStiane negli Statuti delle Regioni italiane
Spazio aperto • Statuti regionali: identità e valori
nati quattro - quelli di Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Piemonte - dispongono di un preambolo, i quali fanno tutti riferi-mento al fatto religioso, tre al Cristianesi-mo: l’Emilia-Romagna si dichiara «consa-pevole del proprio patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso»; la Liguria si definisce «area promotrice di valori di libertà e di indipendenza che, dal lontano Medioevo al Risorgimento e alla Resisten-za, si sono sviluppati in armonioso rap-porto con un Cristianesimo di profonda istanza solidale e partecipativa».
Le Marche optano per un riferimento «alla tradizione laica e alla matrice re-ligiosa che hanno segnato la storia del-le Marche», oltre che «al patrimonio sto-rico del Risorgimento, ai valori ideali e politici della Repubblica nata dalla Resi-stenza, ai princípi di libertà, pluralismo e autonomia già sostenuti in seno all’As-semblea Costituente dalle forze laiche e cattoliche regionaliste».
Il Piemonte, nella raffica di gerundi che precedono l’articolato, si riconosce un «pa-trimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale», il quale costituisce la base per il perseguimento del «pluralismo in tut-te le sue forme».
È ovvio che in questi casi alle difficoltà interpretative si aggiunge quella di stabi-lire il valore giuridico del testo in cui so-no inserite le disposizioni(1).
Sono, infine, presenti nelle Carte statuta-rie anche delle disposizioni che prevedono la possibilità, da parte di alcune Regioni (essenzialmente Lazio, Calabria e Lom-bardia), di porre in essere delle forme di collaborazioni con le confessioni presenti sul territorio, nonostante la Costituzione sembri rimettere la competenza esclusiva sui «rapporti tra la Repubblica e le con-fessioni religiose» alla legislazione stata-le (art. 117, comma 2, lettera f)(2).
dichiara di perseguire «sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il ricono-scimento e la valorizzazione delle iden-tità storiche, culturali e linguistiche pre-senti sul territorio».
In altri Statuti il riconoscimento dell’im-portanza della storia religiosa della Regio-ne, o meglio di una determinata visione della stessa, non si esprime in un predi-cato (“riconosce”), bensí assume la forma di una qualificazione.
Tale enunciazione implicita è ravvisa-bile nell’incerta formulazione dello Sta-tuto pugliese, ove si asserisce (art. 1, co. 2) che la Puglia ha una «storia pluriseco-lare di culture, religiosità, cristianità e la-boriosità delle popolazioni che la abita-no» la quale, assieme al «carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul ma-re», ne fa un «ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo ne-
gli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace».
Un caso analogo è rappresentato dal-lo Statuto del Lazio, ove nel primo com-ma dell’art. 5 (“Roma capitale”) si parla di Roma come «centro del Cattolicesimo e del dialogo fra i cri-stiani»; infine, lo Sta-tuto umbro accenna al «patrimonio spi-
rituale, fondato sulla storia civile e reli-giosa» della Regione, senza peraltro cita-re espressamente il Cristianesimo (art. 2, rubricato “Identità e valori”).
Alle disposizioni citate possono essere aggiunte quelle che, pur avendo conte-nuto analogo, non hanno trovato posto nell’articolato bensí in un testo ad esso premesso: sui dodici Statuti fin qui ema-
99
ETIC
A p
er le
pro
fess
ioni
•
3/2
010
Daniele Mont D’arpizio
no riconosciuto come nazionalità stori-ca» (art. 57)(5).
Eppure i dati culturali e identitari, in particolare quelli di origine religiosa, pur essendo ritenuti fondamentali nello stu-dio della sociologia e della scienza poli-tica, faticano ancora oggi a essere presi sul serio in àmbito giuridico. Questo at-teggiamento trova anzitutto spiegazio-ne dalla concezione, molto radicata nel-la scienza giuridica moderna, della nor-ma intesa come comando, mentre l’iden-tità è associata piuttosto alla memoria, e quindi alla struttura propria della narra-zione(6). Tutto ciò che non fosse classifica-bile come comando si collocherebbe, se-condo questa ricostruzione, a monte del-la norma vera e propria e quindi nell’àm-bito del non “giuridico”, non vincolando nemmeno l’interprete(7).
È stato notato come questa posizione sia strettamente connessa da un punto di vista filosofico a una solida base di re-lativismo etico: essa dunque rischia di di-ventare a sua volta portatrice proprio di una di quelle filosofie morali delle quali dichiara di volersi disinteressare(8).
Rispetto alla querelle sulle radici cristia-ne l’aspetto paradossale della posizione di molti esponenti di questa concezione è che essi, sulla base di un principio non scritto - la separazione tra diritto e mora-le - negano valore a disposizioni appro-vate secondo il procedimento previsto, contraddicendo di fatto il loro presup-posto originario.
Rispetto a questa opinione negli ulti-mi tempi però, soprattutto nei Paesi che per primi hanno affrontato i cambiamen-ti della modernizzazione e dell’immigra-zione diffusa, sembrano aver guadagna-to terreno altre posizioni che impostano in maniera meno rigida la riflessione sui rapporti tra ordinamento, identità cul-turali e valori: è il caso del pensiero del
identità e cultuRa negli statuti
Come mai questa fioritura di norme sul fatto religioso? Rispondere non è sempli-ce, visto che riguardo ad esse pare essere mancata una visione chiara degli effetti giuridici in seno agli stessi Consigli regio-nali. La redazione dei nuovi Statuti è sta-ta interpretata dalle Regioni come un’oc-casione per una riflessione sulla propria identità (il termine ricorre in nove dei do-dici nuovi Statuti), percepita come impre-scindibile dalla fondazione non solo poli-tica, ma anche giuridica dell’ordinamen-to regionale, cosí come rinnovato dalle ri-forme del 1999 e del 2001.
Del resto l’attenzione a questi temi, an-che a livello degli enti substatali, non solo non costituisce una novità assoluta per il nostro ordinamento(3), bensí trova raffron-ti in Paesi come la Germania(4) e la Spa-gna, la quale proprio nello stesso perio-do dell’Italia ha conosciuto un analogo rinnovamento degli statuti delle proprie Regioni autonome. Nel sistema iberico le particolarità storiche e culturali, i cosid-detti hechos deferenciales, sono considerati anzi dall’ordinamento come i presupposti ineludibili per la concessione dell’autono-mia; proprio per questo, rispetto a quelli italiani, gli estatutos autonómicos spagnoli si profondono in vere e proprie narrazioni storiche, valorizzando i simboli culturali e identitari delle comunità rappresenta-te: dalla conformazione del territorio al-le peculiarità linguistiche.
Certamente in essi il fatto religioso non è assurto a un ruolo analogo a quello re-gistrato negli Statuti regionali italiani, ma ad esempio il nuovo Statuto valenziano cita espressamente il Real Monasterio de Santa María de la Valldigna come «tem-pio spirituale, storico e culturale dell’an-tico regno di Valenzia», nonché «simbo-lo della grandezza del popolo valenzia-
100
ETIC
A p
er le
pro
fess
ioni
•
3/2
010
Le RaDiCi CRiStiane negli Statuti delle Regioni italiane
Spazio aperto • Statuti regionali: identità e valori
prattutto famiglia, bioetica e immigrazio-ne - una volta approvate non sono state fatte oggetto di un esame particolarmen-te approfondito da parte della dottrina, che andasse molto al di là dell’esposizio-ne delle problematicità e, soprattutto, del-la riflessione intorno alla loro legittimità ed efficacia.
Al confronto non hanno certo giovato le sentenze della Corte Costituzionale nn. 372, 378 e 379 del 2004; in esse la Consul-ta, riproducendo sul punto un’identica motivazione, se da una parte ha sancito la legittimità delle c.d. norme program-matiche statutarie, categoria alla quale le disposizioni sul fatto religioso sono state prontamente annesse, dall’altra ha stabi-lito che a queste, «anche se materialmen-te inserite in un atto-fonte, non può esse-re riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul pia-no dei convincimenti espressivi delle di-verse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’ap-provazione dello Statuto».
La soluzione prospettata dalla Consul-ta ha, se possibile, suscitato dubbi ancora maggiori rispetto a quelli relativi alle di-sposizioni impugnate. Ha colpito innan-zitutto la perentorietà con la quale, per la prima volta nella giurisprudenza costitu-zionale, si è voluto chiarire che delle di-sposizioni ricomprese in testi normativi, per di piú di altissimo livello, siano com-pletamente sprovviste di portata giuridi-ca(11). L’impressione è stata inoltre quella di un ritorno al passato, con la riesuma-zione di quella categoria delle “leggi pro-grammatiche” con cui, agli albori dell’or-dinamento repubblicano, si era tentato di preservare lo status quo di fronte ad alcu-ne delle norme costituzionali piú innova-tive, e delle quali la critica di Vezio Cri-safulli sembrava aver già avuto definiti-vamente ragione(12).
giurista tedesco Ernst-Wolfgang Böcken-förde, il quale ha messo in evidenza nei suoi studi il profondo legame tra lo Sta-to moderno, costituzionale e democrati-co, e le sue premesse culturali insite nella società europea(9). Secondo questa visio-ne l’ordinamento sarebbe sempre espres-sione di determinati presupposti cultura-li, a partire dalla lingua - che non è mai completamente neutrale rispetto ai con-cetti e ai valori che esprime. Occorre co-munque specificare che in Böckenförde valori e identità rimangono extragiuri-dici e non spetta allo Stato costituzionale il compito di implementarli, bensí sem-mai solo quello di accoglierli; in secondo luogo, l’esigenza di valori condivisi non toglie nulla al fatto che la società e l’or-dinamento, una volta definiti nella loro identità, debbano essere aperti e inclusi-vi verso tutti i cittadini.
La posizione di Böckenförde è stata ri-presa e fatta oggetto di riflessione da par-te di Joseph Ratzinger, in particolare nel suo celebre colloquio con Jürgen Haber-mas(10); nel pensiero del futuro Benedet-to XVI, rivolto al dibattito sul trattato co-stituzionale europeo, le idee del costitu-zionalista tedesco però si affinano e assu-mono caratteristiche parzialmente diver-se: la cultura e la storia comune non si ri-volgono piú alla fondazione concettuale di una determinata nazione bensí al pro-cesso di formazione dell’Europa intera, con uno spazio particolare riconosciuto al Cristianesimo.
legittimità ed efficacia
Le disposizioni che rammentano le “ra-dici” e le “tradizioni cristiane”, pur diven-tate un argomento importante del dibat-tito politico sugli Statuti, assieme ad altri concetti storicamente ed eticamente sen-sibili - come resistenza, liberazione e so-
101
ETIC
A p
er le
pro
fess
ioni
•
3/2
010
Le disposizioni statutarie sul Cristianesimo, per essere in armonia con
i princípi del nostro ordinamento, non
possono essere interpretate in modo
da intaccare la libertà religiosa e di pensiero di qualsiasi individuo
Daniele Mont D’arpizio
getto di questo studio sono o meno com-patibili con l’ordinamento costituzionale italiano e, soprattutto, quali possono es-sere le loro applicazioni concrete?
Quanto al primo aspetto entrano in gio-co anzitutto la tutela dei diritti inaliena-bili dei cittadini (art. 2 Cost.), il principio di uguaglianza di fronte alla legge (art. 3), la libertà di religione (artt. 19 e 20) e di espressione del pensiero (art. 21).
È noto che questi princípi, con l’aggiun-ta di quello di separazione e reciproca in-dipendenza tra Chiesa e Stato, ordine spi-rituale e temporale (art. 7), sono stati con-densati dalla Corte Costituzionale, a par-tire dalla sent. n. 203 del 1989, nel princi-pio supremo di laicità, il quale occupa un posto specifico di preminenza tra le stesse norme di rango costituzionale(14).
La soluzione alla nostra questione sta, ovviamente, nel tipo di laicità che si vuo-le adottare: si tratti di una laicità alla francese, tesa alla neutralizza-zione delle differenze in nome dell’astratta uguaglianza dei citta-dini, oppure di una concezione piú aper-ta alle istanze prove-nienti dalla società, quale è andato pro-gressivamente enu-cleandosi nel nostro ordinamento.
Quello che è certo è che le disposizioni statutarie sul Cristia-nesimo, per essere in armonia coi princípi del nostro ordinamento, non possono in alcun modo essere interpretate in modo da intaccare la libertà religiosa e di pensiero di qualsiasi individuo o collettività.
Allo stesso modo l’esistenza di norme che tutelino il dato cultural-religioso non permette, nemmeno indirettamente, la di-
Le sentenze considerate si inseriscono perfettamente nella linea costante della giurisprudenza costituzionale italiana, tradizionalmente tesa a una lettura pru-dente delle prerogative regionali - indi-rizzo solo limitatamente intaccato dalle riforme del 1999 e del 2000; non di meno la loro applicabilità alle disposizioni sul Cristianesimo presenti negli Statuti regio-nali è affatto discutibile. Occorre innanzi-tutto ricordare che le pronunce richiama-te, rientrando nella categoria delle “sen-tenze interpretative di rigetto”, non vin-colano le decisioni successive degli altri giudici e nemmeno della stessa Consulta; in secondo luogo, da un’analisi comples-siva della giurisprudenza costituzionale si può ricavare come non tutte le norme programmatiche siano state considerate inefficaci dalla Corte, bensí solo quelle che non afferiscono alle materie devolu-te dalla Costituzione all’autonomia statu-taria oppure alla competenza legislativa regionale (artt. 123 e 117 Cost.).
Negli àmbiti di “sicura competenza re-gionale” la presenza di disposizioni pro-grammatiche sarebbe al contrario non solo pienamente legittima, bensí in alcuni casi addirittura necessaria(13). A questo propo-sito è chiaro che le norme sul fatto religio-so non costituiscono altrettante rivendi-cazioni di àmbiti di competenza da par-te delle Regioni, ma attengono piuttosto alla categoria di quei princípi interpreta-tivi che possono trovare applicazione in ogni àmbito delle prerogative regionali; la loro efficacia quindi non appare intac-cata dalle sentenze del 2004.
Radici cRistiane e oRdinamento
Ma, a parte la possibilità di includerle o meno nella categoria delle norme statuta-rie programmatiche descritta dalla Corte Costituzionale, le norme che formano l’og-
102
ETIC
A p
er le
pro
fess
ioni
•
3/2
010
Spazio aperto • Statuti regionali: identità e valori
Le RaDiCi CRiStiane negli Statuti delle Regioni italiane
no una completa neutralizzazione degli spazi pubblici da ogni riferimento o in-flusso da parte del fatto religioso; nell’ac-cezione “italiana” queste norme possono essere anzi addirittura considerate come altrettante riaffermazioni di un concetto comprensivo e aperto di laicità: tramite esse infatti le istituzioni, riconoscendo la cultura e i valori sottesi alla comunità che rappresentano, dichiarano di rinunciare all’imposizione di una propria ideologia, sia essa confessionista o laicista.
Religione, valoRi e pResenza nello spazio pubblico
Come vanno dunque inquadrate le di-sposizioni sulle radici cristiane? Certo non devono essere confuse con le Nomi-nationes Dei e le Invocationes Dei che hanno costellato la tradizione giuridica europea già prima dell’apparire delle costituzioni nazionali, con effetti concreti attualmente scarsi quando non addirittura controver-si(16); piuttosto esse sembrano avvicinarsi nello spirito e nella forma alla lettera del-le costituzioni polacca o slovacca(17). Sot-to un profilo sostanziale tali disposizioni possono essere interpretate innanzitutto come la positivizzazione del richiamo a un elenco aperto di princípi ermeneutici, che dovrebbero informare gli ordinamen-ti locali in modo da renderli piú aderen-ti alle società rappresentate: una sorta di valvola di collegamento tra la comunità rappresentata e la Regione.
Discernere il contenuto applicabile di queste disposizioni sarà compito com-plesso, ma non assolutamente proibitivo; l’apporto del Cristianesimo alla cultura e quindi al diritto della società è un tema sfaccettato, complesso e persino contrad-dittorio, tuttavia è innegabile il ruolo che in esso ha, almeno nella visione dei legi-slatori statutari, la valorizzazione della
scriminazione di coloro che in questo non si riconoscono, con buona pace di chi vor-rebbe condurre in nome di esse una Kul-turkampf contro gli immigrati, in parti-colare di fede musulmana.
La tutela dell’identità culturale, ivi com-presa anche la sua componente religiosa, deve insomma essere intesa come l’espres-sione della libertà di una comunità che si organizza, non può tradursi in una costri-zione verso i cittadini, poiché in questo modo tradirebbe quella che è la sua pre-messa e allo stesso tempo la sua conqui-sta: la libertà di coscienza e il principio della valorizzazione della persona.
Ritornando agli Statuti regionali si può innanzitutto notare come i riconoscimenti del Cristianesimo e del suo lascito siano sempre accompagnati dalla citazione di princípi e di valori intesi a riequilibrarne la portata, determinando un’apertura del sistema verso le minoranze e verso la tu-tela del libero dibattito in àmbito politi-co e culturale: ne sono esempi il largo uti-lizzo dei termini “laicità” o “laico”, uni-to agli accenni al “pluralismo culturale” e al “multiculturalismo”(15).
Al di là del rispetto dei diritti inaliena-bili garantiti dalla Costituzione nulla sem-bra però vietare la valorizzazione delle radici culturali delle comunità regionali, comprese quelle religiose. Disposizioni analoghe del resto sono presenti nei piú diversi livelli dell’ordinamento italiano: dal Concordato del 1984, ove si fa esplici-to riferimento alla presenza culturale del Cattolicesimo in Italia (Art. 9, co. 2), fino alla recente Carta dei valori della cittadi-nanza e dell’integrazione, emanata nel 2007 dal Ministero dell’Interno.
Dunque al principio che vede anche la cultura religiosa tra le realtà meritevoli di valorizzazione non si contrappongono allo stato attuale dei divieti che, in nome di una visione “alla francese”, comporti-
103
ETIC
A p
er le
pro
fess
ioni
•
3/2
010
al principio che vede anche la cultura religiosa
tra le realtà meritevoli di valorizzazione
non si contrappongonodivieti che comportino
la neutralizzazione degli spazi pubblici da
ogni riferimento o influsso del fatto religioso
Daniele Mont D’arpizio
Da questo punto di vista il senso vero e l’obiettivo delle disposizioni regionali sulle “radici” e il “patrimonio” cristiani va ravvisato proprio nel tentativo di evi-tare quell’uguaglianza “per sottrazione” che, prendendo a pretesto l’origine reli-giosa di un simbolo, di un oggetto o di un’idea, ne pretenda la rimozione dallo spazio pubblico in nome di un’astratta uguaglianza(21).
Sotto questo aspetto l’ordinamento re-gionale che faccia un’espressa menzio-ne alle radici culturali cristiane potrà, ad esempio, riconoscere e contribuire allo svolgimento di festività e manifestazio-ni di carattere cristiano, di volta in vol-ta sulla base del riconoscimento del loro specifico valore culturale.
Un altro àmbito di applicazione potrà essere quello dell’insegnamento e della promozione culturale(22); allo stesso modo potranno giustificarsi anche le relazioni e le forme di collaborazio-ni con le confessioni religiose presenti sul territorio e con quel-le strutture che - pur avendo origine religio-sa, come ad esempio gli oratori - svolgo-no una riconosciuta e perdurante azione sociale.
Discorso diverso è se la tutela dell’iden-tità culturale possa legittimamente estrin-secarsi nella presenza dei simboli religio-si nello spazio pubblico - scuole, tribuna-li, uffici pubblici, seggi elettorali. Come è noto proprio su questo tema la dottrina e la giurisprudenza italiane in questi an-ni si sono divise, oscillando tra soluzioni contrapposte(23).
A questo proposito le norme considerate
persona, coi corollari del riconoscimen-to dei princípi fondamentali della libertà religiosa, della libertà di coscienza e del-la stessa laicità.
Il principio personalista, citato espressa-mente dagli Statuti abruzzese, calabrese, campano, lombardo e toscano - ma sotte-so a tutte le carte statutarie - consiste es-senzialmente nel riconoscimento della so-vraordinazione della persona rispetto allo Stato e alla stessa società civile(18).
Si tratta di un concetto che solo a voler-lo prendere sul serio, al di là dei proclami, comporterebbe diverse conseguenze pra-tiche: pensiamo solo al tema semplifica-zione normativa e amministrativa.
A questi princípi si aggiunga quello che implica la distinzione ma assieme la lea-le collaborazione tra ordinamento, socie-tà civile e le confessioni religiose: si trat-ta di una delle caratteristiche piú pecu-liari della civiltà occidentale cristiana(19), che ha come corollario anche il principio di sussidiarietà, che proprio con la rifor-ma del 2001 è stato introdotto anche nella Costituzione. Tutti temi già in parte pre-senti nell’ordinamento, ma nell’applica-zione dei quali in futuro potranno avere un ruolo sempre maggiore anche le Re-gioni, nell’ottica di una tutela multilivel-lo dei diritti fondamentali(20).
In questo senso gli àmbiti di applica-zione delle norme sulle “radici cristiane”, senza che faccia molta differenza il fatto che esse siano presenti nei preamboli de-gli Statuti ovvero nell’articolato, sono al-trettanto vasti di quanto lo sono le com-petenze regionali: dalla sanità all’istru-zione, dalla cultura ai servizi sociali. A questa funzione anzitutto interpretativa ed evolutiva, che mira allo sviluppo della società e dell’ordinamento, le disposizio-ni sul Cristianesimo ne affiancano un’al-tra, che invece è di natura essenzialmen-te identitaria e conservativa.
104
ETIC
A p
er le
pro
fess
ioni
•
3/2
010
Le RaDiCi CRiStiane negli Statuti delle Regioni italiane
Spazio aperto • Statuti regionali: identità e valori
1) Cfr. J. Tajadura Tejada, Funzione e valore dei preamboli costituzionali, in Quaderni costitu-zionali, 2003, 3, 509-530.
2) E. Rossi, Il “fenomeno religioso” nei nuovi statuti regionali. Prime osservazioni, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005, 2, pp. 304-305; Idem, Le chiese e gli statuti regionali, in Chiesa in Italia, Bologna 2004, pp. 197-225.
3) R. Botta, Le norme di interesse religioso negli statuti regionali, provinciali e comunali, Milano 1999.
4) S. Testa Bappenheim, Cenni sulla costituzio-nalizzazione delle radici cristiane in Germania, in Ius Ecclesiae, 2006, 3, pp. 755 – 771.
5) A. Castro Jover e D. Milani, Il fattore religioso negli statuti delle “Comunidades autónomas”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 2, agosto 2005, pp. 321-337; I. Ruggiu, Testi giuridici e identità. Il caso dei nuovi Statuti spagnoli, in Le Istituzioni del Federalismo, 2007, 2, p. 173.
6) Secondo A. de Benoist «l’identità è fonda-mentalmente di natura narrativa e autonar-rativa»: in Identità e comunità, Napoli 2005, p. 56; cfr. P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris 1990, p. 175.
7) N. Colaianni, Europa senza radici (cristiane)?, in Politica del diritto, 2004, 4, pp. 519-520.
8) M. A. Cattaneo, Il positivismo giuridico inglese, Hobbes, Bentham, Austin, Milano 1962, p. 33; U. Scarpelli, Cos’è il positivismo giuridico, Milano 1965, pp. 21-22 e p. 153. Contra N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuri-dico, Milano 1977, pp. 150-151.
9) Si tratta del cosiddetto paradosso, o diktum, di Böckenförde: cfr. Diritto e secolarizzazione, Bari 2007, in part. p. 53 s.
10) J. Ratzinger, J. Habermas, Etica, religione e Stato liberale, Brescia 2005.
11) M. Cammelli, Norme programmatiche e statuti regionali: questione chiusa e problema aperto, in Le Regioni, 2005, 1-2, p. 25; A. Anzon, L’“inef-ficacia giuridica” di norme “programmatiche”, in www.costituzionalismo.it , 21/01/2005;
potrebbero dare luogo a soluzioni originali e variabili da regione a regione, sull’esem-pio di quanto accade in Germania.
Certo la presenza di un riferimento al-le radici cristiane nello Statuto potreb-be deporre a favore della permanenza di simboli religiosi negli spazi di com-petenza regionale, come scuole e ospe-dali; in alternativa le disposizioni esa-minate potrebbero suggerire l’adozione di un modello di procedura conciliativa, sull’esempio di quanto previsto in mate-ria dal Land Bavarese.
Riusciranno le norme statutarie a rica-varsi uno spazio autonomo su questo te-ma scottante?
La questione non ha una risposta auto-matica, ma dipenderà anche dal livello di decentramento che il nostro sistema riu-scirà a raggiungere nei prossimi anni.
Un’ultima notazione riguarda gli stru-menti applicativi, a proposito dei qua-li una prospettiva interessante deriva dall’istituzione dei c. d. “organi di ga-ranzia statutaria”.
Previsti da tutti i nuovi Statuti, esclu-si solo quelli campano e marchigiano, si tratta di organi con denominazioni, composizioni e competenze diverse, ma che hanno tutti in comune la caratteristi-ca di svolgere un ruolo di verifica della conformità allo Statuto regionale in se-no al processo di formazione delle leg-gi regionali(24).
Data la sua natura, questa tipologia di organi si presta in maniera particolare a subire l’influenza delle disposizioni sul fatto religioso: di conseguenza una leg-ge regionale che si ponesse virtualmen-te in contrasto con esse potrebbe incor-rere, in un prospettiva futura, in un ag-gravamento del procedimento di appro-vazione.
Daniele Mont D’ArpizioDottore di ricerca in Giurisprudenza
105
ETIC
A p
er le
pro
fess
ioni
•
3/2
010
19) P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal plura-lismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna 2000, pp. 455-488.
20) Cfr. B. Caravita di Toritto, La tutela dei diritti nei nuovi Statuti regionali (p. 233 ss.), e F. Piz-zatti, La tutela dei diritti nei libelli substatuali, entrambi in P. Bilancia, E. De Marco, La tutela multilivello dei diritti, Milano 2004; E. Griglio, Principio unitario e neo-policentrismo, Padova 2009, p. 334.
21) C. Vigna e S. Zamagni (a cura di), Multi-culturalismo e identità, Milano 2002, p. VII; J.H.H. Weiler, Un’Europa cristiana. Un saggio esplorativo, Milano, 2003.
22) Cfr. ad esempio la legge della Provincia di Bolzano del 16/07/2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” e la legge regionale del 23/07/2009, n. 12 del Friuli-Venezia Giulia.
23) Sul tema cfr. E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), Symbolon/diabolon. Simboli, religio-ni, diritti nell’Europa multiculturale, Bologna 2005 .
24) A. Cardone, Gli organi di garanzia statutaria tra suggestioni del diritto comparato, “paletti” della Corte Costituzionale e apodittiche rico-struzioni del sistema delle fonti, in M. Carli, G. Carpani, A. Siniscalchi, I nuovi statuti delle Regioni ordinarie. Problemi e prospetti-ve, Bologna 2006, pp. 277-302; L. Panzeri, La tutela della “rigidità statutaria” alla luce della più recente giurisprudenza costituziona-le: quali prospettive per gli organi di garanzia regionali?, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, 01, p. 813 ss.
Bartole, Bin, Falcon e Toso, in Diritto Regio-nale, Bologna 2005, p. 29.
12) A. Mangia, Il ritorno delle norme programma-tiche, in Giurisprudenza costituzionale, p. 4068 ss.
13) Cfr. la sent. n. 365/2007, Punto 4 del Consi-derato in diritto; G. Falcon, Alcune questioni a valle delle decisioni della Corte, in Le Regioni, 2005, 1-2, p. 33; A. Anzon, La Corte condanna all’“inefficacia giuridica” le norme “programma-tiche” degli Statuti regionali ordinari, in Giu-risprudenza Costituzionale, 2004, pubblicata in www.associazionedeicostituzionalisti.it, e T. Groppi, Per Emilia-Romagna, Toscana e Umbria la Consulta indica i limiti agli Statuti, in Diritto & Giustizia, 2004, 47, p. 16 ss.
14) Cfr. A. Pin, Il percorso della laicità «all’italiana». Dalla prima giurisprudenza costituzionale al Tar veneto: una sintesi ricostruttiva, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2006, 1, pp. 203-230.
15) Cfr. ad esempio Statuto Abruzzo, art. 7, comma 7; Statuto Campania, art. 4, co. 3 e art. 8, co. 1, lett. e); Statuto Toscana, art. 4, co. 1, lett. t); Statuto Emilia-Romagna nel Preambolo.
16) K. Klecha, The Controversy over Including invocatio Dei into the Future European Consti-tution, in AA. VV., The emerging constitutional law of the European Union. German and Polish perspectives, Heidelberg-Berlin 2003, pp. 551 ss.; T. Iglesias, The Dignity of the Individual in the Irish Constitution: The Importance of the Preamble, in Studies: An Irish Quarterly Review, 2000, vol. 89, 353, pp. 19-34.
17) S. Ferrari, Dio, religione e Costituzione, in www.olir.it , aprile 2004.
18) Cfr. G. W. F. Hegel, Lezioni sulla Storia della filosofia, III, Firenze 1967, p. 101; B. Mondin, Storia della metafisica, vol. 2, Bologna 1998, p. 9-10; E. Mounier, Il personalismo, Roma 1966, pp. 14-16; F. Di Giacomo, Le radici Cristiane dell’Europa, in Il Mulino, 2003, 6, pp. 1001-1009; S. Rudman, Concepts of per-son & Christian ethics, Cambridge 1997, pp. 119-143.