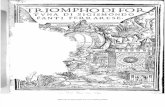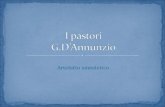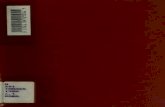Il trionfo della morte - D'Annunzio - recensione
description
Transcript of Il trionfo della morte - D'Annunzio - recensione

5/14/2018 Il trionfo della morte - D'Annunzio - recensione - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-trionfo-della-morte-dannunzio-recensione 1/3
Zanatta Nicole 5 BL
Il trionfo della morteGabriele D’Annunzio
Gabriele D’Annunzio, uno dei più importanti poeti italiani del suo tempo, nasce a Pescara nel 1863 emuore a Gardone Riviera nel 1938 da una famiglia borghese agiata, che lo ricopre di attenzioni anche
per la sua precocità intellettuale.Importante figura di spicco, abbandona presto gli studi, e trasferitosi a Roma, preferisce vivere trasalotti mondani e redazioni dei giornali, dosando perfettamente la propria attività e coltivando la
propria fama sia nell’ambito letterario che in quello mondano. Sono gli anni in cui l’autore si crea lamaschera di quell’individuo superiore che fugge inorridito dalla mediocrità borghese e si rifugia in unmondo di pura arte, disprezzando la morale corrente e accettando come regola di vita solo il ‘bello’.
Nel 1892 D’Annunzio si accosta al pensiero del filosofo tedesco Nietzsche, e rimodella il ruolo delsuperuomo nietzschano conferendogli una superiorità sugli altri per il suo culto della bellezza, per la
sua sensibilità artistica, ed inoltre gli conferisce un diritto di trasgredire le regole morali e sociali invirtù del proprio modo d’essere. È a questo punto che l’autore scrive nel 1894 ‘Il trionfo della morte’,uno dei suoi più importanti romanzi, nel quale intreccia un ritmo cupo ed ossessivo ad una tragicastoria passionale.
Il trionfo della morte è un esempio di romanzo psicologico, nel quale la trama le vicende cedono il posto alla visione soggettiva del protagonista e all’esplorazione della sua coscienza, nella cui mente sisvolge l’intera vicenda romanzesca. Romanzo dedicato a Francesco Paolo Michetti, in cui il poetavuole interpretare gli aspetti dell’individualismo romantico e dell’estetismo europeo, rappresenta un
punto importante perché vi si avverte il primo contatto dell’autore con la filosofia di Nietzsche ed in
particolare con il mito del superuomo.Protagonista del romanzo è il giovane Giorgio Aurispa, un esteta alla ricerca di un significato alto enobile da conferire alla propria esistenza, in contrapposizione alla volgarità e alla banalità della vitaquotidiana, un emblema della condizione negativa dell’uomo moderno, che cerca in ogni modo dicapire il senso della vita attraverso varie esperienze, tra le quali ritroviamo l’abbandono alla forte
passione sensuale per una giovane donna di nome Ippolita. Ma nel romanzo, fin dalle prime pagine,troviamo un senso di catastrofe incombente, la morte si presenta quasi subito ai due innamorati edallora tutto si mescola e viene incentrato su quell’abisso incolmabile che separa gli individui da sestessi. Tutto appare vano, il protagonista si sente sempre più estraneo a se stesso e persino la presenzadella donna amata diventa fastidiosa, diventa sinonimo di pericolo, quasi fosse un nemico, e l’unicasoluzione al problema esistenziale del protagonista si rivela nella morte. Giorgio porta dentro di sé unadisperazione inconsolabile, un mal di vivere che inevitabilmente lo porta alla morte, a quell’attoimprudente che finisce per coinvolgere anche Ippolita. Fino alla fine, amore e morte si intrecciano,dando un ritmo cupo e ossessivo al romanzo, quasi ipnotizzante.
Il linguaggio immediato e quasi spoglio è assai musicale interiormente ed esprime così un’arte liberadalle convenzioni di struttura e di genere letterario, rendendo il romanzo scorrevole ma non per questofacile da comprendere: oltre a riferimenti a Nietzsche, ne troviamo anche a Verlaine e a Baudelaire, o aisimbolisti, e di conseguenza per essere compreso fino in fondo richiede una buona base letteraria.Vi sono abbandonanti ricorsi simbolici, come per il suicidio iniziale che già presagisce la morte del
protagonista, ma in realtà il romanzo utilizza le vicende dell’amore tra lo stesso D’Annunzio e Barbara
Leoni per rappresentare ancora una volta la storia di un fallimento. Questa soggettivitàdell’impostazione narrativa è anche dovuta al peculiare carattere dell’eroe dannunziano, malato egelosamente chiuso in se stesso, per il quale la realtà umana si rivela senza speranza, vuota ed inutile.

5/14/2018 Il trionfo della morte - D'Annunzio - recensione - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-trionfo-della-morte-dannunzio-recensione 2/3
Infatti persino l’amore per Ippolita alla fine non è capace di dare alcuna consolazione al protagonista, e per questa ragione non rimane gli altra scelta se non quella di porre fine a quel ‘mal di vivere’ che gli èinsopportabile.

5/14/2018 Il trionfo della morte - D'Annunzio - recensione - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-trionfo-della-morte-dannunzio-recensione 3/3