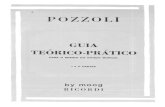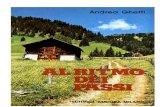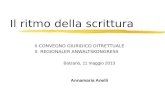Il tema della creazione nell’AT e nel...
Transcript of Il tema della creazione nell’AT e nel...

Capitolo II
Il tema della creazione nell’AT e nel NT
II.1. I due racconti della creazione: Genesi 1,1-2a; 2,4b-25
Tra tutte le parole della Sacra Scrittura sulla creazione, occupano un posto singolarissimo i primi tre capitoli della Genesi. Dal punto di vista letterario questi testi possono avere diverse fonti. Gli autori ispirati li hanno collocati all’inizio della Scrittura in modo che esprimano, con il loro linguaggio solenne, le verità della creazione, della sua origine e del suo fine in Dio, del suo ordine e della sua bontà, della vocazione dell’uomo, infine del dramma del peccato e della speranza della salvezza. Lette alla luce di Cristo, nell’unità della Sacra Scrittura e della Tradizione vivente della Chiesa, queste parole restano la fonte principale per la catechesi dei misteri delle “origini”: creazione, caduta, promessa di salvezza. CCC289
Il primo libro della Bibbia, Genesi, contiene due differenti racconti della creazione del mondo e dell’uomo da parte di Dio. Anzitutto il testo più antico: Genesi 2,4b-25. Appartiene alla tradizione jahvista. Secondo gli studiosi, esso ha avuto origine nella regione della Giudea, al tempo di Salomone (circa dal 970 al 930 a.C.). Il racconto più recente invece è quello di Genesi 1,1-2,4a. Appartiene alla tradizione sacerdota-le. Ha avuto origine durante l’esilio babilonese (dal 587 al 538 a.C.), nella lontana regione di Babilonia. Le differenze più immediate ed evidenti riguardano il diverso nome divino, nel primo Eloim mentre nel secondo Jahvé, e la diversità di stile: Genesi 1 ha una maggiore profondità teologica mentre Genesi 2 è più popolare, più colorito. Approfondendo ulteriormente lo studio delle pericopi risalteranno altre differenze riguardanti il diverso messaggio. Da tutto ciò risulta impossibile tentare di unire i due racconti : sono due documenti giustapposi.

10
II.2. L’interpretazione di Gen 1-3 Nella interpretazione tradizionale si insisteva sul carattere storico dei capi-toli genesiaci. Ci si fermava ad un’interpretazione letterale supponendo che l’autore sacro avresse conosciuto la storia degli origini attraverso “una rivelazione speciale” oppure attraverso una “trasmissione orale” dei fatti. All’inizio del 1900 fu padre Lagrange, uno dei pionieri dell'esegesi storico-critica, presentò un modo diverso di vedere il problema. Considerò inverosimile una trasmissione orale del racconto sottolineandone poi la somiglianza con altri testi dell’antico Oriente; il biblista concludeva che il racconto doveva essere considerato come una rivelazione ricevuta dall’autore sacro. Questa rivelazione si riferiva alla “sostanza” dei fatti, e quindi doveva considerarsi come “storica”. Il rivestimento letterario era tuttavia opera dell’autore1. Successivamente K.Ranher definì questi testi una eziologia storica: aitio-logia, es-posizione delle cause. Dalla realtà presente, fatta di peccato e di infedeltà, gli autori sacri sono risaliti agli avvenimenti delle origini (agli avvenimenti che hanno scate-nato questo presente fatto di peccato), descrivendoli in base alla propria cultura, alle conoscenze del tempo e alla letteratura contemporanea. Essi hanno cercato di trovare la cause di questa realtà ambigua in cui vive l’uomo, non imputando la responsabil-ità a Dio ma all’uomo (teodicea). II.2.1 Esegesi teologica del primo racconto Nato durante l’esilio babilonese, terra politeista, il primo racconto ha come scopo principale quello di proclamare la fede in un solo dio: YHWH, creatore dell’universo. Il primo versetto racchiude un’importantissima professione di fede. Per enfatizzare l’origine di tutte le cose dal Padre creatore, l’agiografo ci racconta la creazione utilizzando lo schema del caos primordiale, tipico delle culture arcaiche. Il racconto si scandisce in ‘‘giorni’’ basandosi su una struttura settimanale. Questo schema non ha nessuna relazione con il periodo di tempo nel quale furono create le creature, né i singoli giorni hanno relazione con un periodo di tempo. La set-timanalità dell’evento creativo racchiude un significato teologico molto importante. - Mostra il ritmo della vita dell’uomo: lavoro e riposo. La stessa cosa si può vedere nella formulazione del terzo comandamento che inizia con ricorda (Es 20,8-11) ed evoca questo schema settimanale. - la ripetizione del ritornello: E venne sera e poi venne mattina: un giorno, si deve intendere partendo dall’esperienza salvifica di Israele. Ha un senso liturgico, così infatti era diviso il giorno liturgico: sacrificio della sera (uscita dall’Egitto) e sacrifi-cio del mattino (memoria del patto del Sinai). C’è dunque unione intima tra l’evento salvifico e creatore. Genesi 1 dimostra che tutto è creato da Dio, che ogni creatura ha la sua natura pro-pria, ma che tutti non sono uguali. Esiste infatti una gradazione nelle creature: nell’apice della piramide cosmica, quindi più vicino a Dio, c’è l’uomo. Preoccupa- 1 Cfr. M.J.LAGRANGE, La méthode historique : la critique biblique et l'Église, Paris 1966.

11
zione dell’agiografo non è raccontare come la creazione fu fatta, ma il fatto stesso della creazione. Infatti l’accento non è posto sulle caratteristiche delle creature, ma su Dio, autore di tali creature, e ciò lo si vede nella ripetizione dei verbi: Dio disse—crea—vide; significa che tutto dipende da Dio nella sua esistenza. Lo stesso si può dire delle affermazioni: e Dio vide che era buono, era un grande bene, ecc. Non sono affermazioni scientifiche sul valore delle creature, ma si riferiscono al rapporto di ogni creatura con Dio e all’assoluta dipendenza da lui, e quindi il suo potere sulle creature e il valore delle creature agli occhi di Dio. In principio Dio creò il cielo e la terra: Professione di fede
II.2.2 Esegesi teologica del secondo racconto Nel secondo racconto Dio crea anzitutto l’uomo e poi gli costruisce un luogo dove vivere: il mondo. L’attività di Dio è descritta alla maniera del vasaio (in Egitto il Dio Amon lo è), che unisce l’uomo (tratto dalla terra) e lo spirito vitale (dono stabile di Dio). -Lo spazio vitale (paradiso): non bisogna intenderlo come realtà storica o geografica e neppure come felicità spirituale, ma come armonia totale dell’essere in sé, dell’esistenza umana in relazione con Dio. -La relazionalità: il racconto intende evidenziare anzitutto l’elemento essenziale di questa situazione armoniosa: la relazione di amicizia con Dio. - La sessualità umana: L’uomo non si rapporta solo a Dio ma anche agli altri uomi-ni. La natura relazionante si costruisce attraverso una dinamica verticale (con Dio) e, simultaneamente, una orizzontale ( con la donna). Non è un bene per lui che sia solo (2,18). La sessualità è una componente fondamentale della persona, un suo mo-do di essere, di manifestarsi, di comunicare con gli altri. Albero della vita e albero della conoscenza del bene e del male. Sono il simbolo delle due peculiari competenze di Dio: creare la vita e definire la differenza tra bene e male. l’uomo non può mangiare dell’albero della vita perchè non può creare, può solo generare; allo stesso modo non può mangiare dall’albero della conoscenza del bene e del male perchè non può sancire in modo definitive ciò che è bene e ciò che non lo è
giorno Creazione degli spazi Collocazione delle cose Giorno
1 Luce/tenebre(giorno/notte) Sole – luna - stelle 4
2 Firmamento: cielo/acqua Uccelli – pesci 5
3 Terra(emersa dal mare) Erba – alberi
Animali terrestri – uomo 6

12
II.3. La creazione nel NT Il NT accoglie e completa i dati dell’AT in merito alla creazione. Numerose sono le citazioni che confermano la fede in Dio creatore. La creazione è fatta da Dio Mc 13,19; Egli è Signore del cielo e della terra, Mt11,25; chiama all’esistenza le cose che non sono Rom 4,17. Cristo si rapporta alla creazione in un duplice modo: -Gesù è mediatore di questa creazione, sin dall’inizio; è il mezzo attraverso il quale la creazione è stata realizzata (ambito protologico). - Ma egli ne è anche la pienezza, il compimento: con lui la creazione ha raggiunto il suo culmine (ambito escatologico).
II.3.1. La creazione in Cristo nella teologia paolina La relazione creazione/Cristo viene espressa con tre proposizioni: IN LUI: Cristo principio vitale di ogni bene; PER MEZZO DI LUI: Cristo mediatore della creazione; IN VISTA DI LUI: Cristo fine ultimo della creazione. Per Paolo la creazione ha: -una dimensione cristologica: la creazione è sostenuta da Cristo, il nuovo Adamo; -una dimensione antropologica: la creazione dell’uomo nuovo si ottiene per configu-rare tutta l’umanità a Cristo per la completa realizzazione. Vediamo alcuni testi particolarmente interessanti: a) 1 Cor 8, 6
Per noi c’è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per lui ; e un solo Signore Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose
PROTOLOGIA CRISTO ESCATOLOGIA (mediatore ) (pienezza)

13
e noi esistiamo per [mezzo di] lui . L’evento storico che spinge Paolo a scrivere queste parole è il problema delle carni degli animali offerte in sacrificio agli idoli: mangiarle o no? Paolo afferma che c’è un solo Dio e non ci sono idoli, quindi, si può mangiarle, perché le carni non sono sacre. Questo testo probabilmente è una professione di fede “pre-paolina”. - Un solo Dio: contro la pluralità degli dei Paolo professa la fede in un solo Dio da cui tutto l’universo ha origine. - Gesù Cristo, non è il Logos, ma la persona concreta di Gesù, è confessato come unico Signore. Ai molti signori della cultura politeista, Paolo oppone l’unico vero Signore, il Cristo. - per mezzo del quale tutto tutto esiste. L’azione mediatrice della creazione di Cristo si comprende in coerenza con il progetto salvifico, che si attua per la mediazione della salvezza di Cristo. Dio ci salva per mezzo di Cristo, proprio perché ci ha creati per mezzo di lui a questo scopo. b) Eb 1, 1-3
Dio , che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi “per mezzo del Figlio” , che ha costituito erede di tutte le cose e “per mezzo del quale” ha fatto anche il mondo. Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati , si è assiso alla destra della maestà nell’alto dei cieli.
Anche in questo brano viene ribadita la mediazione di Cristo nelle due dimensioni: nella creazione e nella salvezza. Il Figlio, per mezzo del quale il Padre ha creato le cose, ci rivela Dio ed è l’erede di tutto. Il testo si riferisce proprio a Gesù incarnato, morto, risorto ed assiso alla destra del Padre. È Gesù Cristo il mediatore della crea-zione e della grazia.. La parola creatrice di Dio è qui la parola di Cristo. Nella perso-na di Gesù sono unite, in un continuum, la mediazione creatrice e quella rivelatrice di salvezza. c) Col 1, 15-20
Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; 16poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. 17Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. 18Egli è

14
anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. 19Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza 20e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli.
Insieme alla lettera agli Efesini, l’epistola indirizzata al popolo di Colossi è stata scritta da Paolo durante la prigionia romana degli anni 60. Colossi è una città della Frigia, nella vallata del Lico, a 200 Km a est di efeso. Il brano che abbiamo consid-erato è l’inno cristologico,; Probabilmente l’autore ha ripreso due strofe appartenenti ad un inno giudaico facendone una poesia cristiana atta a esprimere la supremazia universale del Cristo 2. Entrano in gioco in questo inno i due temi principali: 1) il primato di Cristo sull’universo 2) il suo primato salvifico. a) Prima parte dell’inno (vv. 15-18): il primato di Cristo nell’universo - Il soggetto dell’inno non è il Logos preesistente, ma Gesù di Nazareth, morto e risorto. Questa certezza si deduce da quanto si dice prima: è in lui Gesù Cristo che abbiamo, infatti, la redenzione e il perdono dei peccati. Per Paolo il Logos incarnato è il “primogenito” della creazione. Vi è identità tra il Gesù Cristo manifestatosi nella storia ed il Logos preesistente e creatore. Egli è “ è immagine (“eikon”) del Dio invisibile”, nel senso che ne è il “perfetto rivelatore”. Il primo titolo cristologico dell’inno è questo: “immagine”. Cristo rivela agli uomini nel modo più perfetto il Padre. Per “immagine” si può qui intendere anche “modello”, nel senso che la crea-zione del mondo, da parte di Dio, avrebbe avuto come “modello” Gesù Cristo. Le due sfumature e i due significati (“immagine” che rivela Dio e “modello” della crea-zione), sebbene diversi, possono stare insieme come complementari. Il secondo (“modello” della creazione) si inserisce meglio nel contesto del seguito dell’inno, che parla proprio della mediazione creatrice di Cristo. La relazione di Gesù Cristo, primogenito della creazione, con il mondo viene es-pressa attraverso le formule successive: - in lui : può essere interpretato in due modi, in nel senso che “sostiene e dà fon-damento” ad ogni cosa, o che per mezzo di lui tutte le cose sono state create. - per mezzo di lui Vi è un’attività di Cristo nella creazione di tutta la realtà. Questa particella è quella che ricorre più sovente nel NT per esprimere la mediazione cre-atrice di Cristo (vedi testi precedenti) e anche la mediazione di grazia. - verso di lui più che di “causalità esemplare” (modello di riferimento), qui sembra si debba parlare di “causalità finale” della creazione. Cristo è la causa finale (lo sco-po) verso il quale la creazione è avviata. Tutto l’universo cammina verso Cristo. Dio crea il mondo, incamminandolo verso Cristo, che è all’origine ma anche alla fine del
2 A. GEORGE-P. GRELOT, Introduzione al Nuovo Testamento. Le Lettere apostoliche, Roma 1989, 142-143.

15
mondo. Egli è l’alfa ed omega (Ap 21,6). In questo direzione (verso Cristo) vi è una continua evoluzione: dal primo Adamo al secondo Adamo (Cristo). Quindi, l’universo è stato creato per mezzo (dia) di Cristo, sussiste in (en) lui e cammina verso (eis) di lui. Da lui dipendono passato presente e futuro della crea-zione. C’è dunque una signoria assoluta di Cristo su tutta la creazione. b) Seconda parte dell’inno (18b-20): la funzione salvifica di Cristo - “principio” (v. 18b). Il primo titolo di Cristo che compare è quello di “principio” (cfr la Sapienza in Pvb 8,22: “Il Signore mi creò come principio delle sue vie”). Gesù è il principio, l’inizio di una nuova storia. Egli è il “primogenito (prototokos) dei risorti: egli che è primo nell’ordine della creazione, lo è anche nell’ordine della nuova creazione. II.3.2. La creazione nel prologo giovanneo
“Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tut-to ciò che esiste”. “Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui eppure il mondo non lo riconobbe”
- Nel prologo di Giovanni si dice che il Logos è Dio, ma senza articolo. Dunque, il Logos è distinto dal Padre, che è Dio con l’articolo (o Theos). Il Padre ed il logos sono uniti “fin dal principio”. Sono affermate la preesistenza e la divinità del Logos, in evidente parallelismo con Gn 1. - v. 3. Il Logos agisce nella creazione e tutta la realtà è creata per mezzo di lui. La mediazione creatrice del Logos è universale. Non vi è dualismo di un Dio del bene e di un Dio del male: Padre e Logos agiscono concordemente per portare all’esistenza tutto il creato (contro docetismo-gnosticismo). - v. 10 ripete e precisa la mediazione creatrice del Logos: ci si riferisce ora al logos incarnato: Gesù Cristo. È per mezzo di lui che tutto è stato creato. È questo aspetto che spiega la “pretesa universalistica” di Cristo: egli doveva essere salvatore di tutti ed accettato da tutti, perché tutto è stato creato per mezzo di lui. II. 4. La creazione opera della Trinità La creazione del creato è opera di Dio trinitario. Un’opera d’arte che ben raffigura tale verità è un sarcofago risalente ai primi secoli dell’era cristiana.

16
II.4.1. Sarcofago Dogmatico
E’ un monumentale sarcofago marmoreo risalente al IV secolo rinvenuto durante i lavori ottocenteschi di ricostruzione della Basilica di san Paolo fuori le mura ed ora custodito nei Musei Vaticani (figura 1).
Figura 1. Sarcofago Dogmatico o dei Due Testamenti, IV secolo, Musei Vaticani, Roma.
Intorno ad un clipeo centrale a forma di conchiglia, in cui sono rappresentati i due coniugi defunti, si sviluppano due registri, con una serie di immagini raffiguranti scene dell’AT e del NT apparentemente senza una logica. Nel registro superiore troviamo: la Trinità nell’atto della creazione di Eva, Cristo tra Adamo ed Eva, l’albero del Peccato, le Nozze di Cana, la Moltiplicazione dei pani, la Resurrezione di Lazzaro. Nel registro inferiore si trovano: l’Adorazione dei Magi, la Guarigione del cieco, Daniele fra i leoni, Abacuc con la cesta dei pani e l’angelo, Pietro che rinnega Cristo, la Cattura di Pietro. A noi interessa la prima formella scultorea .

17
E’ la raffigurazione più antica della Trinità, rappresentata nel contesto della Crea-zione e personificata in tre figure maschili di uguali sembianze. É quasi un dettato del dogma della consustanzialià proclamato dal concilio di Nicea nel 325 e del Sim-bolo di fede nel Dio trinitario che vi fu formulato. Evidentemente è da questo parti-colare che prende il nome il sarcofago. Il Padre creatore è il personaggio centrale, seduto in cattedra, ha il braccio alzato nel gesto di parlare. Un gesto che continua nell’immagine del Figlio, il Logos incarnato. Egli estrae Eva dal corpo di Adamo (entrambi sono raffigurati in proporzioni ridotte). L’immagine si ispira alla vecchia scena del Prometeo che modella l’uomo. L’iconografia cristiana trasforma il gesto in quello di imposizione delle mani. E’ il più antico gesto che richiama direttamente la prassi apostolica di conferire il dono dello Spirito. Tertulliano così ne parla: «Finito il lavacro battesimale, dopo ci viene imposta la mano, con una preghiera di bene-dizione per invocare e invitare lo Spirito Santo»3. Lo Spirito è posto a sinistra, meno evidente degli altri due, meno caratterizzato per-chè meno lo caratterizzò il Concilio.
3 Tertulliano, De Baptismo, 8,1, in CCL 1, p.283.

18