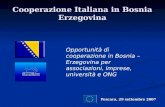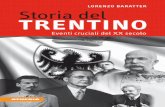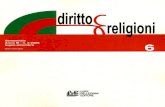Grande Guerra e crisi del regime liberale. - dispi.unisi.it · consideriamo che l’Austia Ungheria...
Transcript of Grande Guerra e crisi del regime liberale. - dispi.unisi.it · consideriamo che l’Austia Ungheria...
Grande Guerra e crisi del regime liberale.
Non possiamo soffermarci sull'Italia e la Grande Guerra, sebbene il tema sia di
grande interesse. Dobbiamo però necessariamente mettere in chiaro alcuni punti.
Innanzitutto che la Prima guerra mondiale a livello europeo costituisce un vero e
proprio trauma, un evento che non aveva avuto precedenti e che muta definitivamente
il volto dell'Europa. A livello di relazioni internazionali e di rapporti tra gli stati essa è
il punto di arrivo di un percorso che parte dal 1870, quando ha avvio la politica di
potenza, quando nasce l'Impero tedesco e la Francia è ferita nel principio di
nazionalità. É in questa fase che prende avvio una politica estera basata non sul
principio di nazionalità ma sulla rivendicazione nazionalistica, il che è molto
differente: ricordiamo il principio altruistico della nazionalità, alla maniera
mazziniana e manciniana (Pasquale Stanislao Mancini), che presuppone il fatto che
tutte le nazionalità siano libere, sovrane, indipendenti, mentre il nazionalismo
presuppone invece la prevaricazione di una nazione sull'altra, cioè il principio della
forza allo stato puro, la forza senza il diritto. Brevemente, possiamo accennare al
fatto che l'Italia arriva al conflitto sulla base del Patto di Londra, firmato dal nostro
ambasciatore a Londra Imperiali di Francavilla nell'aprile del 1915, con il quale
l'Italia si pone a fianco delle potenze dell'Intesa: Gran Bretagna e Francia. Questo
“riaggiustamento” della nostra politica estera dopo la stipulazione della Triplice
Alleanza del 1882 parte da lontano, bisogna partire cioè dalla linea tracciata da
Visconti Venosta nel 1896 con il famoso “colpo di timone” post-crispino, quando
inizia un avvicinamento a Francia e Inghilterra. È in questa fase che comincia il
riallineamento internazionale dell’Italia e ciò per dire che il Patto di Londra del 1915
con il quale si decideva l’entrata in guerra dell’Italia a fianco delle potenze dell’Intesa
non viene dal nulla: già nel 1899 uno scambio di lettere V. Venosta-Barrere
assicurava l’Italia che l’accordo anglo-francese del 1899 non avrebbe leso gli
interessi italiani nel mediterraneo, intesa che veniva consolidata nel 1902 con gli
accordi Prinetti-Barrere di reciproca neutralità in caso di aggressione. È una fase in
cui l’Italia non rompe la sua alleanza con gli imperi centrali, ma attenua di molto la
sua posizione anti-francese.
Nei primi anni del 900 si realizzano tra l'altro le condizioni perchè l'Inghilterra esca
dal suo isolamento (movimentismo navale tedesco, appoggio tedesco ai boeri di
Kruger nella guerra anglo-boera del 1902) e in qualche modo faccia sentire la sua
presenza nel continente, avvicinandosi quindi a Russia e Francia. L’entente cordiale
del 1904 – con la quale la Gran Bretagna riconosceva alla Francia diritti preminenti
sul Marocco costituisce una di queste tappe di avvicinamento, mentre da parte sua la
Francia riconosceva l’occupazione inglese dell’Egitto. La Francia già nell'immediato
post 1870 aveva iniziato una lenta ripresa, ma non aveva mai perso il suo status di
grande potenza.
E’ una fase in cui l’azione italiana senz’altro irrita la Germania, la quale però rimane
passiva e d’altronde la Triplice Alleanza non sembra funzionare perfettamente, se
consideriamo che l’Austia Ungheria aveva proceduto nel 1908 all’annessione della
Bosnia Erzegovina, un atto unilaterale che aveva modificato lo status quo della
regione balcanica stabilito con il congresso di Berlino del 1878. Le conseguenze di
questo fatto non furono irrilevanti, se si considera la reazione della Serbia, che
andava qualificandosi come la nazione leader degli interessi delle popolazioni slave
balcaniche e dietro la Serbia c’era la Russia che invece andava sviluppando un
interesse crescente per quell’area. Al momento del gesto austro-ungarico, l’Italia si
era appellata ad una clausola della Triplice che prevedeva dei compensi in suo favore,
ma il problema dell'Italia era quello delle terre irredente, la soluzione del quale
consigliava di guardare dalla parte opposta a quella dell'impero Austro-Ungarico: con
l’accordo di Racconigi tra Tittoni e Isvolsky del 1909 Italia e Russia arrivavano ad
un’intesa nel contrastare nuove azioni unilaterali dell’Austria-Ungheria nei Balcani e
nel reciproco favore in ordine alle aspirazioni russe sugli Stretti ed a quelle italiane in
Libia, che nel 1912 verrà conquistata con la guerra italo-turca.
Da un punto di vista geo-diplomatico quindi l’area balcanica comincia a configurarsi
come l’epicentro di quello che succederà a breve ed è intuitivo che la guerra italo-
turca non fa altro che rinfocolare le tensioni, perché alimenta le aspirazioni di tutti
quegli stati che vogliono sottrarre all’impero ottomano nuovi territori: di qui le guerre
balcaniche che si aprirono nell’ottobre 1912, in cui l’impero ottomano è sfidato a viso
aperto, e vittoriosamente, da una Lega balcanica composta da Serbia, Bulgaria,
Montenegro e Grecia per la spartizione della Macedonia. Da notare come in generale
in questa fase l’Austria preme affinchè venisse ridimensionata la Serbia ed in questo
senso riesce ad impedirgli uno sbocco al mare grazie anche all’aiuto dell’Italia,
promuovendo la nascita di uno stato autonomo avverso agli slavi meridionali e cioè
l’Albania, una politica antiserba che ebbe come principale effetto quello di aumentare
l’irrendentismo serbo, che poi fu, ricordiamo, la scintilla che fece scoppiare il
conflitto.
Quando dunque l'Italia firma il Patto di Londra guarda ad un solo obiettivo e cioè al
completamento dell'unità territoriale, a ciò che era rimasto incompiuto con il
Risorgimento, alle terre irredente, al predominio nell'Adriatico, all'equilibrio nel
Mediterrano ed anche ad un incremento dei propri possedimenti coloniali.
Da un punto di vista diplomatico e ovviamente per grandi linee sono queste le
premesse del conflitto. Non meno decisivi sui destini dell'Europa furono gli esiti della
pace, che fu stabilita a Versailles nel 1919, ma con una serie di trattati per materie e
aree geografiche. Basta leggersi i giudizi coevi per capire come la pace apparve
subito estremamente difettosa. Un attento osservatore come Nitti, che era successo in
qualità di Presidente del consiglio a Orlando (e Tittoni a Sonnino), nel 1921 in un
saggio intitolato “L'Europa senza pace” giudicava il trattato come un regresso, come
“la negazione di quelli che erano i principi acquisiti dal diritto pubblico”. La guerra
aveva rotto i legami di solidarietà economica e tutti i paesi d'Europa avevano una sola
preoccupazione: difendersi contro la concorrenza della Germania. Per poter pagare le
indennità, la Germania era costretta a produrre ai più bassi costi possibili; per poter
produrre doveva realizzare il massimo dei progressi tecnici, ma esportare a bassi costi
significava danneggiare o distruggere il commercio dei paesi neutrali e anche dei
paesi vincitori. Su questo punto anche Keynes era stato molto chiaro (Le conseguenze
economiche della pace), criticando in particolare la Francia, unicamente interessata,
secondo l'economista, a “riportare l'orologio indietro e a disfare quello che dal 1870
la Germania aveva fatto”, la “politica di un vecchio”, secondo Keynes, con
riferimento a Clemenceau, di uno statista che pensa al passato e non al futuro. E non
a caso Nitti, a proposito dell'Europa di Versailles scriveva di una decadenza e di un
abbrutimento tale da ricordare la caduta dell'Impero romano e soprattutto, scriveva
Nitti, la Grande Guerra aveva avuto questo di caratteristico: non era stata soltanto la
più grande guerra, ma nelle sue conseguenze minacciava di essere una delle peggiori
guerre, perchè il sistema dei trattati aveva diviso l'Europa in due parti: i popoli vinti
sotto il controllo militare ed economico dei vincitori avrebbero dovuto produrre non
solo in rapporto ai loro bisogni, ma per indennizzare chi ha vinto e i popoli vincitori
fino alla liquidazione delle indennità avrebbero dovuto esercitare sui popoli vinti un
controllo militare, ciò che, considerando che un'altra parte d'Europa, e cioè la Russia,
era in fermento rivoluzionario, in sostanza creava uno stato di guerra permanente. Ed
infatti era veramente stupefacente il valore profetico del saggio di Nitti, scritto nel
1921: “L'Europa continentale si prepara a una serie di nuove e più violente guerre di
popoli, che minacciano di far naufragare la civiltà, se non si trova modo di sostituire
agli attuali trattati, basati sul principio che occorre continuare la guerra, un sistema di
accordi che metta vincitori e vinti su un piano di libertà e di uguaglianza”. Il
problema era anche morale: l'Europa abbassava ogni giorno il suo livello morale, per
una politica seguita nei confronti dei vinti che non aveva esempio nella storia
moderna.
Anche l'Italia, vittoriosa in guerra, uscì sconfitta dalla pace, non realizzando a pieno
l'obiettivo sui suoi territori orientali. Ma al di là di questo, vorrei qui parlare delle
conseguenze della guerra sul sistema politico italiano, che furono profonde, così
come d'altronde lo furono a livello europeo. Su questo si è scritto molto, molto si è
scritto sulla funzione palingenetica della Guerra europea: la storiografia italiana è più
o meno concorde nel sostenere che né il crollo dell'Italia liberale, né l'avvento del
fascismo è concepibile a prescindere dai mutamenti provocati dalla Grande Guerra.
Indubbiamente la guerra ha modificato il contesto nel quale i partiti politici si sono
trovati ad operare, ha sconvolto i compiti dei partiti e ne ha rinnovato i modelli. Ma
quali sono questi cambiamenti?
Innanzitutto la modificazione della nozione di massa. In realtà, di dimensione di
massa della politica si può parlare a partire dagli anni Novanta dell'Ottocento, ma ora
diciamo che i concetti di mobilitazione o di propaganda assumono un nuovo
significato. C'è una nuova consapevolezza nei confronti dell'azione collettiva, della
violenza, del pericolo, dell'obbedienza. Un altro binomio sul quale riflettere è quello
di “guerra e rivoluzione”, nel senso che la guerra ha senz'altro contribuito ad
alimentare le passioni rivoluzionarie.
Le modificazioni della guerra sui sistemi politici sono dunque profonde e questo
indipendentemente dallo status di nazione vinta o di nazione vittoriosa, come i casi di
Francia e Italia dimostrano: pensiamo per esempio alle vicende rivoluzionarie del
biennio rosso in Italia o a quelle dei socialisti e sindacalisti francesi più o meno nello
stesso periodo.
Ci sono poi conseguenze profonde sulla tipologia dei partiti: pensiamo alla diffusione
del modello di partito rivoluzionario di Lenin, che in realtà non nasce nel 1917,
perchè è pensato nel 1902. Ma è vero però che il partito bolscevico diventa lo
strumento di una rivoluzione vittoriosa ed il pilastro sui cui poggia uno stato nuovo.
Ciò ha un impatto profondo in campo socialista: i partiti socialisti europei
d'anteguerra avevano parlato di rivoluzione ma non avevano fatto la rivoluzione, ora
devono confrontarsi con un modello vincente, che li costringe ad infiniti ripensamenti
della propria linea, del proprio programma e che produce importanti lacerazioni. In
generale, il modello comunista spinge buona parte del mondo socialista europeo a
conformarsi al modello leninista, basta guardare le adesioni alla III Internazionale,
che è del 1919, o quanto meno ad avvicinarsi a quel modello. E non è da dimenticare
il fatto che il “partito di tipo nuovo” ebbe notevoli conseguenze anche sui partiti
avversari, si pensi agli sforzi organizzativi e di inquadramento delle forze liberali.
Per quanto riguarda il sistema, abbiamo visto come la maggioranza giolittiana tiene
nel 1912-13, ma diciamo che questa data costituisce un punto di non ritorno, l'inizio
di una crisi. Quali i fattori: innanzitutto il variegato mondo liberale in qualche modo
deve corrompersi, e ricorrere al sostegno prima dei socialisti e poi dei cattolici
(critica di Einaudi: non aver dato una risposta liberale alla questione sociale). In
secondo luogo, l'allargamento del suffragio rendeva più complicata l'azione di
sostegno dei candidati filo-governativi da parte delle prefetture. In un sistema di
suffragio allargato, il sostegno prefettizio ai candidati governativi poteva avvenire,
ma ormai soltanto a condizioni imbarazzanti, che esponeva il governo alle critiche
generali dell'opinione pubblica, tanto più che quei meccanismi di mobilitazione
innescati dalla guerra, che accrebbero notevolmente il peso dell'opinione pubblica,
crearono un terreno ancora più favorevole alle critiche anti-giolittiane.
Assolutamente da non sottovalutare sono le divisioni generate in Italia dalla guerra
tra le famiglie politiche al momento della scelta tra neutralità e intervento: i
neutralisti rappresentavano la maggioranza, seguendo Giolitti nella considerazione
che l'Italia non fosse pronta per un conflitto e che essa poteva trarre tutti i vantaggi
possibili mantenendo una posizione di neutralità, cercando di acquisire le terre
irredente senza farsi coinvolgere nella guerra. Nel campo socialista, la sinistra di
classe era contraria alla guerra, così come i riformisti, posizione analoga a quella del
mondo cattolico in ossequio alla linea ufficiale di Benedetto XV che aveva
apertamente condannato la guerra (1° novembre 1914 Ad beatissimi apostolorum
principis cathedram). Anche se in realtà non vi era una opposizione radicale,
giocando infatti fattori di politica internazionale: la gerarchia ufficiale doveva
assumere posizioni di condanna, sia per il rifiuto della guerra in sé, sia perchè sul
fronte degli imperi centrali era schierata una potenza cattolica come l'Austria. D'altra
parte, il fatto che tra le potenze dell'Intesa vi fosse la Francia, il cui governo era
improntato ad uno stretto laicismo, frenava anche la tendenza ad una partecipazione
in quella direzione. Nonostante questo, alcuni settori del mondo cattolico si
mostrarono sensibili all'interesse nazionale ed al riscatto delle terre irredente,
dimostrando come la conciliazione tacita voluta e peseguita da Giolitti stesse in
qualche modo dando dei risultati. Il fronte neutralista era dunque composito, ma
maggioritario e soprattutto le forze popolari, cioè cattolici e socialisti erano contrarie
all'intervento. Quindi la conversione all'intervento del ceto politico liberale, per
volontà del governo Salandra, con il benestare della monarchia, che matura nel 1914,
determinò una frattura politica, culturale e sociale che fece arretrare di molto il
processo di nazionalizzazione delle masse favorito dalla politica giolittiana. Si generò
cioè una frattura, una nuova frattura, tra classe politica e paese reale, una
contrapposizione che fu alla base della incapacità italiana di superare la crisi del
dopoguerra, intesa come crisi di transizione verso una democrazia compiuta, e che fu
base essa stessa sulla quale maturarono tendenze reazionarie ed autoritarie che poi si
consolidarono con la presa di potere del fascismo.
Altrettanto composito era il fronte interventista, di natura trasversale, un arco
politico-ideologico che andava dall'estrema destra, rappresentata dal partito
nazionalista, fino alla estrema sinistra, composta da una componente minoritaria di
sindacalisti rivoluzionari e di socialisti massimalisti transfughi dal partito socialista.
Per quanto riguarda i nazionalisti, essi avevano appoggiato prima l'intervento a fianco
degli Imperi centrali, poi avevano cavalcato l'intervento a fianco dell'Intesa, sulla
base di un progetto di espansione nazionale che sommava alla rivendicazione delle
terre irredente (Trento e Trieste), obiettivi di espansione nei Balcani e nel
Mediterraneo. Si trattava di un progetto di “Grande Italia”, che trovava appoggio in
alcuni settori intellettuali e studenteschi e, dal punto di vista finanziario, nei grupppi
siderurgici e armatoriali che vedevano un interesse economico nell'intervento. Tra gli
interventisi vi fu anche un grande liberale di destra, Luigi Albertini, il direttore del
Corriere della Sera, il quale era consapevole della impreparazione dell'Italia, della
disorganizzazione del suo esercito e della fragilità della sua economia, ma che batteva
sulla necessità di un intervento a fianco di Francia e Inghilterra visto come piena
adesione alla civiltà liberale occidentale. Per farvi capire come la guerra e la
questione di neutralità e intervento alla fine incidono sulle culture politiche e sulle
scelte individuali, basti pensare come su questa strada Albertini alla fine si avvicini
alle componenti dell'interventismo democratico di sinistra, sulla base della difesa
della nazionalità dei popoli.
A sinistra si riconoscevamo due componenti: la componente democratica, espressa
dal movimento irredento, dai radicali, dai repubblicani, dai socialisti riformisti che
avevano rotto con il partito socialista nel 1912, i quali rivendicavano le terre irredente
e vedevano l'opportunità di una quarta guerra di Indipendenza. Non bisogna
dimenticare che in questi settori aleggiava un forte antigiolittismo (Salvemini) e
quindi l'intervento era visto anche come una via per liberarsi dell'esterienza
giolittiana (e questo spiega anche Albertini).
Si trattava di una componente che in generale batteva sul principio di nazionalità
come base per la rivendicazione della libertà dei popoli sottoposti al potere politico
degli imperi multinazionali. Per cui le rivendicazioni italiane erano le rivendicazioni
di tutti i popoli balcanici e non, sottoposti al dominio straniero. Una componente le
cui rivendicazioni affondavano nei risorgimenti nazionali, molto influente sul piano
dell'opinione pubblica, che guardava con favore alle potenze dell'Intesa, considerate
portatrici di una “guerra democratica”, ma che alla fine dovette soccombere di fronte
alle logiche di potenza che invece sempre sottostanno ad una impresa bellica.
Infine esisteva una corrente estremista di sinistra che perseguiva l'intervento secondo
la logica del “tanto peggio tanto meglio”, perchè riteneva che soltanto la guerra
avrebbe favorito una rottura dell'ordine politico esistente e avrebbe aperto prospettive
rivoluzionarie. Mussolini era un degno rappresentante di tale linea, che da dirigente
del partito socialista su posizioni massimaliste, era passato fra il settembre e il
novembre 1914 dalla neutralità all'intervento, disponendo di un quotidiano, «Il
Popolo d'Italia» finanziato da gruppi armatoriali italiani che divenne la voce di punta
della campagna interventista.
C'è poi il nodo dell'introduzione del sistema elettorale proporzionale del 1919, che
tocca anche altri contesti nazionali, ma che in Italia agì da vero elemento detonatore
del sistema. Anche su questo problema si è scritto molto, con un proliferare di tesi
contrapposte. Diciamo che esistono due tesi; una di matrice liberale – dei Maranini,
Ghisalberti - che punta il dito sulla riforma, accusandola di aver provocato la crisi del
sistema e di aver spianato la strada agli avversari; ed altre analisi più recenti che si
basano sulla constatazione che i liberali avrebbero perso anche con un sistema
maggioritario, che in parte quindi riabilitano il sistema proporzionale. Ora, non è
questa la sede per analizzare nel dettaglio la riforma, nei suoi aspetti tecnici; è vero
che non bisogna enfatizzare il significato dei sistemi elettorali nel gioco politico-
istituzionale, ma è vero che quella riforma delle conseguenze le ebbe eccome.
Semmai, quello che dobbiamo dire è che se guardiamo al clima complessivo in cui la
riforma è maturata, non possiamo fare a meno di considerare l'eredità pre-bellica e
vedere come già al momento dell'intervento, come abbiamo visto, la scelta
interventista può essere vista come un vero e proprio colpo di mano per giungere
all'abbattimento del sistema giolittiano: secondo alcune versioni, che ci sentiamo di
accreditare, la proporzionale fu la logica conclusione di un percorso iniziato in quel
momento.
Attraverso la riforma venivano consolidati gli effetti rivoluzionari del conflitto. Certo,
la responsabilità della classe politica liberale nel non provvedere ad una soluzione
alternativa per la crescita del consenso è evidente: collegi allargati, inadeguatezza
delle organizzazioni di partito, difficoltà di adattamento del vecchio sistema
notabilare, difficoltà di mobilitazione della vecchia macchina prefettizia, difficoltà
nella selezione delle candidature, un fattore rispetto al quale furono favoriti i partiti
più strutturati, come il PPI o il PSI, e d'altronde un fattore che in casa socialista favorì
il modello massimalista, accrescendo la centralizzazione del partito.
C'è da chiedersi perchè la classe politica liberale, che era maggioritaria, abbia poi
optato per una riforma. Negli ambienti liberali più avveduti, si credeva che in questo
senso una “evoluzione avrebbe preveduto la rivoluzione”. Lo stesso Gaetano Mosca
che nel 1912 si era schierato contro la proporzionale, nel 1919 appoggia la riforma
prendendo in considerazione questioni di carattere sociale legate al periodo bellico.
Questo non vuol dire che ci fu una sottovalutazione dei possibili effetti della riforma,
e questo anche da parte di estranei alla tradizione liberale: tra i non liberali, la
proporzionale fu vista soprattutto come uno strumento per sbarazzarsi del giolittismo,
piuttosto che come base per una nuova formula di governo (un limite di ogni azione
politica; la politica “anti”, al negativo). Indicativo è poi il fatto che assieme ad un
rifiuto del sistema uninominale maggioritario, ci fu un rifiuto della forma partito
come strumento di lotta politica, nel senso che su questo terreno il ritardo in casa
liberale rimane latente, mentre i partiti al contrario sarebbero stati glorificati dal
proporzionale.
Ma che cosa avvenne? Intanto ci fu un notevole aumento del corpo elettorale: nelle
liste per il 1913 gli iscritti erano stati 8.672.249, mentre nelle liste approvate per
l'anno 1919 gli iscritti risultarono essere 11.115.441. Tuttavia la frequenza alle urne
(56,6%) fu nettamente inferiore a quella registrata nelle elezioni del 1909 (65%) e del
1913 (60,4%), nonostante la consultazione si fosse svolta durante un processo di
progressiva politicizzazione e di accentuata sindacalizzazione, con percentuali di
votanti assai diverse per area geografica: al Nord la percentuale fu del 63,8%, al
Centro del 54,9%, al Sud del 50,9%, nelle Isole del 46,3%. Se guardiamo alle regioni,
si va da un massimo dell'Emilia (71,5%) ad un minimo della Sicilia (44,5%). Le
elezioni del 16 novembre 1919 provocarono una profonda modificazione nella
struttura della rappresentanza parlamentare e per la prima volta nella storia dell'Italia
unita i vari gruppi liberali si trovarono in minoranza. Ma non solo, in confronto alla
legislatura precedente si ebbero 327 sostituzioni (su 508 deputati). Con queste
elezioni la Camera si era rinnovata per circa due terzi nella misura del 65,3%. Le liste
del partito liberale (Salandra) ottenero solo 41 deputati; quelle del partito liberale
democratico (Amendola) 156; quelle radicali 12; Ottennero un rilevantissimo
successo il Partito socialista che passò da 52 seggi ottenuti nel 1913 a 156 seggi. Il
gruppo parlamentare socialista, la cui guida venne conquistata dai massimalisti (70
eletti massimalisti, contro 60 eletti riformisti), divenne il gruppo parlamentare più
numeroso. Il Partito popolare che era stato fondato da Don Sturzo nel gennaio del
1919 ottenne 100 seggi in parlamento. Cioè i due partiti popolare e socialista
ottennero nel complesso circa tre milioni di voti raggiungendo la maggioranza
assoluta nel Parlaemento e nel paese. Altri 20 seggi vennero conquistari dai
combattenti, che dettero vita al partito del Rinnovamento; i socialisti riformisti
ottenero solo 6 seggi, 4 i repubblicani ed altri seggi vennero attribuiti a liste
congiunte repubblicani, socialriformisti e combattenti. Una modifica del regolamento
parlamentare, come conseguenza della legge proporzionale, stabiliva la formazione
dei gruppi parlamentari per cui ogni gruppo doveva essere composto da almeno 20
deputati, anche se in realtà il numero minimo non fu mai di 20 ma di 10: in base a
questo regolamento abbiamo infatti i gruppi di Democrazia liberale; Liberale; Misto;
Popolare; Radicale; Republicano; Rinnovamento; Socialista; Socialista riformista.
Nel 15 maggio del 1921 si andò nuovamente a votare in seguito a scioglimento
anticipato delle Camere. Le elezioni furono indette sotto il V ministero Giolitti, che
era tornato al potere nel giugno del 1920, ed aveva lanciato un programma di riscossa
delle forze liberali realizzando un blocco che andava dai fascisti ai riformisti di
Bonomi. Nelle elezioni per la XXVI legislatura, si ebbe un leggero incremento dei
votanti, e i partiti che si presentarono con caratteri ben distinti furono il PSI, il PPI, il
PRI e il Partito comunista d'Italia – sezione dell'Internazionale comunista, che si era
costituito in seguito alla scissione di Livorno. Le altre formazioni politiche si
presentarono invece con denominazioni e simboli diversi da collegio a collegio.
Come è noto la campagna elettorale fu contrassegnata da una lunga sequela di
violenze e i risultati scalfirono di poco le posizioni raggiunte nel 1919. Alla Camera il
Psi ebbe 124 seggi (32 in meno rispetto al 1919) e il Partito comunista 15. I
combattenti presentarono proprie liste ottenendo 10 seggi, così come i fascisti, che
presentarono liste autonome nei collegi di Napoli e Verona ottenendo 2 seggi. Vi era
poi un Partito economico (partito agrario) ottenne 5 seggi; quelle socialiste
indipendenti 1; il PRI 6 seggi, mentre 4 seggi vennero assegnati ai candidati della
minoranza tedesca dell'Alto Adige e 5 a quella slava della Venezia Giulia. Il PPI
mantenne le percentuali del 1919, con 197 deputati, cioè più 7 rispetto alle precedenti
elezioni. Il blocco costituzionale mantenne 275 seggi, di cui 85 seggi di Democrazia
liberale (Amendola) e 65 seggi di Democrazia sociale (Colonna di Cesarò). Una parte
di deputati fu eletta nei Bocchi nazionali, che però non riuscirono a costituirsi
ovunque, per la presenza di rivalità tra liberali e democratico-liberali. I liberali
costituzionali erano rimasti indipendenti in Piemonte, l'unica regione nella quale i
liberali potevano contare su un alto numero di adesioni (49.000 iscritti su un tolate di
72.000 al momento della fondazione del Partito a Bologna nel 1922). Alla Camera, i
deputati del blocco costituzionale riuscirono tuttavia ad ottenere la maggioranza,
anche se si trattava di una maggioranza eterogenea da un punto di vista politico, in
buona parte composta da elementi non filogiolittiani. Alla Camera i deputati si
suddivisero in 11 gruppi parlamentari. Basta dare un'occhiata a quello che avviene
nella famiglia liberale per capire quanto eterogenea fosse la maggioranza liberale,
infatti abbiamo: un gruppo Agrario, uno di Democrazia Liberale (Amendola); uno di
Democrazia Sociale (Colonna di Cesarò); uno Parlamentare Liberale Democratico
(Salandra), poi abbiamo un gruppo Nazionalista; un gruppo Fascista; poi Popolari,
Socialisti, Socialisti riformisti, comunisti e gruppo misto. E non solo, perchè nel
corso della legislatura ci fu una ridefinizione dei gruppi con la formazione di due
gruppi tra socialisti e socialisti unitari, nuova scissione che si era verificata al
congresso di Roma 1922, per cui i turatiani abbandonarono il PSI per formare il
Partito socialista unitario. Mentre nuove scissioni e ricomposizioni avvenivano anche
all'interno della famiglia liberale a dimostrazione di una frammentazione e mancanza
di unità di intenti che favorì soltanto l'avvento del fascismo al potere.
É una fase in cui tutto viene messo in gioco: giolittismo, partito politico,
parlamentarismo venivano aspramente criticati e si guardava invece a forme di stato
nuovo, a nuove forme di rappresentanza, anche al di fuori della democrazia
parlamentare (Ordine Nuovo di Gramsci). Quello che appare evidente insomma è che
in questo passaggio mancano in Italia elaborazioni riformatrici coerenti che avessero
puntato ad una seria ed incisiva innovazione della democrazia parlamentare. Questa
mancanza di una cultura realmente riformista fece sì che tutto lo sforzo di
mobilitazione si orientasse contro lo stato liberale, travolgendolo e determinandone il
crollo. Stato liberale che, piaccia o no, aveva dato all'Italia l'unità, l'indipendenza, la
libertà e tutti i presupposti necessari per la costruzione di una matura democrazia.