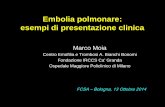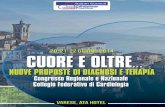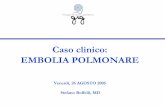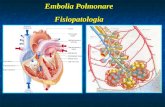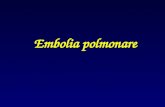ASSISTENZA AL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO … · Embolia polmonare ... Confusione mentale ......
Transcript of ASSISTENZA AL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO … · Embolia polmonare ... Confusione mentale ......
SCOMPENSO CARDIACO
Incapacità del cuore a soddisfare il fabbisogno
metabolico della periferia, che determina così
uno squilibrio tra richiesta e apporto.
Sindrome cronica a significativo impatto clinico e
sociale a causa dell’elevata morbilità e
mortalità
DIMENSIONI DEL PROBLEMA
L’incidenza della sindrome SCC sta assumendo, o
meglio, ha già assunto, dimensioni
epidemiologiche sempre più consistenti, con
preoccupanti ricadute sulla spesa sanitaria. Ciò
è dovuto principalmente all’allungamento della
vita media ed al progressivo miglioramento
delle strategie terapeutiche della cardiopatia
ischemica.
CAUSE
Deficit della contrattilità miocardica
(es.cardiomiopatie, ischemie e infarto
miocardico, patologie valvolari)
Crisi ipertensive
Rottura di cuspide aortica
Embolia polmonare
Cause extracardiache (insufficienza renale,
ipovolemia)
SCOMPENSO CARDIACO
L’aumento del lavoro cardiaco porta il cuore a
sviluppare meccanismi di adattamento sia
rapidi che lenti
MECCANISMI DI ADATTAMENTO RAPIDI
Attivazione del sistema nervoso autonomo con
aumento delle catecolamine circolanti e
conseguente aumento della frequenza cardiaca
Aumento delle dimensioni ventricolari in
diastole che comporta un miglioramento della
gittata cardiaca
MECCANISMI DI ADATTAMENTO LENTI
comportano modificazioni strutturali quali
ipertrofia dei ventricoli
insufficienza mitralica
SINTOMI E SEGNI
Derivano:
Dalla ridotta pressione di perfusione periferica
Dall’aumento delle pressioni di riempimento
dei ventricoli in telediastole
Dall’aumento delle pressioni atriali e quindi
polmonari e venose
Dall’intervento del sistema autonomo
RIDUZIONE DELLA GITTATA SISTOLICA
DETERMINA:
calo pressorio in aorta
stimolazione dei barocettori aorticocarotidei
Attivazione simpatica
Riduzione del tono vagale
RIDUZIONE DELLA GITTATA SISTOLICA
QUINDI
Vasocostrizione arteriosa periferica
Aumento del ritorno venoso
Incremento della frequenza cardiaca
VASOCOSTRIZIONE ARTERIOSA PERIFERICA
RENI
incremento della ritenzione idrosalina
attivazione del sistema renina-angiotensina-
aldosterone
determinando
Oligoanuria
Aumento della volemia
CLASSIFICAZIONE NYHA
Classe I: l’attività fisica abituale non determina dispnea, astenia, palpitazioni
Classe II: lieve limitazione dell’attività fisica abituale per la comparsa di dispnea, affaticamento, palpitazioni, benessere a riposo
Classe III: grave limitazione dell’attività fisica, i sintomi di dispnea, affaticamento insorgono per attività fisica di entità inferiore a quella abituale, benessere a riposo
Classe IV: incapacità a svolgere qualsiasi attività senza comparsa di sintomi, sintomi di scompenso anche a riposo
SINTOMATOLOGIA
MUSCOLARE
Astenia secondaria ad alterazioni dei muscoli
scheletrici con riduzione del flusso ematico e
del metabolismo tissutale e, a lungo termine,
cachessia e perdita di massa muscolare.
(il peso corporeo può aumentare per la ritenzione
idrica)
SINTOMATOLOGIA
NEUROLOGICA
Disorientamento
Insonnia
Sincopi
Disturbi dell’attenzione e della memoria
Confusione mentale
Agitazione psicomotoria per ipo-ossigenazione
cerebrale
SINTOMATOLOGIA
ADDOMINALE
Disturbi digestivi da stasi portale e mesenterica
Inappetenza e nausea
Dolenzia epatica
SINTOMATOLOGIA
ANGINOSA
E’ secondaria alla tachicardizzazione e
all’incremento dello stress della parete
ventricolare con conseguente incremento del
consumo di ossigeno
EDEMA POLMONARE ACUTO
Il malato si presenta:
Dispnoico
Polipnoico
Agitato
Cianotico
Con la cute fredda e sudata
Oligoanurico
Con tosse stizzosa
Tachicardico
Il più delle volte iperteso
ACCESSO VENOSO
Posizionamento di almeno un catetere venoso
periferico da almeno 18G
Posizionamento di un catetere venoso centrale
possibilmente a più vie
ACCESSO VENOSO
PERCHE’
Tutta la terapia viene somministrata per via
endovenosa
Necessità di avere vie infusive separate per
incompatibilità farmacologiche
Necessità di monitorare la PVC
Somministrazione di farmaci irritanti o di
soluzioni ipertoniche
MONITORAGGIO DELLA FC E RITMO CARDIACO
Traccia elettrocardiografica stabile, esente da
artefatti
Almeno 1ECG/die
Osservazione e segnalazione di aritmie,
slivellamenti del tratto ST, incrementi o
decrementi stabili della FC>10bpm
MONITORAGGIO DELLA FC E RITMO CARDIACO
PERCHE’
Documentare ed identificare tempestivamente
eventuali turbe del ritmo
Poter identificare tempestivamente eventuali
variazioni della condizione del paziente ( il
primo e più rapido meccanismo di compenso )
MONITORAGGIO EMODINAMICO
Posizionamento di catetere venoso centrale,
arterioso ed eventualmente di Swan-Ganz
(monitoraggio di PVC, PA, PAP, PWP, GC )
MONITORAGGIO EMODINAMICO
PERCHE’
Necessità di continui controlli emogasanalitici
Nei pazienti in shock la misurazioni incruenta della PA sottostima i reali valori
Identificazione in tempo reale di variazioni dello stato del paziente
Valutazione della funzionalità contrattile miocardica, della perfusione periferica, della volemia, delle resistenze vascolari periferiche e polmonari
Valutazione della risposta alla terapia
MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE VENTILATORIA E
DELL’EQUILIBRIO ACIDO-BASE
PERCHE’
Valutazione dell’entità dell’ipossia tissutale
Valutazione della perfusione periferica
Valutazione della capacità degli scambi gassosi
DIURESI E BILANCIO IDRICO
PERCHE’
Valutazione della perfusione renale
Valutazione dell’evoluzione dello
scompenso/shock
Valutazione della risposta terapeutica
OSSERVAZIONE DEL PAZIENTE
PERCHE’
Sorveglianza dell’evoluzione dello stato di
scompenso/shock
Valutazione della perfusione periferica e
cerebrale
MONITORAGGIO EMATOCHIMICO
Emocromo
Emogruppo
Quadro elettrolitico
Coagulazione
Quadro cardiaco
Quadro epatico
Quadro renale
Glicemia
MONITORAGGIO EMATOCHIMICO
PERCHE’
Sorveglianza degli effetti dell’ipoperfusione
sistemica
(Multi Organ Failure)
RX TORACE
PERCHE’
Valutazione dell’ombra cardiaca
Valutazione dei campi polmonari
Valutazione della posizione dei cateteri
vascolari
NUTRIZIONE ENTERALE O PARENTERALE
PERCHE’
Garantire un apporto energetico e metabolico
idoneo
Ridurre le richieste metaboliche
ULTRAFILTRAZIONE
Il dispositivo consiste in un filtro di dialisi
composto da una membrana semipermeabile
che consente il passaggio di acqua e soluti ma
non di colloidi, permettendo di separare così
l’acqua plasmatica dai soluti colloidi
(ultrafiltrazione), rimuovendo il liquido in
eccesso accumulato nel territorio extracellulare
nel cardiopatico scompensato