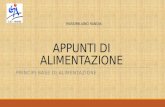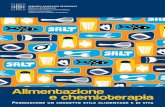ALIMENTAZIONE
description
Transcript of ALIMENTAZIONE


ALIMENTAZIONELATTE MATERNO
• Sostanze nutrienti perfette• Facilmente digeribile• Protegge dalle infezioni

ALLATTAMENTO AL SENO
• Favorisce lo sviluppo del rapporto madre-bambino
• Protegge la salute della madre

• Costa meno dell’alimentazione artificiale
• Riduce i costi sanitari e sociali• Riduce l’impatto ambientale

IN ITALIA 18 BANCHE DEL LATTE NEL 2000

• FIRENZE azienda ospedaliero-universitaria Meyer
• AREZZO ospedale S. Donato• GROSSETO ospedale della
Misericordia• LUCCA ospedale generale provinciale
Campo di Marte• SIENA Policlinico Le Scotte• VIAREGGIO ospedale Versilia
TOSCANA

STORIA DELLA BANCA DEL LATTE
• Allattamento baliatico• Codice di Hammurabi (1800 a.c.)• Europa 1700 <mortalità nei neonati
allattati con latte materno (fine ‘800- inizio ‘900)
• Primi ‘900 due medici di Boston creano la prima banca del latte (tbc, sifilide)

ATTENZIONE!!!Il latte materno rappresenta un terreno
dove i germi si moltiplicano molto rapidamente.
Linee Guida Società Italiana Neonatologia (SIN)

MODALITA’ DI ESTRAZIONE DEL LATTE
Accurato lavaggio delle maniIl seno deve essere deterso con acqua correnteNon è necessario scartare i primi 5-10 ml di latte
estrattoUtilizzare un tiralatte elettrico che simulano la
dinamica di suzione del bambino

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEL MATERIALE
Il materiale deve essere lavato con acqua calda e sapone e risciacquato con cura.
Successivamente devono essere sottoposti a disinfezione
I biberon di vetro devono essere lavati in condizione di termodisinfezione (93°C +/- 1,5°C per 10 minuti)

CONTENITORI PER IL LATTE
Si consiglia l’utilizzo di contenitori di vetro o plastica rigida (considerare lo smaltimento di questi ultimi nell’ambiente)
Si sconsiglia l’utilizzo di sacchetti morbidi di polietilene (perdita di lipidi e vitamine liposolubili)

CONSERVAZIONE DEL LATTE A DOMICILIO
Il latte raccolto deve essere chiuso ermeticamente, raffreddato con acqua e posizionato nella parte più fredda del frigorifero
Si conserva per 24 ore; dopo tale periodo occorre mettere il contenitore nel congelatore
Il contenitore destinato al congelamento non deve essere riempito fino all’orlo

TRASPORTO DEL LATTE
Rispettare la catena del freddo

ARRIVO ALLA BANCA DEL LATTE
Valutazione delle caratteristiche organolettiche del latte
Accertamenti batteriologici

METODICHE DI PASTORIZZAZIONE
Latte da singola donatrice o pool di latte da numero limitato di donatrici (max 6)
Trattamento termico su latte fresco o scongelato in biberon chiusi e di quantità equivalenti
Metodo Holder (+ 62,5°C per 30 minuti)
Fase finale con raffreddamento rapido fino a temp < 10°C

CONSERVAZIONE DEL LATTE
Contenitori muniti di etichetta identificativa con data di raccolta e pastorizzazione
Il latte pastorizzato si conserva a -20°C per max 6 mesi (somm. al neonato pretermine entro 3 mesi)
Il latte scongelato va utilizzato entro 48 ore

METODICHE DI SCONGELAMENTO
Lentamente in frigo per non più di 24 ore
Rapidamente a bagnomaria con acqua a temp non superiore a 37°C
NO MICROONDE!!!!!


American Academy of PediatricsAmerican Heart Association
Neonatal Resuscitation Program
Obiettivi del corso Raccolta linee guida in continuo aggiornamento Standardizzazione delle cure Diffusione capillare delle conoscenze Applicazione alla propria realtà

Rianimazione neonatale
Primi momenti della vita: critici 7% circa dei neonati: rianimazione in Sala Parto (80% circa se < 1500 grammi) Modalità e tempestività RN: qualità della vita Apparecchiature RN: sempre pronte e funzionanti Persone responsabili: esperte, aggiornate e capaci di lavorare in squadra

Nel feto In utero, il feto dipende dalla placenta come organo per gli scambi gassosi
Gli spazi aerei sono pieni di liquido polmonare fetale
Polmoni e Circolazione

Polmoni e Circolazione
Nel feto:
Le arteriole sono costrette
Il flusso ematico è ridotto
Il flusso ematico devia attraverso il dotto arterioso

Dopo il parto I polmoni si espandono con l’aria Il liquido polmonare fetale lascia gli alveoli
Polmoni e Circolazione

Dopo il parto Le arteriole
polmonari si dilatano
Il flusso ematico polmonare aumenta
Polmoni e Circolazione

Dopo il parto Il livello
dell’ossigeno ematico aumenta
Il dotto arterioso si restringe fino a chiusura
Il sangue passa attraverso i polmoni e si carica di ossigeno
Polmoni e Circolazione

Queste modificazioni maggiori hanno luogo nei primi secondi dopo la nascita: Il liquido alveolare viene riassorbito Le arterie e la vena ombelicale si restringono I vasi ematici polmonari si dilatano
Transizione normale

Clearance del liquido polmonare
fetale Migliorato dal travaglio prima del parto Facilitato dai respiri iniziali efficaci Alterato da
– Apnea alla nascita senza espansione polmonare– Respiri deboli ed inefficaci
Polmoni e Circolazione

Flusso ematico polmonare Diminuisce con l’ipossiemia e l’acidosi
in seguito alla vasocostrizione Aumenta con la ventilazione,
l’ossigenazione e la correzione dell’acidosi
Polmoni e Circolazione

• In utero, il feto dipende dalla placenta quale organo per lo scambio dei gas.
• L’asfissia insorge quando la funzione della placenta è alterata.
Polmoni e Circolazione

Polmoni e Circolazione
L’asfissia è caratterizzata da:
Ipossia progressiva
Accumulo di CO2
Acidosi

Funzione cardiaca e meccanismi compensatori durante l’asfissia Risposta iniziale
– Costrizione dei letti vascolari di polmoni, intestino, reni, muscoli e cute per ridistribuire il flusso ematico a cuore e cervello
Effetti tardivi– La funzione miocardica si altera, la gittata
cardiaca diminuisce, e possono verificarsi danni a carico di vari organi
Polmoni e Circolazione

Depressione alla nascita: cause
• Asfissia intrauterina • Prematurità • Farmaci somministrati o assunti dalla madre• Malattie neuromuscolari congenite•Malformazioni congenite•Ipossia intrapartum

Segni di Compromissione nel Neonato
Cianosi Bradicardia Ipotensione Depressione
dello sforzo respiratorio
Ipotonia

Interruzione della Transizione normale: Apnea
Apnea primaria Atti respiratori rapidi Arresto della resp Diminuzione della frequenza cardiaca Pressione arteriosa in genere mantenuta Risponde alle stimolazioni (Stimolazione
fisica e somministrazione di O2)

Apnea secondariaApnea secondaria
Arresto della respirazione
Diminuzione della frequenza cardiaca
Diminuzione della pressione arteriosa
Mancata risposta alle stimolazioni
Apnea primaria
Apnea secondaria
Hea
rt r
ate
Resp
irat
ions
Bloo
d pr
essu
re

Apnea primaria vs secondaria
Sequenza eventi: inizio in utero e prosecuzione dopo la nascita
Clinicamente apnea primaria non virtualmente distinguibile dalla secondaria
In ambedue: Apnea e FC < 100/min

Apnea primaria vs secondaria
L’apnea alla nascita deve essere trattata come
apnea secondaria
ApneaVentilazionea pressionepositiva

Diagramma di flusso della rianimazione

Tappe iniziali (Blocco A)

Valutazione
Dopo questi passi iniziali le azioni successive sono basate sulla valutazione di:
Respiro Frequenza cardiaca

Punteggio Apgar
Non è utile per decidere QUANDO iniziare la rianimazione
E’ utile per valutare l’efficacia delle manovre rianimatorie
Si assegna a 1 min e a 5 min Se a 5 min < 7: ogni 5 min fino a 20
min o fino a quando si ottengono 2 punteggi > o = a 8

Valutazione del neonato
Immediatamente dopo la nascita, ci si deve porre le domande seguenti:

MUCOSUTTORE
CLAMPFORBICE
TELINO TERMICO
Materiale Occorrente per assistenza al
neonato

Prevenire la perdita di calore!!!
• Accendere sorgente di calore• Adagiare su un piano • Asciugare con telini

Calore
Prevenire la perdita di calore (evaporazione, convezione, conduzione, irraggiamento)
• Posizionare il neonato sotto una fonte di calore radiante
• Asciugare accuratamente
• Rimuovere i panni bagnati

Prevenzione della perdita di calore
Neonati prematuri• Problemi particolari
–Cute sottile–Riduzione del tessuto sottocutaneo–Superficie cutanea ampia
• Tappe addizionali–Aumentare la temperatura
ambientale–Coprire con una pellicola di plastica

Aspirare le vie aeree•Aspirare PRIMA il naso, DOPO la bocca
•Aspirazione meccanica NON > 100 mm/Hg (133 cm H2O)

Asciugare, posizionare Togliere i panni bagnati e avvolgerlo con
biancheria asciutta
Posizionare il neonato estendendo leggermente il collo (sniffing position)

Stimolare il respiro…

…così!!!•Dare colpetti leggeri sulla pianta del piede
•Frizionare delicatamente il dorso, il tronco o le estremità del neonato

Il neonato inizia a respirare immediatamente, diventa
rapidamente roseo e ha un buon tono muscolare…
ATTENZIONE!!!
Il cordone ombelicale deve essere clampato

Valutare frequenza cardiaca, respiro e colore
• Se il neonato respira ma presenta CIANOSI CENTRALE somministrare ossigeno a flusso libero a 5lt/min

Cianosi
COLORAZIONE BLUASTRA DI CUTE E MUCOSECianosi centrale : Interessa tutto il corpo, incluse le mucose Causa: riduzione O2 nel sangue
Cianosi periferica : Limitata a mani e piedi( Acrocianosi ) Causa: riduzione o rallentamento del flusso ematico alla periferia

Ossigeno a flusso liberoSe il neonato respira ma presenta cianosi centrale, somministrare ossigeno a flusso
libero.
pallone flusso-dipendente maschera tubo

Ossigeno a flusso libero
• Riscaldato ed umidificato (se somministrato per più di qualche minuto)
• Flusso a circa 5 litri/min• Ossigeno sufficiente per far
diventare roseo il neonato

Valutare frequenza respiratoria
• Il torace deve sollevarsi bene e la profondità dei respiri deve aumentare dopo pochi secondi di stimolazione tattile
• Il GASPING è un respiro inefficace!!!

Valutare frequenza cardiaca
• Auscultare le pulsazioni alla base del funicolo
• Moltiplicare per 10 il numero dei battiti percepiti in 6 secondi
• La frequenza cardiaca deve essere superiore a 100 bpm

…sono passati 30 secondi dalla nascita…APNEA o
FREQUENZA CARDIACA < 100 bpm
VENTILAZIONE A PRESSIONE POSITIVA

Tipi di pallone da rianimazioneA
B
Capacità: 250-750 mlVolume corrente: 6-8 ml/kg

Pallone flusso-dipendente (da anestesia - “va e vieni”)
Somministra ossigeno al 100% Facile ottenimento di buona tenuta “Sente” la rigidità del polmone Può essere utilizzato per l’ossigeno a
flusso libero
Vantaggi
Richiede una tenuta ermetica Richiede una fonte di gas per gonfiarsi Può non avere una valvola “pop-off” di sicurezza
Svantaggi

Pallone auto-insufflante
Si riempie anche in assenza di una sorgente di gas compresso
Valvola di sicurezza
Vantaggi
Si gonfia anche senza tenuta ermetica Richiede un reservoir per somministrare
ossigeno al 100% Non consente la somministrazione di ossigeno a
flusso libero con una maschera
Svantaggi

Pallone flusso-dipendente

Pallone auto-insufflante: parti fondamentali

Pallone auto-insufflante:Controllo dell’Ossigeno
Senza reservoir: Somministra al paziente ossigeno solo al 40%

Pallone auto-insufflante:Controllo dell’Ossigeno
Con reservoir: Somministra al paziente ossigeno al 90%-100%

Pallone auto-insufflante con valvola di apertura a pressione:

Ventilazione a pressione positiva
•Capacità 500 ml circa•Volume corrente 6 – 8 ml/Kg

Maschere facciali
La maschera deve coprire:•Punta del mento
•Bocca
•Naso
LA TENUTA E’ ESSENZIALE PER EFFETTUARE UNA
CORRETTA VENTILAZIONE

Posizionare correttamente il neonato
Non schiacciare la maschera sul volto
Non posizionare le dita o parte della mano sugli
occhi del neonato
Non esercitare pressione sul collo (trachea)

Frequenza della ventilazione
40 – 60 atti al minuto

…dopo 30 secondi si effettua valutazione dei parametri
vitaliFREQUENZA CARDIACA
> 100 bpm
•RESPIRO SPONTANEO: si sospende la PPV e si continua a somministrare ossigeno a flusso libero
•APNEA: si continua la PPV

Il neonato non miglioraFC inferiore a 60 malgrado 30 secondi di ventilazione a pressione positiva

Compressioni toraciche
Aumentano temporaneamente la portata circolatoria
Devono essere accompagnate dalla ventilazione
Compressioni toraciche

Si comprime il cuore contro la colonna
Aumenta la pressione intratoracica
Il sangue circola fino agli organi vitali
Compressioni toraciche

Compressioni toraciche: Indicazioni
FC<60 malgrado 30 secondi di efficace ventilazione a pressione positiva

Compressioni toraciche:Necessarie 2 persone
Una persona comprime il torace
Una persona continua la ventilazione

Compressioni toraciche: Tecniche

Tecniche di compressione toracica a confronto
Tecnica dei pollici (Preferibile)–Meno stancante–Migliore controllo della profondità
della compressione Tecnica delle due dita– Più produttiva se si è da soli–Migliore per le mani piccole– Accesso libero alla vena ombelicale

Compressioni toraciche: Posizionamento dei pollici e
delle dita
Applicare la compressione sul terzo inferiore dello sterno
Evitare il processo xifoideo

Compressioni toraciche:Tecnica dei pollici
I pollici comprimono lo sterno
Le altre dita sostengono il dorso

Compressioni toraciche:Pressione e profondità della
compressione
Comprimere lo sterno di un terzo del diametro antero-posteriore del torace

Compressioni toraciche: Coordinazione con la Ventilazione

Compressioni toraciche: Coordinazione con la ventilazione
Ogni ciclo di 4 eventi dovrebbe durare circa 2 secondi
Approssimativamente 120 eventi al minuto (30 respiri e 90 compressioni)

Compressioni toraciche:Sospensione delle compressioniDopo 30 secondi di compressioni e ventilazione, stop e valutazione della FC per 6 secondi