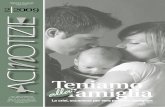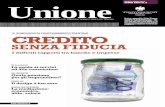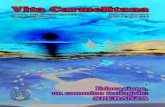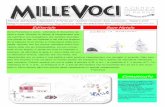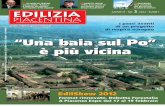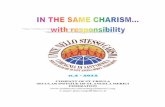ACINotizie 1-2 2012
-
Upload
ac-brescia -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
description
Transcript of ACINotizie 1-2 2012
Reg. TRib. di bRescian. 40/1984 del 22.12.1984
Sped. in a.p. - d.l. 353/2003(conv. l. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 2 dcb breScia
1.2|12
Testimoniamoil Concilio
BIMESTRALE DELL'AZIONECATTOLICA DI BRESCIA
ANNO XXVIuNO.DuE MARZO/ApRILE DuEMILADODICI
direttore reSponSabile:Graziano Biondi
redazione:Michele Bonometti, Michele Busi,Nicola Confortini, Miriam Martini,Massimo Orizio, Massimo pesenti,
Andrea Re, Annachiara Valle,Luciano Zanardini
direzione e redazione:Via Tosio 1 - 25121 Brescia
tel. 030.40102 - fax [email protected]
foto:Alessandro Chiarini,
Luisa ColosioGiorgio Baioni, pierangelo Traversi
editrice:Azione Cattolica Italiana
Consiglio diocesano di Brescia
progetto grafico:Maurizio Castrezzati
realizzazione:Cidiemme - Brescia
Stampa:Tipografia Camuna S.p.A.
Il presente fascicolo di "ACI Notizie"è stato stampato grazie ancheal contributo della Fondazione
Banca San paolo di Brescia
editoriale
Testimoni dello spirito del concilio
www.acbrescia.it
Gli indirizzi dell’associazione
Il prossimo 11 ottobre si celebrerà il 50° anniversario dall’apertura dei lavori del Concilio Vaticano II.Azione Cattolica di Brescia ha voluto dedicare il primo numero di AC Notizie del 2012 a questo evento. Intende farlo non per pura commemorazione, ma perché l’esperienza vissuta con il lavoro di formazione sui temi conciliari, specialmente attraverso i percorsi di Villa Pace, ci ha reso consapevoli di quanto, pur a cinquant’anni di distanza, sia forte il bisogno di conoscere e approfondire il volto di Chiesa che emerge da un Concilio che ha cambiato la storia della Chiesa. Rivolgere attenzione al Concilio è innanzitutto un esercizio di profezia: le intuizioni emerse da quell’evento sono ancora oggi di estrema attualità. Certo molte cose sono cambiate dentro le nostre comunità, ma molto rimane da fare, soprattutto a livello di una piena maturazione della fede cristiana e della cultura dei cattolici in una visione di Chiesa rinnovata, fedele al Vangelo, sinceramente attenta alla vita delle persone e in dialogo con loro. Pensiamo, solo per citarne alcuni, a quanta strada rimane da percorrere rispetto ai temi della corresponsabilità dei fedeli dentro la comunità, della dignità e del ruolo della donna nella Chiesa e nel mondo, del dialogo tra confessioni cristiane, tra religioni, tra Chiesa e territorio, della costruzione di una società fondata sulla giustizia, la pace, la solidarietà. Approfondire il Concilio è anche segno di speranza: una Chiesa che di fronte ad un mondo che si fa complesso decide di non chiudersi su se stessa ma di aprirsi, di “leggere i segni dei tempi” e vivere una nuova stagione autenticamente missionaria può diventare segno di speranza non solo per i cristiani ma per il mondo intero. Viviamo ormai da tempo una stagione segnata dall’incertezza.Sulla fragilità di questo tessuto umano, sullo smarrimento e la paura che questo contesto induce, rischia di radicarsi quella “religione civile” che difende i simboli esteriori della cristianità, recupera forme religiose tradizionali, ma che nelle scelte concrete mostra segni stridenti di chiusura all’altro e di contrasto con il Vangelo. Come associati di Azione Cattolica vogliamo dunque rivolgere una rinnovata attenzione al Concilio per interpretarne pienamente lo stile di speranza e di novità, cogliendo innanzitutto le proposte associative per conoscerlo e sperimentarlo, per nutrire la fede con la Parola e con la formazione, per costruire comunità corresponsabilie una Chiesa realmente evangelica. Un’AC pienamente missionaria sarà degna interprete e testimone dello spirito del Concilio.
andrea Re
il te
ma
03
la Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, ol-tre che di se stessa e del rapporto che a Dio la unisce, dell’uomo quale oggi in realtà si presenta: l’uomo vivo, l’uomo tutto occupato di sé, l’uomo che si fa non sol-tanto centro d’ogni interesse, ma osa dirsi principio e ragione d’ogni realtà. Tutto l’uomo fenomenico, cioè rivestito degli abiti delle sue innumerevoli apparenze, si è quasi drizzato davanti al consesso dei Padri con-ciliari, essi pure uomini, tutti Pastori e fratelli, attenti perciò e amorosi: l’uomo tragico dei suoi propri dram-mi, l’uomo superuomo di ieri e di oggi e perciò sempre fragile e falso, egoista e feroce; poi l’uomo infelice di sé, che ride e che piange; l’uomo versatile pronto a re-citare qualsiasi parte, e l’uomo rigido cultore della sola realtà scientifica, e l’uomo com’è, che pensa, che ama, che lavora, che sempre attende qualcosa, il ‘filius ac-crescens’ (Gen 49,22); e l’uomo sacro per l’innocenza della sua infanzia, per il mistero della sua povertà, per
paolo VI, omelia per la Nona Sessione (7 dicembre 1965)
simpatia per l’uomo d’oggila pietà del suo dolore; l’uomo individualista e l’uomo sociale; l’uomo ‘laudator temporis acti’ e l’uomo sogna-tore dell’avvenire; l’uomo peccatore e l’uomo santo; e così via. L’umanesimo laico profano alla fine è apparso nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è) dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema? Poteva essere; ma non è avvenuto. L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma del-la spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani (e tan-to maggiori sono, quanto più grande si fa il figlio della terra) ha assorbito l’attenzione del nostro Sinodo. Da-tegli merito in questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo”.
04
sono trascorsi quasi 50 anni dall’apertura del concilio Vaticano II. Dall’album della
memoria quali fotogrammi si possono estrarre in ordine al suo inaspettato inizio?Di quel giorno straordinario restano impresse tre immagini. Anzitutto, la processione solenne di oltre duemila padri conciliari che, scendendo la scala del Palazzo Apostolico, entrarono in corteo nella basilica di san Pietro. I vescovi di tutto il mondo erano convocati a Roma in Concilio, non per condannare errori dottrinali o sistemi ideologici, ma per avviare un autentico dialogo all’interno del corpo ecclesiale con lo scopo di riscoprire l’attualità e la vitalità dell’annuncio cristiano nello scenario culturale presente. In secondo luogo, quello pronunciato da papa Roncalli non fu affatto un discorso di circostanza e di convenevoli. Nell’allocuzione Gaudet mater ecclesia, il papa illustrò la sua “filosofia” del concilio: la necessità per la Chiesa di un “balzo innanzi” nella penetrazione della verità cristiana, onde offrire al mondo
circostante una riproposta del vangelo di Gesù, nel quadro di un “aggiornamento” delle forme e del linguaggio cristiani, in un clima di fiduciosa attesa che sollecitava a diffidare dai “profeti di sventura”, così da riscoprire il carattere prevalentemente “pastorale” del magistero episcopale e, perciò, del concilio stesso. Un ultimo fotogramma è quello del papa che, affacciandosi quella sera alla finestra del suo studio sulla piazza gremita dai pellegrini e illuminata dalle fiaccole, improvvisò il famoso “discorso della luna”. Quell’intervento nel suo alone di immediatezza e semplicità ebbe un impatto straordinario sull’opinione pubblica grazie alla sua diffusione per mezzo della televisione, inaugurando una nuova stagione di comunicazione e di presenza mediatica del messaggio ecclesiale nell’era della globalizzazione.
Veniamo ora al momento della chiusura del concilio, avvenuta l’8 dicembre del 1965Nella solennità dell’Immacolata, il movimento dei padri conciliari fu inverso rispetto all’ingresso di tre anni prima, “dalla Chiesa alla
piazza” e ciò acquistò un valore simbolico. I padri conciliari, radunati nella basilica di san Pietro in attesa dell’arrivo di Paolo VI, fuoriuscirono dal portale principale per prendere posto ai lati dell’altare per la celebrazione della santa messa. Nel messaggio pronunciato dopo il Vangelo, papa Montini intese esprimere l’apertura e la prossimità della Chiesa all’umanità tutta, rivolgendo un saluto di amicizia, stima ed affetto a credenti e a non credenti. Quasi a rinforzo di questa disposizione della Chiesa a entrare in dialogo con il mondo, al termine della celebrazione venne data lettura dei messaggi del Concilio ai governanti, agli scienziati, agli artisti, alle donne, ai lavoratori, ai poveri, agli ammalati, ai giovani. Al termine dell’evento straordinario del Concilio spettava alle Chiese locali e ai singoli credenti, nella ordinarietà del quotidiano, testimoniare il nuovo volto della Chiesa cattolica, fedele al Vangelo e appassionata nella costruzione della città degli uomini.
Quali frutti di quella stagione sono oggi patrimonio della comunità credente?
di michele busi
il tema
A 50 annidal ConcilioLa lezione del Vaticano II non è stata ancora completamente assimilata.La svolta da esso reclamata sul pianodella coscienza credente ed ecclesiale non èun dato pacificamente acquisito sul pianodel sentire e dell’agire credente.L’intervista al prof. Massimo Vergottini, promotore del sito internet www.vivailconcilio.it
il tema
05
La risposta non può essere liquidata in poche battute, in quanto il discorso chiederebbe di intavolare un complesso raffronto fra la stagione preconciliare e l’attuale contesto ecclesiale, passando attraverso le diverse fasi della recezione del Vaticano II. Limitandoci a considerare gli apporti più sostanziosi delle quattro costituzioni conciliari, si possono richiamare: a) la riscoperta della “actuosa participatio” nella liturgia, che restituisce la circolarità fra mistero, celebrazione e vita (Sacrosanctum concilium); b) il primato della Parola di Dio, attestata nella Scrittura, la quale diviene, unitamente ai sacramenti, alimento quotidiano per la crescita della coscienza credente (Dei Verbum); c) la nuova consapevolezza della Chiesa come popolo di Dio, nella valorizzazione dei ministeri, dei carismi e della comune dignità di tutti i credenti (Lumen gentium); d) la coscienza della Chiesa di disporsi in un atteggiamento di dialogo franco, costruttivo con la società, disposta a sostenere ogni iniziativa tesa a promuovere concordia, sviluppo e solidarietà in vista della promozione
del bene pubblico (Gaudium et spes). Ma questo elenco inevitabilmente è troppo riduttivo, perché lascia fuori una serie di frutti che il Vaticano II ha generato: basti pensare alla svolta nel campo dell’ecumenismo e del dialogo con le religioni, alla valorizzazione dei laici, al rilancio dell’attività missionaria e così via.
Quali, invece, le eredità disattese del Concilio, i percorsi avviati e tuttora da compiere?A cinquant’anni dall’inizio del Vaticano II, la svolta da esso reclamata sul piano della coscienza credente ed ecclesiale non è un dato pacificamente acquisito sul piano del sentire e dell’agire credente. Sia chiaro, il “nuovo corso” conciliare relativamente al mistero della Chiesa e all’identità del cristiano – al di là di pretestuose ritrattazioni – conta oggi su un consenso pressoché unanime a livello di coscienza diffusa. Eppure, perché un tale guadagno teorico possa conoscere una fattiva ricaduta nelle pratiche ecclesiastiche, e soprattutto nella coscienza credente, devono essere superati ancora non pochi
ostacoli ed essere vinte non poche resistenze. La cosa non deve stupire più di tanto, in quanto costituisce una puntuale conferma della regola più generale per cui nell’esperienza biografica dei singoli individui e degli stessi gruppi sociali si verifica uno scarto fra l’acquisizione teorica di un’idea e la sua assimilazione simbolica. Il passaggio dal sapére (“avere notizia”) al sápere (“divenire consapevoli”) non avviene automaticamente; implica invece un laborioso processo di interiorizzazione, che chiama in causa la decisione responsabile del soggetto. In altre parole, la lezione del Vaticano II è stata recepita sul piano riflesso, ma ancora non è stata appieno assimilata in profondità, fino a entrare pervasivamente nelle strutture, nelle abitudini, nel linguaggio della Chiesa e nella coscienza dei singoli fedeli. A ben vedere, però, se ci si confronta con la storia bimillenaria della comunità cristiana, cinquant’anni sono un periodo tutto sommato ancora breve per sostenere che l’onda lunga dell’ultimo concilio abbia concluso la sua spinta propulsiva.
06
di cesare trebeschi
Se oggi ci fosse un concilio…Brescia ha ben camminato nel Conciliograzie anche ai suoi maestri e ai suoi testimoni, ma adesso bisogna chiedersise non abbiamo dato in beneficenzai messaggi conciliari o se abbiamo ripostole aperture in archivi e biblioteche
nel Concilio, Brescia aveva presenze invidiabili: Montini e Bevilacqua, in qualche
misura profeta e animatore della Gaudium et spes e di una liturgia per tutti: raccontava di aver superato la ritrosia alla porpora lieto di partecipare a viso aperto alla Commissione sullo schema 13 (appunto, chiesa e mondo moderno) e aggiungeva ironicamente alla Commissione dove frati e monache fabbricano i santi (conteggiamo l’inflazione di aureole e porpore fra le ricadute del Concilio?). Furono gli ultimi viaggi del vescovo Tredici, in fide et lenitate, il coraggio della mitezza, allergico egli pure a certe fabbriche: rispettate la Verità, ma non fabbricate verità strumentali.Beati i piedi degli evangelizzatori: Brescia ha ben camminato nel Concilio; e fatto camminare, grazie a Morcelliana (nei giorni scorsi si è ricordato Stefano Minelli), Paideia con Scarpat, Queriniana con Piergiordano Cabra e Rosino Gibellini. Ma dopo mezzo secolo dovremmo parlare di risalite, più che di
ricadute, e forse proprio per risalire con maggior lena il vescovo Monari indice un Sinodo, non solo per fare il punto dopo quello promosso dal vescovo Morstabilini una trentina d’anni fa.Il crollo delle vocazioni lascia invero al cammino e alle battaglie della Chiesa bresciana una città di caserme vuote – chiese, conventi, seminari - o il Concilio ha lasciato fermenti, contenuti, e non soltanto vuoti contenitori?L’attualizzazione della liturgia raggiunge il suo scopo, o deve digerire il mugugno dei cerberi latinisti, vecchi cattolici, innamorati del gregoriano e fermi, col vecchio testamento, alla poligamia di Abramo e di Davide?L’apertura ecumenica del Concilio, fedelmente coltivata dalla CCDC si traduce nell’impegno a camminare insieme, o si riduce ad appannare con un velo d’ignoranza le peculiarità delle diverse Chiese?E l’apertura domestica ci incoraggia soltanto a camminare insieme con casini minuscoli e maiuscoli, rasserenati da bocche spalancate sui santi principi e da molteplici
poltrone per la fatica delle nostre giornate?Ricordo che già prima del Concilio La Pira e Mazzolari spopolavano anche a Brescia chiese e convegni invocando la grazia inquietante: evitiamo che una, questa sì inquietante, ricaduta del Concilio sia la soddisfazione per i risultati raggiunti dai Padri conciliari, non da noi personalmente.A costo di ripetermi, non vorrei che la ricaduta più concreta dei talenti conciliari fosse quella descritta da Trilussa:“Conosco un vecchio ricco, avaroma avaro a un punto taleche guarda li quattrini nello specchio per veder raddoppiatoil capitale.Poi dice questi li do viaperché ci faccio la beneficenza;gli altri li tengo per prudenzae li rimette nella scrivania”.I messaggi conciliari li diamo in beneficenza e riponiamo le aperture in archivi e biblioteche?Quali aperture? Non vedo ancora aperta quella generazionale, e sarebbe urgente spalancarla prima che andandosene i vitelli lascino la
il tema
07
stalla a decrepiti buoi. il vescovo ha parlato in Loggia della necessità di sdoganare: cosa, e soprattutto chi, con indifferibile urgenza?Saremmo ciechi e ingiusti se non prendessimo atto dei grandi passi compiuti da Chiesa e città nei confronti dei disabili: la rivoluzione copernicana della deistituzionalizzazione. Ma siamo ancora – e certo è molto – a livello di elemosina, non di fede: la parabola non distingue tra il destinatario di due talenti e quello di cinque, tutti degni dello stesso premio.Quale premio? Parliamo di evangelizzazione: si fa qualcosa di proprio per loro, o ci si limita a lasciarli a casa perché non disturbino in chiesa o a catechismo? Eppure, hanno tutti una legittima aspettativa all’eredità dei figli di Dio, quali che siano i talenti culturali, intellettuali, fisici. Certo, tocca a noi genitori: ma a prescindere dalla domanda, spesso angosciante, sul dopo di noi, siamo preparati ad una evangelizzazione specifica? Il discorso, se è lecito a un vecchio parlar pro domo sua, vale per i disabili dalla nascita, ma
non meno per i vecchi che perdono fiato e memoria.Ma lasciando ai teologi il discorso religioso, il Concilio afferma doveroso l’impegno civile per costruire una città di uomini liberi che nel loro tempo camminano insieme verso Dio (insieme, come Filippo con l’eunuco sulla strada di Gaza, e qui si dovrebbe aprire una parentesi sul diritto degli eunuchi ad una loro affettività: forse qualcuno ha torto il naso – durante la messa per i deportati – alla preghiera per le vittime omosessuali).Sarebbe sterile retorica chiedere cosa fa la Chiesa per promuovere questo impegno: forse la principale ricaduta – e risalita! – del Concilio è che con i sacramenti – battesimo, cresima, matrimonio – a noi tutti, tutti siamo chiesa, è posto, individualmente e collettivamente, il cogente interrogativo.Ma oltre al problema,di competenza dei pastori,della formazione religiosa di disabili e diversi, sul piano civile quale attuazione diamo al principio della dignità della persona umana
creata – dice il Concilio – ad immagine di Dio? È ben vero, il Concilio aggiunge che il peccato ha deformato questa immagine: ma quale peccato? Gesù, a proposito del cieco nato, è chiaro: né lui né i suoi genitori hanno peccato, l’immagine di Dio è più tersa nel disabile che in sedicenti normali. Bene dunque la giornata per la vita: ma per evitare che inavvertitamente, inconsapevolmente risulti terribilmente ipocrita non possiamo limitarci alla fase ostetrica, a demonizzar l’aborto: cosa facciamo come Chiesa per indurre i pubblici amministratori cristiani a riconoscere concretamente pari dignità, pari diritti a tutti, a partire dal diritto di pregare secondo la loro spiritualità, anche nelle moschee? Non c’è, avverte don Milani,peggior ingiustizia dell’eguaglianza dei diseguali.A che serve accoglier amorevolmentenel nido spedaliero gli immigrati dalla Mongolia fortunosamente scampati al naufragio nell’amniocentesi se poi si nega il sostegno necessario per lo sviluppo della loro personalità?
08
il tema
Ricordare i miei primi passi a Palazzo S. Paolo è riandare ad una stagione molto
intensa della mia vita, proiettata verso un impegno entusiasmante perché legato alla proposta del Concilio Vaticano II, che ci indicava le prospettive positive di un cambiamento nella visione della Chiesa. Fino ad allora la Chiesa – che in AC abbiamo sempre amato profondamente – ci sembrava legata a modelli e modalità di vita per noi un po’ troppo strette. Il Concilio squarciava orizzonti ampi come l’idea di “popolo di Dio”, “responsabilità dei laici”, “liturgia come celebrazione della vita”, “centralità della Parola di Dio”, “libertà religiosa”, ”missionarietà nella nostra realtà quotidiana”, “sguardo positivo sul mondo come luogo della realizzazione del Regno di Dio”. Quando inizia il Concilio, l’11 ottobre 1962, sto svolgendo il periodo di “naja”: sottotenente di complemento a Rovigo, pertanto molto distante da questo straordinario evento ecclesiale.
Finito il servizio militare, a fine estate 1963 riprendo gli impegni in parrocchia ed inizio a frequentare Palazzo S. Paolo (all’Ufficio Diocesano Aspiranti). L’anno successivo il Presidente della GIAC, Avv. Giuseppe Onofri, mi chiama a sostituire Stefano Frerini come Delegato Diocesano Aspiranti. Partecipo, pertanto, ai lavori dell’allora Presidenza Diocesana della GIAC, che tutti i lunedì si trova per un momento intenso di formazione. Intanto, il 21 novembre 1964, viene approvata la Costituzione Dogmatica sulla Chiesa (Lumen Gentium), firmata dal Papa bresciano Paolo VI. Nei primissimi mesi del 1965, i lunedì di Palazzo S. Paolo vengono dedicati allo studio approfondito di tale documento, sotto la direzione di don Renato Poetini, che lo sviluppa non solo sul piano cronologico, ma anche trasversalmente, toccando le varie tematiche fondanti il modo di intendere la Chiesa non più solo come Istituzione, ma
come Comunità, come Famiglia dei figli di Dio, come Popolo di Dio. Il lavoro di studio e di approfondimento ha portato noi giovani ad immergerci nelle idee e nella riscoperta della Chiesa come realtà capace di portare agli uomini forza e speranza per rilanciare il messaggio vivo del Vangelo di Gesù; innanzitutto, nel nostro mondo giovanile ed in secondo luogo ci ha spinto a dibattere con gli adulti i fondamenti di questa riscoperta della Chiesa che ci voleva tutti responsabili (nel rispetto dei rispettivi ruoli) nell’impegno di evangelizzare, di santificazione degli uomini, di formazione della loro coscienza. Questo entusiasmo e questa energia si sono dipanati principalmente in due direzioni: nella predisposizione di sussidi per i vari gruppi parrocchiali di AC, per permettere ad una grande platea di giovani di accostarsi seriamente alle idee ed alla prassi indicata dalla Lumen Gentium; nella disponibilità a servire le parrocchie
di bruno Frugoni
09
Duc in altum,azione cattolicaIl Concilio squarciava orizzonti ampi come l’idea di popolo di Dio, responsabilità dei laici, liturgia come celebrazione della vita, centralità della Parola di Dio, libertà religiosa, missionarietà nella realtà quotidiana
che volevano divulgare tra i parrocchiani, indicati dal Concilio come tutti chiamati all’apostolato direttamente dal Signore in forza del loro battesimo e della loro cresima, le idee del Concilio sulla dignità e sulla responsabilità dei fedeli laici nella vita della Chiesa e nell’impegno a realizzare le sue finalità nel mondo. Questo lavoro è continuato e, affermerei senza tema di essere smentito, continua ancora oggi, logicamente con metodi diversi, nel correre in lungo ed in largo la nostra Diocesi da parte di giovani per veicolare nelle nostre parrocchie le idee e lo stile dei cristiani nella Chiesa e nel mondo. Con l’Assemblea Nazionale del 1970 anche l’AC, leggendo il Concilio, ha sentito il bisogno di rinnovarsi e di ristrutturarsi, approvando un nuovo Statuto, approntato dalla presidenza di Vittorio Bachelet ed approvato da Papa Paolo VI nel 1969. Questo nuovo Statuto ridimensiona e ristruttura sul piano istituzionale l’AC, per poter rileggere in chiave
conciliare le sue originali e fondamentali finalità sia formative che di presenza ecclesiale. Laici, quindi, non solo disponibili a “servire la Chiesa”, ma capaci di acquisire sempre più la coscienza di “essere la Chiesa”. Il processo educativo lo mette in atto a servizio di tutta la comunità ecclesiale italiana. L’impegno è tradotto nella formula “scelta religiosa”, sposata in seguito da tutta la Chiesa italiana ed in servizio rivolto a tutte le nostre Comunità cristiane, per veicolare gli orientamenti del Concilio. I risultati di questo lavoro lungo gli ultimi decenni del XX secolo ci sono stati riconosciuti dai nostri Vescovi e dal Papa Giovanni Paolo II, nel momento in cui ci siamo cimentati a rinnovare lo Statuto con l’Assemblea Nazionale Straordinaria del 2003, sotto la Presidenza di Paola Bignardi. I Vescovi, infatti, riconoscono l’impegno dell’AC, dandole il merito di aver contribuito significativamente alla ricezione del Concilio nelle nostre
parrocchie. I Vescovi parlano del ruolo dell’AC nel rinnovamento della prassi liturgica; nello sviluppo di una nuova e profonda attenzione alla Parola di Dio; nel superamento dell’atteggiamento passivo di tanti laici – al massimo disponibili a rispondere alla richiesta di collaborazione da parte dei pastori – verso una piena corresponsabilità nella realizzazione del fine globale della Chiesa. Da parte sua, Giovanni Paolo II ai delegati all’XI Assemblea Nazionale del 2002 affermava: “Proprio perché la Chiesa ha bisogno di un’Azione Cattolica viva, forte e bella, mi piace ripetere a ciascuno di voi: Duc in altum! Duc in altum, Azione Cattolica! Abbi il coraggio del futuro. La tua storia, segnata dall’esempio luminoso di Santi e Beati, brilli anche oggi per fedeltà alla Chiesa e alle esigenze del nostro tempo, con quella libertà tipica di chi si lascia guidare dal soffio dello Spirito e tende con forza ai grandi ideali”.
10
spiritualità
scrive il decreto Apostolicam ac-tuositatem: “I laici, (mediante il battesimo) resi partecipi dell’uf-
ficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, nella missione di tutto il popolo di Dio assolvono compiti propri nella Chiesa e nel mondo. In realtà essi eser-citano l’apostolato con la loro azione per l’evangelizzazione e la santificazione de-gli uomini e animando e perfezionando con lo spirito evangelico l’ordine delle realtà temporali, in modo che la loro at-tività in questo ordine costituisca una chiara testimonianza a Cristo e serva alla salvezza degli uomini” (n. 2). Vor-rei soffermarmi sul numero 4 del de-creto, intitolato: La spiritualità dei laici in ordine all’apostolato per sottolineare alcune dimensioni ancora valide oggi, che riecheggiano nel Progetto Formati-vo nei capitoli 2, 3 e 4. Siccome la fon-te e l’origine di tutto l’apostolato della Chiesa è Cristo, mandato dal Padre, è evidente che la fecondità dell’apostola-to dei laici dipende dalla loro unione vitale con Cristo, ...Questa vita d’inti-mità con Cristo viene alimentata nella Chiesa con gli aiuti spirituali comuni a tutti i fedeli, soprattutto con la parte-cipazione attiva alla sacra liturgia. I laici devono usare tali aiuti in modo che, mentre compiono con rettitudine i do-veri del mondo nelle condizioni ordi-narie di vita, non separino dalla propria vita l’unione con Cristo, ma crescano sempre più in essa compiendo la pro-
pria attività secondo il volere divino. Su questa strada occorre che i laici progre-discano nella santità con ardore e gioia, cercando di superare le difficoltà con prudenza e pazienza. Né la cura della famiglia né gli altri impegni secolari devono essere estranei alla spiritua-lità della loro vita…Tale vita richiede un continuo esercizio della fede, della speranza e della carità. Solo alla luce della fede e nella me-ditazione della parola di Dio è possi-bile, sempre e dovunque, riconoscere Dio nel quale “viviamo, ci muoviamo e siamo” (At 17,28), cercare in ogni avvenimento la sua volontà, vedere il Cristo in ogni uomo, vicino o estrane-o, giudicare rettamente del vero senso e valore che le cose temporali hanno in se stesse e in ordine al fine dell’uo-mo... Spinti dalla carità che viene da Dio, operano il bene verso tutti, “eli-minando ogni malizia e ogni ingan-no, le ipocrisie e le invidie, e tutte le maldicenze” (1 Pt 2,1), attraendo così gli uomini a Cristo. La carità di Dio, “diffusa nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato da-to” (Rm 5,5), rende capaci i laici di esprimere realmente nella loro vita lo spirito delle beatitudini. Seguendo Gesù povero, non si deprimono nel-la mancanza dei beni temporali, né si inorgogliscono nella abbondanza di essi; imitando Gesù umile, non di-
ventano avidi di una gloria vana (cfr. Gal 5,26), ma cercano di piacere più a Dio che agli uomini… Coltivando l’amicizia cristiana tra loro si offro-no vicendevolmente aiuto in qualsi-asi necessità. I laici non tralascino dunque di col-tivare costantemente le qualità e le doti ricevute, corrispondenti a tali condizioni, e di servirsi dei doni otte-nuti dallo Spirito Santo. Inoltre, quei laici che, seguendo la propria parti-colare vocazione, sono iscritti a qual-che associazione o istituto approvato dalla Chiesa, si sforzino di assimilare fedelmente la spiritualità peculiare dei medesimi.Tutti i laici facciano pure gran conto della competenza professionale, del senso della famiglia, del senso civico e di quelle virtù che riguardano i rap-porti sociali, come la correttezza, lo spirito di giustizia, la sincerità, la cor-tesia, la fortezza di animo: virtù senza le quali non ci può essere neanche u-na vera vita cristiana. Modello perfetto di tale vita spirituale e apostolica è la beata vergine Maria… Invitando cia-scuno, come impegno quaresimale, a rileggere e meditare l’Apostolicam actuositatem, insieme ai capitoli 2, 3 e 4 del Progetto Formativo (altri testi possibili possono essere: Laici secondo il Vangelo e La vita nello Spirito dell’A-VE) voglio richiamare alcuni numeri
Laici secondoil vangelo
di don massimo orizio
Solo alla luce della fede e nella meditazione della parola di Dio è possibile, sempre e dovunque, riconoscere Dio nel quale “viviamo, ci muoviamo e siamo”, cercare in ogni avvenimento la sua volontà, vedere il Cristo in ogni uomo
11
E come continuare a camminare oggi? Ecco alcune proposte semplici per proseguire in questo cammino, senza rinunciare né alla fede,né alla lucidità. Realizzare con tutta naturalezza quello che la fede cristiana ci propone. Osservare con fedeltà e semplicità le esigenze centrali della nostra fede: la preghiera personale e comunitaria; la celebrazione eucaristica e la partecipazione sacramentale, la Regola di vita; la lettura personale/comunitaria della Bibbia; la riflessione per una migliore comprensione della fede; il servizio disinteressato dell’amore al prossimo; la motivazione cristiana della vita quotidiana, familiare, professionale, civica, sociale, politica... Vivere, celebrare e testimoniare la “differenza cristiana” manifestata in Gesù Cristo che rende possibile l’uomo nuovo (Ef 2,15; 4,24), con la proclamazione delle Beatitudini nelle scelte coraggiose. Vivere la comunione ecclesiale centrata sulla parola di Dio e sui Sacramenti, quali basi dell’essere Chiesa, al cui “servizio” – si noti la parola! – sta il ministero pastorale dei vescovi e dei presbiteri (LG 24).Ricordare che la Chiesa è una ‘realtà complessa’, che in modo paradossale contiene il messaggio del Vangelo; per cui la Chiesa è ‘santa’ per quello che offre ma, insieme, come comunità storica e concreta essa ha ‘sempre bisogno di purificazione’ e di ‘perenne riforma’ (LG 8; uR 6). Meditare sulla realizzazione della Chiesa attraverso la sua storia, contrassegnata dalla ‘riforma’ (Benedetto XVI) quale è stato il Vaticano II, la cui ricezione va incoraggiata.Suscitare reti di relazione, di comunione, di solidarietà, di complicità nelle associazioni, tra persone, parrocchie, comunità, servizi, istituzioni... come nuclei ecclesiali.
Tener presente le vere dimensioni della Chiesa universale: non dimenticare la dimensione ‘cattolica-universale della Chiesa’, quella diocesana senza perdere la dimensione concreta, locale, incarnata della propria vita cristiana. Conservare l’importanza della partecipazione nelle istanze ‘sinodali’ della nostra Chiesa (consigli parrocchiali, diocesani, assemblee, giornate, sinodi, concili...) con volontà decisamente “comunionale”, unita alla franchezza per manifestare l’eventuale disaccordo con spirito di dialogo. Riflettere sul fatto che la Chiesa riceve la luce, come la riceve la Luna: i padri della Chiesa, la luce data da Cristo alla Chiesa, amavano paragonarla alla dipendenza che ha la Luna dal Sole, del quale essa non è che un “riflesso semioscuro” (san Bonaventura), per cui la Chiesa appare “bella come la Luna che in pace e sicurezza cresce,o decresce oscurata dalle avversità” (Tommaso d’Aquino). Tener presente il paradosso della Chiesa come madre: “quale paradosso, nella sua realtà, questa Chiesa, in tutti i suoi aspetti contrastanti! Quante irriducibili immagini ce ne offre la storia! In quasi venti secoli, quanti mutamenti sono sopravvenuti nel suo comportamento, quanti strani sviluppi, quante svolte, quante metamorfosi. Mi si dice che è santa, e la vedo piena di peccatori.Sì, paradosso della Chiesa. paradosso di una Chiesa fatta per un’umanità paradossale.La Chiesa è mia madre perché mi ha generato alla vita. In una parola, la Chiesa è nostra madre perché ci dà il Cristo. Ma non tutti i suoi figli la capiscono. Alcuni si spaventano e si scandalizzano...In simili circostanze, quelli che la riconoscono come madre devono compiere la propria missione in umile ed attiva pazienza. La Chiesa infatti porta al mondo la speranza...”(H. de lubac).
degli Orientamenti del decennio E-ducare alla vita buona del Vangelo. Il numero 22 invita a formare alla vita secondo lo Spirito, al valore dell’ac-compagnamento personale; il 23 sot-tolinea la dimensione vocazionale e la misura alta della vita cristiana or-dinaria; il 27 richiama il nesso stretto tra educare e generare, la pazienza di ogni processo di crescita; il 29 riba-disce il ruolo e l’autorevolezza della testimonianza. Come realizzare que-sti inviti? La testimonianza dei laici come segno di credibilità. L’irruzione massiccia della terminologia della te-stimonianza si ha con il Vaticano II e vengono applicati sia alla Chiesa inte-ra sia a ciascun cristiano, e di forma assolutamente prioritaria ai laici nel capitolo IV di Lumen Gentium. Sono gli stessi cristiani con la loro vita san-ta, e le comunità di cristiani con la loro vita di unità e carità, a costituire il segno della Chiesa. La “sinodalità” come espressione della Chiesa come comunione. Essendo la Chiesa una comunione, tutte le sue azioni debbo-no essere contrassegnate da uno stile “comunionale”. A livello di Chiesa lo-cale, oggi la sinodalità si esprime con una partecipazione al cammino ver-so il Sinodo, nonostante le lentezze, le stanchezze e le disillusioni: forse risulterà flebile, ma non tralasciamo di far sentire la voce dell’associazione.
otto propoSteper camminare bene
società
12
l’iniziativa degli «Incontri di Pa-lazzo San Paolo» si sta consoli-dando con l’attenzione vigile e
critica ad aspetti che riguardano nel concreto la realtà bresciana. Il tema del primo incontro del 2012, Il wel-fare a Brescia in tempo di crisi, il 31 gennaio ha richiamato in via Tosio 1 cittadini numerosi e interessati. I re-latori erano: Margherita Rocco, por-tavoce del Forum del Terzo settore, Giorgio Maione, assessore ai servizi sociali del Comune di Brescia, Fabio Capra, presidente della commissio-ne bilancio sempre del comune di Brescia. Ha moderato Roberto Ros-sini, presidente delle Acli bresciane. Da una parte, allora, l’Istituzione, dall’altra la Società civile, entram-be provocate dalla domanda: meno risorse quindi meno servizi? È que-sto l’interrogativo più legittimo in un momento in cui la crisi investe tutti i settori produttivi e da crisi economi-ca sta diventando anche crisi sociale, culturale ed etica. Ma c’è una certezza, e non è stata contestata: la nostra città vanta u-na tradizione di forte impegno sul versante dei servizi sociali: Brescia, operosa e insieme generosa, ha ela-borato un modello di welfare che ha fatto scuola anche a livello naziona-le. Un modello virtuoso che ha potuto contare su una buona disponibilità di risorse e su una efficiente macchina amministrativa che le ha distribuite
con buon senso. Oggi tuttavia il qua-dro è mutato e si è fatto più comples-so. Meccanismi sociali più selettivi e feroci che in passato hanno generato nuove povertà, che ora con un termi-ne più sfumato ma non meno espres-sivo chiamiamo fragilità, e situazioni borderline. Anche la nostra città cam-bia: è una città che invecchia, dove nascono pochi bambini, i giovani non trovano lavoro e dove c’è una percen-tuale di persone sole doppia rispetto alla media nazionale.Quale la risposta a tutto ciò? L’asses-sore Giorgio Maione ha citato il piano del Comune rispetto alla situazione di crisi. Un piano che a livello teori-co ha molti aspetti che non possono non essere condivisi. Uno dei pilastri che lo reggono, per e-sempio, è il tema della coesione socia-le: il cittadino deve poter riconoscersi nella propria comunità; da qui la scel-ta di promuovere l’associazionismo e tutti quegli interventi che in modi diversi creano aggregazione sociale.Il documento municipale delinea un metodo di lavoro e scelte culturali precise: parla di sussidiarietà, che, sottolinea più volte l’assessore, è un richiamo alla dottrina sociale della Chiesa. Un welfare comunitario e sussidiario che riconosce ciò che il territorio è in grado di fare e con es-so co-produce e co-gestisce. Su diver-si livelli questa sintonia si è rivelata vincente e ci sono esempi molto vi-
cini: l’organizzazione dell’emergen-za freddo, la tutela dei minori non accompagnati che si è avvalsa della collaborazione di parrocchie e grup-pi di volontariato. Ben venga un interesse condiviso, ma non è inopportuna la domanda che ne consegue: fino a che punto la sussidiarietà non si confonde con la terziarizzazione o la privatizzazione? Il Terzo settore è d’accordo con que-sto ruolo di collaborazione con l’Isti-tuzione? La questione non è di poco conto. È Margherita Rocco a portare la voce del privato sociale. Al Forum del Terzo settore si riferiscono ben 29 realtà che operano a diversi livelli nel territorio. Il mondo del volontariato, ci spiega Rocco, sta sostenendo casi che le istituzioni neppure conoscono. Ha la capacità di intercettare i biso-gni e di leggerli prima di quanto fac-cia l’istituzione. Ha colto i problemi dell’invecchiamento della popolazio-ne e della famiglia che cambia. Ma c’è il rischio che su di esso si scarichi ciò che lo stato non sa fare. Fabio Capra ha evidenziato come in un momento di crisi come questo non era opportuno il taglio di ben 4 milio-ni e mezzo sui servizi sociali. Stiamo vivendo una fase di emergenza, che va affrontata facendo ricorso a tutte le risorse disponibili per progetti non prioritari. La critica si è fatta più dettagliata quando si sono citati i settori che in
un dibattito sul welfare Da una parte, l’Istituzione, dall’altrala Società civile. Margherita Rocco, portavocedel Forum del Terzo settore,Giorgio Maione, assessore ai servizi sociali,e Fabio Capra, consigliere comunale
di anna maria gavazzi
teoria possono aver tolto risorse ai ser-vizi sociali: le modifiche alla struttura del mercato settimanale, gli automez-zi regalati ai carabinieri, il progetto del parcheggio sotto il Castello, le esage-rate (alla luce della attuale situazione economica) spese per la metro.Negli interventi da parte del pubblico presente in sala, la denuncia di una analisi più precisa da parte del Co-mune sulle reali emergenze espres-se dalla città. Ma dai presenti è arrivato anche u-no stimolo intelligente condiviso dagli amministratori: l’invito a cogliere le opportunità della crisi, che non sono quelle di ridurre le spese ma di cam-biare le regole del gioco. Non solo fare appalti e progetti per un futuro troppo lontano, anche imparare dalla società civile a capire il territorio e a relazio-narsi con esso; un richiamo al corag-gio dell’innovazione con la messa in discussione di standard di servizi che corrispondono ancora ad una società che non è quella di oggi.Sono temi quanto mai coinvolgen-ti, che avrebbero potuto trattenere l’attenzione e l’interesse dei presenti molto più a lungo di quanto il tempo dell’incontro abbia permesso. Tra critiche e domande, il clima è sta-to di forte partecipazione, a riprova che gli incontri di Palazzo San Paolo sono davvero “nel cuore della città” e stanno riflettendo su temi che toc-cano nel vivo il nostro tessuto sociale.
palazzo San paolo è sede da qualche anno anche dell’associazione “Città dell’uomo - Brescia”. L’associazione, aperta a tutti, intende offrire opportunità e servizi per aiutare il laico credente, secondo l’espressione di Giuseppe Lazzati, a “pensare politicamente”, proponendosi di elaborare, promuovere, diffondere una cultura politica che, animata dalla concezione cristiana dell’uomo e del mondo, sviluppi l’adesione ai valori della democrazia espressi nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, rispondendo alle complesse esigenze della società in trasformazione e nel contempo rifacendosi agli insegnamenti ribaditi dal Concilio.“Città dell’uomo - Brescia” è sorta – anche per convinta volontà da parte di esponenti dell’associazionismo cattolico bresciano, quali AC, Acli, Meic – per promuovere nella realtà bresciana una cultura politica rinnovata, intesa come spazio di mediazione e di educazione alla dimensione morale, e intende essere un’associazione dedita non solo alla formazione e alla trasmissione di cultura politica rivolta alle giovani generazioni, ma anche un luogo di elaborazione e diffusione di essa. L’associazione nasce caratterizzata
da un forte radicamento ecclesiale, proprio perché persegue tra i propri obiettivi anche il ritorno di un “pensare politicamente” anche all’interno delle nostre comunità ecclesiali, senza nutrire il timore di un confronto aperto.Nel mese di dicembre si è svolta presso la Sala “Giuseppe Lazzati” l’annuale assemblea dei soci, alla presenza del presidente nazionale prof. Luciano Caimi, per fare il punto del percorso di questi primi anni di vita e per impostare l’attività del prossimo anno. Tra le proposte emerse, un percorso formativo per giovani che hanno o intendono assumere responsabilità in ambito amministrativo nel proprio territorio. Nell’occasione è stato nominato il nuovo gruppo direttivo, costituito da Davide Bellini,Michele Busi, Franco Gheza, pierangelo Milesi, Federica paletti, Marco peli, Massimo pesenti, paolo poli, Stefania Romano,paolo Zaninetta. L’Associazione è aperta a quanti, condividendone le finalità, fossero interessati a farne parte. Per informazioni e adesioni è possibile contattare i membri del Direttivo.L’e-mail dell’Associazione è[email protected].
ac, acli e meic la rinaScitadi “città dell’uomo - breScia”
13
PReTidi frontiera
Tre figure significativedi sacerdoti del Novecento che,in ambiti differenti,hanno caratterizzatola loro vita nell’incontrocon “i lontani”.
15 marzo: don luigi orioneintervengono: Don paolo Clerici e Michele Busi
22 marzo: don giuseppe de lucaintervengono: Marco Roncalli e mons. Antonio Fappani
29 marzo: padre david m. turoldointervengono: Maria Cristina Bartolomei, mons. Angelo Casati e Luciano pazzaglia
gli incontri si tengono alle ore 18,00 a Palazzo s. Paolo
società
spazio ac | iniziativa di solidarietà
14
la XIV Assemblea Diocesana ha lasciato, tra i tanti, un compito chiaro: siamo chiamati ad atti-
varci in modo deciso per “contribuire ad una nuova costruzione della città e della civiltà”, anche attraverso un rin-novo della “centralità della scelta mis-sionaria quale elemento caratterizzan-te il cammino associativo dell’Azione Cattolica”. Ecco quindi che il lavoro di elaborazione svolto comincia ora a prendere forma: accanto ad un per-corso per noi più “tradizionale”, con la raccolta di fondi per un progetto in Congo, è nata l’idea di un cammi-no nuovo, sia per il tema che affron-ta che per lo stile con cui intendiamo percorrerlo. Questo nuovo percor-so, che ha per titolo “Legàmi aper-ti - Per un territorio da riabilitare”, prende spunto dal progetto cittadino
“Brescia Aperta e Solidale”, promos-so e gestito da Associazione Centro Migranti, ACLI provinciali Brescia e MCL Unione Provinciale di Brescia, e intende promuovere l’integrazione tra cittadini italiani e immigrati stranieri attraverso l’incontro, il confronto, la collaborazione nel contesto dei luoghi in cui viviamo: il paese, il quartiere, la città. Lasciando a ciascuna associazio-ne parrocchiale il compito di appro-fondire le modalità di costruzione del progetto, è importante sottolineare le ragioni di questa proposta, destinata in particolare a giovani e adulti. Il pro-getto, infatti, sembra poter far sintesi di alcuni criteri che abbiamo condivi-so negli ultimi trienni, primo fra que-sti l’importanza di un’iniziativa di so-lidarietà destinata a bisogni vicini, sul territorio, per permettere un maggior
un territorio da abitareIl confronto di questi mesi in Consiglio Diocesano ha fatto emergere l’esigenza di dare un volto concreto a questa scelta ideale, in particolare attraverso un progetto innovativo
coinvolgimento concreto delle associa-zioni che anche grazie a questo possa-no sviluppare atteggiamenti missiona-ri, divenendo stimolo per la comunità cristiana a radicare una fede più adul-ta, matura, autentica. Consapevoli del fatto che l’AC non è un’associazione specificatamente orientata al servizio concreto alla persona, vogliamo rivol-gere il nostro impegno ai bisogni che coinvolgono in modo più esplicito la dimensione culturale ed etica della vita: in particolare appare oggi urgen-te un lavoro di carattere culturale sul tema della migrazione e dell’integra-zione tra popoli, che porti alla costru-zione in senso autenticamente popo-lare di una società fatta di persone capaci di convivere pacificamente e vivacemente, facendo della diversità una ricchezza e non un limite. Que-ste sono le ragioni che hanno spinto il Consiglio Diocesano a promuovere questo nuovo progetto. Certamente si tratta di una scelta non facile, che ci spinge fuori dai nostri contesti or-dinari, che potrà anche farci misura-re con opinioni diverse dalle nostre, ma è questo il momento di giocarci, di osare strade nuove, di raccogliere con coraggio l’invito a leggere i “segni dei tempi” per testimoniare il Vange-lo dentro la realtà concreta, convinti che nel confronto con chi è portatore di una cultura diversa vivremo la ric-chezza della relazione, rafforzando e motivando al contempo la nostra scel-ta di fede. Sarà un cammino bello e appassionante, ma come sempre… bisogna saper compiere il primo passo.
di andrea Re
15
educare alla vita buona del Vangelo” è l'orientamento pastorale che l'Episcopato
Italiano ci presenta per il decennio 2010-2020. Una sfida culturale e un segno dei tempi, così la descrivono i Vescovi italiani, ma prima ancora una dimensione costitutiva e permanente della nostra missione di rendere Dio presente in questo mondo e di far sì che ogni uomo possa incontrarlo. è da questa scelta dei Vescovi che scaturisce il desiderio di capire, insieme agli educatori dell’ACR della Diocesi, quanto siamo pronti e preparati a comunicare il messaggio di Dio ai fanciulli.Per questo, già dal Convegno Educatori 2011 del marzo scorso, abbiamo intrapreso un lungo percorso per meglio affrontare la questione. Partiamo appunto da domenica 27 Marzo 2011, dal Convegno educatori dal titolo “La Parola… ai ragazzi”. Ospite del convegno padre Stefano Gorla, responsabile dell’Area Ragazzi Periodici San Paolo e direttore del settimanale “Il Giornalino”. Sollecitato dalle domande degli educatori (Come narrare la Bibbia ai ragazzi? Come rispondere ai loro quesiti? Come affrontare l’indifferenza?) Padre Stefano ha coinvolto i partecipanti in un viaggio attraverso la Parola, un viaggio composto da tante e diverse figure, che si differenziano per esperienza e conoscenze.
La Parola è una storia da narrare e per poterla narrare al meglio, il narratore stesso dev'essere testimone di questa storia e allo stesso tempo deve conoscere e saper ascoltare e capire i fanciulli che lo ascoltano. La Parola è una storia che ha bisogno di gestualità, di spazio, di voce e di corpo in modo che riesca a coinvolgere e ad incuriosire. Nel novembre scorso, gli educatori dell'ACR hanno invece affrontato quattro incontri (tutti di giovedì sera, presso Villa Pace) animati dalla scrittrice bergamasca Giusi Quarenghi, specializzata in libri per l’infanzia. Durante il laboratorio formativo per educatori “La Parola ai ragazzi” gli interventi della Quarenghi ci hanno fornito una serie di forti provocazioni che ci hanno chiamato in causa, prima ancora che come educatori, come Credenti che si accostano alla Parola di Dio.Nessun testo è autosufficiente ed è completo, senza un lettore che lo indaga e lo fa suo. Quindi, quello che ci viene chiesto a noi educatori è quello di fare il primo passo per accostarci alla Parola, perché se l'uomo non collabora l’azione di Dio rimane iniziata, ma non costruita. Ci viene chiesto di metterci in gioco, ricordando che non si può insegnare quello che non si ama e non si può trasmettere quello che non si conosce.
Educare alla vita buona
spazio ac | ragazzi
Il percorso sulla Parola affrontato dagli educatori dell’ACR diocesana nell’anno appena trascorso: tre momenti di riflessione e di confronto
Domenica 5 febbraio 2012 infine, in occasione del Convegno educatori dal titolo “Dalla Parola alla Vita”, abbiamo potuto ascoltare le parole del vice presidente nazionale per i giovani Marco Sposito, della diocesi di Gaeta. Un intervento, quello di Marco, incentrato sull’importanza della regola di vita e della vita spirituale per ogni educatore e associato di AC, con alcuni spunti molto provocatori. Un educatore dev’essere sempre se stesso in ogni ambito del quotidiano e della propria vita e non indossare maschere diverse per ogni occasione. I partecipanti al convegno hanno avuto la possibilità di confrontarsi in piccoli gruppi per poter "provocare" a loro volta il relatore con i loro quesiti. Queste dunque le occasioni proposte agli educatori della diocesi per approfondire il tema dell’Annuncio, una sfida che ci impegna sicuramente, ma allo stesso tempo ci rende veri protagonisti dell’educazione. Una sfida che accogliamo per una continua crescita, non solo personale, ma di tutta l’associazione.
di sara Filippini e nicola confortini
spazio ac | giovani
16
I giovani si interrogano…
gli “alti” organi a livello diocesa-no (la Presidenza, il Consiglio e il Settore Giovani) da un po’
di tempo a questa parte hanno dedi-cato e stanno dedicando forze, pen-sieri e preoccupazioni alla questione dei giovani in Associazione. Questa “emergenza giovanile” parte da un dato di fatto che è oggettivo. I giova-ni sono in crisi. Questa parola, crisi, fin troppo sfruttata negli ultimi me-si, cerca di fotografare una situazio-ne difficile che merita attenzione, fin dalla sua definizione: stato transito-rio di particolare difficoltà o di turba-mento, nella vita di un uomo o di una società. Analizzando nel concreto la situazione, e contestualizzandola nel-la nostra riflessione, essa si traduce in: crisi di valori dei giovani, relativi-
smo culturale, secolarismo universa-le, mancanza di riferimenti solidi, alto tasso di disoccupazione giovanile (sti-mato dall’Istat nei giovani 15-24enni al 30,1%), profondi cambiamenti a livello dell’immagine famigliare (nel 2009 le separazioni sono state 85.945 e i divorzi 54.456). Rispetto al 1995 le separazioni sono aumentate di ol-tre il 64 per cento ed i divorzi sono praticamente raddoppiati (+ 101 per cento), sempre secondo l’Istat), calo di guide religiose cattoliche (in parti-colare in Europa, Annuario Pontificio 2011), ecc. Potremmo trovare molte altre cause che si collegano a questa banale analisi costruita sulla base di alcuni parziali dati statistici e voci di corridoio. Più facile come esercizio potrebbe essere quello di analizza-
Il quadro non è certo positivo: vi è uno scarsoafflusso dei giovani alla vita della parrocchia,un basso numero di aderenti all’associazione etroppo spesso si sovraccaricano le persone
re invece le conseguenze dirette di questo miscuglio di problematiche più o meno verificabili, anche perché di queste conseguenze abbiamo dei dati misurabili a pelle. Ad esempio, vi è uno scarso afflusso dei giovani alla vita della parrocchia, un basso numero di aderenti all’associazione; troppo spesso si programmano le at-tività facendo di necessità virtù, con le forze residue e sovraccaricando i pochi (e decisamente buoni) giova-ni rimasti, cercando di fare capolino con tutto ciò che si vuole o si deve programmare. Alla nostra breve riflessione si aggiun-ge appunto la riflessione a livello u-nitario in sede di Consiglio diocesano (e non solo), sintomo di una impor-tante preoccupazione anche (e forse soprattutto) da parte di quegli adul-ti con cui spesso si viene in contat-to senza potervi costruire un dialogo sano e costruttivo. Interroghiamoci e interroghiamo i giovani, perché può essere davvero la chiave di volta di u-na società che,alla luce di tanti, troppi fatti dell’oggi, sembra non procedere nel verso giusto. Oggi, e da qui all’av-venire, c’è la possibilità di costruire insieme un pensiero che, speriamo, possa tradursi in tante piccole azioni utili per dare una svolta alla nostra piccola porzione di mondo. Non è un gesto eroico, ma percorrere insieme questa strada è, al contrario delle tendenze odierne che purtroppo si leggono nei fatti di cronaca, un non lasciare che la nave affondi senza pri-ma aver tentato di recuperare la rotta.
17
Missionarietàe sinodo
in questi mesi sono stati pensa-ti alcuni momenti di approfondi-mento a Manerbio, Carpenedolo,
Gussago, Gavardo, Sarezzo e Civida-te Camuno. In questi incontri, oltre che porre attenzione alle realtà dei nostri gruppi, l’obiettivo era anche quello di presentare e dare slancio all'Iniziativa di solidarietà e al Cam-mino di preparazione al Sinodo sulle Unità Pastorali. Per quanto riguarda l’iniziativa di Solidarietà, le ultime assemblee diocesane hanno dato in-dicazioni per porre attenzione a due aspetti che la devono contrassegnare: la missionarietà e quindi l'attenzione alla realtà in cui viviamo. Nell'occa-sione degli incontri macrozonali vo-gliamo scoprire con i gruppi quali gli elementi che caratterizzano e quali le tappe che siamo chiamati a per-correre. L’Iniziativa di Solidarietà
che portiamo avanti in contatto con il Centro Migranti della diocesi, ci chiama quest'anno e nei prossimi a sperimentare e concretizzare nuove modalità che, oltre alla carità concre-ta che non va mai dimenticata, pon-gano gesti e scelte che hanno a che fare con il nostro modo di pensare e vivere le situazioni legate all'acco-glienza di coloro che sentiamo come "altri", "stranieri". A proposito, invece, del Sinodo crediamo fermamente in questa occasione come momento di crescita della Chiesa Bresciana, an-che grazie al contributo che possiamo e dobbiamo dare come laici associati. In occasione degli incontri proponia-mo un piccolo cammino fatto di un momento di riflessione nei gruppi, un momento anche a livello zonale per un confronto tra laici e sacerdoti par-tendo da una semplice domanda fatta
Nei mesi di gennaio e di febbraio l'attività delSettore Adulti è stata impostata nello svolgimentodegli incontri macrozonali convocati, come giànegli anni scorsi, per incontrare il territorio
a ciascuna delle parti: "cosa ti aspet-ti da me ?". Il percorso si concluderà al meeting unitario nel quale prove-remo a fare sintesi di questi incontri per elaborare il contributo da portare al Sinodo diocesano. Accanto a que-sto impegno il settore organizza nei giorni 20 – 22 aprile, a Villa Pace, un weekend dedicato ai “giovani-adulti” di riflessione sul tema “Scelte e sfide” dove, principalmente attraverso espe-rienze laboratoriali eterogenee (musi-ca, teatro, pittura, scrittura creativa, ecc.), si cercherà di cogliere le pro-blematiche e le criticità della fase di passaggio dalla giovinezza all'adultità per scoprire a quali sfide porta questa età "speciale" e molto delicata. Stia-mo inoltre programmando, nella con-tinuità con l'Iniziativa di Solidarietà, il campo scuola estivo che si svolgerà dal 6 al 12 agosto a Molfetta in Pu-glia. L'obiettivo è quello di andare a incontrare persone e situazioni che hanno già sperimentato l'accoglien-za e vedere con i nostri occhi come questo è stato concretizzato. Per po-ter predisporre questa esperienza a coloro che fossero interessati chie-diamo di fare una preiscrizione entro il 30 aprile 2012 presso la segreteria a Palazzo San Paolo (03040102- [email protected]). Prevediamo che la giornata sarà divisa in due momenti. Al mattino il momento di impegno, al pomeriggio la possibilità di fare un po' di vacanza al mare o in giro per la regione. Per le famigli con figli preve-diamo la presenza di babysitter per la custodia di ragazzi e bambini.
spazio ac | adulti
18
nuovo anno, nuovi propositi, nuove sfide! Ecco come il Laboratorio della Formazione
(LdF) si è preparato al 2012. Nei primi giorni dell’anno ci siamo trovati con Andrea Re, presidente diocesano, e don Massimo, assisten-te generale, per dar il via ad un im-pegno rinnovato del LdF. Il consiglio diocesano ha dedicato un momento di riflessione per identificare le linee guida per l’azione: unitarietà, che si traduce in collaborazione con i set-tori e l’articolazione dell’ACR; in-novazione, nuovi schemi da osare; responsabilità, progettare la forma-zione dei formatori, di educatori, animatori e vari responsabili, par-tendo dal consiglio diocesano in poi.“Ci vuole un’iniezione di coraggio” ci ha ricordato Andrea, il LdF deve es-sere luogo di ricerca teorico/pratica
degli itinerari formativi, luogo dedi-cato a progettare e sostenere figure educative nuove, atte a interpreta-re le esigenze e le caratteristiche del territorio e della diocesi.Abbiamo già individuato alcuni possibili ambiti su cui lavorare, se-guendo le indicazioni per il trien-nio: primo annuncio, giovani, uni-tarietà e progettazione integra-ta tra i settori. Idee, progetti, dif-ficoltà, bisogni e desideri… un mix di idee su cui confrontarci. La cassetta degli attrezzi base: il Pro-getto Formativo, Sentieri di Speran-za, i sussidi, il magistero. La meto-dologia: il “laboratorio” prevede un fare, un percorso da costruire, ide-are insieme.Una parola d’ordine: pro-gettare, un ponte da gettare avanti verso il fu-turo! Insomma “la messe è abbon-
Come tenersiin formaProblemi con il 2012? Il Laboratorio della Formazionepropone un incontro mensile per recuperareil tempo perduto e per mettere al servizio degli altrile proprie competenze. Accetta la sfida
dante, ma sono pochi gli operai!” (Lc 10, 2).Per fare questo il laboratorio ne-cessita anche di forze nuove, ener-gie rinnovate e, al tempo stesso, di persone con esperienza associativa, magari educatori che per i più vari motivi sono “in stand-by” (eh no, la pensione non c’è neppure in AC). Sei forse un ex educatore che ha passato il testimone, per dar spazio ai giovani o perché la famiglia si è allargata e richiede tempo?!? Gio-vani, giovani/adulti, adulti o adul-tissimi col desiderio di dar il proprio contributo per l’AC, per le nostre realtà parrocchiali e per la nostra Chiesa?!?Bene, il LdF ha proprio bisogno di voi, con il vostro vissuto e con lo sguardo allenato sulle realtà delle nostre associazioni parrocchiali, po-treste aiutarci a individuare quali vie e quali sfide ci interpellano.Ci stai pensando, ma ti chiedi quan-to tempo mi prenderà?!? Don’t worry, il laboratorio si incon-tra una sera al mese, talvolta (spes-so) si lavora anche in differita (tra-mite mail).Vuoi saperne di più?!? Non esitare inviaci una e-mail ([email protected]) ti contatteremo il prima possibile.P.S. Cogliamo l’occasione per rin-graziare tutti quelli che hanno per-messo al LdF di giungere fino qui, grazie alla loro esperienza, alla loro lungimiranza, alla loro tenacia tan-te cose sono già state fatte e altre si potranno ancora concretizzare.
spazio ac giovani
19
cosa significa per te benessere? Siamo partiti da questa do-manda noi giovani del gruppo
Liberamente, affrontando insieme il tema della sostenibilità sociale. Per-ché, abbiamo ricordato dopo il nostro confronto, lo scopo “alto” dell’econo-mia è proprio il benessere della co-munità di riferimento. Ma che be-nessere? L’uomo è davvero al cen-tro, o il profitto ha preso il suo posto?Noi abbiamo in mente cosa sarebbe giusto, ideale, per la nostra vita e per un mondo più “sano”, ed è qualcosa che si discosta parecchio dall’impe-rativo consumista, ma d’altro canto ci rendiamo conto che non sempre fare delle scelte etiche, seguendo i propri princìpi, è una cosa accessi-bile a tutti, a causa di scarso tempo, scarsa informazione, scarsi mez-zi economici… La realtà sociale in cui viviamo, fortemente influenza-ta, soprattutto in periodo di crisi, dal sistema economico, ovviamente condiziona il nostro modo di vivere quotidianamente, i nostri ritmi, i no-stri consumi, i nostri rapporti con gli altri, la nostra immagine di uomo-
donna, e spesso ci ostacola nel per-seguire la nostra idea di uno stile di vita sostenibile. Vivere bene, e quindi “essere bene”, è per noi un insieme di condizioni, riconducibili al tema della vocazione, cioè condizioni che ci permettano di essere pienamen-te noi stessi.Queste le cose che di getto ci sono venute in mente da accostare alla parola benessere: venir riconosciuti professionalmente, avendo la possi-bilità di svolgere il lavoro per cui ci si sente portati e/o per cui si è scel-ta una certa formazione; un lavoro che garantisca una vita dignitosa; avere tempo per dedicarsi alle re-lazioni; avere tempo e possibilità di dedicarsi a se stessi, ai propri inte-ressi culturali, alle proprie passioni; investire energie in ciò in cui si cre-de, a favore degli altri (volontariato, educazione...); godere di occasioni di incontro con altre persone; una vi-ta sana, con la possibilità di passare del tempo all’aperto, nella natura e nella propria città che non dovrebbe essere iper-inquinata; una comunità solidale in cui tutti abbiano l’acces-
so alla soddisfazione dei propri biso-gni; un “sistema” giusto. Ci aiutano a ben-essere, ad andare avanti con fiducia, la nostra rete sociale, la con-divisione con gli amici e la famiglia, l’energia che spendiamo a favore di ciò che per noi è giusto, il confronto con le persone che incontriamo, il fabbricarci da noi qualcosa invece di comprare tutto, la fede. Ciò che sem-bra invece remarci contro è il clima di incertezza che oggi percepiamo nel nostro “contesto ampio” di vita, in cui osserviamo che il sistema non è giusto, che ci sono delle ingiustizie sociali, che chi governa le nostre cit-tà fa a volte scelte discriminatorie, e in cui pensare al bene comune sem-bra fuori luogo quando la precarietà è condizione diffusa ma ciascuno la vive come un problema personale… Impegnarsi ad essere incisivi nella nostra società, testimoniando e dif-fondendo un modo sostenibile di vi-vere la vita quotidiana, in cui sia co-stante l’attenzione e il rispetto per il benessere di tutti, è l’impegno che vogliamo prenderci, consapevoli che “un altro mondo è possibile”.
di Francesca scaroni
Sostenibilitàè ben-essereNella società attuale l’uomo è al centro o il profitto ha preso il suo posto? In questo articolo raccontiamo un incontro del gruppo “Liberamente” che vede impegnati diversi giovani provenienti da vari ambiti
spazio ac giovani
nella GF Marì divenne prima attiva propagandista e poi dirigen-te; fu l’esperienza che gli permise di percorrere la diocesi per incon-trare le diverse associazioni parroc-chiali. Terminata l’esperienza nella Gioventù Femminile, grazie alle sue riconosciute capacità divenne diri-gente dell’UDACI, l’Unione Donne di Azione Cattolica.Venuti gli anni bui della guerra, par-tecipò attivamente alla Resistenza, correndo più volte gravi pericoli. In quel tempo, in alcune fabbriche della città, avevano preso vita i ‘raggi’, os-sia una sorta di cellule di apostolato cristiano tra gli operai. Lei stessa te-stimoniò: “I raggi avevano una pre-
Marì Bosettispese le sue energie nell’attività religiosae sociale
di michele busi
20
marì bosetti, una vita per le donne
nata a brescianell’agosto 1914, marì bosetti iniziò fin da piccola il suo impegno in ac come socia della gioventù Femminile, fondata pochi anni prima da armida barelli, e guidata a brescia da maria freschi
valente finalità di carattere religioso, essi però venivano a costituire una prima trama organizzativa, un’occa-sione di contatto coi nostri lavoratori e le nostre lavoratrici, suscettibile di preziosi sviluppi”.
Nell’impegno socialeMarì Bosetti spese le sue energie nell’attività religiosa e sociale.Quando nell’immediato dopoguerra nacquero le Acli, a Brescia Marì fu chiamata da Dino Filtri, presiden-te AC divenuto primo presidente delle Acli Bresciane, ad affiancarlo nell’impresa di questa nuova associa-zione. Così Marì si lanciò con com-petenza ed entusiasmo, divenendo la prima delegata femminile provinciale delle ACLI e membro della presiden-za provinciale dal 1945 al 1949 ed in seguito per anni consigliere provin-ciale In questa veste partecipò nel novembre 1961 all’ottavo congresso provinciale, che si tenne a Palazzo san Paolo, sede che l’aveva vista per anni impegnata con le donne dell’A-zione Cattolica. È stato sottolineato
come la Bosetti si caratterizzava co-me sostenitrice di ogni iniziativa in-tesa alla promozione umana e sociale della donna nei più svariati campi di attività. Per quasi vent’anni diresse con Maria Capoduro la Scuola di ar-tigianato femminile: in essa le giovani apprendevano un’arte e insieme rice-vevano un insegnamento e un esem-pio positivo di vita cristiana. Marì ricoprì anche importanti incari-chi nell’ambito civile: fu infatti con-sigliere comunale e commissaria ai Luoghi Pii, imprimendo assieme al presidente ing. Zanelli nuova vitalità alle istituzioni assistenziali nella co-stante ricerca di soluzioni per veni-re incontro soprattutto ai più poveri. Con intuizione profetica lavorò per la costituzione di una sorta di Con-sulta femminile in cui convergeva-no rappresentanti dei vari organismi femminili di ispirazione cristiana per affrontare a livello di studio il tema della promozione della donna.
Nella provaGli ultimi anni, vissuti nella sofferen-
testimoni
21
marì bosetti, una vita per le donneza, fecero emergere ancora di più la profondità e la maturità della sua scelta di fede. Ha sottolineato Tere-sa Venturoli in un suo ricordo: “La malattia, inesorabile e dolorosissima, rivelò a quali profonde radici di fe-de e di amore attingessero l’instan-cabile slancio, la prodigiosa sempre nuova attività di questa donna. Poi-ché sentiva che il tempo si faceva breve per lei, si tenne a portata di mano un foglietto che, a fianco di una riproduzione di un orologio da polso, portava scritte queste parole: ‘è necessario che nelle ore di Dio vi sia sempre qualche cosa che noi non comprendiamo e che non vorremmo, perché occorre che vi sia posto per la fede e per la Croce. Ciò che non piace alla natura giova alla grazia’. Attraverso l’oscurità della fede e la prova crocifiggente, il cuore di Marì Bosetti si dilatava ormai oltre i con-fini del mondo e si apriva all’eterna beatificante luce”.La giornata terrena di Marì si chiu-deva a Brescia il 30 giugno 1969, a soli 55 anni.
non c’è scommessa più persa di quella che non giocherò”. L’Azione
Cattolica di Brescia si è presa del tempo per riflettere e accogliere la scommessa dei nostri Vescovi: “Educare alla Vita Buona del Vangelo”. Questo è il documento che raccoglie le linee guida che i nostri pastori hanno indicato per il decennio che stiamo vivendo. Accogliere la sfida dell’impegno educativo è, per l’AC, una conferma, in quanto l’attenzione alla formazione della persona nell’arco dell’intera vita, con particolare cura per il servizio educativo delle nuove generazioni, è tradizionalmente insita nel dna dell’associazione. L’essere in sintonia con gli orientamenti previsti per i prossimi dieci anni è segno che il servizio reso alla Chiesa risponde alle urgenze dei nostri tempi. “Chi ama educa e chi educa ama”. Dovere di ogni cristiano è l’impegno nell’educazione alla vita buona del Vangelo, qui e ora, nel nostro oggi, al passo con la vita vera che ogni bambino, ragazzo, giovane e adulto vive. Compito di ogni cristiano è coniugare le linee guida delineate nei documenti dell’episcopato italiano con la quotidianità della vita, senza limitarsi ai confini della Parrocchia, ma spingendosi anche al di fuori, con spirito missionario, nei luoghi in cui si lavora, si studia, ci si diverte, si vive. Come
fare? Partendo dalla cura delle relazioni, mettendo al centro la persona. Queste sono solo alcune delle riflessioni emerse nella mattinata di domenica 5 febbraio 2012, a Villa Pace di Gussago, casa di formazione e spiritualità dell’Azione Cattolica diocesana, dove si è tenuto l’annuale Convegno per gli educatori di AC, aperto a tutti coloro che hanno a cuore l’educazione delle giovani generazioni. Il tema affrontato è stato e continua ad essere impegnativo, come lo stesso relatore, Marco Sposito, vice-presidente nazionale del settore Giovani, ha sottolineato in apertura del proprio intervento. Gli impegni concreti che il rappresentante della presidenza nazionale ha prospettato, agli educatori di AC presenti nonostante la neve, chiamano in causa ognuno molto direttamente e toccano sul vivo: puntare sulla propria spiritualità, strutturarsi una Regola di vita che guidi nella quotidianità, pensata e condivisa con una guida spirituale.Vivere una vita pienamente cristiana è la condizione necessaria per poter testimoniare ed educare. “Educare alla vita buona del Vangelo” rappresenta un obiettivo alto, di fronte al quale non ci si può proprio tirare indietro: non rimane quindi che cogliere la sfida e cercare di arrivare fino alla vetta.
formazione
Dalla parolaalla vitaIl Convegno diocesano degli educatori si è confrontato a Villa Pace di Gussago sugli orientamenti pastorali della Ceiper il decennio 2010-2020
di stefano cittadini
testimoni di oggi
2222
villa pace.Al servizio
di massimo e lidia
in un caldo giorno d’estate del 2007 ricevemmo una chiamata dalle più alte sfere dell’associazione per fis-
sare un incontro, “Cosa vorranno da noi?”. Chi poteva immaginare dopo quasi quattro anni di ritrovarci qui a scrivere questo articolo. Il tutto è nato da una frase sconvolgente: “Abbiamo pensato a voi per un servizio a Villa Pace”. Subito io e mio marito ci sia-mo guardati e, senza parlare, abbiamo entrambi pensato a cosa questa propo-
sta poteva riferirsi, dal momento che un servizio a Villa Pace lo stavamo già facendo. Man mano che l’incontro si svolgeva emergevano tanti piccoli par-ticolari e tante domande da entrambe le parti. “Stiamo cercando una cop-pia che possa garantire una presenza stabile in Villa e che sia di supporto al direttore per un periodo di due o tre anni al massimo. Non sappiamo in che forma e in che termini, è tutto da co-struire insieme”. Non ci saremmo mai
ve lo racconto io...
Otto personaggi del Vangelo parlano di GesùDI ALBERTO CAMpOLEONI
Maria di Nazaret, Maria Maddalena, pietro, Guida, pilato... Quanti uomini e donne hanno incontrato Gesù di Nazaret, hanno avuto una parte nella vicenda della sua esistenza. Il libro raccoglie otto “interviste” con altrettanti personaggi del Vangelo che raccontano, dialogando con l’autore, qualcosa di Gesù, quello che hanno capito di quell’uomo conosciuto in palestina e che, per ciascuno di loro, ha significato una svolta decisiva nella vita.
in libreria
“Storie di uomini, storia di Dio” è una nuova collana per ragazzi, che nasce con l’intento di educare alla fede attraverso la bellezza, e che si sviluppa lungo tre filoni: figure dell’Antico Testamento, figure del Nuovo e di Santi, aggregate secondo un tema unificante, che per i primi titoli è “l’inizio”: Abramo, Giuseppe e Maria e S. Francesco. Ricche e raffinate le illustrazioni di Anna Casaburi e Arcadio Lobato, pensate in sintonia con la narrazione poeticamente intensa di don Andrea Marinzi.
la storia di abramoANDREA MARRINZIANNA CASABuRIARCADIO LOBATO
I due “custodi” della Casa di spiritualità,che dall’agosto del 2008 accolgono gli ospiti,si raccontano agli associati. Dopo quasi quattro anni, hanno deciso di ritornare in parrocchia
aspettati una proposta del genere, ci siamo trovati completamente spiazzati e senza parole. Al contrario di quanto ci potessimo immaginare la nostra ri-sposta non è stata un “no” immedia-to, ma con molte perplessità abbiamo terminato con un “ci pensiamo”. Le settimane che seguirono l’incontro non furono per niente tranquille, tan-te domande, dubbi e paure nascevano giorno dopo giorno. Continui confronti tra noi, con le no-stre famiglie e con l’associazione e, fidandoci nuovamente di Lui, siamo arrivati alla fine ad affidare alla Prov-
23
Via Crucis... già solo il nome mette soggezione ed un bambino se ne domanda il significato. Ecco allora che un piccolo libro di sole 40 pagine, tutto illustrato con vivacità, arriva in soccorso ad ogni educatore, ogni sacerdote o suora che vogliano far scoprire ai più piccoli il senso profondo di queste quindici “stazioni”. un brevissimo passo del Vangelo è commentato da una preghiera tratta dagli scritti della piccola Nennolina.
“E sorridi quando mi guardi, perché non vedrai altro che la felicità di vivere. La vita è bella!”. Alessia, fermata da una malattia devastante, impara a non lasciarsi sopraffare dall’angoscia, trasformando in energia nuova e positiva la paura e la rassegnazione, e facendo di questo passaggio doloroso della sua breve esistenza terrena un palcoscenico della fede e della speranza: arriva così a comprendere sotto una luce nuova il significato della vita.
la vita è bella!
Storia di AlessiaUn’adolescente di frontealla morteDI pAOLA BIGNARDI
caro gesù (via crucis)
Io voglio stare sotto la croce con teAZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI
voglia e bisogno di incontro e di rela-zioni. La dimensione diocesana: dove il vivere nella Casa ci ha permesso di respirare quell’aria associativa fatta di studio, programmazioni, preoccupa-zioni, incontri formativi e non, dove l’incontro con le persone impegnate nei vari ambiti e settori ci ha fatto capi-re una volta di più quanto impegno ri-chieda amare l’associazione. Una sot-tolineatura particolare merita il nostro rapporto con Paolo (il mega direttore galattico). Insieme abbiamo maturato questo percorso giorno dopo giorno e condividiamo questa bellissima espe-rienza in un confronto continuo. Nel nostro piccolo abbiamo cercato e cerchiamo di aiutarlo nella gestione pratica della Casa consapevoli che il nostro è solo un piccolo aiuto rispetto alle tante esigenze che lui deve affron-tare ogni giorno. Approfittiamo di que-sta occasione anche per ringraziarlo della sua pazienza e disponibilità nei nostri confronti e gli ribadiamo ancora una volta il nostro appoggio e sostegno. L’esperienza è stata positiva, come lo è sempre l’incontro con l’altro, augu-riamo a tutti la possibilità di regalare un po’ di tempo agli altri e perché no anche all’associazione. Siamo ora al termine del nostro servizio, ci sembra
giusto fare un passo indietro per dare la possibilità a qualcun altro di vivere questa esperienza. È arrivato il mo-mento di ritornare a casa nostra, nel nostro paese, nella nostra parrocchia e continuare l’esperienza associativa in altre forme. Un pensiero particola-re lo vorremmo spendere nel ricorda-re quelle persone che ci hanno fatto questa proposta e non ci hanno mai fatto mancare il loro apporto, la loro vicinanza e la loro preghiera con mo-di diversi e discreti: stiamo parlando di Mariangela, Marina e don Angelo, a loro va il nostro grazie sincero e sentito per averci dato la possibilità di vivere questo cammino. Un ricordo partico-lare anche per Lina, è grazie a lei se abbiamo iniziato ad amare Villa Pace, lei con i suoi modi e la sua attenzione alle persone ci ha fatto capire l’impor-tanza del servizio. Ringraziamo inoltre tutte le persone che abbiamo avuto modo di conoscere e con cui abbiamo avuto la gioia di lavorare, ricordiamo l’instancabile e disponibile Marì e tut-ti i volontari che in questi anni hanno prestato il loro servizio e continueran-no a farlo. Auguriamo all’AC di avere sempre a cuore il bene di Villa Pace sentendola come Casa propria, come è successo a noi. Grazie a tutti.
videnza il nostro sì. Così nell’agosto 2008 è iniziata la nostra avventura a Villa Pace. Qualcuno ci ha chiamato angeli custodi, altri semplicemente cu-stodi, fortunatamente la maggior parte ci chiama per nome: Lidia e Massimo. Cosa significa fare un servizio come il nostro a Villa Pace? Concretamente è prendersi a cuore le esigenze della Casa nelle piccole cose della vita quo-tidiana. L’accoglienza degli ospiti, sia quelli di passaggio che quelli a lunga permanenza, venendo a conoscenza di realtà ed esperienze di vita, legate alla sofferenza e alla malattia, alla fede, alla
marzo 2012
DO
M 04 ore 8.00Consiglio diocesano a Villa pace
VEN 09 ore 20.30
pregare con i salmi a Villa paceSA
B 10 Training Giovanissimi a Villa pace
DO
M 11 Training Giovanissimi a Villa pace
SAB 17 Interassociativo
DO
M 18 Giornata presidenti e responsabili a Villa pace
SAB 24 Ritiro quaresima Acr a Villa pace
DO
M 25 Ritiro quaresima Acr a Villa pace
aPRile 2012
DO
M 08 Pasqua
VEN 13 ore 20.30
pregare con i salmi a Villa pace
SAB 14 ore 15
Consiglio diocesano a Villa pace
DO
M 15 Consiglio regionale
VEN 20 Campo giovani e adulti a Villa pace
SAB 21 Campo giovani e adulti a Villa pace
DO
M 22 Campo giovani e adulti a Villa pace
SAB 28 Esercizi ecumenici a Villa pace
DO
M 29 Esercizi ecumenici a Villa pace
maggio 2012
DO
M 15 Meeting a Concesio
VEN 25 ore 20.30
Consiglio diocesano a Villa pace
proposteestive 2012Campo acr 6-8 venite e vedrete a Villa pace, dal mattino del 31 agosto al pomeriggio del 2 settembre, quota per associati 60 euro, all’iscrizione 30 euro; non associati 70 euro, all’iscrizione 40 euro, il saldo per tutti entro la settimana prima dell’inizio, sconto del 20% per i fratelli. È necessario portarsi lenzuola e asciugamani da casa.
Campo acr 9-11 venite e vedrete ad Astrio, dal 25 agosto al 1 settembre, quota per associati€ 160,00 all’iscrizione € 60,00;non associati € 180,00 all’iscrizione € 80,00il saldo per tutti entro la settimana prima di partire sconto del 20% per i fratelli.
Campo terza media e giovanissimi miSSion (im)poSSible a Borno, dal 29 luglio al 4 agosto, quota per associati 175 euro, all’iscrizione 75 euro;non associati 195 euro, all’iscrizione 95 euro: il saldo per tutti entro la settimana prima di partire, sconto del 20% per i fratelli.
proposta per giovani in polonia7-10 agosto. Quota indicativa 250 euro variabilein base alle iscrizioni.
Campo adulti legami aperti on tHe road6-12 agosto puglia. preiscrizioni entro il 30 aprile.
Campo educatori a Villa pace dal 7 settembre (sera cin cena) al 9 settembre (pomeriggio),quota 50 euro. È consigliato portarsi lenzuola e asciugamani da casa.
Esercizi spirituali a Villa pace, dal pomeriggio del 3 agosto al 5 agosto con cena, quota 110 euro.Guida il dott. Carmelo Dotolo. Chi desidera una camera singola, deve segnalare tale richiesta all’atto dell’iscrizione.
AZIONE CATTOLICA - BRESCIA
calendario degli incontri