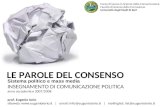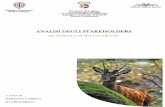4 Mass Media e Partiti
-
Upload
sbalassone -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of 4 Mass Media e Partiti
-
8/9/2019 4 Mass Media e Partiti
1/7
Stefano Balassone I Mass Media fra societ, potere e mercato 15/07/2010book in progress - sezione I Mass Media e Societ
capitolo 4: Mass Media e Partiti
1
Abst rac t Entrambi prodotti dalla societ di massa, Mass Media e Partiti vivono oggidestini diversi: i Mass Media navigano nella societ consumista, i Partiti viaffondano.
Mass media e Partiti .......................................................................................................................... 1Democrazia di massa ............................................................................................................... 1La crisi del Cittadino Produttore .............................................................................................. 1Laffermazione del Cittadino Consumatore ............................................................................. 2Il Bengodi dei Mass Media. ..................................................................................................... 3Partiti a venire .......................................................................................................................... 6
Mass media e Partiti
Democrazia di massa
Mass media e Partiti nascono ambedue con la societ di massa. I Partiti assumono fisionomiediverse a seconda del carattere politico del Paese in cui sorgono. Fondamentalmente:
- in un quadro democratico1- in un quadro autoritario, i partiti sono uno strumento di organizzazione per le masse, come
accaduto per alcuni decenni nellEuropa Continentale (Russia sovietica, Italia fascista eGermania nazista).
i partiti sono espressione delle masse, come accaduto nei paesianglosassoni e, con alcune contraddizioni, in Francia;
Dopo la guerra la democrazia di massa ha prevalso, in forme diverse, presso tutti i popoli europei ein Giappone, sembra che stia prevalendo in India, in Sud Africa, ancora lontana dallessereproclamata, ancor prima che messa in atto, in Cina, fortemente contestata nei paesi di culturaislamica.
Il modello USA rappresenta tuttora la versione di democrazia pi liberale grazie ai seguenti fattori:
o la divisione tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario (in Europa prevalgonoinvece varie forme di commistione fra legislativo ed esecutivo;
o la esistenza di una piena libert di comunicazione (che in Europa continentale, puressendo proclamata, subisce contenimenti di diritto e/o di fatto);
o
la dominanza di partiti aperti alla influenza degli elettori2
o la vivacit della societ civile, largamente autonoma dai poteri istituzionaliSulla base della esperienza fin qui maturata, indubbio che senza i mass media (pi o meno liberi)e i partiti (pi o meno aperti) una democrazia di massa (pi o meno democratica) non esisterebbe.Nella retorica che accompagna la crescita della stampa e del cosiddetto Quarto Potere, watchdognei confronti dei poteri statuali e dei Partiti che li esercitano, i ruoli dei Mass Media e dei Partitinon dovrebbero mai sovrapporsi, ma nella realt essi sono divenuti concorrenziali, tanto che labilancia del potere reale pu pendere verso gli uni o verso gli altri in modo diverso da paese a paesee da epoca ad epoca.
La crisi del Cittadino Produttore
1 nei paesi anglosassoni, a partire dagli USA descritti attorno al 1830 in La democrazia in America di Tocqueville2 si pensi al funzionamento, sostanzialmente autoritario, della attuale legge elettorale italiana.
-
8/9/2019 4 Mass Media e Partiti
2/7
Stefano Balassone I Mass Media fra societ, potere e mercato 15/07/2010book in progress - sezione I Mass Media e Societ
capitolo 4: Mass Media e Partiti
2
I Partiti intermediano le procedure elettorali di accesso ai poteri pubblici e accumulano voti in nomedi idee di societ (a parte le pure clientele, che utilizzano il voto per acquistare favori personali). Inaltri termini, i partiti moderni sono sempre ideologici, si identificano con un racconto delmondo, nel quale gli elettori possano trovare conveniente inserire le proprie personali aspirazioni.Cos stato da quando esistono i Partiti, e cio dopo la rivoluzione industriale (meta 700) e larelativa ristrutturazione della figure sociali. In particolare, da allora, e per circa due secoli, i progettidei Partiti sono stati pensati per un mondo di Produttori e Cittadini3
- Il Progresso corrisponde allidea che la realt abbia un senso e che sia perfettibile., e sono stati qualificati da
due idee forti: Progresso e Emancipazione.
- LEmancipazione, sia per chi la desidera sia per chi vi si oppone, consiste nel superamentodei vincoli che in vario modo fissano la subalternit di intere fasce di popolazione rispettoad altre. Nella fase della Emancipazione la dialettica politica e sociale verte in misuradominante sulla affermazione di diritti (ad esempio a non essere legati alla terra, a un orariolavorativo limitato, alla pensione, alla istruzione, alla sanit, etc) attraverso azioni di forza
nella societ (sindacati, vertenze etc) e la elezione di rappresentanti nel potere legislativo edesecutivo.
Nella fase del Progresso e della Emancipazione la politica si autorappresenta come un fare permigliorare, perch il senso comune ritiene che la realt sociale sia trasformabile in nome diGiustizia, Sviluppo, Civilt etc., pur essendo aperto lo scontro sulla organizzazione (liberalismo,socialismo, totalitarismo) volta a calare quei principi nella realt. Si avuto allora lo scontro fraidee generali quali comunismo, solidarismo, fascismo, liberalismo etc.; uno scontro di veritconcorrenti che trasforma il confronto di idee in guerra civile fredda.
Lesperienza delle ultime decine di anni ha tuttavia dimostrato che qualsiasi astrazioni concettuale,specie in politica, figlia del suo tempo e con esso muore, anzi, lo stesso concetto che afferrava il
bandolo della realt se questa cambia diviene un intralcio. Ad esempio, il Produttore e il Cittadinoerano definiti rispetto alle loro controparti, rispettivamente la Fabbrica e lo Stato, controparti chetendono a svanire a causa:
- del mutamento delle tecnologie produttive, che incorporano nei software quote crescenti delsapere delle maestranze di un tempo;
- per lavanzare della globalizzazione4Da qui la crisi dei partiti-progetto, che negoziavano e sancivano con leggi le conquiste di reddito estatus che maturavano nello scontro, anche furibondo, fra gli interessi sociali. La logica e lecondizioni di quelle conquiste sono cambiate e per questo si determina oggi il loro contrario, come
la generalizzazione del precariato, il ridimensionamento delle prestazioni pensionistiche, etc.
che delocalizza e sparpaglia nel mondo le imprese checos si sottraggono contemporaneamente ai sindacati e allo Stato.
Laffermazione del Cittadino Consumatore
3Produttore e Cittadino sono le figure emerse dalle rivoluzioni del XVII e XVIII secolo, dalla Glorious Revolutioniniziata con Cromwell e approdata alla monarchia contrattuale di William e Mary, alla Rivoluzione Francese, allaDichiarazione di Indipendenza degli USA e alla loro Costituzione qualificata dal Primo Emendamento di fine 700.Altri paesi hanno poi seguito, ivi compresa lItalia con la Costituzione del 1948 che esordisce dichiarando che: LItalia una repubblica fondata sul lavoro (quindi sui Produttori).La sovranit appartiene al popolo (che quindi compostodi Cittadini e non di sudditi) che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione..
4 Il tutto pu essere sintetizzato nel tramonto del socialismo, quello de il secolo breve, secondo lomonimo titolo dellibro di Erik Hobsbawn. Secolo breve (il 900) perch in 80 anni ha visto sorgere, giganteggiare e scomparirelidea della classe operaia come motore della Storia.
-
8/9/2019 4 Mass Media e Partiti
3/7
Stefano Balassone I Mass Media fra societ, potere e mercato 15/07/2010book in progress - sezione I Mass Media e Societ
capitolo 4: Mass Media e Partiti
3
Mentre lorizzonte delle narrazioni collettive del mondo dei Produttori scompariva alla vista, si venuto affermando una societa senza orizzonti narrativi: la societ dei Consumatori. Dopo duesecoli di industrialismo i pi sono infatti liberi dai bisogni immediati (cibo, tetto, sanit) eindossano pressoch in permanenza non labito psicologico del Produttore, che esiste per le merciche sa fare, ma quello del Consumatore che si identifica nelle merci di cui pu disporre5
Il consumo di massa non infatti riducibile al semplice accesso delle moltitudini alla cura dellapersona, allistruzione, alla moda, alla mobilit, alla casa etc. Il punto che non solo questi bisognivengono soddisfatti, ma che la gamma delle merci amplissima: cosicch sono possibili espressionidi vit diversissime e c chi si veste tuffandosi nella iconografia delle firme, chi le sprezza per ilpiacere dessere sobrio, etc etc. Sia il tipo trendy sia quello sobrio, sia lecologico sia linvasivosono chiamati costantemente a scegliere per manifestare la loro personalit. E quindi, come
lucidamente spiega questa scritta colta su una vetrina a Viareggio,
sia per illoro valore duso che per il loro significato simbolico/linguistico.
consumando comunicano, perch ogni decisione di consumo, in quanto scelta tra opportunitdiverse, un segno di comunicazione su se stessi, sul rapporto con gli altri, sulle proprie speranze epaure.
Il Bengodi dei Mass Media.
Il linguaggio del consumo , ovviamente, della stessa qualit delle emozioni. Non si avvale diconcetti, ma di sensazioni o, meglio, di sentimenti. E mentre il Produttore e il Cittadino, impegnatisul piano del know how e delle idee pensavano di essere guidati dal vero, il Consumatore cercapi immediatamente di essere figo. La comunicazione prevalentemente iconica e il controllodel linguaggio sfugge ai grammatici e ai colti per andare direttamente, in mano alle masse. Chi sichina su questo brulicare di emozioni non sono i Politici e gli Intellettuali, ma chi vuole immergervile proprie merci: in pratica, chi ha qualcosa da vendere. Ovvero le imprese e fra esse in particolare imass media che, fra tutte le imprese, sono le sole che ascoltino il pubblico giornalmente, attraversole vendite alle edicole, i biglietti del cinema e i sondaggi dascolto.
La societ del consumo aperta, ben diversa da quella in ordine chiuso dei ceti e delle classi;
sballotta i singoli nel caos delle emozioni, ognuno molecola vagante tra altre molecole prive disolidi legami. , pertanto una societ gassosa6. Bauman7
5 Solo in situazioni estreme, quando c crisi, riemerge, annaspando, il Produttore: per rinnovare un contratto, per
sventare una delocalizzazione, per affrontare la crisi di una azienda. Ma sono eventi eccezionali, legati, perlappunto, alle crisi e non alla normalit delle cose. Almeno nelle economie cosidette avanzate.
parla di societ liquida, espressione
6 Lespressione societ gassosa risale a un nostro intervento, accolto nelle conclusioni, di un convegno del 2001 aBarcellona fra sociologi, studiosi delle comunicazioni e uomini dei media
7Zygmunt Bauman(Poznan,19 novembre1925) unsociologoefilosofobritannico. Nei suoi libri sostiene chel'incertezza che attanaglia la societ moderna deriva dalla trasformazione dei suoi protagonisti da produttori aconsumatori. In particolare, lega tra di loro concetti quali ilconsumismoalla creazione di rifiuti "umani", laglobalizzazioneall'industria della "paura", lo smantellamento delle sicurezze ad una vita 'liquida' sempre pi
frenetica e costretta ad adeguarsi alle attitudini del 'gruppo' per non sentirsi esclusa, e cos via. L'esclusione socialeelaborata da Bauman non si basa pi sull'estraneit al sistema produttivo o sul "non poter comprare l'essenziale", madel "non poter comprare per sentirsi parte della modernit". Secondo Bauman il "povero", nella vita liquida, cerca distandardizzarsi agli schemi comuni, ma si sente frustrato se non riesce a sentirsi "come gli altri", cio non sentirsi
http://it.wikipedia.org/wiki/Poznanhttp://it.wikipedia.org/wiki/Poznanhttp://it.wikipedia.org/wiki/Poznanhttp://it.wikipedia.org/wiki/19_novembrehttp://it.wikipedia.org/wiki/19_novembrehttp://it.wikipedia.org/wiki/1925http://it.wikipedia.org/wiki/1925http://it.wikipedia.org/wiki/1925http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologohttp://it.wikipedia.org/wiki/Sociologohttp://it.wikipedia.org/wiki/Sociologohttp://it.wikipedia.org/wiki/Filosofohttp://it.wikipedia.org/wiki/Filosofohttp://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unitohttp://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unitohttp://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unitohttp://it.wikipedia.org/wiki/Consumismohttp://it.wikipedia.org/wiki/Consumismohttp://it.wikipedia.org/wiki/Consumismohttp://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazionehttp://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazionehttp://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazionehttp://it.wikipedia.org/wiki/Consumismohttp://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unitohttp://it.wikipedia.org/wiki/Filosofohttp://it.wikipedia.org/wiki/Sociologohttp://it.wikipedia.org/wiki/1925http://it.wikipedia.org/wiki/19_novembrehttp://it.wikipedia.org/wiki/Poznan -
8/9/2019 4 Mass Media e Partiti
4/7
Stefano Balassone I Mass Media fra societ, potere e mercato 15/07/2010book in progress - sezione I Mass Media e Societ
capitolo 4: Mass Media e Partiti
4
simile che ci pare tuttavia perfino sottovalutare la disintegrazione dei solidi rapporti di produzione,e sovente anche daffetto. Una tale societ, che risponde alle leggi della dinamica dei fluidi,risponde, va da s, a modalit di governo del tutto diverse da quelle meccanicistiche che hannocaratterizzato il secolo breve ed fatta su misura per i Mass Media.
Per loro natura i mass media attivano chiavi empatiche (esemplare il successo dei reality) emeccanismi di racconto funzionali pi che a costruire una persuasione a catturare e mantenerelattenzione dello spettatore (sensazionalismo e luoghi comuni costituiscono i lemmi essenziali delloro linguaggio).
Mentre la politica, privata delle sue radici sociali e dei suoi orizzonti narrativi, sopravvive in quantomestiere e sbanda nella societ gassosa come ognuno che vi abita, i mass media non hannodifficolt a mettersi al servizio della personalizzazione di massa, che consiste nel servire unmercato vastissimo offrendo nel contempo a ciascun individuo (si pensi a cosa diventato ilmercato della musica in rete) quanto pi simile alle sue preferenze/idiosincrasie personali, senzalaggancio a progetti di significato collettivo. imparano a sfruttare la spinta, ovvero incassare
denaro, dalle vaganti molecole della attuale societ gassosa, pi dicendo dei NO! che affermandodei SI!.
La situazione di una societ gassosa somiglia a quella, vorticosa e caotica, del moto di particellebrowniane, che si agitano a livello subatomico. Gli scienziati si sono misurati col problema di comedare un senso a questi movimenti, realizzando motori (nanomotori, ovviamente) capaci diprocedere sfruttando la spinta di particelli provenienti da ogni direzione e non da una sola, come se iventi in mare spingessero da ogni parte anzich da una sola. La superficie esposta allurto delleparticelle collegata a un asse che termina con una ruota dentata che pu procedere in senso orarioo antiorario, ma un fermo a scatto consente solo il movimento in uno dei due sensi, come avviene inmolti attrezzi di uso comune, usati dai meccanici per avvitare bulloni etc. Uscendo dallesperimentofisico e passando al controllo sociale, si pu dire che lequivalente del fermo che blocca un senso dimovimento costituito, ad opera della comunicazione, dalla delegittimazione di ci che preme inquella direzione, cos da ottenere per default la spinta verso le direzioni opposte.
ovvio del resto che le pro-poste richiedano adesioni specifiche mentre le chiamate contro (ilcomunismo, il berlusconismo, etc.) mettono insieme anche gente che insieme si rifiuterebbe direalizzare alcunch.
Ad esempio e al di l di ogni consapevolezza dei media stessi- il sensazionalismo intrinseco allaloro natura enfatizza i problemi che scaturiscono dalle novit positive, come limmigrazione,esercitando la funzione di blocco nella direzione delle politiche umanitarie e precorrendo leuniche scelte politiche che a quel punto possibile ai politici proclamare, ovvero quelle di tipoproibizionista (non importa quanto velleitarie).
Servirsi dei media senza servirli, non dunque affatto facile. Chi volesse tentare limpresa,
dovrebbe cercare innanzitutto di non dipendere solo dai media nel rapporto con la societ, il ch
accettato nel ruolo di consumatore. La critica alla mercificazione delle esistenze e all'omologazione planetaria si faspietata soprattutto in Vite di scarto,Dentro la globalizzazione eHomo consumens.
-
8/9/2019 4 Mass Media e Partiti
5/7
Stefano Balassone I Mass Media fra societ, potere e mercato 15/07/2010book in progress - sezione I Mass Media e Societ
capitolo 4: Mass Media e Partiti
5
significa che nella societ stessa dovrebbe essere tanto abile da trovare riferimenti per interessi epensieri condivisi (la Lega, ad esempio, risolve il problema ancorandosi al territorialismo). Risoltocos il problema strategico, che consiste nel dare un senso alla propria narrazione, il nostro Eroedovrebbe, su un piano pi tattico:
- inserire i media nel cursus honorum delle figure potenzialmente carismatiche, ledizionepost-ideologica dei funzionari di partito di met Novecento, per produrle in proprio,muovendo dalla politica verso i Mass Media, anche per contrastare la corrente in sensoinverso, rigonfia di giornalisti e conduttori tv in vena di riciclaggio professionale. (ilpericolo di questa invasione era lucidamente valutato nel 1949 da uno dei capi della BBCche invitava lEnte inglese a non fare affermare personaggi-star che possono attrarre unaaudience da se stessi su qualsiasi soggetto8
- Sequestrare tirannicamente la visibilit sui media dei propri alleati e collaboratori e favorireinvece , sul fronte opposto, la perenne presenza di avversari tanto accesi da illuminarlo diluce continua;
).
- rileggersi larticolo che nel 1963 Umberto Eco, nel pieno dei trionfi di Lascia o Raddoppia edi Rischiatutto, dedic a Mike Bongiorno.Fenomenologia di Mike Buongiorno
Luomo circuto dai mass media in fondo, fra tutti i suoi simili, il pi rispettato: non gli si chiedemai di diventare che ci che egli gi. In altre parole gli vengono provocati desideri studiati sulla
falsariga delle sue tendenze.... La situazione in cui si pone LA TV9 questa: la TV non offre comeideale in cui immedesimarsi il superman ma leveryman. La TV presenta 10 come ideale luomoassolutamente medio11
8 F. Williams, in BBC Yearbook 1949
. Il caso pi vistoso di riduzione del superman alleveryman lo abbiamo inItalia nella figura di Mike Bongiorno e nella storia della sua fortuna....questuomo deve il suosuccesso al fatto che in ogni atto e in ogni parola del personaggio cui d vita davanti alle
telecamere traspare una mediocrit assoluta unita (questa lunica virt che egli possiede in gradoeccedente) ad un fascino immediato e spontaneo spiegabile col fatto che in lui non si avvertenessuna costruzione o finzione scenica: sembra quasi che egli si venda per quello che e che quelloche sia tale da non porre in stato di inferiorit nessuno spettatore, neppure il pi sprovveduto. Lospettatore vede glorificato e insignito ufficialmente di autorit nazionale il ritratto dei proprilimiti.....Mike Bongiorno non si vergogna di essere ignorante e non prova bisogno diistruirsi.....Pone gran cura nel non impressionare lo spettatore, non solo mostrandosi alloscuro dei
fatti, ma altres decisamente intenzionato a non apprendere nulla.....Mike Bongiorno apprezza tuttii miti della societ in cui vive: alla signora Balbiano dAramengo bacia la mano e dice che lo fa
perch si tratta di una contessa. Oltre ai miti accetta della societ le convenzioni. paterno econdiscendente con gli umili, deferente con le persone socialmente qualificate.... Mike Bongiorno
parla un basic italian. Il suo discorso realizza il massimo di semplicit. Abolisce i congiuntivi, leproposizioni subordinate, riesce quasi a rendere invisibile la dimensione sintasi. Evita i pronomi,ripetendo sempre per mesteso il soggetto, impiega un numero stragrande di punti fermi. Non siavventura mai in incisi o parentesi, non usa espressioni ellittiche, non allude, utilizza solo metaforeormai assorbite dal lessico comune. Il suo linguaggio e rigorosamente referenziale e farebbe lagioia di un neo-positivista. Non necessario fre alcuno sforzo per capirlo. Qualsiasi spettatoreavverte che alloccasione egli potrebbe essere pi facondo di lui..... Porta i clichs alle estremeconseguenze. Una ragazza educata dalle suore virtuosa, una ragazza con le calze colorate e lacoda di cavallo bruciata. Chiede alla prima se lei, che una ragazza cos per bene,
9 Rispetto al racconto epico-romantico che propone lideale di nobili, ancorch irraggiungibili eroi.10 N potrebbe fare altrimenti, per la sua stessa natura casalinga e di massa11 dotato cio di passioni e prudenza in grado spentamente medio.
-
8/9/2019 4 Mass Media e Partiti
6/7
Stefano Balassone I Mass Media fra societ, potere e mercato 15/07/2010book in progress - sezione I Mass Media e Societ
capitolo 4: Mass Media e Partiti
6
desidererebbe diventare come laltra; fattogli notare che la contrapposizione offensiva, consolala seconda ragazza mettendo in risalto la sua superiorit fisica e umiliando leducanda. ... Per luiogni cosa ha un nome e uno solo... In fondo la gaffe nasce sempre da un atto di sincerit nonmascherata; quando la sincerit voluta non si ha gaffe ma sfida e provocazione; la gaffe ... nasce
proprio quando si sinceri per sbaglio e per sconsideratezza. Quanto pi mediocre, luomomediocre maldestro. Mike Bongiorno lo conforta portando la gaffe a dignit di figura retorica....Egli rappresenta un ideale che nessuno deve sforzarsi di raggiungere perch chiunque si trova gial suo livello. Nessuna religione mai stata cos indulgente coi suoi fedeli. In lui si annulla latensione tra essere e dover essere.
Mike Bongiorno era gi celebre, nel 1963, quando larticolo di Eco lo fece divenire importantespiegando che Mike era lincarnazione della televisione, strumento anti epico come nessun altro,che dona il successo e laffetto del pubblico a chi ha lumilt e la lucidit di apparire, per cultura,virt morali, intelligenza ed ogni altro ornamento dellanima, pi piccolo di chi lo guarda. Eco attento a precisare che il minimalismo da lui osservato riguarda il personaggio e non la persona diBongiorno, ma questa scontata distinzione non venne colta dai notisti dellepoca, attardati a
fustigare il carattere basso della tv e dei suoi divi a fronte delle nozioni apprese sui banchi discuola.In Italia Mike sta alla tv come Alberto Sordi sta al cinema. Luno nel piccolo e laltro nel grandeschermo hanno incarnato lItalia reale a scorno dellItalia eccellente. Ambedue hanno avuto il lorocorrispondente nel mondo del potere.Per Sordi l Avatar fu Andreotti, che condivideva con Alberto, ma aggiungendovi odor di zolfo, lastessa retorica antiepica. I due formavano talmente una coppia agli occhi del Paese, che quandoBaudo nel 1989 fece un sondaggio a puntate per individuare i due personaggi eminenti deldopoguerra, gli spettatori li nominarono massicciamente fra le star dello spettacolo e i volti dellapolitica. LAndreotti di Bongiorno invece senza dubbio Berlusconi. Anzi, vien da pensare cheproprio Bongiorno sia il Geppetto che ha tirato fuori dal ciocco dellaffarista il Berlusconi politico,magari dandogli da leggere larticolo di Eco. Sta di fatto che Mike nei primi anni 80, trasferendosidalla RAI nel nascente Canale 5 gli ha recato unidea e una prassi di televisione americana,totalmente estranea a quella immaginabile dalle lites, operaie e borghesi, accademiche e religiose:una tv fatta sulla misura e in funzione del consumismo come da tempo si era affermata negli USA.Altre star dellepoca, come Tortora e lo stesso Baudo, che pure fecero un giro nelle tv private, eranosolo personaggi, mentre Mike era la tv stessa. Dalla tv Berlusconi ha imparato che il potere ogginon solo solidariet, complicit o corruzione (come in buona parte continua ad essere) ma impastato con la seduzione esercitata dal proprio simile. Cos luomo daffari con le mani in pastanel potere, che gi disponeva di tutte le risorse del potere verticale denaro, relazioni, segreti- stato lesto a impadronirsi, culturalmente e patrimonialmente, anche di quello orizzontale, nato
con e per i mass media. Come se Cesare Borgia, trasferito ai giorni nostri, dopo aver bene imparatola lezione di Machiavelli, avesse anche succhiato lanima del personaggio di Mike. Altro che laiutodelle lance francesi! Un p di riflessione sul perch piace ci che piace, qualche gaffe, portata adignit di figura retorica (Eco) per non essere meno maldestro di coloro dei quali si vuoleconquistare lempatia, e presto sopraggiunge la simpatia popolare, consolidata dalle altre accortezzeche fin qui abbiamo elencato.
Partiti a venire
Mentre il bengodi dei Mass Media impazza, non manca chi ritiene che, invece che invece diprendere parte al divertimento, sarebbe meglio rimediare alle rovine che la fine del secolo breve,
quello delle grandi idee collettive e della socialit, ha lasciato sul campo sotto forma di partiti
-
8/9/2019 4 Mass Media e Partiti
7/7
Stefano Balassone I Mass Media fra societ, potere e mercato 15/07/2010book in progress - sezione I Mass Media e Societ
capitolo 4: Mass Media e Partiti
7
spiazzati ed elites senza prestigio. Cos c chi12
- Ideologia: non ritratti di padri e nonni alle pareti, bens principi resistenti al mutare dellecircostanze, per istituzioni, democrazia, giustizia, laicit, economia, socialit, Europa, relazioni colmondo.
propone di rifondare i partiti suggerendo alcunelinee di riferimento dallaspetto ultra concreto,
- Organizzazione: tesseramento, militanza, democrazia interna, finanziamenti.- Linea politica: alleanze, programma, proposte per affrontare, oggi e nella prossima legislatura,
questioni quali l'illegalit e la crisi finanziaria.
- Leadership: chi deve guidare il partito, con che criterio fare la scelta, che relazioni tra partito ecapo del governo.
che per ci sembrano sottovalutare la effettiva difficolt di trovare, nella societ gassosa, un
effettivo capo e una effettiva coda che dia un senso a qualsiasi programma. Un problrema culturalenon si presta, temiamo, ad essere risolto a colpi di buonsenso.
E c chi13
Sono le lites ad avere la capacit, e il dovere, di esercitare pi consapevolmente le virt sociali epolitiche, di esserne lesempio concreto. Infatti i loro membri sono s orientati al successo, maanche alla lungimiranza, alla disciplina, al differimento dellutile, al merito, al decoro,allefficienza; non per amore della virt, ma per legittimare le proprie pretese. ...
si preoccupa delle lites,
il cinismo delle lites facilmente trasmesso allintero corpo sociale- una delle pi gravi tare delPaese, lorigine della sconnessione fra morale e politica, della corrosione dello spazio civile, del
frammentarsi del discorso pubblico in una congerie di particolarismi dialettali. Ed anchelorigine oltre che il prodotto- dei tentativi della politica di polverizzare la societ, di governarlaattraverso il combinato disposto della propaganda e del populismo...
Con un programma -in qualche misura neo-risorgimentale- di una riforma morale degli italiani, sitratta di ricominciare dai pochi (che saranno certo tacciati di moralismo, azionismo, giacobinismo)cio da lites nuove o rinnovate, la cui rigorosa esemplarit sappia riportare la decenza e lavergogna fra le virt civili della nostra democrazia.
forse trascurando che in realt una riforma morale, adattata ai tempi recenti, gi stata incarnatain qualche modo dal marketing sposato con lutopia individualistico-familistica, ovvero da SilvioBerlusconi, che ha raccolto un ampio consenso come italiano esemplare, indossabile dagli italiani
dellepoca consumistica.In altri termini, schemi culturali e schemi politici sono piombati in un vuoto di senso, insieme e perle stesse ragioni. E se dovessimo scommettere su una priorit, ci sembra che sar semmai unaCultura nuova, nuova anche nei suoi modo di produzione, a fare da incubatrice ai nuovi Partiti,quali che essi saranno.
12 Tommaso Padoa Schioppa, per il Corriere della Sera, Luglio del 2009.13 Carlo Galli, per La Repubblica del 6 settembre 2009.