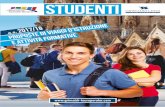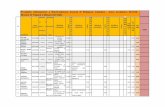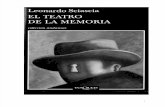· Web viewIstituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo Sciascia” Erice. Istituto...
Transcript of · Web viewIstituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo Sciascia” Erice. Istituto...

Istituto drsquoIstruzione Secondaria SuperioreldquoLeonardo Sciasciardquo
Erice
INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
ANNO SCOLASTICO 2013 ndash 2014
PIANO DI LAVORO
DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
1
Istituto Tecnico Economico ldquoL Sciasciardquo (sede Erice)
Istituto Tecnico Economico ldquoL Sciasciardquo(sede Valderice) Istituto Tecnico Economico ldquoL Sciasciardquo(sede Carceraria)
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari ldquoG Bufalinordquo (sede Trapani)
CLASSE 3 F
COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
COMPETENZE
Partendo dalla consapevolezza che la competenza motoria esprime lrsquointegrazione di conoscenze (i saperi che sottintendono lrsquoesecuzione di un compito di una attivitagrave motoria) abilitagrave motoria (i saper fare) e comportamenti (saper essere) sulla base delle capacitagrave personali
Lrsquoalunno deve saper
- elaborare ed organizzare le informazioni propriocettive ed esterocettive (capacitagrave percettive)- esprimere motivazione intrinseca allrsquoapprendimento motorio ed un adeguato livello di auto
efficacia percepita- eseguire un compito motorio secondo un determinato livello di difficoltagrave intensitagrave durata varietagrave
esecutiva (rapporti tra abilitagrave motorie capacitagrave coordinative e condizionali)- essere consapevole del processo compiuto autovalutare le proprie esperienze ed imparare ad
apprendere ulteriori abilitagrave motorie e conoscenze (processi metacognitivi)- interagire e cooperare con gli altri per uno scopo comune (fattori socio affettivi)- trasferire i saperi appresi in contesti differenti della vita di relazione o sportiva
Non basta saper fare un compito ma egrave sempre piugrave necessario riuscire ad integrare e mobilitare saperi diversi (abilitagrave e conoscenze) comportamenti ed atteggiamenti riuscendo ad applicarli in contesti diversi per risolvere problemi
2
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Per lrsquoindividuazione degli obiettivi specifici bisogneragrave valutare i livelli cognitivi e psicomotori
dei ragazzi
Allo scopo appaiono opportuni sia un iniziale colloquio con le classi per vagliare le loro conoscenze specifiche della materia sia lrsquoeffettuazione di prove attitudinali al fine di conoscere il vissuto motorio di ogni singolo alunno
Questa metodologia saragrave applicata in tutte le classi e non soltanto per le prime classi dato che insegno per la prima volta in questo istituto per cui non conosco ancora le capacitagrave e le conoscenze degli alunni di tutte le classi
Successivamente si tenderagrave ad accrescere nello studente la coscienza del proprio corpo attraverso il movimento guidato
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
3
OTTOBRE
GINNASTICA
A
CORPO LIBERO
Attivitagrave ed esercizi a carico naturale
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e per il controllo della respirazione Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi di equilibrio
9
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresetate da un carico naturale
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero dellrsquoequilibrio
NOVEMBRE ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA PALLAVOLO
PALLACANESTRO
Regole della pallavolo e della pallacanestro
Le infrazioni della pallavolo e della pallacanestro
La battuta il bagher il palleggio il pallonetto
il muro la schiacciata
Palleggio passaggi tiro
a canestro
7
Saper applicare le regole per giocare e arbitrare
Saper applicare praticamente i fondamentali individuali gli schemi di squadra ed i diversi ruoli della pallavolo e della pallacanestro
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
DICEMBRE EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La salute un bene individuale e sociale
Le malattie a trasmissione sessuale lrsquoAIDS
Le droghe
Tabacco
5 Saper trasferire il concetto di benessere al proprio modo essere e di lavorare rispettando le regole che vigono per effettuare lrsquoattivitagrave motoria
Saper discriminare quali danni provocano le sostanze tossiche quali sono gli effetti dannosi delle sostanze dopanti dal punto di vista biologico e delle ripercussioni che
4
Alcol
Il doping
Integratori alimentari e lo sport
Paramorfismi e dimorfismi
Il mal di schiena
essi hanno dal punto di vista etico ma sa anche comprendere i benefici degli integratori alimentari
Saper riconoscere le posture scorrette che portano allrsquoassunzione di atteggiamenti viziati e prevenirli
MODALITArsquo DI LAVORO
STRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese ottobre
Lavoro individuale a coppie a gruppo ed in circuito Spazio attorno allrsquoistituto
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
5
Mese novembre
Lavoro individuale a coppie a gruppo e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Palloni di pallavolo
Palloni di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
6
Mese dicembre
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
7
GENNAIO
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
LrsquoATLETICA
LEGGERA
Regole principali delle discipline dellrsquoatletica leggera
Corsa di resistenza
Corsa veloce
Staffetta
Salto in lungo
6 Saper applicare le regole di ogni disciplina atletica per un efficace risultato durante le prestazioni
Saper applicare i gesti atletici in modo efficace ed economico
Saper applicare le discipline atletiche di squadra (staffetta) adattandosi ai tempi dei compagni e alle situazione mutevoli ed impreviste calcolandone la soluzione ideale
FEBBRAIO
GINNASTICA EDUCATIVA CON GRANDI ATTREZZI
Attivitagrave ed esercizi con attrezzi
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi drsquoequilibrio in condizioni dinamiche complesse
Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico
Esercizi posturali e di controllo segmentario
7 Saper discriminare le varie tipologie degli attrezzi e la loro utilitagrave a seconda dei movimenti proposti
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresentate da un carico addizionale adeguato
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero
8
dellrsquoequilibrio
MARZO
ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA
CALCIO A CINQUE
CALCIO A 11
Regole del calcio a cinque e a 11
Lo stop il calcio o passaggio il controllo della palla il palleggio il colpo di testa la parata
7
Saper applicare le regole del calcio per giocare e arbitrare
Saper applicare i fondamentali individuali del calcio gli schemi di difesa ed attacco
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese gennaio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra(staffetta)
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina peso e testimone
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
Mese febbraio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non Grandi attrezzi
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
9
Mese marzo
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non
Pallone di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
APRILE Principali regole della ginnastica artistica
9 Saper applicare le regole della ginnastica artistica per un efficace risultato durante le
10
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

CLASSE 3 F
COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
COMPETENZE
Partendo dalla consapevolezza che la competenza motoria esprime lrsquointegrazione di conoscenze (i saperi che sottintendono lrsquoesecuzione di un compito di una attivitagrave motoria) abilitagrave motoria (i saper fare) e comportamenti (saper essere) sulla base delle capacitagrave personali
Lrsquoalunno deve saper
- elaborare ed organizzare le informazioni propriocettive ed esterocettive (capacitagrave percettive)- esprimere motivazione intrinseca allrsquoapprendimento motorio ed un adeguato livello di auto
efficacia percepita- eseguire un compito motorio secondo un determinato livello di difficoltagrave intensitagrave durata varietagrave
esecutiva (rapporti tra abilitagrave motorie capacitagrave coordinative e condizionali)- essere consapevole del processo compiuto autovalutare le proprie esperienze ed imparare ad
apprendere ulteriori abilitagrave motorie e conoscenze (processi metacognitivi)- interagire e cooperare con gli altri per uno scopo comune (fattori socio affettivi)- trasferire i saperi appresi in contesti differenti della vita di relazione o sportiva
Non basta saper fare un compito ma egrave sempre piugrave necessario riuscire ad integrare e mobilitare saperi diversi (abilitagrave e conoscenze) comportamenti ed atteggiamenti riuscendo ad applicarli in contesti diversi per risolvere problemi
2
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Per lrsquoindividuazione degli obiettivi specifici bisogneragrave valutare i livelli cognitivi e psicomotori
dei ragazzi
Allo scopo appaiono opportuni sia un iniziale colloquio con le classi per vagliare le loro conoscenze specifiche della materia sia lrsquoeffettuazione di prove attitudinali al fine di conoscere il vissuto motorio di ogni singolo alunno
Questa metodologia saragrave applicata in tutte le classi e non soltanto per le prime classi dato che insegno per la prima volta in questo istituto per cui non conosco ancora le capacitagrave e le conoscenze degli alunni di tutte le classi
Successivamente si tenderagrave ad accrescere nello studente la coscienza del proprio corpo attraverso il movimento guidato
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
3
OTTOBRE
GINNASTICA
A
CORPO LIBERO
Attivitagrave ed esercizi a carico naturale
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e per il controllo della respirazione Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi di equilibrio
9
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresetate da un carico naturale
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero dellrsquoequilibrio
NOVEMBRE ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA PALLAVOLO
PALLACANESTRO
Regole della pallavolo e della pallacanestro
Le infrazioni della pallavolo e della pallacanestro
La battuta il bagher il palleggio il pallonetto
il muro la schiacciata
Palleggio passaggi tiro
a canestro
7
Saper applicare le regole per giocare e arbitrare
Saper applicare praticamente i fondamentali individuali gli schemi di squadra ed i diversi ruoli della pallavolo e della pallacanestro
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
DICEMBRE EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La salute un bene individuale e sociale
Le malattie a trasmissione sessuale lrsquoAIDS
Le droghe
Tabacco
5 Saper trasferire il concetto di benessere al proprio modo essere e di lavorare rispettando le regole che vigono per effettuare lrsquoattivitagrave motoria
Saper discriminare quali danni provocano le sostanze tossiche quali sono gli effetti dannosi delle sostanze dopanti dal punto di vista biologico e delle ripercussioni che
4
Alcol
Il doping
Integratori alimentari e lo sport
Paramorfismi e dimorfismi
Il mal di schiena
essi hanno dal punto di vista etico ma sa anche comprendere i benefici degli integratori alimentari
Saper riconoscere le posture scorrette che portano allrsquoassunzione di atteggiamenti viziati e prevenirli
MODALITArsquo DI LAVORO
STRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese ottobre
Lavoro individuale a coppie a gruppo ed in circuito Spazio attorno allrsquoistituto
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
5
Mese novembre
Lavoro individuale a coppie a gruppo e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Palloni di pallavolo
Palloni di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
6
Mese dicembre
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
7
GENNAIO
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
LrsquoATLETICA
LEGGERA
Regole principali delle discipline dellrsquoatletica leggera
Corsa di resistenza
Corsa veloce
Staffetta
Salto in lungo
6 Saper applicare le regole di ogni disciplina atletica per un efficace risultato durante le prestazioni
Saper applicare i gesti atletici in modo efficace ed economico
Saper applicare le discipline atletiche di squadra (staffetta) adattandosi ai tempi dei compagni e alle situazione mutevoli ed impreviste calcolandone la soluzione ideale
FEBBRAIO
GINNASTICA EDUCATIVA CON GRANDI ATTREZZI
Attivitagrave ed esercizi con attrezzi
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi drsquoequilibrio in condizioni dinamiche complesse
Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico
Esercizi posturali e di controllo segmentario
7 Saper discriminare le varie tipologie degli attrezzi e la loro utilitagrave a seconda dei movimenti proposti
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresentate da un carico addizionale adeguato
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero
8
dellrsquoequilibrio
MARZO
ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA
CALCIO A CINQUE
CALCIO A 11
Regole del calcio a cinque e a 11
Lo stop il calcio o passaggio il controllo della palla il palleggio il colpo di testa la parata
7
Saper applicare le regole del calcio per giocare e arbitrare
Saper applicare i fondamentali individuali del calcio gli schemi di difesa ed attacco
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese gennaio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra(staffetta)
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina peso e testimone
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
Mese febbraio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non Grandi attrezzi
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
9
Mese marzo
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non
Pallone di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
APRILE Principali regole della ginnastica artistica
9 Saper applicare le regole della ginnastica artistica per un efficace risultato durante le
10
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Per lrsquoindividuazione degli obiettivi specifici bisogneragrave valutare i livelli cognitivi e psicomotori
dei ragazzi
Allo scopo appaiono opportuni sia un iniziale colloquio con le classi per vagliare le loro conoscenze specifiche della materia sia lrsquoeffettuazione di prove attitudinali al fine di conoscere il vissuto motorio di ogni singolo alunno
Questa metodologia saragrave applicata in tutte le classi e non soltanto per le prime classi dato che insegno per la prima volta in questo istituto per cui non conosco ancora le capacitagrave e le conoscenze degli alunni di tutte le classi
Successivamente si tenderagrave ad accrescere nello studente la coscienza del proprio corpo attraverso il movimento guidato
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
3
OTTOBRE
GINNASTICA
A
CORPO LIBERO
Attivitagrave ed esercizi a carico naturale
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e per il controllo della respirazione Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi di equilibrio
9
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresetate da un carico naturale
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero dellrsquoequilibrio
NOVEMBRE ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA PALLAVOLO
PALLACANESTRO
Regole della pallavolo e della pallacanestro
Le infrazioni della pallavolo e della pallacanestro
La battuta il bagher il palleggio il pallonetto
il muro la schiacciata
Palleggio passaggi tiro
a canestro
7
Saper applicare le regole per giocare e arbitrare
Saper applicare praticamente i fondamentali individuali gli schemi di squadra ed i diversi ruoli della pallavolo e della pallacanestro
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
DICEMBRE EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La salute un bene individuale e sociale
Le malattie a trasmissione sessuale lrsquoAIDS
Le droghe
Tabacco
5 Saper trasferire il concetto di benessere al proprio modo essere e di lavorare rispettando le regole che vigono per effettuare lrsquoattivitagrave motoria
Saper discriminare quali danni provocano le sostanze tossiche quali sono gli effetti dannosi delle sostanze dopanti dal punto di vista biologico e delle ripercussioni che
4
Alcol
Il doping
Integratori alimentari e lo sport
Paramorfismi e dimorfismi
Il mal di schiena
essi hanno dal punto di vista etico ma sa anche comprendere i benefici degli integratori alimentari
Saper riconoscere le posture scorrette che portano allrsquoassunzione di atteggiamenti viziati e prevenirli
MODALITArsquo DI LAVORO
STRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese ottobre
Lavoro individuale a coppie a gruppo ed in circuito Spazio attorno allrsquoistituto
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
5
Mese novembre
Lavoro individuale a coppie a gruppo e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Palloni di pallavolo
Palloni di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
6
Mese dicembre
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
7
GENNAIO
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
LrsquoATLETICA
LEGGERA
Regole principali delle discipline dellrsquoatletica leggera
Corsa di resistenza
Corsa veloce
Staffetta
Salto in lungo
6 Saper applicare le regole di ogni disciplina atletica per un efficace risultato durante le prestazioni
Saper applicare i gesti atletici in modo efficace ed economico
Saper applicare le discipline atletiche di squadra (staffetta) adattandosi ai tempi dei compagni e alle situazione mutevoli ed impreviste calcolandone la soluzione ideale
FEBBRAIO
GINNASTICA EDUCATIVA CON GRANDI ATTREZZI
Attivitagrave ed esercizi con attrezzi
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi drsquoequilibrio in condizioni dinamiche complesse
Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico
Esercizi posturali e di controllo segmentario
7 Saper discriminare le varie tipologie degli attrezzi e la loro utilitagrave a seconda dei movimenti proposti
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresentate da un carico addizionale adeguato
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero
8
dellrsquoequilibrio
MARZO
ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA
CALCIO A CINQUE
CALCIO A 11
Regole del calcio a cinque e a 11
Lo stop il calcio o passaggio il controllo della palla il palleggio il colpo di testa la parata
7
Saper applicare le regole del calcio per giocare e arbitrare
Saper applicare i fondamentali individuali del calcio gli schemi di difesa ed attacco
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese gennaio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra(staffetta)
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina peso e testimone
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
Mese febbraio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non Grandi attrezzi
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
9
Mese marzo
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non
Pallone di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
APRILE Principali regole della ginnastica artistica
9 Saper applicare le regole della ginnastica artistica per un efficace risultato durante le
10
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

OTTOBRE
GINNASTICA
A
CORPO LIBERO
Attivitagrave ed esercizi a carico naturale
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e per il controllo della respirazione Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi di equilibrio
9
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresetate da un carico naturale
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero dellrsquoequilibrio
NOVEMBRE ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA PALLAVOLO
PALLACANESTRO
Regole della pallavolo e della pallacanestro
Le infrazioni della pallavolo e della pallacanestro
La battuta il bagher il palleggio il pallonetto
il muro la schiacciata
Palleggio passaggi tiro
a canestro
7
Saper applicare le regole per giocare e arbitrare
Saper applicare praticamente i fondamentali individuali gli schemi di squadra ed i diversi ruoli della pallavolo e della pallacanestro
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
DICEMBRE EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La salute un bene individuale e sociale
Le malattie a trasmissione sessuale lrsquoAIDS
Le droghe
Tabacco
5 Saper trasferire il concetto di benessere al proprio modo essere e di lavorare rispettando le regole che vigono per effettuare lrsquoattivitagrave motoria
Saper discriminare quali danni provocano le sostanze tossiche quali sono gli effetti dannosi delle sostanze dopanti dal punto di vista biologico e delle ripercussioni che
4
Alcol
Il doping
Integratori alimentari e lo sport
Paramorfismi e dimorfismi
Il mal di schiena
essi hanno dal punto di vista etico ma sa anche comprendere i benefici degli integratori alimentari
Saper riconoscere le posture scorrette che portano allrsquoassunzione di atteggiamenti viziati e prevenirli
MODALITArsquo DI LAVORO
STRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese ottobre
Lavoro individuale a coppie a gruppo ed in circuito Spazio attorno allrsquoistituto
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
5
Mese novembre
Lavoro individuale a coppie a gruppo e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Palloni di pallavolo
Palloni di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
6
Mese dicembre
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
7
GENNAIO
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
LrsquoATLETICA
LEGGERA
Regole principali delle discipline dellrsquoatletica leggera
Corsa di resistenza
Corsa veloce
Staffetta
Salto in lungo
6 Saper applicare le regole di ogni disciplina atletica per un efficace risultato durante le prestazioni
Saper applicare i gesti atletici in modo efficace ed economico
Saper applicare le discipline atletiche di squadra (staffetta) adattandosi ai tempi dei compagni e alle situazione mutevoli ed impreviste calcolandone la soluzione ideale
FEBBRAIO
GINNASTICA EDUCATIVA CON GRANDI ATTREZZI
Attivitagrave ed esercizi con attrezzi
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi drsquoequilibrio in condizioni dinamiche complesse
Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico
Esercizi posturali e di controllo segmentario
7 Saper discriminare le varie tipologie degli attrezzi e la loro utilitagrave a seconda dei movimenti proposti
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresentate da un carico addizionale adeguato
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero
8
dellrsquoequilibrio
MARZO
ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA
CALCIO A CINQUE
CALCIO A 11
Regole del calcio a cinque e a 11
Lo stop il calcio o passaggio il controllo della palla il palleggio il colpo di testa la parata
7
Saper applicare le regole del calcio per giocare e arbitrare
Saper applicare i fondamentali individuali del calcio gli schemi di difesa ed attacco
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese gennaio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra(staffetta)
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina peso e testimone
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
Mese febbraio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non Grandi attrezzi
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
9
Mese marzo
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non
Pallone di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
APRILE Principali regole della ginnastica artistica
9 Saper applicare le regole della ginnastica artistica per un efficace risultato durante le
10
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Alcol
Il doping
Integratori alimentari e lo sport
Paramorfismi e dimorfismi
Il mal di schiena
essi hanno dal punto di vista etico ma sa anche comprendere i benefici degli integratori alimentari
Saper riconoscere le posture scorrette che portano allrsquoassunzione di atteggiamenti viziati e prevenirli
MODALITArsquo DI LAVORO
STRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese ottobre
Lavoro individuale a coppie a gruppo ed in circuito Spazio attorno allrsquoistituto
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
5
Mese novembre
Lavoro individuale a coppie a gruppo e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Palloni di pallavolo
Palloni di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
6
Mese dicembre
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
7
GENNAIO
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
LrsquoATLETICA
LEGGERA
Regole principali delle discipline dellrsquoatletica leggera
Corsa di resistenza
Corsa veloce
Staffetta
Salto in lungo
6 Saper applicare le regole di ogni disciplina atletica per un efficace risultato durante le prestazioni
Saper applicare i gesti atletici in modo efficace ed economico
Saper applicare le discipline atletiche di squadra (staffetta) adattandosi ai tempi dei compagni e alle situazione mutevoli ed impreviste calcolandone la soluzione ideale
FEBBRAIO
GINNASTICA EDUCATIVA CON GRANDI ATTREZZI
Attivitagrave ed esercizi con attrezzi
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi drsquoequilibrio in condizioni dinamiche complesse
Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico
Esercizi posturali e di controllo segmentario
7 Saper discriminare le varie tipologie degli attrezzi e la loro utilitagrave a seconda dei movimenti proposti
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresentate da un carico addizionale adeguato
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero
8
dellrsquoequilibrio
MARZO
ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA
CALCIO A CINQUE
CALCIO A 11
Regole del calcio a cinque e a 11
Lo stop il calcio o passaggio il controllo della palla il palleggio il colpo di testa la parata
7
Saper applicare le regole del calcio per giocare e arbitrare
Saper applicare i fondamentali individuali del calcio gli schemi di difesa ed attacco
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese gennaio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra(staffetta)
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina peso e testimone
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
Mese febbraio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non Grandi attrezzi
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
9
Mese marzo
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non
Pallone di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
APRILE Principali regole della ginnastica artistica
9 Saper applicare le regole della ginnastica artistica per un efficace risultato durante le
10
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Mese novembre
Lavoro individuale a coppie a gruppo e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Palloni di pallavolo
Palloni di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
6
Mese dicembre
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
7
GENNAIO
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
LrsquoATLETICA
LEGGERA
Regole principali delle discipline dellrsquoatletica leggera
Corsa di resistenza
Corsa veloce
Staffetta
Salto in lungo
6 Saper applicare le regole di ogni disciplina atletica per un efficace risultato durante le prestazioni
Saper applicare i gesti atletici in modo efficace ed economico
Saper applicare le discipline atletiche di squadra (staffetta) adattandosi ai tempi dei compagni e alle situazione mutevoli ed impreviste calcolandone la soluzione ideale
FEBBRAIO
GINNASTICA EDUCATIVA CON GRANDI ATTREZZI
Attivitagrave ed esercizi con attrezzi
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi drsquoequilibrio in condizioni dinamiche complesse
Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico
Esercizi posturali e di controllo segmentario
7 Saper discriminare le varie tipologie degli attrezzi e la loro utilitagrave a seconda dei movimenti proposti
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresentate da un carico addizionale adeguato
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero
8
dellrsquoequilibrio
MARZO
ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA
CALCIO A CINQUE
CALCIO A 11
Regole del calcio a cinque e a 11
Lo stop il calcio o passaggio il controllo della palla il palleggio il colpo di testa la parata
7
Saper applicare le regole del calcio per giocare e arbitrare
Saper applicare i fondamentali individuali del calcio gli schemi di difesa ed attacco
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese gennaio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra(staffetta)
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina peso e testimone
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
Mese febbraio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non Grandi attrezzi
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
9
Mese marzo
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non
Pallone di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
APRILE Principali regole della ginnastica artistica
9 Saper applicare le regole della ginnastica artistica per un efficace risultato durante le
10
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Mese dicembre
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
7
GENNAIO
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
LrsquoATLETICA
LEGGERA
Regole principali delle discipline dellrsquoatletica leggera
Corsa di resistenza
Corsa veloce
Staffetta
Salto in lungo
6 Saper applicare le regole di ogni disciplina atletica per un efficace risultato durante le prestazioni
Saper applicare i gesti atletici in modo efficace ed economico
Saper applicare le discipline atletiche di squadra (staffetta) adattandosi ai tempi dei compagni e alle situazione mutevoli ed impreviste calcolandone la soluzione ideale
FEBBRAIO
GINNASTICA EDUCATIVA CON GRANDI ATTREZZI
Attivitagrave ed esercizi con attrezzi
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi drsquoequilibrio in condizioni dinamiche complesse
Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico
Esercizi posturali e di controllo segmentario
7 Saper discriminare le varie tipologie degli attrezzi e la loro utilitagrave a seconda dei movimenti proposti
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresentate da un carico addizionale adeguato
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero
8
dellrsquoequilibrio
MARZO
ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA
CALCIO A CINQUE
CALCIO A 11
Regole del calcio a cinque e a 11
Lo stop il calcio o passaggio il controllo della palla il palleggio il colpo di testa la parata
7
Saper applicare le regole del calcio per giocare e arbitrare
Saper applicare i fondamentali individuali del calcio gli schemi di difesa ed attacco
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese gennaio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra(staffetta)
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina peso e testimone
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
Mese febbraio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non Grandi attrezzi
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
9
Mese marzo
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non
Pallone di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
APRILE Principali regole della ginnastica artistica
9 Saper applicare le regole della ginnastica artistica per un efficace risultato durante le
10
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

GENNAIO
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
LrsquoATLETICA
LEGGERA
Regole principali delle discipline dellrsquoatletica leggera
Corsa di resistenza
Corsa veloce
Staffetta
Salto in lungo
6 Saper applicare le regole di ogni disciplina atletica per un efficace risultato durante le prestazioni
Saper applicare i gesti atletici in modo efficace ed economico
Saper applicare le discipline atletiche di squadra (staffetta) adattandosi ai tempi dei compagni e alle situazione mutevoli ed impreviste calcolandone la soluzione ideale
FEBBRAIO
GINNASTICA EDUCATIVA CON GRANDI ATTREZZI
Attivitagrave ed esercizi con attrezzi
Attivitagrave ed esercizi di opposizione e resistenza
Attivitagrave ed esercizi eseguiti in varietagrave di ampiezza di ritmo in situazioni spazio temporali variate Esercizi drsquoequilibrio in condizioni dinamiche complesse
Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico
Esercizi posturali e di controllo segmentario
7 Saper discriminare le varie tipologie degli attrezzi e la loro utilitagrave a seconda dei movimenti proposti
Saper tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Saper vincere resistenze rappresentate da un carico addizionale adeguato
Saper compiere azioni semplici e complesse nel piugrave breve tempo possibile
Saper eseguire movimenti con lrsquoescursione piugrave ampia possibile nellrsquoambito del normale raggio di movimento articolare
Saper avere disponibilitagrave e controllo segmentario
Saper realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio ndash temporali
Saper svolgere compiti motori che richiedono la conquista il mantenimento ed il recupero
8
dellrsquoequilibrio
MARZO
ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA
CALCIO A CINQUE
CALCIO A 11
Regole del calcio a cinque e a 11
Lo stop il calcio o passaggio il controllo della palla il palleggio il colpo di testa la parata
7
Saper applicare le regole del calcio per giocare e arbitrare
Saper applicare i fondamentali individuali del calcio gli schemi di difesa ed attacco
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese gennaio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra(staffetta)
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina peso e testimone
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
Mese febbraio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non Grandi attrezzi
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
9
Mese marzo
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non
Pallone di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
APRILE Principali regole della ginnastica artistica
9 Saper applicare le regole della ginnastica artistica per un efficace risultato durante le
10
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

dellrsquoequilibrio
MARZO
ATTIVITArsquo SPORTIVE DI SQUADRA
CALCIO A CINQUE
CALCIO A 11
Regole del calcio a cinque e a 11
Lo stop il calcio o passaggio il controllo della palla il palleggio il colpo di testa la parata
7
Saper applicare le regole del calcio per giocare e arbitrare
Saper applicare i fondamentali individuali del calcio gli schemi di difesa ed attacco
Saper comprendere ed applicare la logica del gioco
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
Mese gennaio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra(staffetta)
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina peso e testimone
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
Mese febbraio
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra
Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non Grandi attrezzi
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
9
Mese marzo
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non
Pallone di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
APRILE Principali regole della ginnastica artistica
9 Saper applicare le regole della ginnastica artistica per un efficace risultato durante le
10
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Mese marzo
Lavoro individuale a coppie a gruppo in circuito in percorsi e a squadra Spazio attorno allrsquoistituto
Piccoli attrezzi codificati o non
Pallone di calcio
La verifica consiste nei risultati ottenuti nellrsquoobiettivo che viene esaminato ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
MESE BLOCCHI TEMATICIELENCO DEGLI ARGOMENTI
TEMPO
IN OREABILITArsquo
APRILE Principali regole della ginnastica artistica
9 Saper applicare le regole della ginnastica artistica per un efficace risultato durante le
10
ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

ATTIVITArsquo SPORTIVA INDIVIDUALE
GINNASTICA ARTISTICA
Il corpo libero
-tipologie di andature ginniche
-tipologie di salti artistici
-elementi di acrobatica a corpo libero
prestazioni
Saper eseguire i gesti ginnici in modo efficace ed economico
Saper eseguire i diversi movimenti della disciplina adattandoli e alle situazione mutevoli ed agli imprevisti dovuti ad un mutevole equilibrio durante le fasi di volo (acrobatica e volteggio) o durante le traslocazioni ed i salti ginnici (trave e suolo)
MAGGIO GIUGNO
CENNI SUL CORPO UMANO
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Apparato locomotorio
Apparato respiratorio
Apparato cardio circolatorio
Come ripristinare o sostenere le funzioni vitali in caso di emergenza
Primo soccorso nellrsquoesercizio fisico tipologia di trauma e come intervenire
Primo soccorso in
11 Saper riconoscere le strutture ossee e muscolari coinvolti nei diversi movimenti
Saper riconoscere le modificazioni dei diversi apparati dovuti allrsquoattivitagrave fisica
Saper riconoscere uno stato di emergenza
Conoscere i diversi tipi di traumi quali conseguenze possono apportare e cosa si deve fare nellrsquoimmediato
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di malesseri dovuti a situazioni ambientali climatiche o in caso di morsi di animali o punture di insetti
Prevenzione e conoscenza delle situazione di intervento in caso di incidenti domestici
11
ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

ambiente naturale situazioni di intervento
Primo soccorso in ambiente domestico
incidenti casalinghi
Conoscenza delle norme di comportamento in caso di calamitagrave naturali
MODALITArsquo DI LAVOROSTRUMENTI
(MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI)
RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE
VERIFICA E VALUTAZIONE
12
Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Mese aprile
Lavoro individuale a coppie
Piccoli e grandi attrezzi
Attrezzi specifici della disciplina
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
La verifica consiste nei risultati ottenuti nella disciplina che viene esaminata ed opportunamente inserito in delle griglie di valutazioni precostituite e debitamente tarate
13
Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Mese maggio e giugno
Lezione frontale
Aula
Libri di testo o fotocopie
Ricerche in laboratorio multimediali
Proiezioni di filmati
Prove strutturate scritte aperte o chiuse
Prove orali
Erice 01122013
Il docente
Scarcella Carla
14
FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

FINALITArsquo DELLrsquoINSEGNAMENTOLo studio della disciplina intende contribuire alla formazione culturale generale dello studente finalizzata soprattutto allrsquoorientamento Turistico Lo studio della disciplina ha come finalitagrave
Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura i significati e i complessi valori storici culturali ed estetici dellrsquoopera drsquoarte
Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico artistico nelle sue diverseespressioni in particolare quello del territorio di residenza cogliendo il filo dialettico culturale che lega la cultura del passato alla attuale attivare un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale sviluppando la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualitagrave della vita
Sviluppare interesse salvaguardia e curiositagrave nellrsquoapprezzare e tutelare i beni culturali artistici naturalistici e paesaggisti del territorio
Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltagrave e aeree culturali e la civiltagrave occidentale
Incrementare le capacitagrave di raccordo con gli altri ambiti disciplinari affini alla materia al fine di rilevare il confluire nellrsquoopera drsquoarte dei diversi aspetti dei campi del sapere umanistico scientifico tecnologico
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi della disciplina sono Instaurare nella classe un sereno clima di dialogo e fiducia promuovere la maturazione e la formazione degli allievi stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e responsabile fare acquisire agli allievi un efficace metodo di studio assicurarsi sulla padronanza dei contenuti far comprendere agli allievi che gli argomenti giagrave fatti in itinere e da fare
contribuiscono allrsquoaccrescimento del loro bagaglio culturale sviluppare attraverso lo studio dei linguaggi visivi il senso spaziale ed estetico indirizzare lo studente allrsquoanalisi del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico-
naturalistico utilizzando gli strumenti piugrave idonei alla natura del problema e di promuovere il rispetto e
la salvaguardia di queste risorse che fanno parte del patrimonio beni culturali da tutelare
risalire al contesto socio-culturale entro cui la produzione artistica si egrave formata tenendo conto in particolare del rapporto artista-committenza
individuare le principali rilevanze artistiche della propria cittagrave e regioneA fine anno scolastico lo studente dovragrave conoscere gli autori le tecniche artistiche ed i vari periodi con le adeguate opere artistiche proposte durante il corso dellrsquoanno scolastico possedere una terminologia adeguata alla disciplina che gli consenta di esprimersi correttamente e con proprietagrave di linguaggio saper applicare le regole ed i principi appresi
COMPETENZE utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitagrave di studio ricerca ed
approfondimento disciplinare identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti analizzare lrsquoimmagine del territorio sia per riconoscere la specificitagrave del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Capacitagrave di lettura dellopera darte a piugrave livelli descrittivo stilistico contenutistico
storico e sociale e iconologico
CONOSCENZE Concetto di bene culturale Teorie interpretative dellrsquoopera drsquoarte
15
Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Lineamenti di storia dellrsquoarte italiana in relazione al contesto mediterraneo ed europeo dalle origini al Settecento
Movimenti artistici personalitagrave e opere significative di architettura pittura scultura e arti applicate dalle origini al Trecento
Elementi caratterizzanti il territorio italiano ed europeo dalle origini allrsquoetagrave medievale con particolare riferimento alle testimonianze storico-artistiche dellrsquoambito territoriale di appartenenza
Rappresentazione del paesaggio nelle arti figurative Evoluzione della realtagrave urbana delle tipologie edilizie e degli spazi urbani dalle origini
allrsquoetagrave medievale Categorie di beni del patrimonio storico-artistico in Italia e loro distribuzione nel
territorio Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche
studiate la storia dellrsquoarte e la critica drsquoarte Conoscenza dei beni culturali e delle leggi che li tutelano Conoscenza di un metodo di lettura dellrsquoopera drsquoarte
ABILITAgrave Leggere lrsquoopera drsquoarte individuando le componenti strutturali tecniche iconografiche
stilistiche e relative alla committenza Delineare la storia dellrsquoarte italiana dalle origini al Trecento evidenziando i nessi con la
storia e la cultura locale Riconoscere i linguaggi propri dellrsquoarchitettura della pittura della scultura e delle arti
applicate Inserire il manufatto nel contesto storico-artistico di riferimento Riconoscere lrsquoevoluzione storica del territorio e del paesaggio attraverso le
testimonianze storico-artistiche Riconoscere lrsquoevoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso lrsquoanalisi delle
tipologie edilizie Riconoscere le categorie dei beni culturali in Italia e la loro distribuzione nel territorio Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione
dellrsquoambito territoriale di appartenenza
METODOLOGIA
Lrsquoinsegnamento terragrave sempre presente la situazione concreta della classe e metteragrave in primo piano lrsquoalunno e il dialogo aperto che occorreragrave sviluppare con coerenza e continuitagrave In questa attivitagrave provvederagrave a
far leggere il territorio e lambiente costruito per individuare le diverse stratificazioni degli interventi delluomo (complessi archeologici architettoniche urbanistici)
promuovere un contatto diretto con le opere presenti su territorio anche attraverso visite a musei e a monumenti
affidare a singoli studenti o a gruppi il compito di elaborare ricerche e itinerari su temi specifici
concentrare lattenzione su una o piugrave opere di grande rilievo nazionale e internazionale che consentano a loro volta di risalire alle personalitagrave dominanti alle scuole e alle correnti piugrave significative
sottolineare i valori di comunicazione dei diversi linguaggi delle arti visive anche nei loro risvolti professionali
utilizzare ampiamente gli opportuni strumenti didattici forniti dalle attuali tecnologie sollecitare nella programmazione didattica un continuo interscambio con i docenti
delle altre discipline
Lrsquoanalisi e lrsquointerpretazione dellrsquoopera drsquoarte terragrave conto delle varie metodologie stilistico-formale iconografica-iconologica sociologica antropologica
16
Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Il livello didattico terragrave presente da un lato le competenze giagrave acquisite e lrsquoesperienza culturale dello studente dallrsquoaltro i processi di apprendimento propri dellrsquoetagrave e quelli legati allrsquooggetto di studio Saranno suscettibili di trattazione interdisciplinare e pluridisciplinare quegli argomenti che si svolgono contemporaneamente ad altre materie Gli approcci didattici terranno conto dei livelli di partenza rilevati in modo da stabilire un fruttuoso rapporto insegnamento-apprendimento Durante lrsquoitinerario didattico il suddetto rapporto si articoleragrave in maniera piugrave dinamica e relazionata
STRATEGIE DIDATTICHE lezione frontale lezione interattiva Lezione multimediale Cooperative learning Attivitagrave di laboratorio
Supporti didattici Libro di testo materiale vario di documentazione (riviste giornali saggi testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo fotocopie DVD didattici visite di istruzione a monumenti pinacoteche musei mostre temporanee
Le lezioni vengono svolte ndash a seconda delle necessitagrave didattiche e delle opportunitagrave o nelle aule di studio o nelle aule di informatica
Visite didattiche Trapani centro storico ndash Erice Segesta MarsalaMazara del Vallo Palermo ndash percorso AraboNormanno
Quantitagrave e tipologia delle prove Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre minimo N 1 Prove strutturate eo semistrutturate - N 2 Orale - Schedatura delle opere drsquoarte ndash
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Tipologie delle prove di verifica verifiche orali relative sia alla presentazione di un periodo storico di una tendenza
artistica di una singola personalitagrave sia allanalisi di singole immagini proposte dallinsegnante
verifiche scritte volte allanalisi di opere darte o allaccertamento delle conoscenze in ambito artistico anche per quanto concerne il livello di padronanza della terminologia specifica Tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie a seconda delle necessitagrave didattiche
Schedatura opere drsquoarte analisi testuale libera questionario a risposta aperta questionario a risposta chiusa-multipla
Esercitazione grafiche o multimedialiLa valutazione periodica e formativa tende ad ottenere una quantitagrave di informazioni atte acomprendere la metodologia di studio la maturazione progressiva la padronanza o le lacune nel processo di apprendimento del discente al fine di vagliare se la condotta educativa didatticanecessita di correttivi pertinentiSono oggetto di valutazione sulla base della distinzione fra obiettivi minimi medi e massimi le seguenti conoscenze capacitagrave e abilitagrave
17
(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

(obiettivi minimi) la conoscenza specifica di stili correnti e singole personalitagrave del campo artistico la capacitagrave di fornire una descrizione delle opere darte affrontate la correttezza e la specificitagrave terminologica adottata nella descrizione la capacitagrave di analizzare unopera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico la capacitagrave di contestualizzare opportunamente lopera darte la personalitagrave artistica il
movimento o la tendenza la correttezza dei dati storici indicati
(obiettivi intermedi) in aggiunta a quanto sopra indicato la capacitagrave di analizzare lopera darte in termini iconologici evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle
opere darte la capacitagrave di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalitagrave artistiche
diverse la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche(obiettivi massimi) in aggiunta a quanto sopra indicato
la capacitagrave di approfondimento personale degli argomenti trattati la capacitagrave di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di unimpostazione solamente mnemonica dellanalisi)
la capacitagrave di individuare i nodi problematici connessi allopera darte o alla tendenza artistica affrontata noncheacute la capacitagrave di superare un approccio solamente descrittivo allopera darte
Inoltre egrave oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluiditagrave espositiva
Per la valutazione verragrave utilizzata la griglia di valutazione presente nel POF
Recupero e potenziamentoQualora le verifiche diano esito negativo si procederagrave al recupero per coloro che non hanno raggiunte conoscenze minime e la restante parte verragrave impegnato in attivitagrave di potenziamento
CONTENUTI DELLA DISCIPLINAModulo 1 I BENI CULTURALIUD1 Beni Culturali ndash normativa Tematica drsquoapprofondimento I beni culturali del proprio territorioModulo 2 LE ANTICHE CIVILTArsquo DEL MEDITERRANEO
ldquoLa prime forme dellrsquoarterdquoUD1 La nascita dellrsquoarte ndash Dal Paleolitico allrsquoetagrave dei metalliUD2 Lrsquoarte per il sovrano ndash Le civiltagrave MesopotamicheUD3 Unrsquoarte conservatrice ndash LrsquoAntico EgittoUD4 Dal mar Egeo verso la Grecia ndash Le civiltagrave Cicladica Minoica e Micenea Tematica drsquoapprofondimento I Fenici - MoziaModulo 3 LrsquoARTE GRECA
ldquoNel segno del mito e della bellezzardquoUD1Dalla geometria alle forme ideali ndash lrsquoarte Greca ArcaicaUD2 Una splendida perfezione ndash Lrsquoarte Greca ClassicaUD3 Pathos realismo ed enfasioltre lrsquoEllade ndash Lrsquoarte Ellenistica Tematica drsquoapprofondimento
Segesta ndash Agrigento ndash Selinunte ndash Solunto Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in
SiciliaModulo 4 LrsquoARTE ROMANA
ldquoLrsquoimmagine del potererdquoUD1 Prima di Roma ndash Lrsquoarte Italica ed EtruscaUD2 Lo stile della repubblica ndash Lrsquoarte romama dalle origini al I secolo acUD3 Lrsquoarte degli imperatori ndash da Augusto ad Adriano (I Secolo AC ndash II Secolo DC)UD4 LrsquoImpero continua ndash Dagli Antonini a Costantino (II ndash IV Secolo DC)Tematica drsquoapprofondimento
18
Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Turismo culturale la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici in Sicilia
Modulo 5 IL PALEOCRISTIANO E LrsquoALTO MEDIEVOldquoContinuitagrave e novitagraverdquo
UD1 La sintesi e il simbolo ndash LrsquoArte dei primi cristianiUD2 Le nuove capitali dellrsquoimpero ndash Milano Ravenna CostantinopoliUD3 Da Roma allrsquoEuropa ndash Lrsquoarte di Longobardi Carolingi e OttoniModulo 6 IL ROMANICO
ldquoFra solide Torri e robuste murardquoUD1 Uno stile monumentale ndash Lrsquoarchitettura RomanicaUD2 Educare con le immagini ndash La scultura e la pittura RomanicaTematica drsquoapprofondimento itinerari in SiciliaModulo 7 IL GOTICO
ldquoLrsquoeleganza e lrsquoannuncio di una nuova umanitagraverdquoUD1 Splendenti vertiginose altezze ndash Lrsquoarchitettura goticaUD2 Volume grazia leggerezza ndash La scultura goticaUD3 Giotto e gli altri ndash La pittura italiana del XIII e XIV secoloUD4 In viaggio per le corti ndash Il gotico internazionaleTematica drsquoapprofondimentoItinerari in Sicilia ndash Basilica di S Francesco drsquoAssisi
Programmazione di francese classe 3^ F corso turistico Valderice profssa Adriana Abate
Anno scolastico 2013-2014scuola IISS L Sciascia Erice Casa Santa Trapani
Con riferimento alla programmazione del dipartimento delle lingue straniere della scuola
inerente il trienniosecondo le direttive del Quadro comune europeo per le linguela programmazione
preventiva di francese si basa sulle competenze che gli alunni devono acquisirearticolate in conoscenze
e abilitagravePertanto essa egrave la seguente
revisione di alcune funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua
Per lo studio della materia turistica e la creazione del profilo professionalizzantesi fa riferimento al testo
in adozione Carnets de voyagele franccedilais des professions touristiques Juvenilia Scuola
Modulo primo
Uniteacute 1 Le tourisme Un secteur de premier plan
En situation Arsquo lrsquooffice du tourisme
Les types de tourisme Les entreprises touristiques
Lrsquoagence de voyage19
En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

En situation Arsquo lrsquoagence de voyages
Le devis
Uniteacute 2 Les types drsquoheacutebergement
Lrsquohocirctellerie Preacutesenter un hocirctel
Un hocirctel Le travail agrave la reacuteception
En situation Arsquo la reacuteception drsquoun hocirctel Au village touristique Au camping
Uniteacute 3 Les transports
Reacuteserver un vol Les transports aeacuteriens Arsquo la gare
En situation Arsquo la billetterie
Les transports urbainsmaritimesles transports routiers
Une croisiegravere Arsquo lrsquooffice du tourisme
Modulo secondo
La communication touristique
Uniteacute 1 Les outils de la communication
La communication oraleeacutecritepar Internet
Uniteacute 2 Demander et donner des renseignements
Se renseigner Donner des renseignements
La lettre circulaire
Modulo terzo
La geacuteographie touristique
Uniteacute 1 La France physique et politique son administration
Uniteacute 2 La France touristique et ses reacutegions (cenni sulle varie regioni turistiche)
20
Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Trapani 7 dicembre 2013 Profssa Adriana Abate
Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
ldquoLeonardo Sciasciardquodi Trapani
Sezione associata Istituto Tecnico Turistico
Via XV MaggioValderice
Programma di Geografia del turismo
Anno scolastico 20132014
Classi III F-III G
Prof Alessio Lo Presti
Modulo a Il paesaggio
Elementi di cartografia
LrsquoItaliaelementi fisicieconomici e politici
Il paesaggio alpino
Il paesaggio prealpino-lacustre
Il paesaggio padano
Il paesaggio appenninico
Il paesaggio costieroinsulare
Contenuti
Elementi di cartografia
Fusi orari
21
Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Realtagrave geofisiche e geopolitiche dellrsquoItalia
Elementi caratterizzanti i diversi paesaggi italiani
Obiettivi conoscitivi
Le fondamentali caratteristiche della carta geografica
I diversi tipi di carte in relazione a riduzione in scala e tematismi
Le interazioni costanti tra uomo e natura nel paesaggio
Elementi fondamentali della realtagrave fisica e politica dellrsquoItalia
Obiettivi metodologico-operativi
Saper individuare i punti di orientamento
Saper leggere ed interpretare le diverse carte geografiche
Saper cogliere ed analizzare i diversi elementi presenti in un determinato paesaggio
Saper descrivere in modo semplice un determinato paesaggiopartendo dalla scomposizione ed individuazione degli elementi che lo compongono e delle relazioni tra essi esistenti
Saper operare confronti tra le realtagrave affrontate
Modulo b Il turismo
Storia ed evoluzione del fenomeno turistico
Turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchiaree protette di particolare valore naturale e culturale
Lrsquoitinerario
Gli strumenti per la costruzione dellrsquoitinerario
Contenuti
Definizione di turismo
Storia del fenomeno turistico
La rete dei trasporti
Il fenomeno turistico in Italia
22
Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Relazione tra turismoterritorio e sostenibilitagrave
Parchi ed aree protette
La costruzione dellrsquoitinerario
Obiettivi conoscitivi
Definizione del termine turismo
Origine e sviluppo della rete dei trasporti
Conoscere i luoghi principali del patrimonio naturale e culturale dellrsquoItalia
Importanza del turismo come fenomeno culturale ed economico
Obiettivi metodologico-operativi
Saper scegliere i mezzi di trasporto
Saper calcolare le distanze ed i tempi di percorrenza per raggiungere un determinato luogo
Saper individuare le fonti e gli strumenti adeguati relativi alla rete dei trasporti e agli orari ed alle frequenze di partenze ed arrivi
Saper individuare gli elementi di attrattiva turistica presenti in un determinato luogo
Modulo c Le forme di turismo
Turismo montanoalpino
Turismo balneare
Turismo lacustre
Turismo culturale
Turismo termale
Turismo religioso
Turismo congressuale
Turismo drsquoaffari
Turismo incentive
Turismo scolastico
Turismo della terza etagrave
Turismo di crociera e diporti stico
23
Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Agriturismo
Turismo ecologico e sportivo
Turismo eno-gastronomico
Contenuti
Varie forme di turismo
Obiettivi conoscitivi
Conoscere gli elementi fondamentali presenti nelle diverse tipologie turistiche proposte
Obiettivi metodologico-operativi
Saper costruire semplici itinerari conformi alle tipologie turistiche proposte
Saper utilizzare diverse fonti informative e materiali di vario genere per costruire gli itinerari
Modulo d I beni culturali
Contenuti
Definizione di bene culturale
I siti italiani dellrsquoUnesco
Legame tra arte e paesaggio
Beni culturalienti preposti alla gestionevalorizzazione e tutela
Obiettivi
Conoscere la definizione di bene culturale
Saper descrivere in modo adeguato un determinato luogo di particolare pregio culturale o naturale
Valderice14112013
Il docente
Alessio Lo Presti
24
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTArsquo INGLESE
CLASSE 3^F INDIRIZZO TURISTICO VALDERICE
a s 20132014
Prof ssa TARANTO GIUSEPPA RITA
Testi
SUCCESS 2 ndash Longman ( Studentrsquos book- Vocabulary builder - live book - audio CD
GLOBALEYES - Mondadori
PREMESSA
Lrsquoinsegnamento dellrsquoinglese nel secondo biennio e 5deg anno concorre insieme a tutte le altre discipline del curriculum allrsquoacquisizione delle competenze relative allrsquoambito turistico Lrsquoinsegnamento della lingua straniera pur riferendosi principalmente ad uno dei quattro assi lrsquoasse dei linguaggi trova significative intersezioni con le discipline degli altri assi e contribuisce a promuovere lrsquoacquisizione progressiva delle abilitagrave e competenze professionali
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe 3^ F egrave composta da 19 alunni 14 femmine e 5 maschi residenti a Valderice e nei paesi limitrofi Il gruppo classe risulta formato da 18 alunni provenienti dalla classe seconda e da 1 alunno ripetente della classe terza frequentata nella sede di Erice Lrsquoalunno diversamente abile
25
Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Buscemi Leonardo viene seguito dallrsquoinsegnante di sostegno La frequenza alle lezioni egrave regolare e la classe ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole Gli alunni mostrano positiva curiositagrave per i contenuti della disciplina partecipano attivamente al dialogo educativo lavorano con entusiasmo rispettano i tempi stabiliti per le verifiche e la maggior parte svolge i compiti assegnati con regolaritagrave Per un gruppo di alunni la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano piugrave che sufficienti il lessico egrave abbastanza ricco e la fluency efficace per un secondo gruppo la competenza linguistica e la conoscenza delle strutture grammaticali di base risultano sufficienti mentre un terzo gruppo di alunni presenta carenze di base ha difficoltagrave a condurre autonomamente le attivitagrave proposte ha bisogno di essere guidato e sollecitato ad un maggior impegno ed alla puntualitagrave nelle consegne
Nel primo anno del secondo biennio lrsquoinsegnamento della lingua Inglese verteragrave
al rafforzamento degli assi culturali attraverso lrsquointegrazione tra i saperi linguistici storico-sociali e tecnico-professionali ed al consolidamento delle competenze-chiave di cittadinanza
allo sviluppo della capacitagrave ad utilizzare la lingua inglese in modo integrale (listening speaking interacting reading writing) in situazioni concrete e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Considerati i descrittori di competenze e capacitagrave comunicative articolati in tre livelli generali (A B C) suggeriti dal ldquoQuadro Comune Europeo di riferimentordquo del Consiglio drsquoEuropa e viste le Linee guida (DM n 65 del 28 luglio 2010) relative alla Riforma del Secondo Ciclo del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n 87) si prevede per il secondo biennio ed il 5deg anno il raggiungimento del livello di competenza B2
Il percorso di insegnamento-apprendimento per la classe terza saragrave articolato in cinque Unitagrave che oltre a sviluppare le competenze strettamente disciplinari afferenti alla lingua straniera concorreranno a creare apprendimenti trasversali
COMPETENZE
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
Progettare documentare e presentare servizi o prodotti legati al mondo del lavoro
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONOSCENZE ABILITArsquo
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici Interagire con relativa spontaneitagrave in brevi
26
della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
Strategie compensative nellrsquointerazione orale
Strutture morfosintattiche ritmo e intonazione della frase adeguati al contesto comunicativo
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi scritti orali e multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie testuali fattori di coerenza e coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro varietagrave espressive e di registro
Tecniche drsquouso dei dizionari anche settoriali multimediali e in rete
Aspetti socioculturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni
conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale lo studio o il lavoro
Utilizzare strategie compensative nellrsquointerazione orale
Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-professionali in base alle costanti che le caratterizzano
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni intenzioni ipotesi e descrivere esperienze e processi
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi inerenti la sfera personale lrsquoattualitagrave il lavoro o il settore di indirizzo
Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note
Produrre brevi relazioni sintesi e commenti coerenti e coesi anche con lrsquoausilio di strumenti multimediali utilizzando il lessico appropriato
Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto
SUCCESS
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 1
Revisione delle piugrave importanti funzioni e strutture linguistiche studiate
27
Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Inspiration
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti diversi Comprendere i punti principali di messaggi e annunci orali e scritti su argomenti di interesse personale e quotidiano Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale eo personali Interagire in brevi conversazioni Usare in modo adeguato le strutture grammaticali
ABILITAgrave Dare e chiedere informazioni su eventi passati Leggere e comprendere testi contenenti informazioni hellip Raccontare eventi passati
CONOSCENZE Past continuous ndash Defining relative clauses Lessico Feelings and emotions
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale problem solving tutoring
Tempi circa 15
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 2
Look To The Future -ndash Love And Friendship -- New Technologies
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Chiedere e dare informazioni sulla tecnologia Parlare di probabilitagrave Produrre un volantino pubblicitario Chiedere e dare informazioni su un romanzo
28
Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Organizzare un evento ( party) Interagire in conversazioni su Internet Produrre una lettera Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE Going to and will for predictions ndash First conditional ndash maymight ndash Indefinite pronouns Present perfect ndash just already yet How long hellip for since Will for spontaneous decisions Present perfect continuous vs Present perfect ndash Question tags Lessico Technology ndashRelationships ndashPhrasal verbs - Computers
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 30 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO N 3
Health Matters ndash It Canrsquot Be True
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Ascoltare messaggi alla radio Interagire in una conversazione in merito a problemi di salute Chiedere e dare consigli Produrre una e-mail con lrsquoausilio di strumenti multimediali Comprendere dettagli di un testo relativamente complesso Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
29
CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

CONOSCENZE Second Conditional Review of modal verbs Modal verbs for deduction - present and past Lessico Sports ndash Health ndash Illnesses and remedies ndash Descriptive adjectives ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 4
Mad About Media ndash Crime Doesnrsquot Pay
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Interagire in contesti diversi Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Comprendere globalmente utilizzando appropriate strategie messaggi radio-televisivi Interagire dando opinioni su chat - site Produrre una lettera formale per una rivista Chiedere e dare informazioni su una investigazione Interagire in conversazioni Produrre un articolo di giornale Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE The passive Past perfect Articles Lessico The media ndash Newspapers ndash TV programmes ndash Crime and Criminals ndash Feelings
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 20 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo lettore cd laboratorio linguistico LIM
30
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
UNITAgrave DI APPRENDIMENTO 5
English Around The World ndash Leisure Time - The British Isles
COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi in merito agli aspetti socio ndash culturali del Regno Unito e dei paesi anglofoni
Leggere e comprendere testi nella forma scritta orale e multimediale Saper confrontare usi e costumi dei paesi anglofoni con quelli della propria cultura Produrre testi scritti di tipo funzionale eo personali Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua straniera
ABILITAgrave Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali Comprendere idee principali e specifici dettagli di un testo Interagire in conversazioni di gruppo f Produrre brevi sintesi e commenti con lrsquoausilio di strumenti multimediali Applicare consapevolmente regole grammaticali Utilizzare in autonomia i dizionari con scelta lessicale adeguata al contesto
CONOSCENZE A world language
English-speaking countries ndash Abbreviations and Acronyms ndash English past and present
Leisure time
Celebrating Festivals The British Isles
The Geography of Britain The countries of Britain ndash London People in Britain Ireland
STRATEGIE METODOLOGICHE
Metodi lezione frontale e interattiva didattica laboratoriale tutoring
Tempi circa 15 h
Attivitagrave ascolto mirato lettura guidata completamento di tabelle e griglie esercizi VF e a scelta multipla role-playing cloze tests completamento ordinamento e trasformazione di frasi e dialoghi attivitagrave di abbinamento copiati semplici traduzioni esercizi di riflessione grammaticale
Strumenti libro di testo laboratorio linguistico LIM
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove strutturate eo semi-strutturate e colloqui orali
31
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche orali e scritte formative ( prove strutturate e semistrutturate brevi sondaggi orali lavoro domestico ) e sommative (colloqui individuali prove strutturate semistrutturate e non strutturate come breve e semplice trattazione di argomenti) accompagneranno il processo di apprendimento in tutte le fasi per la valutazione di conoscenze abilitagrave e competenze Ci si avvarragrave di prove di tipo oggettivo e di prove di tipo soggettivo sempre conformi alle esercitazioni svolte durante le fasi di apprendimento Le verifiche orali saranno valutate tenendo conto di efficacia comunicativa pronuncia intonazione organizzazione del discorso accuratezza grammaticale lessico Le verifiche scritte saranno valutate tenendo conto di esecuzione del compito rispetto alla consegna organizzazione dei contenuti efficacia comunicativa correttezza morfo-sintattica ricchezza lessicale La valutazione di fine periodo terragrave conto non soltanto di quello che gli alunni ldquosannordquo ma soprattutto di quello che ldquosanno farerdquo dei risultati delle verifiche dellrsquoimpegno della partecipazione della frequenza dei progressi rispetto ai livelli di partenza senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati Per le carenze che gli alunni mostreranno durante il corso dellrsquoanno scolastico il recupero potragrave essere effettuato secondo strategie concordate in Consiglio di Classe pause didattiche recupero in itinere sportello didattico La scelta della strategia di recupero delle competenze e dei contenuti saragrave strettamente legata ai dati oggettivi sul livello di apprendimento degli alunni
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Dizionario
Realia
Documenti tratti da Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio linguistico
CDs DVDs
IL DOCENTE
Profssa Giuseppa Rita Taranto
32
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquoITT VALDERICE
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F TURISTICO
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
33
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
COMPETENZE
middot Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piugrave appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
middot Redigere relazioni tecniche e documentare le attivitagrave individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
middot Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte alla realtagrave ai suoi fenomeni ai suoi problemi anche ai fini dellrsquoapprendimento permanente
Al termine del percorso educativo gli alunni dovranno acquisire
CONOSCENZE ABILITArsquo
Lingua
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Lingua
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale
34
Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Rapporto tra lingua e letteratura
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia
Fonti dellrsquoinformazione e della documentazione
Tecniche della comunicazione
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione
Caratteri comunicativi di un testo multimediale
Letteratura
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle
origini allrsquoetagrave della Controriforma
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano lrsquoidentitagrave culturale
nazionale italiana nelle varie epoche
Significative opere letterarie artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche
Elementi di identitagrave e di diversitagrave tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi
Fonti di documentazione letteraria siti web dedicati alla letteratura
Tecniche di ricerca catalogazione e produzione multimediale di testi
e documenti letterari
Altre espressioni artistiche
Caratteri fondamentali delle arti e dellrsquoarchitettura in Italia e in
della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari artistici
scientifici e tecnologici
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici
Consultare dizionari e altre fonti informative per lrsquoapprofondimento e
la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche
professionali
Raccogliere selezionare ed utilizzare informazioni utili allrsquoattivitagrave di
ricerca di testi letterari artistici scientifici e tecnologici
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessitagrave
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio
e professionali
Letteratura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura
letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale
italiano ed internazionale dal Medioevo allrsquoUnitagrave nazionale
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli
europei nella produzione letteraria artistica
35
Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Europa dalle origini allrsquoetagrave della Controriforma
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche
scientifica e tecnologica
contemporanea
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario scientifico
tecnico storico critico ed artistico
Contestualizzare testi e opere letterarie artistiche e scientifiche di
differenti epoche e realtagrave territoriali in rapporto alla tradizione
culturale italiana e di altri popoli
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche
mettendolo in relazione alle esperienze personali
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o
di un prodotto
Altre espressioni artistiche
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti siti
archeologici istituti culturali musei significativi in particolare del
proprio territorio
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 (Storico-culturale) LA NASCITA DELLA CIVILTArsquo EUROPEA36
MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

MODULO 2 (Genere) LA POESIA DALLE ORIGINI AL TRECENTO E LA PROSA TRA XI E XIV SECOLO
MODULO 3 (Autore) DANTE ALIGHIERI E LA DIVINA COMMEDIA
MODULO 4(Autore) FRANCESCO PETRARCA
MODULO 5 (Opera) DECAMERON DI G BOCCACCIO
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 6 (Storico-culturale) UMANESIMO E RINASCIMENTO
MODULO 7 (Genere) IL POEMA CAVALLERESCO
MODULO 8 (Opera) LrsquoORLANDO FURIOSO
MODULO 9 (Autore) TORQUATO TASSO
MODULO 10 (Tema) LO STRANIERO DALLrsquoETArsquo ANTICA AL RINASCIMENTO
Scritture professionali
- La lettera formale- Il Curriculum Vitae- Il Verbale di riunione- La relazione tecnica
MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi
come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
middot contestualizzazione dellrsquoargomento
middot presentazione dellrsquoargomento
middot consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali testi e appunti37
middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

middot collegamento con argomenti giagrave noti
middot confronto sui temi discussione
middot verifica sommativa orale eo scritta
La lettura saragrave occasione di discussione e di confronto di ipotesi interpretative
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
[x] Lezione frontale [x] Lezione dialogata[] Metodo induttivo [x] Metodo deduttivo [] Metodo esperenziale []Metodo scientifico [x] Ricerca individuale eo di gruppo [] Scoperta guidata [x]Lavoro di gruppo [x] Problem solving [x] Brainstorming
9 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Dal testo al mondo Vol 1 Casa Editrice Paravia [x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
10 MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
38
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [x Temi [x] Saggi brevi [x] Articoli di giornale [x] Analisi testuale [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Scritte N 2
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 8 ore di lezione di recupero e contestualmente N 8 ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
39
11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

11 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti
Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza
middot Comprendere il significato complessivo di un testo letto
middot Esporre il contenuto del proprio vissuto o di un lavoro svolto in forma corretta e comprensibile
middot Conoscere gli elementi costitutivi del testo narrativo e del testo poetico e i principali argomenti della letteratura
middot produrre elaborati semplici su un argomento proposto
40
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE ________________ Il Docente
Scuderi Maria Stella
IISS rdquoL SCIASCIArdquo
VALDERICE ( TP )
Programmazione di Matematica
Classe 3 sez F anno scolastico 201314
41
La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

La classe egrave formata da 19 studenti 5 maschi e 14 femmine Ersquo presente un alunno diversamente abile con programmazione differenziata seguito da un docente di sostegno per 18 ore settimanale
La classe non presenta grosse difficoltagrave disciplinari e gli alunni sembrano seguire con interesse la lezione e per adesso parteciparne in modo attivo anche se il ritmo di apprendimento egrave piuttosto modesto
Nelle attivitagrave curricolari saranno utilizzati tutti i sussidi didattici a disposizione della scuola ogni occasione saragrave utile per creare nella classe unatmosfera di collaborazione fra gli alunni e fra questi e linsegnante ciograve per invogliare ogni alunno a partecipare attivamente alla vita scolastica
Il lavoro in classe potragrave essere svolto anche in gruppi non omogenei ciograve per dare responsabilitagrave chi ha una preparazione di base migliore a far capire agli altri che lasciandosi coinvolgere e partecipando attivamente potranno apprendere facilmente gli argomenti proposti
PRIMA FASE analisi della situazione di partenza
Si egrave proceduto alla somministrazione di test e a dei colloqui per verificare il livello di preparazione ed egrave emerso che un piccolo gruppo non ha le basi per poter fare un percorso formativo accettabile
SECONDA FASE formulazione degli obiettivi
Linsegnamento della matematica nel triennio dellistituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico amplia quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che egrave iniziato al biennio in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline esso contribuisce alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica
Lo studio della matematica infatti promuove
a) Il consolidamento dei possesso delle piugrave significative costruzioni concettuali
b) Lesercizio ad interpretare descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
42
c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

c) Labitudine a studiare ogni questione attraverso lesame dei suoi fattori
d) Lattitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto ed appreso
In particolare gli obiettivi disciplinari per la classe terza saranno
a) Consolidare le conoscenze in precedenza acquisite
b) Conoscere i linguaggi e i metodi specifici dellanalisi matematica
c) Potenziare le capacitagrave di apprendimento di astrazione e di rielaborazione personale sia come processi induttivi che deduttivi
d) Applicare consapevolmente le tecniche e le procedure apprese
TERZA FASE indicazione sintetica dei contenuti disciplinari per quadrimestre
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
CLASSE TERZA
COMPETENZE ABILITAgrave (ESSENZIALI) CONOSCENZE (CONTENUTI)
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune
Riconoscere lrsquoequazione di una retta sia in forma esplicita sia implicita
Riconoscere rette parallele e perpendicolari
LA RETTA
Richiami sulla rappresentazione di punti nel piano
Equazione della retta
Perpendicolaritagrave e parallelismo
Problemi sulla retta
Saper determinare lrsquoequazione di una parabola Essere in grado di interpretare e manipolare i coefficienti
che figurano nellrsquoequazione di una parabola allo scopo di individuarne le caratteristiche e la posizione nel piano
Saper individuare le intersezioni di una parabola con gli assi Riconoscere lrsquoequazione della circonferenza nelle sue
tipologie piugrave importanti
LE CONICHE
Generalitagrave sulle coniche
La parabola
La circonferenza
Riconoscere una funzione esponenziale e rappresentarla graficamente
Risolvere equazioni esponenziali
FUNZIONI ED EQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Potenza nel campo reale
Funzioni esponenziali
43
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio ricerca e approfondimento disciplinare
Analizzare confrontare sviluppare e risolvere problematiche che riguardano lrsquointeresse semplice e composto
Saper definire la natura del tasso drsquointeresse nelle sue possibili configurazioni
REGIMI FINANZIARI
Generalitagrave sulle operazioni finanziarie
Regime finanziario dellrsquointeresse semplice
Regime finanziario dellrsquointeresse composto
Tassi equivalenti
Problemi sulle operazioni finanziarie
Saper valutare un capitale o una rendita a una data epoca Analizzare confrontare sviluppare e risolvere
problematiche finanziarie nelle quali intervengono rendite annue e frazionate
RENDITE
Generalitagrave sulle rendite
Montante e valore attuale di rendite temporanee di rata costante
Cenno su altri tipi di rendite
STRUMENTI E MODALITArsquo PER LE VALUTAZIONI
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Ai fini della valutazione diagnostica si terragrave conto
per lrsquoaspetto COGNITIVO
possesso dei prerequisiti capacitagrave di apprendimento comprensione ed uso del linguaggio specifico
per lrsquoaspetto FORMATIVO
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo metodo di lavoro orientamento inteso come consapevolezza di seacute dei propri limiti delle proprie capacitagrave-
fiducia in se stesso autovalutazioneSTRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni Registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede il
coinvolgimento attivo dellrsquoalunno Assegnazione e correzione di specifiche esercitazioni individuali chiarendo gli obiettivi
(compiti tradizionali dalla cui attenta osservazione si possono rilevare eventuali difficoltagrave e
44
conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

conseguentemente organizzare unrsquoimmediata azione di recupero mediante lrsquoaggiunta di compiti differenziati)
Discussione ed eventuale approfondimento di esercizi od argomenti proposti dagli allievi Osservazione sulla corrispondenza tra voti assegnati e livelli raggiunti Corsi IDEI
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Verifiche sommative scritte quadrimestrali (minimo tre) prove strutturate semistrutturate test a scelta multipla esercizi e problemi a risposta aperta
Verifiche sommative orali (minimo tre anche frutto di piugrave interventi documentati)CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
VALUTAZIONE
La valutazione va considerata un processo da cui trarre indicazioni sul percorso di crescita dello studente (valutazione formativa) In questrsquoottica essa saragrave improntata al principio della massima trasparenza e si avragrave cura di stabilire quel clima di fiducia necessario tra gli interlocutori del processo valutativo in modo che lo studente si possa consapevolmente riconoscere nel giudizio del docente
Il tradizionale voto numerico verragrave integrato e convalidato da tutti quegli strumenti (griglie valutative giudizi schede ecc) che possano renderlo leggibile trasparente e pienamente condivisibile In particolare la valutazione delle prove scritte saragrave accompagnata da un attento lavoro che coinvolgeragrave lo studente con lrsquoausilio di griglie che possano guidarlo nello sviluppo della consapevolezza dellrsquoerrore e nella capacitagrave della sua valorizzazione per lrsquoauto-correzione
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Saranno utilizzati i seguenti strumenti in relazione alla prova in analisi
middot Griglia di valutazione INDICATORIPUNTEGGIO per le prove scritte strutturate e non appresso indicata
Se lesercizio item egrave
esatto punti 3
incompleto o con qualche imperfezione punti 2
con errori diffusi ma non gravi punti 1
con errori diffusi e gravi oppure omesso punti 0
Il punteggio di un esercizio Pc si ottiene moltiplicando i punti (3 2 1 0) ottenuti in quellesercizio per il peso p dello stesso esercizio
Il punteggio totale conseguito Pc egrave dato dalla somma dei singoli punteggi
Il voto (V) intero su un massimo di dieci egrave dato da
45
1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

1 piugrave 9 che moltiplica il Punteggio conseguito (Pc) diviso il Punteggio massimo ottenibile (Pmax)
Il giudizio sintetico saragrave espresso in ottimo buono sufficiente lacunoso e carente
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE
Impegno attenzione motivazione allo studio Partecipazione Interventi pertinenti Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale ed i
progressi raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa Puntualitagrave e precisione nel rispetto delle consegne e nellrsquoesecuzione dei compiti domestici Capacitagrave di approfondimento e di rielaborazione anche a livello interdisciplinare
METODOLOGIE DIDATTICHE ndash CRITERI
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale Lezione interattiva intesa come dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (didattica
della matematica per problemi) Esercizi applicativi guidati Esercizi applicativi individuali e di gruppo Attivitagrave di recupero mediante pause didattiche eo corsi IDEI Attivitagrave di approfondimento Attivitagrave di laboratorio informatico Utilizzo delle TIC (Tecnologie dellrsquoInformazione e della
Comunicazione) e delle TD (Tecnologie Didattiche)CRITERI METODOLOGICI
Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere lrsquointeresse la partecipazione costruttiva e quindi lrsquoassimilazione con minor sforzo dei vari argomenti
Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi volti a rafforzare lrsquoacquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli la capacitagrave di scegliere i procedimenti piugrave adatti la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite noncheacute da numerosi esempi e controesempi (nellrsquointroduzione dei nuovi concetti) che ne rafforzino la comprensione mettano in luce i casi particolari e ne diano ove possibile una visualizzazione grafica
MODALITArsquo DI RECUPERO EO APPROFONDIMENTO
RECUPERORipresa dei contenuti non assimilati alternata allrsquoesecuzione in classe di esercizi guidati (realizzata sia con pause didattiche sia con corsi IDEI)
APPROFONDIMENTOSvolgimento individuale di esercizi e problemi che richiedono una particolare capacitagrave di rielaborazione personale (sviluppo delle capacitagrave di analisi e sintesi)
46
Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Valderice 30112013 LrsquoINSEGNANTE
IISS ldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ERICE
AS 201314 CLASSE 3ordf ERICE -VALDERICE-MATERIA RELIGIONE CATTOLICA-
Docente prof Alastra Caterina
1 modulo 2 modulo
TITOLO Il mondo paese globale Il popolo di Dio la Chiesa Le principali confessioni cristiane e il dialogo ecumenico
ObiettiviLrsquoadolescente sappia riconoscere nellrsquoaltro pari dignitagrave
Lrsquoadolescente sappia orientarsi negli elementi principali della vita della Chiesa per prendere coscienza del ruolo spirituale e sociale di essa nei secoli
Lrsquoadolescente sappia conoscere la storia e i tratti caratteristici delle principali confessioni cristiane e valutare lrsquoimportanza del dialogo ecumenico
Contenuto La dichiarazione universale dei diritti dellrsquouomo e la Genesi
La nascita della Chiesa la vita delle prime comunitagrave cristiane lrsquoannuncio del Vangelo la storia del cristianesimo delle origini il catecumenato e la penitenza i Concili e la professione di fede il Concilio Ecumenico Vaticano II Chiesa come comunitagrave la Chiesa che celebra lavoro festa i Sacramenti la testimonianza i testimoni la Chiesa Madre Maria Madre della Chiesa Chiese e architetture
Percheacute siano una cosa sola i fratelli cristiani ortodossi i fratelli cristiani protestanti lrsquoecumenismo
Competenze (saper essere)Lrsquoalunno saragrave in grado di
Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
Confrontarsicorr
nellrsquoesperie
Tempi di svolgimento Ottobre - Novembre Dicembre - Gennaio - Febbraio Marzo - Aprile - Maggio
Criteri di valutazioneNote Strumenti di valutazione
Metodologia didattica e strumenti
a) Conoscenza degli argomenti b) capacitagrave di analisi e sintesi c)
Gli alunni con disabilitagrave seguiranno la stessa
Verifica tradizionale questionari interventi interesse e partecipazione al dialogo educativo
Lezione frontale metodo induttivo e deduttivo libro di testo riviste
47
capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

capacitagrave di rielaborazione personale
programmazione per obiettivi minimi
documenti sacri e profani audiovisivi
Si ovvieragrave alla mancanza drsquointeresse drsquoimpegno e alla scarsa partecipazione al dialogo scolastico per mezzo di visione di filmati e ricerche interattive
Lrsquoinsegnante aderiragrave ai progetti o alle attivitagrave promossi dalla Diocesi che si possa ritenere abbiano una ricaduta positiva sui discenti
Il docente prof Alastra Caterina
Istituto Tecnico Economico
ldquoL Sciasciardquo PIANO DI LAVORO
INDIVIDUALEValderice
AS 2013-2014
DISCIPLINA
Lingua e civiltagrave Spagnola48
LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

LIBRO DI TESTO
C Polettini JP Navarro
Adelante 1 - Zanichelli
DOCENTE
Giacomazzi Angela
Classe III Sezione F
Indirizzo
Turismo
49
- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

- Situazione di partenza della classe
Numero alunni Tipologia della classe Livello cognitivo globale di ingresso
vivace ottimo
tranquilla buono
collaborativa accettabile
passiva scarso
M F Totale Rip problematica
5 14 19 1
- Analisi dei prerequisiti
La classe affronta per la prima volta lo studio della lingua spagnola Requisiti necessari per lapprendimento di una nuova lingua sono la conoscenza delle funzioni e delle strutture morfosintattiche e fonetiche della lingua italiana
- Definizione degli obiettivi
Obiettivi educativo-cognitivi generali
Si fa riferimento alla programmazione del Consiglio di Classe
In relazione alla programmazione curricolare si prevede il conseguimento dei seguenti Obiettivi cognitivi disciplinari in termini di
CONOSCENZE
Aspetti comunicativi socio-linguistici e paralinguistici dellrsquointerazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori
50
Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Strutture grammaticali di base della lingua sistema fonologico ritmo e intonazione della frase ortografia e punteggiatura
Strategie per la comprensione del senso generale e di informazioni specifiche e prevedibili di testi e messaggi semplici e chiari scritti orali e multimediali su argomenti noti inerenti lrsquoesperienza personale
Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Tecniche drsquouso dei dizionari anche multimediali Strutture morfosintattiche di base adeguate alla produzione di testi semplici e brevi scritti e orali riferiti ad
eventi ed esperienze personali Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua
ABILITA
Scambiare informazioni di routine e su argomenti di interesse personale quotidiano o di studio usando strategie compensative
Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in messaggi chiari brevi scritti e orali relativi ad argomenti noti e di immediato interesse personale e quotidiano
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativo ad attivitagrave ordinarie di studio e lavoro Produrre testi brevi e semplici scritti e orali su esperienze personali e situazioni di vita quotidiana Distinguere e utilizzare gli elementi strutturali della lingua in testi comunicativi scritti orali e multimediali Utilizzare i dizionari monolingui e bilingui compresi quelli multimediali
COMPETENZE IN USCITA (corrispondenti al livello B1 del QCER)
progettare documentare e presentare servizi o prodotti turistici utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche
CONTENUTI
51
Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Unidad 1 Presentarse y presentar a alguien Settembre- Ottobre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Saludar y despedirse Geacutenero y nuacutemero de los nombres y Saludos y despedidas
Presentar y presentarse adjetivos Presentaciones
Deletrear palabras Pronombres personales sujeto Paiacuteses y nacionalidades
Decir el nombre y la nacionalidad Verbos Ser y LLamarse Las profesiones
Preguntar y pedir algo al profesor Uso del artiacuteculo Nuacutemeros de 0 a 15
Contar hasta 15 Presente de indicativo de los verbos Apellidos
Hablar de profesiones regulares
Rellenar fichas Verbos reflexivos
El alfabeto
Cultura y Civilizacioacuten
El espantildeol en el mundo
Funcionamiento de los nombres y apellidos espantildeoles
Unidad 2 Orientarse en el espacio Novembre
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Preguntar e indicar doacutende estaacuten situadas las Verbos Estar Dar y Tener La casa
cosas Los ubicadores Diacuteas de la semana
Preguntar y decir la direccioacuten Hay y Estaacuteaacuten Meses del antildeo
Expresar existencia Ser y Estar El aula
Describir la casa Presente de indicativo de algunos Nuacutemeros de 16 a 100
Describir el instituto verbos irregulares Nuacutemeros ordinales
Contar hasta 100 Contracciones al y del Asignaturas
52
Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Cultura y Civilizacioacuten
El sistema educativo en Espantildea
Tierras de Espantildea
Unidad 3 Describirse y describir a personas Dicembre - Gennaio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir a personas Verbos gustar y encantar Los colores
Expresar gustos Los demostrativos Vida diaria
Hablar de la familia Los posesivos Parentesco
Expresar coincidencia Preposiciones a y en Adjetivos para expresar el
Expresar posesioacuten Muy y Mucho caraacutecter y la personalidad
Identificar El que El de
Hablar de las Navidades Tambieacuten tampoco
Cultura y Civilizacioacuten
La familia real espantildeola
La familia espantildeola actual
Las Navidades en Espantildea
53
Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Unidad 4 Invitar y proponer Febbraio
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Describir acciones en desarrollo Dea desde hasta La hora
Invitar y proponer Estar + gerundio Partes del diacutea
Aceptar una invitacioacuten o rechazarla Presente de los verbos con Expresiones de frecuencia
Preguntar y decir la hora diptongacioacuten
Concertar una cita Presente de los verbos con
Felicitar alternancia vocaacutelica
Agradecer y responder al agradecimiento Ir venir
Hablar de acciones habituales El acento
Expresar frecuencia
Cultura y Civilizacioacuten
Los jόvenes y el tiempo libre
Los Carnavales en Espantildea
Unidad 5 Hablar de la salud Marzo - Aprile
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Hablar del estado de salud Verbos impersonales Trabalenguas
Expresar dolor Preteacuterito perfecto Enfermedades y
Hablar del pasado reciente Participios irregulares medicamentos
Expresar obligacioacuten o necesidad Pronombres complemento directo e El cuerpo humano
Preguntar la causa y justificarse indirecto
Yatodaviacutea no + preteacuterito perfecto
Tener que + infinitivo
Hay que + infinitivo
54
Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Verbos pronominales
Doler y Hacer dantildeo
Cultura y Civilizacioacuten
Fiestas y tradiciones espantildeolas
Unidad 6 Contar algo del pasado Maggio - Giugno
Comunicacioacuten Gramaacutetica Leacutexico
Pedir algo en un bar o en un restaurante Los comparativos Los alimentos
Pedir consejo y recomendar Los superlativos Los platos y los cubiertos
Describir en el pasado El imperfecto
Hablar de acciones habituales en el pasado
Hacer comparaciones
Cultura y Civilizacioacuten
El tapeo
Gastronomiacutea en Espantildea
METODI
Le lezioni saranno prevalentemente di tipo interattivo favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli studenti e fra gli studenti stessi Per questo fine saranno organizzate se la classe risponderagrave in maniera adeguata attivitagrave a coppie e in piccolo gruppo cooperativo che simulino in lingua spagnola una situazione di normale vita quotidiana (scolastica familiare ) Si cercheragrave di stimolare lrsquointeresse degli alunni guidandoli allrsquoosservazione e alla riflessione Per favorire il dialogo educativo e lrsquoapprendimento attivo ciascuno saragrave protagonista del processo formativo Nelleventualitagrave si rendessero necessarie attivitagrave di recupero le stesse saranno realizzate nei modi e nei tempi della pausa didattica o in altre forme secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Classe I contenuti di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltagrave incontrate dagli allievi e saranno finalizzati allrsquoacquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva scritta eo orale
55
STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

STRUMENTI
Libri di testo materiale audio visivo e multimediale riviste specializzate fotocopie televisione personal computer LIM e Internet
MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si svolgeranno verifiche scritte e orali per monitorare progressi e individuare punti di forza e di debolezza dellrsquoapprendimento degli allievi La frequenza con cui saranno sottoposte le prove varieragrave a seconda delle particolari situazioni ed esigenze del gruppo classe Gli strumenti da utilizzare saranno quelli con cui gli allievi hanno raggiunto familiaritagrave in fase di insegnamento test esercizi di completamento e di trasformazione conversazioni comprensione di un testo tramite domande VF a scelta multipla a risposta apertahellip I criteri di valutazione verranno espressi in modo chiaro ed univoco al fine di attivare negli alunni un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il rendimento La valutazione finale effettuata secondo i criteri definiti nel POF terragrave conto dei risultati delle prove orali e scritte della partecipazione dellrsquoalunno allrsquoattivitagrave didattica dellrsquoimpegno della costanza nello studio noncheacute dei progressi nel processo di apprendimento
Erice 3 dicembre 2013
LA DOCENTE
Angela Giacomazzi
ISTITUTO DrsquoISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREldquoLEONARDO SCIASCIArdquo
ITT VALDERICE56
PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

PROGRAMMAZIONE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Docente Prof ssa Scuderi Maria Stella
Classe III F Turistico
ATTIVITAgrave DI ACCOGLIENZA
[X]Lettura ed illustrazione del POFe del Regolamento drsquoIstituto
[X]Conoscenza delle strutture delle attrezzature e dei servizi della scuola
[X]Presentazione dei libri di testo
[X]Attivitagrave finalizzate a favorire lintegrazione degli studenti nel gruppo classe
[X]Test drsquoingresso
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
[X] Prove oggettive di valutazione (test questionari etc)
[X] Prove soggettive di valutazione (temi relazioni interrogazioni etc)
[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attivitagrave didattiche
[X]colloqui con gli alunni
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI [SI] n 1
57
COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

COMPETENZE
middotCorrelare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
middotRiconoscere gli aspetti geografici ecologici territoriali dellrsquoambiente naturale ed antropico le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
CONOSCENZE ABILITArsquo
Principali persistenze e processi di trasformazione dal Mille alla metagrave del Seicento in Italia in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici con
riferimenti agli aspetti demografici sociali e culturali
Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico
Innovazioni scientifiche e tecnologiche fattori e contesti di
riferimento
Territorio come fonte storica tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale culturale e artistico
Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale
Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuitagrave
Riconoscere la varietagrave e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali demografiche sociali e culturali
Individuare i cambiamenti culturali socio-economici e politicoistituzionali
(es in rapporto a rivoluzioni e riforme)
Analizzare correnti di pensiero contesti fattori e strumenti che
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
Individuare lrsquoevoluzione sociale culturale ed ambientale del territorio
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla
58
trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

trasformazione (es riforme e rivoluzioni)
Lessico delle scienze storico-sociali
Categorie e metodi della ricerca storica (es analisi di fonti
modelli interpretativi periodizzazione)
Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es vari
tipi di fonti carte geo-storiche e tematiche mappe statistiche
e grafici manuali testi divulgativi multimediali siti Web )
storia generale
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali
Utilizzare ed applicare categorie metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive multimediali e
siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche
SVILUPPO MODULARE DEI CONTENUTI
Il piano di lavoro egrave articolato nei seguenti moduli
PRIMO QUADRIMESTRE
MODULO 1 LrsquoEuropa feudale e la rinascita economica dellrsquoOccidente
MODULO 2 Cristianesimo e Islam
MODULO 3Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo
MODULO 4 La crisi del Trecento
59
SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

SECONDO QUADRIMESTRE
MODULO 5 La Civiltagrave Rinascimentale
MODULO 6 Lrsquoespansione dellrsquoOccidente
MODULO 7 La Riforma protestante e la Controriforma
MODULO 8 Carlo V e la fine della libertagrave italiana
MODULO 9 Il Seicento la dominazione spagnola in Italia e la cultura seicentesca
METODO DI LAVORO
Il programma saragrave svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe ponendosi come obiettivo primario il raggiungimento degli obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti
La struttura modulare del programma prevede per ogni modulo il seguente percorso
contestualizzazione dellrsquoargomento presentazione dellrsquoargomento consultazione del libro di testo eo della dispensa e di altri eventuali appunti visione di filmati-documenti di carattere storico collegamento con argomenti giagrave noti confronto e discussione su problemi eventualmente emersi verifica sommativa orale
Il programma viene svolto in classe i compiti assegnati per casa sono finalizzati a consolidare le conoscenze
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
[x] Libroi di testo Titolo Millennium Vol 1 Casa Editrice La Scuola
[x] Laboratori [x ] Computer
[ x] LIM [] Lavagna luminosa [] Audioregistratore [] Diaproiettore []
[x]Sussidi multimediali [] Fotoriproduttore [x] Testi di consultazione
60
MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

MODALITA DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Le verifiche orali vogliono accertare
comprensione delle informazioni acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione organizzazione logica delle informazioni uso corretto del ldquocodice linguardquo
Assieme alle verifiche orali viene proposto alla fine di ogni modulo un test per valutare conoscenze competenze abilitagrave in relazione allrsquoargomento trattato tale test potragrave contenere
questionari a risposta chiusa tipo scelte multiple schemi e testi da completare questionari a risposta aperta
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
[X] Test [X] Questionari [x] Relazioni [X] Interrogazioni [X]Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione impegno metodo di studio e di lavoro etc)
Numero Verifiche previste per il quadrimestre
Orali N 2
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Si prevede di svolgere in orario curriculare nel periodo febbraiomaggio N 4 ore di lezione di recupero e contestualmente N_______ ore di lezione di approfondimento
Si prevede di svolgere in orario extracurriculare N ______ ore di lezione di recupero nel periodo ____________ e N ___ ore di approfondimento con un limitato numero di alunni della classe nel periodo ______________
61
MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

MODALITAgrave DI RECUPERO MODALITAgrave DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero in coerenza con il POF si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche
[x] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata
[x] Attivitagrave guidate a crescente livello di difficoltagrave
[x] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro
Per le ore di approfondimento invece le seguenti
[x] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
[x] Impulso allo spirito critico e alla creativitagrave
[x] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
Attivitagrave previste per la valorizzazione delle eccellenze
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche puntuali e frequenti saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni percorso
didattico allo scopo di controllare il processo di apprendimento attraverso colloqui risoluzione di
esercizi prove scritte in classe prove pratiche di laboratorio Le verifiche si baseranno
sullrsquoosservazione assidua dei comportamenti dei discenti e sulla continua analisi dei risultati le
prove saranno strutturate e somministrate tenendo conto delle voci della scheda di valutazione
La valutazione formativa serviragrave a dare indicazioni sia sulla validitagrave del lavoro svolto sia sulla
direzione del lavoro da svolgere La valutazione sommativa evidenzieragrave il raggiungimento o meno
degli obiettivi globali preventivi e consisteragrave nella misura delle conoscenze delle capacitagrave delle
abilitagrave e dei comportamenti Esprimeragrave inoltre un giudizio che terragrave conto anche dei livelli di
partenza degli interessi della presenza in classe delle capacitagrave di partecipazione attiva e della
professionalitagrave acquisita Nellrsquoattribuzione dei voti si faragrave riferimento alla tassonomia stabilita
dal POF e alle griglie proposte dai Dipartimenti62
Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Obiettivi minimi1 Conoscere gli aspetti significativi degli eventi storici2 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati3 Ascoltare e leggere cogliendo i concetti essenziali di una comunicazione4 Saper esprimere il proprio pensiero in modo chiaro
5 Saper consultare i testi specialistici (vocabolario atlante enciclopedia)
6 Esporre in modo chiaro i nuclei portanti dei temi trattati
12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
[x] Ora settimanale di ricevimento
[x]Comunicazioni eo convocazioni in casi particolari (debiti formativi scarso impegno assenze ingiustificate ritardi frequenti comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare etc)
[x] Incontri collegiali scuola ndash famiglia n 2
VALDERICE
Il Docente
MARIA STELLA SCUDERI
63
ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

ANNO SCOLASTICO
2013-2014
CLASSE 3
SEZIONE F-G
DISCIPLINA TECNICA TURISTICA
DOCENTE CAMPANELLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA CLASSE TERZA
Il programma della classe terza si presenta ampio e articolato e risulta quindi impegnativo per gli allievi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e al mondo del turismo in generale
Egrave quindi utile in accordo con gli altri docenti di materia puntare a64
bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

bull svolgere in modo approfondito i contenuti tipici del programma di terza che non saranno oggetto di ulteriore sviluppo negli anni successivi (come per esempio il fenomeno turistico le agenzie di viaggi i trasporti la redazione di preventivi)
bull svolgere in modo essenziale gli argomenti che verranno trattati in modo piugrave dettagliato e pertinente
bull dare spazio alle attivitagrave tipiche svolte dalle agenzie di viaggi con ricorso a una didattica che parta da situazioni reali utilizzando tariffari orari dei mezzi di trasporto cataloghi e documenti tipici su supporti informatici in modo da facilitare lrsquoapprendimento e sostenere la motivazione degli studenti
Dal punto di vista metodologico si ritiene che non si possa dare delle indicazioni precise relativamente ai singoli moduli percheacute in questo caso occorre tener conto del contesto delle esigenze dei singoli studenti cioegrave della loro diversitagrave in termini di stile cognitivo di stile di apprendimento di condizioni di sviluppo di personalitagrave di capacitagrave intellettive Il docente dovragrave quindi sperimentare metodologie differenti (affiancare alla classica lezione frontale la lezione dialogica i lavori di gruppo lrsquoanalisi di casi il role playing il learning by doing il laboratorio professionale la simulazione ecc) avvalendosi anche delle nuove tecnologie in quanto funzionali alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamento-apprendimento Occorre osservare che per quanti insegnano in un Istituto Tecnico la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie egrave un tema di scottante attualitagrave percheacute ogni giorno ci si trova a fare i conti con importanti cambiamenti che caratterizzano e condizionano lrsquoagire educativo
bull il fatto che gli studenti dedicano sempre meno tempo allo studio a casa
bull una sempre piugrave diffusa demotivazione allo studio e la scarsa efficacia di metodologie tradizionali a stimolare lrsquoapprendimento
bull il cambiamento nella struttura cognitiva degli allievi che non apprendono piugrave solo in modo sequenziale ma sempre piugrave spesso in modo simultaneo
Il nostro ruolo di insegnante quindi si trasforma lentamente da semplice trasmettitore di nozioni a guida dei processi di conoscenza degli allievi e ci obbliga a una continua riflessione sul nostro agire educativo per sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale e intellettuale allrsquoapprendimento continuo e la capacitagrave di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e consapevole
Di seguito si propone il piano di lavoro per la terza classe con lrsquoindicazione delle ore necessarie per lo svolgimento del singolo modulo
MODULO 1
Aspetto storico psicologico e sociologico del turismoDurata 37 ore
Obiettivi
65
bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

bull Comprendere il fenomeno turistico le sue caratteristiche e la sua natura eterogenea e multidisciplinare
bull Conoscere gli elementi essenziali che hanno caratterizzato lrsquoevoluzione del turismo
bull Individuare le principali tendenze del turismo contemporaneo
bull Conoscere i modelli di comportamento del turista
bull Acquisire consapevolezza degli effetti positivi e negativi che il turismo determina dal punto di vista economico socio-culturale e ambientale
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Il turismo e viaggio
Il turismo come realtagrave e come oggetto di studio
Il viaggio
UD 2 Turismo e tecnica
Concetto di turismo
Componenti basilari
Dalle componenti basilari al pacchetto turistico
Le risorse naturali per il turismo
Le risorse culturali per il turismo
Attivita produttive e turismo daffari
Vie di comunicazione e mezzi di trasporto
La ricettivita
Servizi turistici di accoglienza e di accesso
Impiantistica
Strutture per il tempo libero
Levoluzione del turismo contemporaneo
La funzione tecnica turistica
Classificazione tipologica del turismo
UD 3 Elementi di sociologia del turismo
La sociologia
66
Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Sociologia del turismo
La persona sociale
Modelli di comportamento
Turismo e Status sociale
Modelli di turista
Le aggregazioni i gruppi
Il processo di istituzionalizzazione
Il turismo fenomeno sociale e culturale
UD 4 Motivazioni ed elementi di psicologia del turismo
Psicologia e turismo
I suoi stati danimo
Motivazioni sul fare turismo
Percezione da parte del turista di ciograve che gli viene offerto
UD 5 Laspetto sociale del turismo
Significato del termine
Modalita di intervento
Enti promotori e organizzatori del turismo socisle
Turismo sociale e di massa
Allargamento del concetto di turismo sociale
Il turismo e i giovani
Turismo della terza etagrave
UD 7 Il marketing turistico
Le ricerche di marketing
La segmentazione del mercato e il posizionamento del prodotto
Il marketing-mix
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in
laboratorio
67
Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Collegamenti con altre discipline Storia Matematica Italiano Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio trattamento testi
MODULO 2
Il mercato e laspetto tecnico del turismoDurata 65 ore
Obiettivi
conoscenze
bull la funzione produttiva e culturale del turismo
bull la peculiaritagrave del mercato turistico
bull la classificazione dei servizi turistici
bull i documenti del turista
bull il marketing
Abilitagrave
bull Organizzare servizi turistici
bull Progettare itinerari turistici- culturali
Contenuti ndash Argomenti
UD 1 Consistenza funzioni e tendenze evolutive del turismo
Rapporto del turismo
Il Word economic forum
il turismo mondiale
Il turismo degli italiani
Il tempo libero e turismo
La funzione produttiva
Interdipendenze con lindustria artigianato e commercio
Rapporti con i trasporti e lindustria ricettiva
Rapporti turismo - agricoltura
UD 2 Ruolo del turismo nelleconomia ed il mercato turistico
generalitagrave e terminologia68
la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

la filiera turistica ed il soddisfacimento dei bisogni
i bisogni turistici
beni e servizi turistici
il mercato turistico
marketing
UD 3 Aspetto tecnico del turismo
generalitagrave e terminologia
consorzi dellincoming internazionali
le scelte turistiche degli italiani
classificazione ed analisi dei servizi turistici
i prodotti turistici
il contratto di viaggio
i pacchetti long weekend
UD 4 Mezzi di pagamento e documenti del turista
deregulation e norme doganali
mezzi di pagamento allestero
il cambio e servizi valutari
le coperture assicurative specializzate
i documenti del turista
classificazione dei paesi in base ai documenti richiesti per lentrata e per il soggiorno
La mappa del livello di rischio
UD 5 I percorsi turistico- culturali
generalitagrave
turismi minori
cittagrave darte
ciclo di vita di una destinazione turistica
progettazione di un itinerario turistico
Prove di verifica
Prove strutturate interrogazioni esercizi da svolgere in laboratorio69
Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Collegamenti con altre discipline Storia dellrsquoarte Geografia Legislazione turistica Lingue straniere Laboratorio Trattamento testi
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione si renderanno immediatamente noti agli alunni i criteri per lrsquoattribuzione dei voti Mentre la valutazione di fine quadrimestre terragrave conto del processo di apprendimento e di maturazione dellrsquoalunno in base ai seguenti elementi
- gli apprendimenti e le competenze- lrsquoacquisizione e lrsquouso dei metodi e linguaggi specifici della disciplina- lo sviluppo personale della formazione personale di ogni alunno (motivazione impegno autonomia
interazione con i compagni e gli insegnanti partecipazione al dialogo educativo) noncheacute progressione rispetto ai livelli di partenza
- I saperi minimi stabiliti nelle riunioni dipartimentaliPer quanto riguarda la corrispondenza tra i voti e i livelli si rinvia a quanto stabilito dal collegio docenti e inserito nel POF
ISTITUO TECNICO COMMERCIALE
ldquoL SCIASCIA rdquo ndash VALDERICE
PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2013 2014
DISCIPLINADISCIPLINE GIURIDICHE
CLASSE E SEZIONEIII F
DOCENTEPROF Giovanni Messina
70
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZALa classe risulta composta da 20 alunni
Il gruppo classe si presenta eterogeneo alcuni alunni si mostrano abbastanza spigliati e si inseriscono nel dialogo educativo senza particolari problemi e con sufficienti capacitagrave espressive
Altri un numero ridotto sono poco abituati ad esporre con chiarezza i contenuti anche di argomenti semplici Non si riscontrano problemi disciplinari o di condotte non consone Tutti gli alunni sono rispettosi e seguono con assiduitagrave le lezioni sebbene alcuni di essi con scarso profitto
Dai primi approcci si registrano in alcuni alunni carenze lessicali di sintesi
Lrsquoimpegno di eseguire i compiti assegnati viene quasi sempre rispettato e ciograve facilita non poco lrsquoapprendimento dei vari argomenti
Prerequisiti
gli alunni dovranno
- imparare ad utilizzare un appropriato linguaggio tecnico - giuridico semplice
-sviluppare la capacitagrave di comprensione ed analisi degli argomenti
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVIObiettivi educativi (comuni a tutte le discipline)
Nellrsquoambito degli obiettivi educativi comuni a tutte le discipline il docente dovragrave
1) contribuire allrsquoulteriore formazione dellrsquoalunno stimolandone la capacitagrave critica2) motivare gli alunni a vedere la scuola come centro di cultura e di accoglienza dove sia possibile
mettere in luce le proprie attitudini ed abilitagrave senza timore di sbagliare3) fornire le strategie di studio necessarie per rendere lrsquoapprendimento piugrave efficace4) migliorare le abilitagrave di comunicazione5) favorire attivitagrave mirate a trasformare in modo positivosituazioni di disagio e di emarginazione6) favorire le relazioni ed il dialogo interpersonale docente-discente e tra discenti stessi7) educare al rispetto delle norme comuni che regolano i comportamenti allrsquointerno della societagrave e
della struttura scolastica8) sviluppare nello studente la motivazione allo studio e favorirne il processo di apprendimento con
lrsquoutilizzo di metodologie comunicative efficaci adatte allrsquoetagrave e alla realtagrave sociale in cui egli vive9) Contribuire a sviluppare ulteriormente una coscienza etico-morale rispettosa delle leggi e dei
regolamenti attenta alla difesa degli equilibri ambientali
Obiettivi didattici (in termini di conoscenze competenze e capacitagrave)
71
CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

CONOSCENZE
lrsquoalunno dovragrave
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana
-dovragrave padroneggiare gli argomenti giuridici affrontati
-dovragrave sapersi destreggiare tra i vari soggetti economici
COMPETENZE
Lrsquoalunno dovragrave
- imparare a ricercare nel vissuto della quotidianitagrave le questioni trattate che costituiscono argomenti di studio
-sviluppare la propria memoria fotografica attraverso lrsquoausilio delle mappe concettuali elaborate dal docente prima e da lui stesso successivamente
CAPACITArsquo
Lrsquoalunno dovragrave
-saper cogliere le relazioni fondamentali tra lrsquoastratto principio normativo e la realtagrave vissuta
-saper analizzare gli istituti ed affrontarli in chiave problematica
-saper utilizzare il linguaggio tecnico-giuridico pur nella sua essenzialitagrave
METODOLOGIEPer il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici della disciplina saragrave privilegiata lrsquoosservazione diretta dei fenomeni quotidiani della vita
La metodologia didattica attuata in classe saragrave finalizzata allo sviluppo della professionalitagrave dei singoli allievi considerato che lrsquoinsegnamento della disciplina mira alla formazione dei giovani come cittadini oltre che alla loro formazione giuridico ed economica
Saragrave cura del docente quindi cercare di rendere meno nozionistico ed astratto lo studio dei vari argomenti
Saragrave adottato sia il metodo della lezione frontale sia quello dellrsquoapproccio che parte dalle esperienze piugrave comuni dellrsquoallievo da concetti acquisiti spontaneamente da avvenimenti attuali per arrivare alla
72
definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

definizione del concetto astratto
Visto gli innumerevoli agganci con la realtagrave circostante ed il vissuto dei ragazzi le varie situazioni verranno impostate in chiave problematica coinvolgendo cosigrave tutti gli allievi che saranno chiamati a dare soluzioni utilizzando non solo ciograve che hanno appreso ma anche la loro capacitagrave di ragionamento
I tempi della lezione frontale saranno intervallati da continui interventi degli alunni al fine di tenere alta costantemente lrsquoattenzione
Saranno anche a fine unitagrave didattica utilizzate le tavole sinottiche presenti sul libro di testo e completati gli esercizi a scelta multipla o a risposta aperta sempre prospettati dal testo
STRUMENTIPer consentire al docente di raggiungere gli obiettivi prefissati saragrave utilizzato oltre al tradizionale libro di testo anche il codice civile riviste giuridiche ed economicheAnche i fatti di cronaca quotidiana dovranno essere conosciuti tramite lrsquoinformazione autonoma e diretta per mezzo dellrsquoausilio dei mass-mediaLaddove saragrave possibile anche le mappe concettuali elaborate dal docente dovranno rivelarsi utili per lrsquoacquisizione dei vari contenuti sussidio didattico insostituibile saragrave pertanto anche la lavagna tradizionale che consentiragrave di sintetizzare i temi piugrave importanti e allo stesso tempo stimoleragrave negli allievi il senso dellrsquoessenzialitagrave e delle associazioni logicheAnche i quotidiani letti in classe si potranno rivelarsi utili nella ricerca di quegli avvenimenti che si agganceranno con le tematiche svolte ed apprese dal libro di testo
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione formativa dovragrave dare agli studenti informazioni sul livello raggiunto dagli studenti e al docente elementi per una riflessione sullrsquoefficacia della sua azione didattica e sullrsquoopportunitagrave di attivare interventi di recuperoEssa verragrave effettuata in una fase iniziale per verificare il livello di partenza dei discenti cioegrave le conoscenze e le abilitagrave che essi possiedono allrsquoinizio dellrsquoanno e che hanno acquisito negli anni precedentiEssa saragrave in itinere per verificare il processo di apprendimento quindi per verificare il graduale conseguimento delle conoscenze capacitagrave competenzeEssa saragrave sommativa per valutare lrsquooperato ed profitto degli allievi e saragrave articolata in forma orale e scrittaLa valutazione terragrave conto drsquoogni possibile elemento utile a definire il grado di preparazione raggiunto ed al riguardo saranno tenute in debito conto le verifiche annotate sul registro e verragrave valutato anche lrsquoimpegno costante la frequenza la partecipazione il miglioramento rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento degli obiettivi educativi
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE
Mod 1 ndash Settembre ndash Dicembre
73
a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-

a- La norma giuridica ndash le fonti del diritto ndash i diritti ndash i beni ndash i soggetti del diritto
Mod 2 ndash Gennaio - Marzo
b- La capacitagrave giuridica ndash la capacitagrave di agire ndash lrsquoincapacitagrave naturale ndash lrsquointerdizione ndash
lrsquoinabilitazione ndash la persona giuridica
Mod 3 - Aprile ndash Maggio
Le obbligazioni ndash la tutela del credito ndash le altre fonti dellrsquoobbligazione Il contratto turistico
Valderice 20102013 Prof Giovanni Messina
74
- Istituto drsquoIstruzione Secondaria Superiore
- ldquoLeonardo Sciasciardquo
- Erice
-
- INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
- PIANO DI LAVORO
-
- DISCIPLINA Scienze motorie e sportive
- DOCENTE PROF ssa Scarcella Carla
-
- COORDINATORE PROF Scuderi Maria Stella
-
- PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- TITOLO
-
- Obiettivi
-
- Contenuto
-
- Lrsquoalunno saragrave in grado di
- Discutere e confrontarsi con i suoi pari anche se di altre etnie o fedi religiose
- Essere consapevole che Gesugrave egrave un personaggio della storia dellrsquoumanitagrave rilevare e discutere il valore dellrsquoamore salvifico di Dio nellrsquoopera di Gesugrave per lrsquouomo di oggi riconoscere il valore della missione della Chiesa confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
- Confrontarsi e discutere la correlazione tra fede e vita nellrsquoesperienza dei testimoni cristiani
-
- Note
- Strumenti di valutazione
-
- PROGRAMMAZIONE DI STORIA
- ANNO SCOLASTICO 2013-2014
-
- Obiettivi minimi
-
- 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
-
- ANNO SCOLASTICO
- 2013-2014
- CLASSE
- 3
- SEZIONE
- F-G
- DISCIPLINA
- TECNICA TURISTICA
- DOCENTE
- CAMPANELLA
-
- PROGRAMMAZIONE
-
- DISCIPLINA
- CLASSE E SEZIONE
- DOCENTE
-
- METODOLOGIE
- STRUMENTI
- VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
-