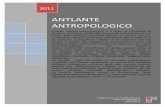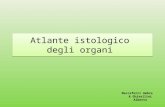VIII – ATLANTE CRONOTIPOLOGICO DELLE...
Click here to load reader
Transcript of VIII – ATLANTE CRONOTIPOLOGICO DELLE...

184
Lo studio condotto sulle murature attestate nel territorio di Chiu-sdino, in un arco cronologico compreso tra fine XI-inizio XII secoloe XVIII secolo, ha portato all’individuazione di 6 Tipi murari prin-cipali. I Tipi individuati con una certa frequenza nell’area di inda-gine, tali da permettere confronti interni a una stessa tipologia, sonostati a loro volta distinti in base alle principali varianti rintracciate 1.I dati raccolti nel corso della ricerca sono stati esemplificati nelleschede che seguono, dove sono prese in esame le USM ritenute piùsignificative per la descrizione delle diverse tipologie murarie indi-viduate 2.Per ogni campione 3 è riportata l’ubicazione, la documentazionegrafica (in scala 1:20) o fotografica, una descrizione della muratura,basata sui suoi componenti principali 4, e l’eventuale presenza ditracce di lavorazione.
1. I CAMPIONI
Campione CH 1Frosini, chiesa di San Michele Arcangelo (sito 105)Il campione è stato rilevato tramite ripresa fotografica all’esterno del-l’edificio, nella porzione inferiore della facciata. In buono stato diconservazione, il paramento murario presenta un degrado superfi-ciale minore rispetto a quello visibile sul fianco sinistro del tempio.Composizione: calcare, travertino compatto.Posa in opera: paramento in conci di medie e medio-grandi dimensioni,disposti per orizzontale e faccia quadra su corsi perfettamente orizzon-tali e paralleli. I filari hanno un’altezza compresa tra 21 e 37 cm.Nella zona di raccordo con i prospetti laterali dell’edificio il para-mento non presenta differenze nelle dimensioni dei conci impiegatinella definizione delle angolate. Lavorazione e finitura: conci perfettamente squadrati e spianati conl’uso del nastrino, per la definizione degli spigoli, e dell’ascettino perla faccia a vista. Le tracce della finitura superficiale sono conservatenella porzione inferiore della facciata e, sporadicamente, in alcuniconci del fianco sinistro.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,3-0,9 cm) e dei letti diposa (0,2-1 cm) è sottile e regolare.
Campione CH 2Frosini, chiesa di San Michele Arcangelo (sito 105)Il campione è stato rilevato tramite ripresa fotografica all’esterno del-l’edificio, nella porzione inferiore del prospetto absidale. Conservato
solo parzialmente, il paramento murario presenta profonde lesioniche, specialmente nella parte settentrionale dell’abside, hanno cau-sato un distacco (da 0,7 a 1,5 cm) dei giunti della muratura.Composizione: calcare.Posa in opera: paramento in conci di medie e medio-piccole dimen-sioni, disposti per orizzontale e, raramente, faccia quadra, su corsi ge-neralmente orizzontali e paralleli. In alcuni punti il paramento pre-senta un andamento leggermente irregolare dei filari. I filari hannoun’altezza compresa tra 17 e 27 cm.
VIII – ATLANTE CRONOTIPOLOGICO DELLE MURATURE
Figura 81. CH 1. Frosini, chiesa di San Michele Arcangelo
Figura 82. CH 2. Frosini, chiesa di San Michele Arcangelo
1 Per la classificazione delle murature campionate, è stata seguita la linea metodolo-gica, inizialmente proposta da T. Mannoni, sviluppata da R. Parenti (MANNONI,1976, pp. 291-300; PARENTI, 1987). 2 Per il metodo d’indagine adottato nella campionatura delle tecniche costruttive siveda cap. IV, paragrafo 6.3 L’indagine stratigrafica si è limitata ai soli paramenti murari esterni degli edifici in-dagati.4 La descrizione tiene infatti conto dei seguenti parametri: materiali, posa in opera, la-vorazione, finitura, spessore dei giunti e dei letti di posa.

Lavorazione e finitura: conci da bene a perfettamente squadrati, spia-nati con uno strumento a punta, di cui non sempre sono riconosci-bili le tracce.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,3-1,1 cm) e dei letti diposa (0,4-1 cm) risulta abbastanza regolare e sottile.
Campione CH 3Castello di Frosini (sito 105)Il campione è stato rilevato, tramite documentazione grafica in scala1:20, nel prospetto esterno sud del palazzo, in prossimità del portaled’ingresso ad arco senese.Composizione: calcare, travertino compatto.Posa in opera: bozze di medie e piccole dimensioni disposte per oriz-zontale e faccia quadra, raramente per verticale, su corsi general-mente orizzontali e paralleli. La parte superiore del campione pre-senta bozze di piccole dimensioni disposte su filari più irregolari. Ifilari hanno un’altezza compresa tra 16 e 25 cm.Lavorazione e finitura: bozze sommariamente squadrate e spianatecon uno strumento a punta (probabilmente picconcello).Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,3-1,6 cm) e dei letti diposa (0,6-1,8 cm) è variabile e irregolare.
Campione CH 4Pieve di Santa Maria a Luriano (sito 51)Il campione è stato rilevato tramite ripresa fotografica all’esterno del-l’edificio, nella parte inferiore della facciata, in prossimità del portaled’ingresso. È questo il punto dove è meglio leggibile la muratura ori-ginaria dell’edificio, in gran parte coperta dal rivestimento a intonacodella parete.Composizione: calcare, travertino, e rara arenaria.Posa in opera: paramento in conci di medie dimensioni posti perorizzontale e faccia quadra, raramente per verticale, su corsi oriz-zontali e paralleli. Nella zona inferiore della facciata si nota, in rela-zione all’impiego di alcuni conci di grandi dimensioni, uno sdop-piamento di corsi della muratura. I filari hanno un’altezza compresatra 18 e 27 cm.Lavorazione e finitura: conci ben squadrati e spianati. La finitura de-gli elementi lapidei è difficilmente individuabile a causa dell’erosione
superficiale della faccia a vista dei conci; è ipotizzabile l’utilizzo diuno strumento a tranciante piano (ascettino).Giunti e letti di posa: lo spessore di giunti (0,4-1,2 cm) e dei letti diposa (0,3-0,9 cm) è abbastanza regolare ma si riferisce a pochi puntidi verifica.
Campione CH 5Papena, chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano (sito 72)Il campione è stato rilevato, tramite documentazione grafica in scala1:20, all’esterno dell’edificio religioso, sul fianco sinistro; questo latodel complesso architettonico presenta un paramento in buono statodi conservazione, contrariamente a quello visibile nella facciata, og-getto di numerosi rimaneggiamenti.Composizione: calcare, travertino spugnoso.Posa in opera: paramento in conci di medie dimensioni disposti perorizzontale e faccia quadra su corsi orizzontali e paralleli. Raro uti-lizzo di zeppe in scaglie di laterizio nei giunti della muratura. I filarihanno un’altezza compresa tra 18 e 29 cm.Lavorazione e finitura: conci ben squadrati e spianati; la finitura dellesuperfici non è leggibile a causa dell’erosione superficiale degli ele-menti lapidei.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,4-1,2 cm) e dei letti diposa (0,5-1,5 cm) è variabile e si riferisce a pochi punti di verifica.
185
Figura 83. CH 3. Frosini, castello
Figura 84. CH 4. Luriano, pieve di Santa Maria
Figura 85. CH 5. Papena, chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano
0 50 cm
0 50 cm

Campione CH 6Chiusdino, chiesa dei SS. Iacopo e Martino (sito 29)Relativo alla muratura esterna della chiesa, il campione è stato rile-vato, tramite documentazione grafica in scala 1:20, sulla facciata del-l’edificio religioso, nel punto di raccordo tra questa e il fianco destro.Composizione: calcare.Posa in opera: paramento in conci di medie e grandi dimensioni di-sposti per orizzontale e faccia quadra, raramente per verticale, su corsiorizzontali e paralleli. In prossimità dell’angolata destra, è visibile la‘cesura’ di un concio del pannello. La presenza di scaglie di laterizionei giunti e nei letti di posa della muratura è da attribuire ai rima-neggiamenti subiti. I filari hanno un’altezza compresa tra 17 e 35 cm.Lavorazione e finitura: conci squadrati e spianati con uno strumentoa punta (subbia o picconcello).Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,2-0,8 cm) e dei letti diposa (0,3-1 cm) è abbastanza sottile e regolare.
Campione CH 7La Magione (sito 157)Il campione è stato rilevato, tramite una ripresa fotografica, nellaparte centrale del prospetto nord-est dell’abitazione.Composizione: arenaria, travertino compatto.Posa in opera: paramento in bozze di medio-piccole e piccole di-mensioni disposte per orizzontale e faccia quadra su corsi general-mente orizzontali e paralleli, in alcuni punti sdoppiati. I filari hannoun’altezza compresa tra 14 e 34 cm.Lavorazione e finitura: bozze sommariamente squadrate e spianate conuno strumento a punta (forse picconcello), di cui restano poche tracce.Giunti e letti di posa : lo spessore dei giunti (0,4-1,7 cm) e del lettidi posa (0,3-1,5 cm) è variabile e si riferisce a pochi punti di ve-rifica.
Campione CH 8Podere Tamignano (sito 110)Relativo alla muratura esterna, a scarpa, della torre, il campione èstato rilevato, tramite una ripresa fotografica, nella parte inferiore delprospetto sud dell’edificio.Composizione: calcare cavernoso e rari laterizi.Posa in opera: paramento in bozze di medio-piccole dimensioni di-sposte su filari generalmente orizzontali e paralleli; frequente im-piego di zeppe in scaglie di pietra nei giunti e nei letti della mura-
tura. Nella parte sud-est del prospetto si notano alcuni laterizi, forsedi reimpiego, in qualità di elementi verticali. Nella zona di raccordocon il prospetto ovest, l’impiego di conci di grandi dimensioni e per-fettamente squadrati nella definizione dell’angolata, impone, rispettoa questi conci, lo sdoppiamento dei corsi del pannello. I filari hannoun’altezza compresa tra 15 e 23 cm.Lavorazione e finitura: pietre spaccate o sommariamente sbozzate,prive di finitura.Giunti e letti di posa: il restauro in cemento dei giunti e dei letti diposa ne impedisce la lettura.
Campione CH 9Le Palazze (sito 145)Relativo alla muratura esterna della torre, il campione è stato rile-vato, tramite una ripresa fotografica, nella parte inferiore del pro-spetto ovest dell’edificio.Composizione: calcare cavernoso, alberese, ciottoli fluviali.Posa in opera: paramento in bozze e ciottoli di fiume di medio-pic-cole dimensioni disposti su corsi sub-orizzontali e paralleli, spessosdoppiati nel punto di raccordo tra pannello e angolata; quest’ultimaè risolta in conci squadrati di medie dimensioni. Utilizzo di zeppe in
186
Figura 86. CH 6. Chiusdino, chiesa dei SS. Iacopo e Martino
Figura 88. CH 8. Podere Tamignano
Figura 87. CH 7. La Magione
0 50 cm

187
scaglie di pietra nei letti di posa. I filari hanno un’altezza compresatra 16 e 23 cm.Lavorazione e finitura: pietre spaccate o prive di lavorazione.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,5-1,5 cm) e dei letti diposa (0,3-2 cm) è variabile.
Campione CH 10Podere San Martino (sito 153)Relativo alla muratura esterna dell’abitazione poderale, il campioneè stato rilevato tramite ripresa fotografica nella parte inferiore delprospetto ovest del corpo di fabbrica centrale, in prossimità dellaporta di ingresso.Composizione: calcare marnoso, calcare cavernoso, laterizi.Posa in opera: muratura irregolare con periodici filari di orizzonta-mento ogni 70-80 cm. Numerosi conci di reimpiego. Frequentizeppe in pietra e laterizio, anche di copertura.
Lavorazione e finitura: solo le pietre di reimpiego, di medie e grandidimensioni, sono squadrate e spianate. In generale la muratura pre-senta pietre messe in opera prive di lavorazione.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,4-2,8 cm) e dei letti diposa (0,2-3,2 cm) è fortemente irregolare.
Campione CH 11Vesperino (sito 152)Relativo alla muratura esterna dell’abitazione poderale, il campioneè stato rilevato tramite documentazione grafica in scala 1:20, nellaparte superiore del prospetto ovest del corpo di fabbrica centrale, inprossimità della porta di ingresso.Composizione: calcare cavernoso, laterizi.Posa in opera: paramento formato da elementi lapidei apparecchiatisu filari irregolari, in parte regolarizzati con l’utilizzo di laterizi orga-nizzati su brevi filari di orizzontamento. Frequente uso di zeppe inscaglie di pietra e frammenti di laterizio.Lavorazione e finitura: pietre spaccate messe in opera prive di lavo-razione con frequente utilizzo di bozze di medie dimensioni, squa-drate, verosimilmente di riutilizzo.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti è irregolare, non verificabile.
Campione CH 12Valloria (sito 150)Relativo alla muratura esterna della grangia, il campione è stato rile-vato tramite ripresa fotografica nella parte inferiore del prospetto suddel corpo di fabbrica centrale.Composizione: calcare cavernoso e marnoso.Posa in opera: paramento in conci di medie dimensioni, disposti perorizzontale e, in misura minore, per faccia quadra, su corsi sub-oriz-zontali e paralleli. Utilizzo abbastanza frequente di zeppe in scagliedi pietra nei giunti e nei letti di posa. I filari hanno un’altezza com-presa tra 20 e 34 cm.Figura 90. CH 10. Podere San Martino
Figura 91. CH 11. Vesperino
0 50 cm
Figura 89. CH 9. Le Palazze

188
Lavorazione e finitura: conci squadrati e sommariamente squadrati,spianati ad ascettino, di cui restano rare tracce.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,5-2,3 cm) e dei letti diposa (0,4-3,5 cm) è variabile.
Campione CH 13Chiusdino, casa di San Galgano (sito 29)Relativo alla muratura esterna dell’abitazione, il campione è stato ri-levato tramite documentazione grafica in scala 1:20, nella parte in-feriore della facciata, in prossimità del portale d’ingresso.Composizione: calcare marnoso.Posa in opera: paramento in bozze di medio-piccole e piccole di-mensioni, disposte per faccia quadra e, in misura minore, per oriz-zontale su corsi generalmente orizzontali e paralleli. I filari hannoun’altezza compresa tra 12 e 21 cm.Lavorazione e finitura: pietre sbozzate e sommariamente spianate conun picconcello, di cui restano rare tracce a causa delle frequenti frat-ture concoidi del materiale lapideo, scarsamente gelivo, visibili sullesuperfici esterne delle pietre.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,3-1 cm) e dei letti diposa (0,2-1,3 cm) è abbastanza regolare.
Campione CH 14Chiusdino, chiesa dei SS. Iacopo e Martino (sito 29)Relativo alla muratura esterna dell’edificio religioso, il campione è
stato rilevato tramite documentazione grafica in scala 1:20 nellaparte inferiore del fianco laterale sinistro.Composizione: calcare marnoso.Posa in opera: paramento in bozze di medio-piccole e piccole dimen-sioni, disposte per faccia quadra su corsi generalmente orizzontali eparalleli. Utilizzo di periodiche zeppe in scaglie di pietra nei giuntidella muratura. I filari hanno un’altezza compresa tra 15 e 20 cm. Lavorazione e finitura: pietre sbozzate e spianate con un picconcello.Il materiale litoide, poco gelivo, mostra fratture concoidi che hannoin parte asportato le tracce superficiali di lavorazione.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,4-1,5 cm) e dei letti diposa (0,4-1,7 cm) è abbastanza regolare.
Campione CH 15Chiusdino, circuito murario, via delle Mura (sito 29)Relativo alla muratura del circuito murario più esterno all’abitato diChiusdino, il campione è stato rilevato, tramite documentazione fo-tografica, a pochi metri di distanza dalla Porta Bacucchi (o Senese),in via delle Mura, nella parte inferiore del paramento.Composizione: calcare e calcare marnoso.Posa in opera: paramento in bozze di medie e medio-piccole dimen-sioni, disposti per orizzontale e faccia quadra su corsi generalmenteorizzontali e paralleli. Utilizzo di frequenti zeppe in scaglie di pietrae frammenti di laterizio nei giunti e nei letti della muratura. I filarihanno un’altezza compresa tra 18 e 26 cm.
Figura 94. CH 14. Chiusdino, chiesa dei SS. Iacopo e Martino
Figura 92. CH 12. Valloria
Figura 93. CH 13. Chiusdino, casa di San Galgano
0 50 cm
0 50 cm
Figura 95. CH 15. Chiusdino, circuito murario, Via delle Mura

189
Lavorazione e finitura: pietre sbozzate e sommariamente spianate conun picconcello. Alcuni conci di grandi dimensioni, squadrati e spia-nati, sono forse di reimpiego.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,5-3,1 cm) e dei letti diposa (0,4-3,2 cm) è variabile.
Campione CH 16Luriano (sito 58)Relativo alla muratura esterna del complesso architettonico, il cam-pione è stato rilevato, tramite documentazione grafica in scala1:20, nella parte inferiore del prospetto a monte del corpo di fab-brica centrale.Composizione: calcare, ciottoli fluviali.Posa in opera: paramento in ciottoli e bozze di medio-piccole di-mensioni disposte, per orizzontale e faccia quadra, su corsi sub-oriz-zontali e paralleli. Periodicamente, a intervalli di 1,20-1,40 m, filariformati da bozze lamellari (max. 9 cm di spessore) indicano forse lafine della giornata di lavoro. La muratura presenta sdoppiamenti deicorsi in prossimità delle angolate. Utilizzo di zeppe in scaglie di pie-tra nei giunti e nei letti di posa. I filari hanno un’altezza compresatra 14 e 24 cm.Lavorazione e finitura: pietre spaccate o prive di lavorazione.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,2-2,7 cm) e dei letti diposa (0,5-3,5 cm) è irregolare.
Campione CH 17Miranduolo, Area 1, US 8 (sito 28)Relativo alla muratura dell’edifico rinvenuto durante la campagna discavo condotta nei mesi di agosto-settembre 2001, nella parte som-mitale del colle, il campione è stato rilevato, tramite documentazionegrafica in scala 1:20, nel paramento esterno dell’edificio. Composizione: calcare cavernoso.Posa in opera: paramento in conci squadrati di medie dimensioni, di-sposti su filari orizzontali e paralleli. Sono visibili, allo stadio attualedelle indagini, solo quattro filari dell’alzato. I filari hanno un’altezzacompresa tra 18 e 27 cm.Lavorazione e finitura: conci squadrati e spianati; rare tracce di fini-tura fanno ipotizzare che per la spianatura delle superfici sia stato uti-lizzato uno strumento a punta.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,4-1,6 cm) e dei letti diposa (0,5-1 cm) è abbastanza sottile e regolare.
Campione CH 18Miranduolo, Area 2, US 2 (sito 28)Il campione è stato rilevato, tramite documentazione grafica in scala1:20, nel paramento esterno del circuito murario visibile nel versantemeridionale del poggio. Composizione: calcare.Posa in opera: paramento in bozze di medie e medio-piccole dimen-sioni disposte, per orizzontale e faccia quadra, su corsi generalmenteorizzontali e paralleli. Raro utilizzo di zeppe in scaglie di pietra la-mellari (max. 3,5 cm di spessore) nei giunti della muratura. I filarihanno un’altezza compresa tra 17 e 22 cm.Lavorazione e finitura: pietre spaccate e sommariamente sbozzate conun picconcello.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,5-3,7 cm) e dei letti diposa (0,4-2,5 cm) è irregolare.
Campione CH 19Miranduolo, Area 1, US 7 (sito 28)Relativo alla muratura dell’edificio situato nel Settore A, il campioneè stato rilevato, tramite documentazione grafica in scala 1:20, nel pa-ramento murario interno del lato orientale della struttura.Composizione: calcare cavernoso.Posa in opera: paramento in conci di medie e medio-piccole dimen-sioni, disposti per orizzontale e faccia quadra su corsi generalmenteorizzontali e paralleli. Utilizzo di zeppe in scaglie di pietra lamellari(max. 4,1 cm di spessore) nei giunti della muratura. I filari hannoun’altezza compresa tra 16 e 25 cm.Lavorazione e finitura: conci squadrati e sommariamente squadrati,spianati con un ascettino di cui non sempre sono riconoscibili le tracce.Giunti e letti di posa: lo spessore dei giunti (0,3-1,3 cm) e dei letti diposa (0,5-2 cm) è variabile.
Figura 96. CH 16. Luriano, castello
Figura 97. CH 17. Miranduolo, Area 1, US 8
0 50 cm
0 50 cm
Figura 98. CH 18. Miranduolo, Area 2, US 2
0 50 cm

CAMPIONE CH 20
La Cura, pieve di San Bartolomeo (sito 155)Il campione è stato rilevato tramite ripresa fotografica all’esterno del-l’edificio, nella parte inferiore della facciata, in prossimità del portaled’ingresso.Composizione: calcare, travertino.Posa in opera: paramento in conci di medie e medio-grandi dimensioniposti per orizzontale e faccia quadra, raramente per verticale, su corsiorizzontali e paralleli. I filari hanno un’altezza compresa tra 22 e 34 cm.Lavorazione e finitura: conci ben squadrati e spianati. La finitura de-gli elementi lapidei, dove conservata, mostra tracce di uno strumentoa tranciante rettilineo (ascettino).Giunti e letti di posa: lo spessore di giunti (0,3-1,6 cm) e dei letti diposa (0,3-1,4 cm) è abbastanza regolare ma si riferisce a pochi puntidi verifica.
2. CRONOTIPOLOGIA DELLE MURATURE
Tipo 1 Paramento in conci di calcare e calcare cavernoso disposti su corsiorizzontali e paralleli, per orizzontale e faccia quadra. Conci di me-die e grandi dimensioni, da bene a perfettamente squadrati. Le su-perfici lapidee sono finite con ascettino. L’altezza dei filari è com-presa tra 17 e 35 cm. Lo spessore dei giunti (0,2-1,4 cm) e dei lettidi posa (0,3-1,5 cm) è abbastanza sottile e regolare.
Appartengono al Tipo i campioni CH 4, 5, 6, 17 e 20.Cronologia: fine XI-inizio XIII secolo.Variante A: simile al Tipo 1, ma realizzato in conci di travertino di-sposti su corsi perfettamente orizzontali e paralleli. I conci, perfetta-mente squadrati e spianati, presentano una finitura delle superficicon uso dello scalpello per la resa del nastrino e dell’ascettino per lasuperficie lapidea. Lo spessore dei giunti (0,3-0,9 cm) e dei letti diposa (0,2-1 cm) è sottile e regolare.Variante attestata dal campione CH 1.Cronologia: fine XI-metà XIII secoloVariante B: simile al Tipo 1, ma in conci di medie e medio-piccoledimensioni disposti per orizzontale e, raramente, per faccia quadrasu corsi generalmente orizzontali e paralleli. Variante attestata dal campione CH 2.Cronologia: fine XI-metà XII secolo.
Tipo 2 Paramento in bozze di calcare marnoso disposte su corsi general-mente orizzontali e paralleli per faccia quadra e, più raramente, perorizzontale. Bozze di medio-piccole dimensioni, sommariamentespianate a picconcello. Utilizzo di zeppe in scaglie di pietra nei giuntie nei letti di posa. I filari hanno un’altezza compresa tra 12 e 26 cm.Lo spessore dei giunti (0,3-3,7 cm) e dei letti di posa (0,2-3,2 cm) èvariabile.Appartengono al Tipo i campioni CH 13, 14, 15 e 18.Cronologia: fine XII-inizio XIII/inizio XIV secolo.
Tipo 3 Paramento in bozze di calcare e ciottoli di fiume disposti su corsi sub-orizzontali e paralleli sdoppiati in prossimità delle angolate. Bozze dimedio-piccole dimensioni non spianate. I filari hanno un’altezzacompresa tra 14 e 24 cm. Lo spessore dei giunti (0,4-1,5 cm) e deiletti di posa (0,3-2 cm) è irregolare.Appartengono al Tipo i campioni CH 9 e 16.Cronologia: metà XIII-XIV secolo.Variante A: simile al Tipo 2, ma con frequente utilizzo di zeppe inscaglie di pietra nei giunti e nei letti della muratura e di sporadicilaterizi in qualità di elementi verticali.Variante attestata dal campione CH 8.Cronologia: fine XIII-XIV secolo.
Tipo 4 Paramento in conci di calcare cavernoso disposti per orizzontale e, piùraramente, per faccia quadra su corsi generalmente orizzontali e paral-leli. Conci di medie e medio-piccole dimensioni, da sommariamentesquadrati a squadrati. Finitura ad ascettino. I filari hanno un’altezzacompresa tra 20 e 34 cm. Lo spessore dei giunti (0,3-2,3 cm) e dei lettidi posa (0,4-3,5 cm) è variabile.Appartengono al Tipo i campioni CH 12 e 19.Cronologia: XIII-inizio XIV secolo.
Tipo 5 Paramento in bozze di travertino compatto disposte per orizzontalee faccia quadra, raramente per verticale, su corsi generalmente oriz-zontali e paralleli, in alcuni casi sdoppiati. Bozze di medie e piccoledimensioni, sommariamente squadrate e spianate con uno stru-mento a punta. I filari hanno un’altezza compresa tra 14 e 34 cm. Lospessore dei giunti (0,3-1,7 cm) e dei letti di posa (0,3-1,8 cm) è ab-bastanza regolare.Appartengono al Tipo i campioni CH 3 e 7.Cronologia: metà XIII –XIV secolo.
190
Figura 99. CH 19. Miranduolo, Area 1, US 7
Figura 100. CH 20. La Cura, pieve di San Bartolomeo
0 50 cm

Tipo 6 Paramento in pietre spaccate e laterizi, spesso spezzati, disposti su fi-lari irregolari, con periodici filari di orizzontamento ogni 40-70 cm.Notevole riutilizzo di materiale da costruzione. Frequente uso dizeppe in scaglie di pietra e frammenti di laterizi. Lavorazione presentesoltanto sulle pietre di reimpiego.Appartengono al Tipo i campioni CH 10 e 11.Cronologia: XVII-metà XVIII secolo.
3. TECNICHE COSTRUTTIVE NEL TERRITORIO DI CHIUSDINO
All’interno di uno studio diacronico delle tipologie murarie individuatenel territorio indagato per il periodo compreso tra fine XI secolo e metàXVIII secolo, emergono alcune linee di tendenza riscontrabili sia nel-l’evoluzione dell’apparecchiatura muraria e nella sua lavorazione sianella scelta del materiale utilizzato.Il territorio di Chiusdino, geologicamente non omogeneo, è, in lineadi massima, caratterizzato nella porzione settentrionale, zona delle ul-timi propaggini della Montagnola Senese, dalla presenza di litologiericonducibili a formazioni calcaree (verrucano e calcari cavernosi); laparte centrale del territorio, caratterizzata dalla piana alluvionale delFeccia, è occupata da depositi alluvionali associati a depositi traverti-nosi. La parte sud-ovest infine, interessata dal sistema di rilievi colli-nari che costituiscono la base delle Colline Metallifere, presenta for-mazioni carbonatico-argillose-silicee e rocce calcareo-conglomeratiche.In questo contesto l’indagine archeologica ha permesso di constatarecome la distribuzione dei materiali sul territorio indichi in genere unutilizzo ‘locale’ del materiale lapideo nel corso dei secoli: l’impiegodiffuso di rocce calcaree, impiegate come materiale da costruzione eper la produzione della calce, è collegabile anche alla vicinanza dellaMontagnola Senese, ricca di cave di calcare cavernoso e di marmo 5;l’utilizzo del travertino compatto, presente in una porzione limitatadi territorio, è attestato nella costruzione di edifici posti nelle imme-diate vicinanze delle cave, come Villanuova, o a breve distanza daqueste, come Frosini e l’abbazia di San Galgano 6.Il rapporto tra disponibilità dei materiali litoidi e loro utilizzazione,basato su condizioni che spesso guidavano la scelta dei costruttorimedievali, come la distanza tra la cava e l’edificio, la facilità del per-corso e la lavorabilità della pietra, sembra dunque essere confermatoanche dal loro raggio di diffusione nel territorio 7. Gli edifici indagati mostrano un utilizzo quasi esclusivo della pietracome materiale da costruzione per tutto il periodo medievale. Il late-rizio, a eccezione del cantiere dell’abbazia di San Galgano, dotato difornaci proprie 8, sembra non essere attestato prima del XIII secolo elimitato a impieghi particolari quali pavimentazioni, stipiti e volte in-terne 9. I laterizi si trovano utilizzati nella costruzione delle aperture a
partire dal XV secolo, oppure se usati, interi o spezzati, come zeppenei giunti e nei letti di posa delle murature sono indicativi di conso-lidamenti di solito databili tra XVI e XVIII secolo. Rimpelli e rifaci-menti in laterizi di murature in pietra sono in genere riferibili an-ch’essi a un periodo tardo, non prima della fine del XV secolo.La messa in opera di paramenti realizzati in conci ben squadrati e spia-nati 10, disposti su corsi orizzontali e paralleli, mostra, negli edifici in-dagati, il buon livello tecnico raggiunto, nel periodo compreso tra fineXI secolo e XIII secolo, dalle maestranze operanti nel territorio. In par-ticolare edifici quali la chiesa dei SS. Martino e Iacopo a Chiusdino ela chiesa di San Michele Arcangelo a Frosini che, ricostruita quasi com-pletamente nel secolo successivo, conserva nella parte inferiore del-l’abside (fig. 101) resti della muratura più antica, presentano un’at-tenzione particolare nella resa delle superfici esterne dei conci.La lavorazione e la finitura degli elementi litoidi, dove conservata, at-testa a partire dalla metà del XII secolo, in edifici religiosi quali lapieve di San Michele Arcangelo a Chiusdino e la chiesa di Frosini,l’utilizzo dell’ascettino 11. Tracce di questo strumento si ritrovano poiin alcuni edifici religiosi romanici del XII e XIII secolo, come le pievidi Luriano e di Pentolina e la chiesa di Papena 12.Se dunque è possibile datare l’introduzione di questo strumento allametà del XII secolo, è forse ipotizzabile collegare la sua diffusione al-l’introduzione di un tipo di paramento che, come abbiamo visto, eraparticolarmente accurato e, richiedendo una buona finitura delle su-perfici, necessitava di strumenti di finitura raffinati 13. L’analisi di strutture abitative datate tra XIII e XIV secolo ci mostrainvece un netto cambiamento sia nel tipo di paramento che nel tipodi finitura del materiale da costruzione. È possibile osservare, oltre allatendenza delle maestranze a dedicare una cura maggiore nella realiz-zazione delle murature destinate alle facciate rispetto a quelle desti-nate ai prospetti laterali, un’evoluzione nella tecnica edilizia: stru-menti a punta, quali la subbia o il picconcello, prendono gradual-mente il posto dell’ascettino nella spianatura degli elementi lapideidella muratura. Nel paramento murario l’attenzione si concentrasempre più nella resa degli elementi architettonici; nella lavorazionedei conci, perfettamente squadrati, delle angolate, delle finestre e deiportali, si ritrova l’uso dell’ascettino e, a partire dalla metà del XIII se-colo, i primi esempi di lavorazione a martellina dentata 14.La martellina dentata a punte fini, uno degli strumenti più diffusinell’architettura medievale europea e, a partire dal XIV secolo, unodegli strumenti di finitura più usati in Toscana 15, è utilizzata intornoal 1220 nel cantiere dell’abbazia di San Galgano. Questo è proba-bilmente il primo utilizzo attestato nel territorio di Chiusdino 16.
191
5 Nel XIV secolo i marmi della Montagnola erano inviati a Siena, per la costruzionedel Duomo, a Firenze, per il cantiere di Santa Maria del Fiore, e a Orvieto. PARENTI,1995, p. 374.6 Nella seconda metà del XIII secolo il travertino utilizzato per l’edificazione dell’ab-bazia di San Galgano era estratto nelle cave poste in prossimità della grangia di Villa-nuova, località tuttora chiamata Cave di Travertino; nella grangia ci si occupava didirigere l’attività di estrazione e di lavorazione delle pietre. GABBRIELLI, 1998b, p. 19.7 Definire i confini dell’areale di diffusione di un litotipo è comunque difficoltoso espesso legato a fattori quali il minore o maggiore successo costruttivo del materiale nelcorso del tempo (PARENTI, 1995, p. 388).8 La fabbricazione in proprio di laterizi è attestata nel cantiere a partire dal 1234 (GAB-BRIELLI, 1998b, p. 18).9 Il dato sembra trovare conferma nei primi risultati della campagna di scavo, condottanei mesi di agosto-settembre 2001, nel castello di Miranduolo. I livelli di crollo perti-
nenti alla struttura palaziale, situata in posizione sommitale, hanno reso porzioni dimuratura in laterizi, interne alla struttura. A tale proposito, si veda sito 28.10 A tale proposito si veda il Tipo 1.11 L’ascettino, costituito da due trancianti piani, appartiene alla categoria degli strumentia percussione lanciata. La sua presenza è attestata nello stesso periodo in Val d’Elsa, aColle, San Gimignano e Castelfiorentino (MENNUCCI, 1993-1994, pp. 531-532).12 Si vedano i campioni CH 5, 6 e 20.13 L’indagine condotta sulle murature databili tra fine XI e XII secolo, è basata, allo statoattuale delle ricerche, essenzialmente sullo studio di edifici religiosi (campioni CH 1, 2,4, 5, 6). Questo, purtroppo, rende parziale l’analisi delle tecniche edilizie in uso al tempo. 14 È questo il caso, ad esempio, del castello di Frosini dove il portale di accesso al pa-lazzo, coronato da un arco senese, mostra nelle superfici esterne dei conci una finituraa martellina dentata. Similmente le grange di Villanuova e Valloria (siti 151 e 150)mostrano, nei conci del portale d’ingresso a sesto acuto, tracce di finitura a martellinadentata.15 BIANCHI-PARENTI, 1991; PARENTI, 1995.16 GABBRIELLI, 1998b, pp. 19-21.

192
Figura 103. Chiusdino, chiesa dei SS. Jacopo e Martino, raddrizzamento fo-tografico e suddivisione per fasi
Figura 104. Pieve di San Bartolomeo a La Cura, raddrizzamento fotograficoe suddivisione per fasi
Figura 101. Chiesa di San Michele Arcangelo a Frosini, suddivisione per fasiFigura 102. Le Palazze, raddrizzamento fotografico e suddivisione per fasi

Presente sporadicamente già nella seconda metà del secolo prece-dente in Val d’Elsa, dove il suo impiego è documentato nella pievedi San Salvatore a Colle e nella chiesa di Sant’Agnese a Poggio Bo-nizio 17, la martellina è stata, con molta probabilità, introdotta nellaToscana centrale dalle maestranze pisane che, utilizzando già datempo questo strumento, lo portarono, nel corso del XIII secolo, nelcontado volterrano e in Val d’Elsa 18.Al momento, le uniche attestazioni dell’utilizzo della martellina den-tata rintracciate nel territorio di Chiusdino, riferibili alla secondametà del XIII secolo, appartengono o a edifici di committenza si-gnorile come quello di Frosini, o a strutture pertinenti l’ordine ci-stercense, come le grange di Valloria e Villanuova. Sebbene le atte-stazioni siano sporadiche, è comunque ipotizzabile, allo stadio at-tuale delle indagini, che la presenza sul territorio di maestranzespecializzate abbia contribuito alla diffusione della martellina già nelcorso del XIII secolo.Pertanto, in una fase ancora preliminare della ricerca, un filone d’in-dagine di particolare interesse potrebbe essere aperto dallo studio del-l’influenza e del contributo apportato, nella diffusione di nuove me-todologie e nello sviluppo di nuove tecniche, sul territorio circo-stante da un cantiere che, come quello di San Galgano, vedevaoperare maestranze specializzate probabilmente a fianco di mae-stranze locali 19.Nel corso del XIV secolo persiste l’attenzione costante nella resa ditutti quegli elementi architettonici che caratterizzano la destina-zione signorile dell’edificio, mentre la muratura, forse coperta daintonaco, presenta una resa sempre meno accurata del paramento,che passa da pietre sommariamente squadrate o solo sbozzate nellaseconda metà del Duecento a ciottoli di fiume e materiale il piùdelle volte non lavorato nel Trecento 20. È questo il caso, a esem-pio, delle Palazze, dove l’edificio principale del complesso, unacasa-torre signorile (fig. 102), mostra nel ‘contrasto’ tra il para-
mento murario, costruito con materiali disponibili in loco, e leaperture in conci spianati di travertino compatto, il gusto e le esi-genze dei committenti.A partire dal XV secolo i laterizi compaiono sempre più frequente-mente negli edifici rurali del territorio: le apparecchiature messe inopera con il mattone risultano irregolari, con un vasto ricorso a ele-menti spezzati e a materiale lapideo non lavorato che, spesso direimpiego, è ancora una componente fondamentale nella muratura.Numerosi nuclei rurali di epoca medievale si trasformano, a partiredal XV-XVI secolo, in strutture a conduzione mezzadrile che, ca-ratterizzate da un insieme di annessi e corpi di fabbrica addossati al-l’abitazione principale, mostrano murature irregolari con angolatesempre ben definite e risolte in conci ben squadrati. In generale, latendenza all’impiego di materiale eterogeneo è attestata, in nume-rosi edifici rurali presenti nel territorio, fino almeno alla metà delXVIII secolo.Murature in laterizio sono inoltre caratteristiche di tutta una se-rie di interventi di restauro che interessarono, a partire dal XVI se-colo, numerosi edifici religiosi romanici, come nel caso dellachiesa di SS. Iacopo e Martino a Chiusdino (fig. 103). A questoproposito è interessante notare come i restauri condotti in alcunechiese romaniche nel XIX secolo, in sintonia con il rinnovato in-teresse per il periodo medievale, siano invece caratterizzati da unutilizzo esclusivo della pietra. La pieve di Pentolina, ad esempio,mostra nella parte superiore della facciata, una muratura in conciben squadrati e spianati, frutto di un restauro della seconda metàdel XIX secolo (fig. 104).Improntati all’imitazione delle strutture romaniche, questi restaurisi sono spinti a volte fino all’utilizzo degli stessi strumenti che, comel’ascettino, erano utilizzati per la finitura delle superfici nelle costru-zioni del XII-XIII secolo.
Marie Ange Causarano
193
17 MENNUCCI, 1996a, pp. 51-5218 Sulla diffusione della martellina dentata si veda BIANCHI-PARENTI, 1991,pp. 143-146 e PARENTI, 1995, p. 391. 19 Per un inquadramento della questione si veda GABBRIELLI, 1998b, p. 15. Sul ruolosvolto da maestranze monastiche e maestranze laiche nel cantiere dell’abbazia di SanGalgano, si veda GABBRIELLI, 2000.20 Si vedano i Tipi 2 e 3. Questa tecnica costruttiva è attestata non solo in struttureabitative ma anche in costruzioni dal carattere difensivo, come nel caso del circuitomurario di Chiusdino.

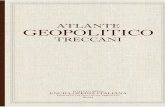



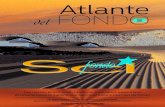







![Atlante Di Istologia [Atlante Istologia]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/553f232a4a7959960d8b471e/atlante-di-istologia-atlante-istologia.jpg)