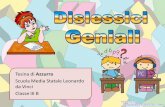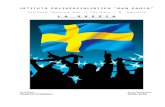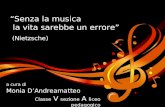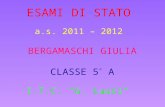Tesina - LETTERATURA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO.pdf
-
Upload
alexpagnini -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Tesina - LETTERATURA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO.pdf
-
00562 LETTERATURA ITALIANA
A. A. 2012/2013
Docente: Giardinazzo Francesco
Numero di crediti: 10
LETTERATURA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Il rapporto dei classici con la storia
Alex Pagnini N matricola: 660470
-
Alex Pagnini Letteratura tra passato, presente e futuro
1
Introduzione
Nellintroduzione al suo Perch leggere i classici, Italo Calvino afferma che clas-sico ci che tende a relegare lattualit al rango di rumore di fondo, ma nello stesso tempo di questo rumore di fondo non pu fare a meno e immediatamente dopo aggiunge: classico ci che persiste come rumore di fondo anche l dove
lattualit pi incompatibile fa da padrona. Queste due affermazioni vogliono essere allo stesso tempo punto di partenza e li-
nea di arrivo di questo percorso, che si focalizza sul rapporto dei classici (e della letteratura in senso pi ampio) con il tempo. Un rapporto analizzato da due punti
di vista diversi, ma in stretta relazione tra loro: in primo luogo il rapporto dei clas-sici con la propria contemporaneit, quindi il loro distaccarsi dalla stessa per avvi-
cinarsi a un tempo grande, che abbraccia passato, presente e futuro.
Tempo cronologico e tempo grande
Per prima cosa occorre definire il concetto fondamentale di tempo. Sul lato pratico, il tempo pu intervenire nelle opere con diverse funzioni: pu rappresentare il
contesto, la cornice storica in cui la narrazione si svolge; pu essere identificato come soggetto centrale, nel caso in cui tutta la vicenda si muova attorno al sistema
temporale in qualit di portatore di significati particolari; pu coincidere con il concetto di velocit, nel momento in cui viene evidenziata la differenza tra tempo
della storia e tempo della narrazione. Una simile analisi costituisce la premessa alla trattazione di Michail Bachtin in
Estetica e romanzo: il teorico della letteratura russo definisce nel concetto di cro-notopo linterconnessione degli aspetti spaziali e temporali nelle opere letterarie e ne analizza le diverse forme seguendo lo sviluppo delle variet di genere del ro-manzo europeo dallantica Grecia alla letteratura dinizio Cinquecento. Ne risulta un quadro molto ben delineato, in cui il tempo assume di volta in volta ruoli diver-si: se nel romanzo greco astratto e non lascia tracce, gi in quello romano assume
un valore concreto, ma rimane isolato rispetto al tempo storico. Dal Medioevo, e in maniera ancor pi consistente nel Rinascimento, tale isolamento viene meno e il
contesto storico-sociale assume un ruolo fondamentale nella letteratura. Ci spiegato chiaramente nelle osservazioni conclusive, in cui Bachtin analizza
lapproccio dellautore alla propria opera. Lautore, sostiene, guarda il componi-mento dal suo presente: un presente che comprende in primo luogo la sfera lette-
raria, e non esclusivamente della letteratura contemporanea, ma anche di quella passata, che esercita unimportante influenza sul presente. Lo stesso incontro tra passato e presente costituisce il contesto dellopera letteraria e della posizione dellautore in essa, situazione fuori dalla quale risulta impossibile la comprensione dellopera e dellintenzione dellautore. In senso lato possiamo quindi definire il tempo come ununit che racchiude in s levento che raccontato nellopera e levento stesso del raccontare, abbracciando dunque lopera nella sua totalit e includendo in essa limmagine di tempo in quan-to fattore esterno, oggetto e risultato della raffigurazione.
-
Alex Pagnini Letteratura tra passato, presente e futuro
2
Il tempo dei classici
Questa idea di tempo grande si affianca e, allo stesso tempo, si contrappone al concetto di cronotopo, delineando nelle opere un aspetto astorico o, per meglio di-
re, oltrestorico. Per analizzare questo carattere opportuno prendere in conside-razione i classici della letteratura, quelle opere che si collocano per definizione tra
storia e oltrestoria. In Futuro del classico Salvatore Settis spiega come nel corso del Novecento lo stu-dio dei classici ha isolato due visioni di questi ultimi, non solo in senso letterario. La prima cala il classico nella sequenza degli anni e degli eventi, lo connette indis-
solubilmente alla rete di relazioni storico-sociali del suo tempo e, quindi, lo isola nella sua dimensione prettamente storica. La seconda visione rapporta il presente
del classico con il passato e il futuro fino ad arrivare a situare il classico in un con-testo astorico e connotarlo come eterno sistema di valori universali, senza luogo e
senza tempo. Tuttavia, Bachtin sostiene che vedere nel classico un sistema di valori ideali signifi-
ca inevitabilmente considerare lideale come gi attuato e legare quindi lidea dideale al passato, attribuendo al futuro una realt pi effimera, priva di concre-tezza. Si giunge, conclude, a preferire al futuro il passato, pi ponderabile e consi-stente, e ancora a prediligere al passato una dimensione eterna ed extratemporale,
nella quale si individua una contemporaneit assoluta. Ma proprio tale contemporaneit assoluta costituisce una caratteristica specifica e
imprescindibile dei classici, che operano in una dimensione caratterizzata da una pienezza del tempo in senso ampio, da un forte legame con il passato e con il futu-
ro, senza il quale il presente e il contemporaneo perderebbero la loro unit e di-verrebbero un conglomerato astratto di singoli eventi. Tuttavia appare impossibile
elevare il classico a modello tenendo in considerazione esclusivamente il tempo grande: necessario osservare anche limportante rapporto dellunit artistica con la realt in senso pi stretto e concreto e attribuire la giusta rilevanza al valore cronotopico delle opere.
Dal giusto equilibro tra rapporto con la realt e ideale astratto, e pi in generale tra astoricit e contemporaneit assoluta, deriva limportanza del classico come trait dunion tra il passato e il presente che viviamo e come finestra su un futuro da co-struire, rifacendosi a quellideale rappresentato, appunto, dai classici.
Il tempo e la storia in Poema senza eroe di Anna Achmtova
Il rapporto dellopera con le altre forme precedentemente esistenti fu preso in for-te considerazione dalla scuola del formalismo russo, che nel primo Novecento si serviva delle opere precedenti e contemporanee come premessa per la creazione
di nuove forme letterarie, che mettessero in ombra le precedenti e venissero ine-sorabilmente messe in ombra a loro volta da forme pi evolute.
Al pensiero formalista strettamente legato il movimento poetico dellacmeismo, nato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale e poi sviluppatosi lungo tutto il Nove-
cento nella Russia sovietica. Lidea di tempo come elemento chiave trova spazio
-
Alex Pagnini Letteratura tra passato, presente e futuro
3
nelle opere di grandi poeti che si riconoscevano in questo movimento, tra i quali Osip Mandeltam, Nikolaj Gumilv e, soprattutto, sua moglie Anna Achmtova. proprio in unopera di questultima che il tempo e la storia assumono un ruolo determinante, dimostrato gi a partire dal titolo (come accadr poi per la raccolta
di poesie La corsa del tempo). Poema senza eroe, infatti, ci indica subito come il ve-ro protagonista sia, in realt, il tempo considerato sotto tutti gli aspetti. Il poema
diviso in tre parti ineguali, ognuna delle quali percorre un periodo storico diverso: per quanto riguarda il tempo storico si potrebbe dire, come ha osservato Kornej
ukovskij, che nel poema due sono gli eroi, due i Tempi. Due epoche polarmente antitetiche e ostili luna allaltra. Ciascuna notevole perch si presenta come vigilia deccezionali avvenimenti. Le due vigilie sono il 1913 e il 1940, che indicano rispettivamente lultimo anno della guerra dalla quale sarebbe nata la rivoluzione e lanno precedente allapertura del fronte orientale durante la Seconda Guerra Mondiale. Su questi due piani si svolge la vicenda, che narra il suicidio di un giovane innamorato di una bel-la donna e non corrisposto. Tratta da fatti realmente accaduti che gi in passato
avevano ispirato la Achmtova, la storia non coinvolta in uno svolgimento: la vi-cenda ferma nel tempo, viene evocata attraverso istantanee slegate che appaiono
allautrice durante la solitaria serata dellultimo dellanno del 1940. Questa discontinuit nella narrazione fa s che i due piani temporali, che rappre-
sentano passato e presente, si intersechino continuamente allinterno del poema, apportando numerosi riferimenti al proprio momento storico. In Poema senza eroe
la storia entra prepotentemente nella poesia della Achmtova, rompendone la di-stintiva atemporalit. Lautrice tenta il recupero storico di un passato che sembra-va ormai dimenticato e ne proietta le ombre sul proprio tempo presente, accostan-do in questo modo due epoche cariche di contenuti e di eventi decisivi per la storia
russa. Lopera si presenta, nella sua complessit, come sospesa tra lossessione del passato e la reazione al presente, basata su un piano continuamente in movimento
che la memoria della stessa Achmtova, unica poetessa russa prerivoluzionaria (oltre a Pasternk) ad aver continuato a scrivere in epoca sovietica.
Nella prefazione al poema lautrice si rivolge direttamente ai suoi lettori contem-poranei, come a voler instaurare un rapporto ancora pi forte con il proprio pre-
sente, da opporre alla rievocazione del passato. Un passato che, per, viene ricor-dato nella dedica: la Achmtova dedica il suo poema alla memoria di coloro che
per primi lascoltarono. Anche la memoria, quindi, si presenta da subito come te-ma centrale, che si ripresenta pi volte allinterno del poema costituendone un sot-tofondo persistente. In questo fitto reticolo costituito da passato e presente, la memoria si intreccia a sua volta con le vicende personali dellautrice: dopo larresto e la morte di persone a lei molto vicine (tra cui il figlio e il marito), il rap-porto con la realt divenne pi complesso. Raggiunto lideale di classicit dei gran-di poeti russi, la Achmtova temeva di perdere il contatto con il tempo che mutava, di non avere pi presa con una realt in continua evoluzione. Nei primi anni po-
strivoluzionari, spinta da questa paura, la Achmtova scrisse diverse raccolte di
-
Alex Pagnini Letteratura tra passato, presente e futuro
4
poesie in rapida successione, con forti riferimenti alla propria vita privata, ma sen-za che si notassero in esse sostanziali differenze. La Achmtova non aveva creduto
negli ideali della rivoluzione, era rimasta una poetessa radicata al passato prerivo-luzionario, fino a essere definita relitto di un passato da seppellire. Della Achm-
tova era stato creato uno stereotipo del passato della poesia russa, contrapposto al futuro riconosciuto in Majakovskij. Tuttavia, dopo la rivoluzione, la lirica achmato-
viana sub una forte scossa: non pi condannata a ripetersi, assunse il ruolo di voce del popolo. Il suo dolore divenne il dolore di tutti i russi che subivano le angherie
del regime. Il modo in cui il poema radicato alla realt, pur mantenendo una certa dimensio-
ne oltrestorica, contribuisce a rendere Poema senza eroe un classico della lettera-tura russa e ad affiancare la Achmtova ai grandi scrittori russi del Novecento. Il
filo rosso che collega lopera al canone classico richiamato inoltre dai molteplici riferimenti ai grandi classici (non solo della letteratura) presenti allinterno del poema: vengono citati Faust, Don Giovanni, Casanova, Don Chisciotte, Lorenzo de Medici, Bach, Botticelli.
Poema senza eroe di Anna Achmtova , quindi, un esempio di come i classici siano quelle opere sospese tra passato, presente e futuro; quelle opere indissolubilmente
legate alla contemporaneit e allattualit e allo stesso tempo attive in una dinami-ca oltrestorica e ultrastorica, protagoniste di quel gi citato tempo grande che racchiude tutti i cronotopi analizzati da Bachtin in una dimensione astratta ed eterna.
Limportanza della storia nella lettura critica
Riprendendo Calvino, evidente come lattualit sia inevitabilmente il punto in cui lo scrittore e il lettore devono situarsi per guardare in avanti o indietro, nel futuro o al passato. Diventa fondamentale, quindi, stabilire dove e quando il classico viene
scritto e successivamente letto, per evitare di perdere il necessario rapporto dello stesso con il tempo.
Risulta importante, a questo punto, osservare lanalisi del tempo e della storia allinterno della lettura critica dei classici svolta da due scrittori del Novecento a loro modo molto legati allattualit, quali Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino. Nel caso di Pasolini sono evidenti il suo interesse e il suo profondo rapporto con la
realt socio-politica del suo tempo. I suoi scritti militanti sono un esempio impor-tante di letteratura in stretta relazione con il mondo reale e con la propria storicit.
Il fatto stesso di scrivere brevi saggi sulle pagine di un quotidiano quale il Tempo conferisce agli scritti di Pasolini una ben delineata dimensione storica e temporale.
Non a caso, sia in Descrizioni di descrizioni sia nel successivo Scritti corsari i saggi sono raccolti in successione cronologica, come a indicare che, se venissero estrapo-
lati dal loro contesto storico e culturale, perderebbero qualsiasi valore critico e ar-tistico. Pasolini, in veste di scrittore come in quella di regista, descrive la realt. Lo
fa esponendosi in prima persona e confrontandosi con gli altri e con il proprio
-
Alex Pagnini Letteratura tra passato, presente e futuro
5
tempo, spesso esprimendo forti critiche, ma sempre tenendo ben in considerazione la dimensione storica delle proprie opere e, in qualit di critico, di quelle altrui.
Per quanto riguarda Calvino, il rapporto con il tempo e con la storia non altret-tanto evidente. Calvino preferisce occultare la figura dellautore e non esporsi; egli descrive la scrittura non come professione, ma come mestiere, che richiede tempo ed legato allo stesso. Il punto di partenza delle sue Lezioni americane una rifles-
sione sulla fine del millennio, sullo sviluppo della letteratura fino a quel momento e sulle ipotesi di sviluppo nel nuovo millennio. Il suo breve resoconto sul secondo
millennio apre una finestra sul futuro, nel quale Calvino si dice fiducioso: tale fidu-cia fondata sulla consapevolezza che esistono valori che solo la letteratura pu
trasmettere. Una simile riflessione costituisce la base di Per una biblioteca indispensabile, di Ni-
cola Gardini. Il progetto di Gardini consiste nello scrivere un libro sullItalia mi-gliore, avendo chiara cognizione di quella peggiore; e cercare nel passato, per amo-
re della vita, perch la vita pi nel passato che nel presente. Per farlo sceglie il 2011, anno del centocinquantesimo anniversario dellunit dItalia, e scrive un ca-talogo (come lui stesso lo definisce) di cinquantadue classici della letteratura ita-liana. Gardini sceglie dichiaratamente di rinunciare agli schemi della storia lettera-
ria, ma chiarisce subito che la lettura dei libri, a maggior ragione quella dei classici, deve poggiare su una base storica. Tale base storica coincide con la tradizione, vale
a dire con i rapporti che i libri instaurano gli uni con gli altri. Il lettore, secondo Gardini, deve essere in grado di riconoscere tali rapporti e deve utilizzarli per sta-
bilire limportanza di determinati testi. Dal confronto con le opere passate, quindi, deriva il valore umano e artistico del classico. In questa affermazione Gardini si
trova in perfetta sintonia con Calvino quando questultimo sostiene che un classi-co un libro che viene prima di altri classici; ma chi ha letto prima gli altri e poi
legge quello, riconosce subito il suo posto nella genealogia. In questo caso il rapporto dei classici con il tempo emerge, in primo luogo, come
relazione tra i classici tra di loro e con la loro storicit, fino a diventare un parame-tro per la definizione del canone classico.
Il canone e la storiografia della letteratura
Il concetto di canone vive, infatti, a stretto rapporto con la storia letteraria.
Questultima lespressione della memoria storica collettiva. Secondo Luperini il rapporto tra passato e presente non mai definitivamente fissato, ma in ogni mo-
mento subisce profonde trasformazioni: i mutamenti del presente si riflettono allindietro e la rilettura del passato si ripercuote sulla cultura del presente. La sto-riografia letteraria esprime quindi la memoria selettiva di una comunit, che porta nel tempo allaffermarsi di una tradizione letteraria, spesso oggetto di conflitti e dibattiti. Il ruolo del canone nello studio della letteratura consiste nel stimolare una co-
scienza critica nei confronti delle questioni storiche, filosofiche e letterarie del pas-sato. Per avere un quadro chiaro del nostro presente necessario acquisire la sen-
-
Alex Pagnini Letteratura tra passato, presente e futuro
6
sibilit e la cultura della contemporaneit e riuscire a guardare il passato attraver-so il punto di vista del presente. Senza la conoscenza dei caratteri della contempo-
raneit, lo studio del passato e la sua comparazione con il presente rischiano di di-ventare un esercizio inutile e noioso.
Conclusione
Tornando alle citazioni di Calvino da cui siamo partiti, dunque, possiamo aggiunge-
re una nuova definizione. classico ci che rende possibile una pi chiara visione del presente stimolando
una maggiore coscienza del passato e, viceversa, ci che attraverso la consapevo-lezza della contemporaneit consente una rilettura della storia.
-
Alex Pagnini Letteratura tra passato, presente e futuro
7
Bibliografia:
A. ACHMTOVA, La corsa del tempo: liriche e poemi, a cura di Michele Colucci, Torino,
Einaudi 1992
A. ACHMTOVA, Poema senza eroe, prefazione e traduzione di Carlo riccio, Torino:
Einaudi, 1966
M. BACHTIN, Estetica e romanzo, introduzione di Rossana Platone, Torino: Einaudi,
1997
I. CALVINO, Lezioni americane: sei proposte per il prossimo millennio, Milano: Monda-
dori, 1993
I. CALVINO, Perch leggere i classici, Milano: Mondadori, 1995
N. GARDINI, Per una biblioteca indispensabile: cinquantadue classici della letteratura italiana, Torino: Einaudi, 2011
R. LUPERINI, Il canone del Novecento e le istituzioni educative, in Il canone letterario del Novecento italiano, a cura di N. Merola, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2000
P. P. PASOLINI, Descrizioni di descrizioni, a cura di Graziella Chiarcossi, Torino: Ei-naudi, 1979
P. P. PASOLINI, Scritti corsari, prefazione di Alfonso Berardinelli, Milano: Garzanti, 2003
S. SETTIS, Futuro del classico, Torino: Einaudi, 2004