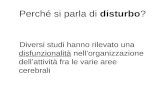Storia Economica | Dispensa > Managment
-
Upload
blab-bocconi -
Category
Documents
-
view
228 -
download
3
description
Transcript of Storia Economica | Dispensa > Managment
Dispensa di Business History
Managment Edizione A.A. 2014/2015
A cura di Chiara Leoni
CAPITOLO 1
La Business History inizia negli anni ’50 e ’60 nelle business school MBA.
Il principale oggetto di studio è la forma dell’impresa moderna, la quale è l’esito dell’interazione tra diverse variabili:
-gli assetti proprietari
-le strutture organizzative
-le strategie e scelte imprenditoriali.
…all’interno di un quadro definito da:
-tecnologia;
-istituzioni (regolamentazioni, legislazioni..);
-mercato.
La metodologia di studio implica un metodo induttivo (dall’analisi del particolare, il caso aziendale, si cerca di trarre delle generalizzazioni) sviluppato anche grazie all’interazione tra diverse discipline (tra cui la sociologia). Si adottano due prospettive:
-micro: settori, imprese, imprenditori;
-macro: nazioni, continenti, mondo
Vi sono tre variabili essenziali da utilizzare per capire quello si sta studiando:
-natura dei mercati;
� 1
-rapporto fra Stato-impresa
-culture nazionali (in ottica comparativa), cioè l’atteggiamento di una nazione nei confronti dell’attività economica e del cambiamento economico.
Si parte dal Muckracking, un filone molto importante di giornalismo economico. Si tratta dell’antecedente del giornalismo investigativo sulle grandi imprese. Questi accusano le grandi imprese statunitensi di essere dei “baroni ladri”.
Dall’altro lato ci sono coloro che vedono gli imprenditori come delle risorse (Schumpeter).
Alla fine Chandler cambia questo panorama, detronizza l’imprenditore, e mettendo al centro dell’analisi l’impresa.
Egli ha scritto tre grandi opere:
-Strategy and structure (1962)->comparazione fra imprese. Fu il primo vero studio sull’impresa multidivisionale. Venne realizzato attraverso la comparazione delle prime 100 imprese USA dal 1909 al 1948. Fu analizzato il funzionamento della loro “administration” (coordinamento,
controllo, valutazione e allocazione delle risorse). Il risultato dell’analisi empirica è stato
l’individuazione di fasi successive nella crescita dell’impresa: da struttura accentrata, all’inizio del secolo, alla diversificazione degli anni ’20.
-The visible hand (1976) ->comparazione fra settori
Si studia la seconda metà dell’800 (II Rivoluzione Industriale). La tecnologia impone il cambiamento dell’organizzazione dell’impresa e il ricorso alla “mano visibile” del management. Il libro è un’analisi del rapporto fra mercati, tecnologie e organizzazioni.
-Scale and scope (1990) ->comparazione fra nazioni
L’obiettivo era confrontare l’evoluzione della grande impresa in USA, Germania e UK per comprendere come le opportunità offerte dalla seconda Riv. Industriale siano state sfruttate da questi 3 paesi e con quali conseguenze.
I limiti sono:
-prospettiva incentrata sul caso USA;
-incapacità di cogliere le diverse tipologie di rapporto Stato-impresa;
-interesse esclusivo per la grande impresa.
� 2
Il culmine dell’analisi Chandleriana: l’impresa moderna per essere vincente sul mercato deve compiere un triplice investimento:
-produzione
-distribuzione
-gerarchia manageriale
Il punto di arrivo del triplice investimento è la formazione delle “capacità organizzative” (organizational capabilities, cioè un insieme di conoscenze e di persone in grado di gestire l’impresa in modo efficiente). Esse rappresentano il vero punto di forza con le quali l’impresa può anche ripensare se stessa e restare leader.
Ci furono due critiche a Chandler:
-Solo grandi imprese? Ci sono alternative storiche alla produzione di massa (Sabel e Zeitlin)
-The Vanishing hand (Richard Langloise): ora che i costi di transazione stanno svanendo, con essi svanisce anche la “mano visibile” e si torna verso il mercato.
CAPITOLO 2
A partire dalla prima rivoluzione industriale l’impresa è stata una delle più importanti unità di analisi per comprendere la crescita economica moderna.
Dall’inizio del XIX secolo l’impresa è stata identificata sempre con la “fabbrica”, cioè con la modalità inglese di organizzazione della produzione. La “fabbrica” non era una novità. Ciò che si presentava come nuovo era la speciale combinazione di un processo produttivo centralizzato con una tecnologia più efficiente. La specializzazione delle funzioni e la conseguente divisione del lavoro imponevano nuove forme di disciplina della manodopera. Così si creò un’organizzazione d’impresa altamente produttiva e sempre più efficiente, che diventò l’unità fondamentale delle prime economie industriali.
Le teorie d’impresa hanno migliorato la nostra comprensione delle attività interne all’impresa e delle sue relazioni con l’esterno, nel mercato e nei confronti di altre forme di autorità.
Le domande di fondo, da cui poi le teorie d’impresa partono a raggiera, sono:
CHE COS’E’ L’IMPRESA? L’impresa è un’organizzazione che trasforma i fattori di produzione in merci e servizi.
PERCHE’ ESISTONO LE IMPRESE? Perché nel mercato esistono costi di transazione.
PERCHE’ DIFFERISCONO LE UNE DALLE ALTRE? Dipende dal mercato nel quale l’impresa opera. Secondo Chandler ci sono settori destinati inevitabilmente alle grandi dimensioni (settori core). Chandler venne accusato di determinismo tecnologico.
� 3
Quello che emerge dalle teorie d’impresa è che:
-bisogna adottare una prospettiva comparativa poiché le imprese non sono tutte uguali: la loro forma varia in base al settore, e all’interno del medesimo settore in base al contesto di riferimento.
-l’impresa è un soggetto dinamico (tecnologia come agente del mutamento). Le imprese che suscitano il maggior interesse da parte degli storici sono quelle che mostrano la tendenza alla crescita dimensionale. Questo accade sia nei settori ad alta intensità di capitale, sia nei settori ad alta intensità di lavoro. Data una certa tecnologia, ci si aspetta che le imprese si espandano fino al punto in cui i rendimenti marginali iniziano a decrescere. Nel mondo reale, tuttavia, la crescita non è un processo meccanico, soggetto solo ai calcoli economici. Le imprese possono continuare ad espandersi anche in presenza di una riduzione nel tasso di crescita dei profitti. Inoltre possono anche volontariamente frenare la crescita limitando la loro dimensione, per evitare i problemi connessi all’espansione.
-vi è complessità relazionale in quanto le imprese hanno un vasto impatto sull’ambiente circostante.
I fattori che influenzano la struttura dell’impresa sono molteplici. Tra questi i più importanti sono:
-la tecnologia
-i mercati
-l’efficienza dei mercati finanziari nel convogliare le risorse necessarie alla stessa;
- la presenza di un sistema giuridico in grado di proteggerne i suoi asset e di facilitarne l’attività economica.
-la cultura
La prospettiva neoclassica (Alfred Marshall)
È un approccio analitico piuttosto statico che considera il comportamento dell’impresa in un segmento temporale definito. L’equilibrio che si raggiunge nel mercato è stabile.
Secondo questa teoria, tutte le imprese sono uguali e tendono alla massimizzazione del profitto (Ricavo marginale=Costo marginale). Sono quindi in concorrenza perfetta e conoscendo perfettamente il mercato non possono influenzarne né i prezzi né la tecnologia (esogena). Non vi è modo di diversificarsi dai concorrenti in quanto le conoscenze tecnologiche e le informazioni sono ipotizzate come liberamente disponibili o ottenibili a costi minimi.
Si parla, quindi, d’impresa rappresentativa, cioè di un’impresa simbolo di tutte le altre, identiche ad essa. È di dimensioni medio-piccole e svolge un numero limitato di funzioni. Esempi d’imprese simili a quelle proposte dalla teoria neoclassica erano le imprese scarsamente
� 4
integrate, che operavano su una singola fase del processo produttivo nell’industria cotoniera o nei distretti dove si lavoravano i metalli nella prima fase dell’industrializzazione britannica (distretto marshalliano).
Debolezze dell’analisi neoclassica:
-Questa impresa non è orientata alla crescita perché la sua espansione si ferma al raggiungimento della dimensione media determinata dal punto più basso della curva dei costi. Inoltre, le modalità della crescita, così come le risorse impiegate, erano considerate esogene.
-è poi irrilevante la distribuzione del potere all’interno e all’esterno dell’impresa, o il suo funzionamento. L’impresa resta, quindi, una scatola nera.
Molti anni fa l’economista austriaco Schumpeter ha lanciato una sfida all’approccio neoclassico. La sua riflessione era costruita su due assunti fondamentali:
-egli vede il funzionamento del sistema economico in modo ciclico (Teoria Austriaca del ciclo economico) con fasi di espansione ed altre di recessione. Non si arriva mai ad un equilibrio. Vi è disequilibrio. L’espansione avviene grazie alla tecnologia, ma quando le onde d’innovazione tecnologica si esauriscono, il sistema entra in recessione.
-egli ritiene che la propensione competitiva dell’impresa sia il principale motore della crescita economica.
La grande impresa schumpteriana sfidava così il concetto neoclassico dell’impresa rappresentativa. Egli era interessato al ruolo innovativo dell’impresa e al modo in cui l’innovazione veniva realizzata sotto la guida dell’imprenditore, mentre poneva un’enfasi minore sulle strutture organizzative e su ciò che realmente accadeva al suo interno (le imprese restano in gran parte delle scatole nere).
La situazione cambiò dopo la seconda guerra mondiale, quando venne sviluppata la maggior parte delle nuove teorie dell’impresa. Gli studiosi iniziarono ad interessarsi con successo alla grande impresa, verticalmente integrata, multidivisionale, multinazionale e a guida manageriale. Questo tipo di organizzazione era in parte responsabile della leadership economica americana negli anni ‘50. La comprensione dei meccanismi di governo della grande impresa era quindi considerata estremamente importante proprio per capire il “mistero” dello sviluppo economico. Per la prima volta si stabiliva una stretta relazione tra il livello microeconomico dell’impresa e il livello macroeconomico, ovvero la ricchezza della nazione.
In molti settori, la grande dimensione dell’impresa appariva come quella ottimale, mentre il sistema economico sembrava tendere a un assetto oligopolistico, piuttosto che alla competizione perfetta.
� 5
Peter Drucker, “guru” sui temi del management, dedicò uno dei suoi primi libri “The concept of the Corporation” (1946), all’emergere di questo tipo d’impresa. Partendo dalla sua conoscenza della General Motors (in cui fu ospite per due anni), Drucker ha descritto nei dettagli questo nuovo attore economico, sostenendo che la grande impresa potesse essere compresa al meglio qualora si fossero analizzate:
-le sue fondamenta tecnologiche;
-lo “sforzo” necessario al coordinamento efficiente della moltitudine di individui in essa operante;
-l’impatto sociale che questa impresa ha sul capitalismo moderno.
Egli vede dunque l’impresa come un’istituzione sociale, un intreccio di variabili tecnologiche e umane.
Questo nuovo approccio teorico presentava diverse declinazioni che andavano ad indagare all’interno della scatola nera:
-la comprensione delle determinanti e delle dinamiche relative alla crescita dell’imprese a livello nazionale e internazionale;
-le decisioni (più tardi definite strategie) da dover intraprendere;
-l’architettura organizzativa ottimale dell’impresa;
-i ruoli e i modelli di comportamento degli attori operanti all’interno delle organizzazioni (il rapporto fra individui e organizzazione).
Un’attenzione crescente venne dedicata alla tecnologia, considerata quale motore principale del processo di crescita. Innovazioni di prodotto e di processo resero più conveniente, e talvolta obbligata, l’espansione della dimensione produttiva.
Si passa, quindi, dalla teoria d’impresa alla teoria della crescita dell’impresa.
Alfred Chandler ha analizzato gli effetti di questa trasformazione indotta dalla tecnologia sull’organizzazione e sulla performance dell’impresa. Egli ha evidenziato le risposte imprenditoriali, sul piano organizzativo, al cambiamento tecnologico, dando così inizio a un filone di studi riguardante la relazione interattiva fra la strategia e la struttura di una grande impresa (libro Strategy and structure).
Chandler considerava il cambiamento tecnologico come una forza esogena che aveva un impatto decisivo sulle scelte imprenditoriali. Nella sua prospettiva, i “paradigmi” tecnologici (un insieme di principi scientifici e tecnologici che producono “traiettorie dominanti”) determinano la competitività delle imprese e le loro strutture organizzative ottimali.
� 6
Altri studiosi hanno sottolineato, invece, la natura endogena del progresso tecnologico e dell’attività innovativa, che sempre più diffusamente si è svolta all’interno dei laboratori di ricerca e sviluppo delle grandi aziende. Quando la tecnologia viene generata essenzialmente all’interno dell’impresa, e si presenta come conoscenza particolare e originale della stessa, questa tecnologia diventa una risorsa strategica e spesso all’origine di uno dei più importanti vantaggi competitivi.
A tal proposito, l’economista americana Edith Penrose, nel suo libro “The Theory of the Growth of the Firm” (1959), ha evidenziato un nuovo tema (approccio resurced based view). Secondo l’autrice, le imprese sono stratificazioni di risorse e competenze. Tutte le imprese sono diverse e con esse le capacità umane (firm specific). Il processo di crescita è spiegato dall’abilità dell’impresa di sfruttare al meglio le sue capacità materiali e umane. Nel corso del tempo la stessa impresa evolve, produce nuova conoscenza e accumula capacità applicabili in una varietà di settori diversi. Le risorse umane (capabilities) sono il frutto dell’attività e dell’esperienza dell’impresa: non possono essere acquisite sul mercato.
Sulla base delle idee di Schumpter e di quelle elaborate dalla Penrose, due economisti, Nelson e Winter, hanno elaborato il concetto di routines, cioè le modalità con cui le organizzazioni sono in grado di ricordare il comportamento di successo per mantenere le loro posizioni di vertice. Gli agenti economici (le imprese fra questi) sono caratterizzati da razionalità limitata e da apprendimento cumulativo basato sull’esperienza e su procedure “per tentativi ed errori”. Essi cercano di ridurre l’incertezza adottando routines (conoscenze tacite) che inducono a ripercorre i sentieri noti e conosciuti (path dependance). Questo spiega la diffusa resistenza al cambiamento da parte di individui e organizzazioni.
L’idea che l’impresa moderna agisca come deposito di competenze si distacca definitivamente dalla concezione neoclassica, generando ad esempio una serie di riflessioni teoriche centrate sulle strategie di internazionalizzazione delle grandi imprese. Dopo la seconda guerra mondiale le corporation statunitensi assunsero una posizione di dominio internazionale per quanto riguarda gli investimenti diretti all’estero. Nel 1960, a un anno di distanza dalla pubblicazione del libro della Penrose, Hymer propose una spiegazione convincente dell’espansione dell’impresa multinazionale: questa era fondata sulla premessa che il vantaggio competitivo acquisito da un’impresa sul mercato interno potesse essere sfruttato, in seguito, anche all’esterno. L’analisi di Hymer venne ulteriormente sviluppata da altri studiosi nella seconda metà degli anni Sessanta. Jhon Dunning propose una spiegazione dell’attività internazionale delle imprese basata su una combinazione di vantaggi competitivi sviluppati sul mercato interno (vantaggi di proprietà) e vantaggi presenti nel paese ospite (vantaggi di localizzazione, per esempio una forza lavoro specializzata).
Nei primi anni Sessanta Robin Marris sviluppò un’altra importante area di ricerca con la pubblicazione del volume “The Economic Theory of Managerial Capitalism” (1964). Nella sua analisi la crescita dell’impresa è attribuita all’interesse personale (self-interest) del management.
� 7
Ai manager non interessa ottenere il massimo profitto, gli interessa solo la crescita dimensionale dell’impresa in quanto questa impatta sulla loro reputazione, immagine e remunerazione. Le loro scelte arrivano però a scontrarsi con gli interessi degli azionisti, più sensibili alle performance e all’eventuale distribuzione dei dividendi che alle strategie di crescita. In questa prospettiva, quindi, il processo di crescita di un’impresa finisce per essere il risultato di una sorta di contrattazione fra manager e azionisti.
Marris ha gettato le basi per un successivo dibattito, quello sulla relazione fra “principale” e “agente” formalizzato nella cosiddetta teoria dell’agenzia.
Nel 1976 due studiosi americani, Michael Jensen e William Meckling hanno pubblicato un articolo dal titolo “Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure”. L’analisi si concentrava sui problemi che sorgono nel rapporto fra gli azionisti (coloro che detengono la maggioranza del capitale dell’impresa, definiti principal) e i manager (che possiedono solo una frazione minima di capitale di rischio, denominati agent). La teoria dell’agenzia considera l’impresa come una sorta di “finzione legale” (l’impresa non viene più vista come un insieme di persone e risorse, ma un insieme di contratti).
La redistribuzione degli utili, in presenza di interessi potenzialmente conflittuali tra principale e agente, spiega la necessità di un allineamento tra gli interessi.
L’idea dell’impresa come “artificio legale”, destinato a risolvere i problemi emergenti dall’interazione fra i vari attori economici, è stata alla base di un’altra feconda corrente di studi, che si è proposta di spiegare la ragione dell’esistenza stessa dell’impresa: la teoria dei costi di transazione. L’origine di questa teoria risale all’articolo pubblicato da Ronald Coese nel 1937 intitolato “The nature of the Firm”. La questione fondamentale proposta allora da Coese era la seguente: perché esistono le imprese? La risposta è: a causa dell’inefficienza dei mercati. Secondo Coese le imprese devono la loro origine alla necessità di contenere i costi che le transazioni di mercato comportano (ricerca, negoziazione e monitoraggio). Il limite della loro dimensione è laddove il costo di organizzare la transazione eguaglia quello della sua effettuazione sul mercato.
Il nucleo della riflessione di Coase fu in seguito sviluppato da Williamson in un importante volume dal titolo Markets and Hierarchies. Secondo Williamson, le transazioni comportano costi di ricerca e controllo. In un quadro in cui l’azione degli attori economici è caratterizzata da asimmetria informativa, razionalità limitata e inclinazione a comportamenti opportunistici, più le risorse sono strategiche, maggiori sono i costi di transazione legati al loro scambio (il punto di partenza è dunque il comportamento dell’uomo contrattuale).
Oltre ai rischi insiti nel comportamento, le transazioni richiedono strutture di governo specializzate (le imprese) anche a causa di condizioni specifiche:
-specificità delle risorse (investimenti)
� 8
-incertezza (contratti incompleti)
-frequenza e ripetizione delle transazioni.
Questo sistema però dà anche la possibilità alle imprese di internalizzare alcuni tipi di transazione senza dover ricorrere al mercato, per esempio quelle ricorrenti o quelle che coinvolgono le attività strategiche, decisive per la sopravvivenza stessa dell’impresa.
La teoria dei costi di transazione ha avuto un potente impatto sugli studi di business history. Ha aiutato a comprendere meglio una serie di eventi storici, dall’affermazione del sistema di fabbrica alle strategie di crescita perseguite, attraverso l’integrazione verticale, per giungere alla grande impresa industriale.
Infine, la teoria dei costi di transazione, ha fornito un’interpretazione convincente dell’efficienza di sistemi alternativi alla produzione di massa. Fra questi, per esempio, i distretti industriali, nei quali unità produttive specializzate di piccole dimensioni hanno beneficiato di un coordinamento informale fondato sull’appartenenza a un sistema locale di valori condivisi: questo ha abbassato l’incertezza negli scambi e quindi i costi di transazione, eliminando anche la necessità, per una singola azienda, di crescere ricercando strategie di integrazione verticale.
All’inizio del nuovo millennio sono emersi diversi modelli organizzativi e differenti approcci teorici. Le tecnologie della terza rivoluzione industriale (elettronica e telecomunicazioni) hanno avuto infatti un impatto profondo sulla struttura e sulle dinamiche delle aziende; nuove forme di coordinamento del processo produttivo hanno acquistato importanza (network). Le nuove tecnologie informatiche hanno facilitato un processo di coordinamento fra aziende, che a sua volta ha favorito una sostanziale riduzione dell’incertezza e dei costi di transazione. L’esito complessivo dei recenti sviluppi appare quindi il ridimensionamento del ruolo della grande impresa integrata a guida manageriale, a favore del rafforzamento dei meccanismi di mercato, in particolare nei settori che hanno visto la diffusione dell’organizzazione produttiva modulare. Singoli componenti, legati l’uno con l’altro, possono essere infatti sviluppati all’interno di unità produttive relativamente piccole e indipendenti, che portano avanti il processo di innovazione in maniera coordinata.
Dopo un secolo all’insegna dei processi di integrazione, sembra che il presente stia disegnando la prospettiva della disintegrazione (the vanishing hand).
� 9
CAPITOLO 3
L’imprenditorialità appare centrale per la ricchezza e la competitività di una nazione. Tuttavia, nonostante la sua riconosciuta centralità nel processo economico, l’imprenditorialità è un fenomeno elusivo, un concetto molto difficile da definire con chiarezza.
Questa stessa incertezza e confusione si ritrova nella comunità accademica, al punto che l’economista Baumol scrive: “L’imprenditore è il più intrigante e il più elusivo dei personaggi che costituiscono il soggetto dell’analisi economica”.
Nel periodo a cavallo fra il XIX e XX secolo si sviluppò un clima intellettuale, il quale sottolineava il ruolo della cultura nella spiegazione dell’attività imprenditoriale. Si pensi a figure di enorme importanza come Max Weber, il quale descrive l’imprenditore come portatore di una “razionalità strumentale” che lo rende capace di mettere in relazione il perseguimento del profitto con i mezzi più adatti a raggiungerlo oppure Sombart, il quale sottolinea le caratteristiche elitarie dell’imprenditore, che con la sua energia vitale e la sua creatività dà vita a fattori economici, quali il lavoro e il capitale, che altrimenti potrebbero essere considerati inerti. Per questi individui la ricchezza non è il fine; al contrario, essi aspirano all’ascesa sociale e sono sostenuti dalla gioia della creazione, dal piacere della vittoria contro i loro concorrenti e dalla consapevolezza del loro ruolo quali capi di imperi economici.
In ogni caso nessuno più di Schumpeter ha posto l’imprenditore al centro del sistema economico, considerandolo il motore della crescita.
Primo Schumpeter (fino agli anni ’30 in Europa): l’imprenditore è innovatore (non necessariamente inventore). Gli imprenditori creano nuovi prodotti, nuovi metodi di produzione, nuovi mercati, nuove fonti di materie prime o una nuova forma organizzativa. L’innovazione, che giustifica il profitto imprenditoriale, non si adatta alla domanda corrente, ma impone il suo prodotto sul mercato. Innovazione significa cambiamento, squilibrio, “distruzione creatrice”; essa non coincide con l’invenzione, ma è la realizzazione di questa a livello economico. In tale visione, l’imprenditore è una sorta di “traduttore” che compie ogni sforzo per trarre vantaggio dalle onde lunghe della tecnologia delineate da Kondratieff: dal 1786 al 1842 l’onda caratterizzata dai grappoli d’innovazioni nei settori tessile e metallurgico; dal 1843 al 1897 le innovazioni concentrate nel settore delle ferrovie; dal 1897 allo scoppio della seconda guerra mondiale, quando i settori elettrico, chimico e automobilistico nacquero e iniziarono un periodo crescente di espansione. L’innovazione tecnologica risulta cruciale per l’eroe schumpeteriano il quale era soprattutto un uomo impegnato nella produzione, non necessariamente colui che assumeva il rischio d’impresa (e non necessariamente un proprietario).
Secondo Schumpeter (dal 1933 in USA): non c’è più spazio per l’imprenditorialità individuale. Vi è solo un’imprenditorialità trustificata all’interno delle grandi imprese.
In ogni modo, il primo Schumpeter si contrappone in modo rilevate alla visione classica e neoclassica dell’imprenditore. Infatti egli osserva che, se leggiamo The Wealth of Nations di
� 10
Smith o i Principles di Ricardo ricaviamo l’impressione che il processo economico avanzi per forza propria. Nell’analisi di Adam Smith, la funzione più importante dell’uomo d’affari è quella di fornire il capitale, mentre Ricardo sottolinea ancora più chiaramente l’automatismo dei movimenti economici. Il meccanismo cruciale alla base dello sviluppo economico è l’accumulazione del capitale, non l’innovazione! Al massimo l’imprenditorialità è un fattore residuo.
L’imprenditorialità è stata così sempre trascurata a causa del successo del paradigma neoclassico fondato sul concetto dell’equilibrio del mercato. Qui, l’impresa viene vista come il luogo in cui i fattori produttivi sono trasformati in beni sulla base di meccanismi conosciuti e prevedibili; l’incertezza deriva da variabili esogene quali il prezzo di vendita dei beni o il prezzo dei fattori produttivi utilizzati. In questo schema l’imprenditore deve soltanto scegliere la combinazione produttiva più efficiente e valutare che gli “ingredienti” siano assemblati in modo coerente.
Sempre in quest’ottica Edward Denison, cercando di individuare l’origine della crescita degli USA nel periodo 1900-1960, menziona fattori quali il progresso tecnologico, il capitale umano, la riallocazione delle risorse, il cambiamento istituzionale, mentre non cita l’imprenditorialità in quanto la considera automaticamente inclusa nei vari input.
C’è però una via di mezzo fra Schumpeter e la teoria neoclassica. Partiamo, ad esempio, da Richard Cantillon, il primo pensatore moderno (1680-1734). In un suo articolo troviamo per la prima volta il termine “imprenditore”, un mediatore che acquista beni a un prezzo dato per poi rivenderli ad un prezzo ancora non determinato. Cantillon riconosce nell’imprenditore il vero motore dell’economia. Secondo lui l’imprenditore è un individuo abile nel fronteggiare l’incertezza e questi rischi assunti giustificano i suoi profitti. Inoltre l’imprenditore è diverso dal capitalista poiché egli ha anche il compito di organizzare la produzione.
Jean Baptiste Say lega l’imprenditore all’organizzazione. La skill distintiva dell’imprenditore è la sua capacità di far concorrere differenti elementi, come il lavoro e le risorse finanziarie, in un’unica visione tesa alla creazione di un prodotto. Il primo compito dell’imprenditore è creare e guidare un’organizzazione di produzione (agente principale della produzione).
Anche Alfred Marshall colloca l’imprenditorialità all’interno della routine gestionale, sia pure distinguendo un ruolo imprenditoriale dedicato alle decisioni fondamentali da un ruolo manageriale caratterizzato da un potere delegato. Nella concezione di Marshall l’imprenditore non è una personalità eccezionale; al contrario egli è ritratto nella sua attività quotidiana, profondamente inserito nell’impresa e impegnato a far funzionare l’organizzazione.
Nella maggioranza dei casi quindi, per essere sicuro che le sue idee si realizzino e per sostenerle, l’imprenditore è indotto a creare un’impresa con un’organizzazione, un sistema di risorse fisiche e umane tenuto insieme da relazioni gerarchiche. Il tessuto connettivo dell’impresa è rappresentato dagli strati intermedi del management, collocati fra i lavoratori e
� 11
l’imprenditore. In questo modo le direttive dell’imprenditore sono trasmesse all’intera organizzazione ed egli può controllarne la realizzazione.
Negli Stati Uniti, la nascita della grande impresa e l’ascesa del management hanno avuto l’impatto maggiore sugli studi della prima metà del XX secondo in cui si enfatizza la centralità dell’organizzazione rispetto a un’imprenditorialità, la cui forza va svanendo.
Nel suo primo importante lavoro Chandler distingue attentamente le funzioni di un imprenditore da quelle di un manager. Mentre il primo ha la responsabilità di allocare le risorse ai massimi livelli dell’impresa, il secondo agisce all’interno di un sistema di risorse creato dall’imprenditore. Compito imprescindibile dell’imprenditore è la creazione di un’organizzazione burocratica dotata di un’ampia gerarchia manageriale. Questo network è essenziale per il buon funzionamento della grande impresa, a sua volta strumento indispensabile per la crescita e la competitività economica.
Molto più recentemente alcuni economisti hanno sottolineato la dimensione psicologica dell’azione imprenditoriale. Israel Kirzner, il quale appartiene alla “scuola austriaca”, considera l’attenzione (alertness) come l’essenza dell’agire imprenditoriale. L’attenzione è descritta come l’abilità di riconoscere le opportunità che nascono dall’errata allocazione delle risorse sul mercato. Si intende cioè la capacità di prevedere l’andamento dei prezzi, non essendoci informazione perfetta nel mercato. A questo fine è necessario possedere creatività, immaginazione, abilità di anticipare gli eventi e di individuare le giuste fonti di informazione sulla situazione dei mercati.
Ancora, sul versante che sottolinea l’importanza della relazione fra economia e psicologia, troviamo Mark Casson, che definisce come il talento più importante per un imprenditore la sua abilità di prendere decisioni appropriate riguardanti il coordinamento delle risorse in condizioni di scarsità. L’imprenditore è diverso dalle altre persone per la sua abilità di riconoscere le situazioni in cui è possibile trarre un profitto.
Un’ultima definizione di imprenditorialità viene fornita da Thurik e Wennekers:
“Entrepreneurship is the manifest ability of individuals, on their own, in teams, within and outside existing organizations, to perceive and create new economic opportunities (new products, new production methods, new organizational schemes and new product-market combinations) and to introduce their ideas in the market, in the face of uncertainty and other obstacles, by making decisions on location, form and the use of resources and institutions”.
Loro individuano 4 tipi di imprenditori sulla base di due variabili:
-se è una persona autonoma o meno;
-se è un innovatore o un manager.
� 12
�
Alla fine, qualsiasi definizione o rappresentazione si voglia dare dell’imprenditorialità, non possiamo non collocarla all’interno del sistema economico, sociale, culturale o politico del quale è parte (immagine suggestiva dell’ “effervescenza collettiva” di Durkheim come precondizione per l’imprenditorialità).
Per quanto il fenomeno dell’imprenditorialità possa essere elusivo, sono stati condotti vari tentativi di misurazione. Un esempio è offerto dal lavoro del sociologo Wilken, volto a comprendere il valore dell’impatto dell’imprenditorialità sullo sviluppo economico nazionale.
Sempre di più nel corso dei decenni il concetto di imprenditore si è esteso e sta aumentando il tasso di imprenditorialità in tutto il mondo.
� 13
CAPITOLO 4
Si analizza la trasformazione storica ed economica dall’età preindustriale all’epoca industriale.
Molto prima dell’età dominata dalle fabbriche inglesi, gli uomini d’affari avevano sviluppato nuove combinazioni di capitale, lavoro e risorse naturali (la terra) per rispondere alla domanda di beni e servizi.
L’Europa preindustriale non si presentava come un’area economica omogenea. Tuttavia i paesi condividevano alcuni tratti comuni, ed esempio la preponderanza del settore primario, a cui le stime attribuiscono una quota fra l’80 e il 90% del PIL. La forza lavoro era infatti composta soprattutto da contadini e dalle loro famiglie, che lavoravano appezzamenti di terra trasmessi di generazione in generazione. La mobilità era contenuta, come modesto era il livello di urbanizzazione.
Nel mondo stazionario pre industriale non c’era crescita del PIL pro-capite. Nonostante alcuni miglioramenti delle tecniche agricole, la produzione alimentare mostrava incrementi minimi. Il potere d’acquisto era concentrato quasi esclusivamente nelle mani di un’esigua quota della popolazione totale, cioè coloro che possedevano e controllavano l’attività economica, agricola e industriale.
Condizioni climatiche negative e lunghe guerre causavano imprevedibili flessioni nella produzione; la malnutrizione rendeva le popolazioni vulnerabili alle malattie e le periodiche carestie avevano effetti devastanti sulla dinamica demografica.
In questa fase si possono individuare quattro diverse tipologie principali di organizzazione della produzione:
-L’industria domestica:
È svolta dai componenti della famiglia (unità di produzione fondamentale) per far fronte al bisogno di beni non agricoli. La produzione e il consumo avvengono ad opera dei medesimi soggetti. È localizzata prevalentemente nelle campagne, nelle zone più povere e lontane dalle vie di comunicazione. Vi è la quasi totale assenza di transazioni di mercato e specializzazione.
-Putting-out system:
Dopo il XV secolo, a seguito della positiva diffusione di nuove tecniche nella coltivazione dei terreni, si arrivò a disporre di un surplus agricolo. L’economia nel suo complesso diventa progressivamente più dinamica, grazie alla diffusione di una serie di importanti innovazioni nel settore primario, la cosiddetta “rivoluzione agraria”. L’espansione della domanda stimolò allora lo sviluppo del commercio a lunga distanza, a sua volta sostenuto dai miglioramenti nelle tecniche di navigazione e di costruzione delle navi. Si perfezionano in questo periodo anche alcuni strumenti legali per definire contratti e per regolare le transazioni finanziarie complesse e rischiose tra i soci che operavano su mercati talvolta molto distanti. L’efficienza dei mercati
� 14
finanziari traeva contemporaneo giovamento dall’introduzione di innovazioni come la cambiale e la banconota.
Le campagne, di conseguenza, erano diventate un importante serbatoio di manodopera eccedente (a causa dell’aumento della produttività agricola che aveva lasciato molte famiglie, ora più numerose, con un piccolo lotto di terra da coltivare). I contadini poveri potevano dedicare una parte del loro tempo ad attività non agricole e la manifattura rappresentava un’alternativa all’emigrazione. La presenza di una manodopera poco costosa incoraggiò gli imprenditori a trasferire in campagna alcune fasi produttive della manifattura, sviluppando il putting-out system, basato su un’architettura gerarchica ma flessibile. Al vertice dell’organizzazione vi era il mercante-imprenditore, proprietario delle materie prime, il quale coordinava l’attività di una rete di lavoratori a domicilio impegnati in alcune fasi del processo produttivo. Il mercante-imprenditore controllava direttamente le fasi di lavorazione ad alta intensità di capitale, quelle che consentivano più elevate economie di scala, e la vendita. Il putting-out system era diffuso soprattutto nelle lavorazioni tessili, dove il processo produttivo poteva essere facilmente segmentato in fasi da svolgere separatamente. L’efficienza di questa formula di organizzazione derivava, oltre che dall’ampia disponibilità di manodopera rurale a basso costo, dall’elevata flessibilità del sistema: la rete di lavoranti poteva essere facilmente estesa o ridimensionata a seconda delle fluttuazioni della domanda, senza aggravio di costi per lo stesso imprenditore: l’unità produttiva coincideva infatti con la famiglia contadina, proprietaria di un capitale fisso poco costoso e di semplice manutenzione (per esempio i telai a mano).
In questo sistema, come in altri caratterizzati da un’organizzazione decentrata, i costi di transazioni e di esercizio erano destinati a crescere in proporzione all’espandersi della produzione. Il mercante esercitava infatti un controllo scarso sulla qualità del prodotto e sull’efficienza e affidabilità della forza lavoro, pagata a cottimo in base alla quantità di pezzi prodotti. Le tecnologie rudimentali in uso nella manifattura domestica rurale non richiedevano particolari competenze da parte dei lavoranti; il sistema nel suo complesso non incentivava però il miglioramento e può aver rallentato l’introduzione di strumenti e tecniche produttive più efficienti.
Quali sono le differenze con l’industria?
-forza lavoro dispersa
-no tecnologia
-no forme di apprendimento tecnico (il mercante non governa l’innovazione)
-il mercante non garantisce la qualità del prodotto finito
-L’artigianato:
� 15
Caratteristiche di questa attività erano un maggiore livello di complessità organizzativa, tecniche più sofisticate e la presenza di lavoratori specializzati (sebbene vi sia comunque scarsa divisione del lavoro e bassa produttività). I lavoratori erano impiegati in settori a più elevata intensità di capitale e dediti a mansioni in cui maggiore era il valore aggiunto al prodotto finale.
La localizzazione di queste attività artigiane dipendeva dalla disponibilità di materie prime e dalla vicinanza alle fonti di energia a basso costo: acqua, vento, legna o carbone; di conseguenza, la modalità di insediamento vedeva la formazione di sistemi produttivi altamente specializzati che aggregavano gruppi di artigiani in aree geografiche definite, in campagna o prevalentemente nell’ambiente urbano.
L’organizzazione interna di un’unità produttiva artigiana era semplice e fondata su una rigida gerarchia. Il maestro, proprietario della bottega, gestiva l’intero processo produttivo supervisionando il lavoro degli apprendisti. Questi ultimi, retribuiti a cottimo, imparavano i segreti della professione direttamente sul lavoro e, dopo un lungo periodo di apprendistato, erano pronti a diventare maestri a loro volta, iniziando un’attività propria.
La maggioranza delle botteghe restava di modeste dimensioni, legata alla presenza del maestro che, proprietario del capitale fisso e delle materie prime, era anche l’unico responsabile della commercializzazione dei prodotti e di tutte le attività collegate.
Il maestro e la sua bottega erano parte integrante di un sistema organizzato più ampio, la corporazione, la quale riuniva le attività (arti) specializzate dello stesso tipo.
-La corporazione:
Alla base della rigida struttura corporativa vi era un precisa regolamentazione scritta. La corporazione operava sulla scorta di due principi fondamentali:
-la tutela dell’uguaglianza economica fra i membri (regolamentazione della quantità, della qualità, del prezzo delle merci prodotte e dell’accesso al mercato del lavoro).
-la concentrazione del monopolio della produzione nelle mani degli associati.
Alcune delle competenze della corporazione riguardavano: la composizione dei conflitti fra i membri, il controllo dell’osservanza degli standard qualitativi, l’articolazione dei meccanismi di formazione degli apprendisti e il monitoraggio dei costi di produzione.
Gli obiettivi del sistema corporativo variavano in relazione all’area di insediamento e alla particolare situazione politica, ma la regolazione dell’attività artigianale presentava in ogni modo molti vantaggi. Ad esempio le corporazioni regolavano l’accesso al mercato del lavoro operando una selezione attraverso l’obbligo di lunghi periodi di apprendistato. In aggiunta gli artigiani inseriti nel sistema corporativo godevano di una protezione e di una stabilità lavorativa rari nell’economia preindustriale.
� 16
Un lungo dibattito storiografico ha però evidenziato come gli aspetti positivi dell’organizzazione corporativa fossero oscurati da molteplici svantaggi derivanti dalla posizione di monopolio di cui quasi ovunque essa godeva: questa consentiva di mantenere prezzi relativamente elevati restringendo la produzione e limitando la domanda, e inibiva il processo di innovazione tecnologica attraverso il severo controllo delle tecniche produttive. Il sistema corporativo era conservatore: l’introduzione e la diffusione dell’innovazione tecnologica erano scoraggiate perché ne minacciavano la stabilità, e questo è evidente nel caso inglese, che ha visto il sistema di fabbrica affermarsi eludendo i controlli corporativi.
Il sistema corporativo ha sofferto un progressivo indebolimento nel corso del Cinquecento, e quasi ovunque è stato abolito entro la fine del XVIII secolo. È del resto importante sottolineare che tale sistema rappresentava una frazione circoscritta dell’attività manifatturiera preindustriale; il suo impatto sull’economia europea è stato di conseguenza limitato e inoltre la sua fisionomia “istituzionale” non arrivava a influenzare in profondità le modalità di produzione al livello dell’organizzazione del lavoro nelle botteghe.
Lo storico Cipolla vide nelle corporazioni un freno allo sviluppo nel lungo periodo e la causa del declino economico italiano di fine 600.
Quando la domanda aumentò ulteriormente, già in epoca preindustriale, comparvero le grandi imprese (es. i cantieri, le miniere o l’Arsenale navale di Venezia che durante la Repubblica produsse tutte le navi da guerra dello stato veneto). Si tratta tuttavia di isole in mezzo al mare (sia riguardo al numero degli addetti, ma anche riguardo alla percentuale di produzione realizzata).
Un aspetto che differenza le imprese pre industriali da quelle di fine 800 è il loro carattere orizzontale. Vi è una totale assenza di gerarchie manageriali e di sistemi di divisione del lavoro: il più delle volte si tratta di aggregazioni orizzontali di squadre di lavoratori.
I governi o, più spesso, la Corona, interessati direttamente nelle attività economiche, garantivano vantaggi e protezione agli imprenditori privati per stimolare l’insediamento di impianti specializzati nella produzione di particolari categorie di beni. Le motivazioni di questi interventi erano varie e andavano dalla necessità di assicurarsi la fornitura di alcuni prodotti “strategici” (navi e armi) al perseguimento di politiche mercantilistiche dirette a contenere l’acquisto all’estero di merci ad alto valore aggiunto. È questa l’origine della Saint-Gobain, oggi uno dei maggiori produttori internazionali nel comparto del vetro: fondata nel 1665 dal ministro delle finanze francese, la società era gestita da imprenditori privati, era finanziata in parte dalla Stato e godeva di privilegi reali. L’obiettivo principale alla base dell’avvio dell’attività era quello di ridurre le importazioni francesi di vetro da Venezia, e in particolare di specchi, un prodotto che inglobava un valore aggiunto elevatissimo.
CAPITOLO 5
� 17
La prima rivoluzione industriale inglese (1760-1830) ha segnato una transizione lenta, ma profonda e irreversibile, da un’economia agricola ad una economia dominata dalla fabbrica e dalla meccanizzazione dei sistemi produttivi. Ha inoltre imposto l’egemonia britannica sul resto d’Europa. La vera differenza tra la Gran Bretagna e gli altri Paesi si realizzava nel diverso contributo fornito dal macrosettore industriale alla formazione del PIL e del valore aggiunto.
L’Europa seguì l’esempio britannico con ritmi diversi da paese a paese. Man mano aumentava anche il grado di specializzazione nelle esportazioni dei Paesi coinvolti. Grazie a un livello di apertura senza precedenti, alcuni Paesi acquisirono, nella seconda metà del XIX secolo, la posizione di leaders nella graduatoria delle esportazioni di prodotti industriali, trovandosi così in condizione di finanziare l’importazione di grandi quantitativi di beni prodotti in altri Paesi.
Solo alcuni furono i settori toccati dalla rivoluzione industriale:
-tessile
-metallurgico
-di estrazione mineraria.
Gli incrementi di produttività furono permessi da grappoli di innovazioni specifiche all’interno del singolo settore e da una “general purpose technology”: la macchina a vapore di Watt. L’introduzione e la diffusione della macchina a vapore mise a disposizione dell’industria quantità crescenti di energia inanimata a basso costo che, per la prima volta, poteva essere trasferita con relativa facilità da un luogo all’altro, con un impatto significativo sull’efficienza e sui costi di localizzazione degli impianti.
Nel tessile, e in particolare nella lavorazione del cotone, le innovazioni tecnologiche nella filatura e nella tessitura avevano prodotto un notevole incremento dell’efficienza e della produttività del settore. Si pensi alla Spinning Jenny di James Hargreaves, al Water Frame di Richard Arkwright o alla Mule di Samuel Crompton (ibridazione delle due macchine precedenti -> innovazione radicale).
L’”illuminismo industriale”, un clima culturale favorevole alla scienza, all’innovazione, alla sperimentazione e alle nuove applicazioni tecniche, aveva creato un contesto positivo per l’attività di inventori, tecnici e imprenditori desiderosi di realizzare profitti mettendo in pratica le conoscenze sviluppate in proprio o apprese in altri settori.
Un ruolo importante nei processi della “grande trasformazione” (come lo storico Polanyi ha definito l’enorme cambiamento provocato dalla rivoluzione industriale) è quello svolto dagli imprenditori.
Le nazioni che mostravano una struttura sociale più articolata, come la Gran Bretagna e i Paesi Bassi, offrivano anche un ambiente più favorevole allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali.
� 18
La composizione della “classe imprenditoriale” variava da paese a paese, in base alla combinazione di fattori istituzionali, storici e culturali tipici di ogni ambiente economico.
Un sistema di valori sociali e culturali favorevoli all’iniziativa individuale ha contribuito a incoraggiare i comportamenti che hanno promosso l’innovazione, così come l’accettazione dello status di imprenditore. In molti casi, infatti, l’attività imprenditoriale ha rappresentato uno strumento potente di ascesa sociale.
Nel popolo degli imprenditori inglesi della prima rivoluzione industriale troviamo gli artigiani, i maestri e i mercanti imprenditori che costituivano la componente più dinamica della manifattura pre industriale. Per costoro la metamorfosi in imprenditori era il risultato di strategie di integrazione a monte, finalizzate a stabilire un solido controllo su tutte le fasi del processo produttivo.
Occasionalmente diventavano imprenditori anche esponenti di classi nobili e proprietari terrieri, investendo nell’attività minerarie o nella costruzione di infrastrutture ad alta intensità di capitale (canali, strade a pedaggio, ferrovie) per realizzare i necessari collegamenti ai nuovi mercati di sbocco.
I proprietari terrieri, però, erano comunque poco presenti nella classe imprenditoriale in quando le attività economiche che svolgevano erano già molto redditizie. Non c’era fame di ascesa sociale, di ambizione, di novità come invece avveniva per gli altri soggetti (Boulton man on the make).
L’intervento di partner finanziari portò negli ambienti della ricerca e della sperimentazione tecnica i capitali necessari a trasformare le invenzioni in innovazioni importanti per tutta l’economia (incident Watt e Boulton).
Le nuove tecnologie e l’allargamento dei mercati portarono all’affermarsi di una realtà più complessa di quella del passato: la fabbrica.
Le dimensioni iniziali ancora ridotte (in rari casi si superavano i 100 dipendenti) comportavano necessità finanziare contenute che, nella maggioranza dei casi, venivano fornite da investitori in buone relazioni con l’imprenditore: questa modalità di reperimento dei capitali faceva si che proprietà e controllo delle aziende restassero stabilmente nelle mani del fondatore e della sua cerchia familiare.
In attesa di una regolamentazione legislativa che consentisse la diffusione delle società per azioni (fino al 1840 in UK non si potevano creare s.p.a -> una rivoluzione di imprenditori senza imprese), lo strumento legale della partnership permetteva di associare al proprietario dell’impresa soci apportatori di capitali aggiuntivi.
Data la dimensione media delle unità produttive, le strutture organizzative delle società erano ancora relativamente elementari. Gestione e proprietà delle aziende facevano capo unicamente al proprietario/fondatore, il quale talvolta delegava alcune funzioni ai familiari o ai soci. � 19
Le nuove tecnologie impiegate, inoltre, avevano generato solo scarse economie di scala e di flusso. Nel caso del tessile, per esempio, grappoli di innovazioni avevano interessato singole fasi o stadi, senza coinvolgere l’intero ciclo di trasformazione della materia prima al tessuto finito. L’innovazione introdotta in una fase creava una strozzatura del flusso della produzione e spingeva le aziende a introdurre innovazioni anche nella tessitura. Se questa dinamica di “innovazione per contagio” incoraggiava un rinnovamento generale a lungo termine, non necessariamente era in grado di indurre un’immediata integrazione dei vari stadi della produzione.
Per tentare di compensare le scarse economie di scala, si è iniziato a raggruppare unità produttive simili nella stessa area geografica (distretti industriali marshalliani), in modo tale da sfruttare i vantaggi di localizzazione e vicinanza: questi andavano dalla velocità di circolazione di beni e servizi, alla concentrazione di lavoratori specializzati, alla diffusione rapida di competenze innovative. La prossimità geografica delle imprese attive consentiva quindi di abbassare i costi di informazione e di condividere le conoscenze in maniera efficiente (economie distrettuali).
È Marshall a evidenziare l’importanza della “forza collettiva” derivante dalla concentrazione di attività omogenee dei distretti. I distretti erano diffusi in quasi tutte le aree europee toccate dal processo di industrializzazione e speso le nuove tecnologie e le nuove forme organizzative si innestavamo su un tessuto locale di attività manifatturiere risalente al periodo pre industriale. Nell’era della fabbrica, tuttavia, le forme tradizionali della manifattura, come il putting-out system e la bottega artigiana, non erano ancora completamente scomparse: dove sopravvisse più a lungo, però, il vecchio tipo di impresa si trovò a competere con i bassi prezzi e i beni standardizzati portati sul mercato dalle nuove imprese industriali.
La trasformazione sul versante della produzione impose una complessa ridefinizione anche delle funzioni distributive e commerciali all’interno del sistema economico. Per gestire le relazioni con il mercato era ora necessario per l’imprenditore creare reti efficienti di agenti, rappresentanti e partner commerciali indipendenti, capaci di spingere le vendite oltre gli stretti limiti dei mercati locali. La specializzazione della funzione commerciale all’ingrosso e al dettaglio, così come la creazione di un’adeguata rete di vendita, poneva all’impresa industriale nuovi problemi, riconducibili a un aumento dei costi di transazione e all’incertezza nella gestione di relazioni con operatori indipendenti. Era necessario specializzarsi con grandi commercianti capaci di agire da mediatori nelle transazioni su mercati anche molto lontani. In realtà, per i produttori la relazione con i mercanti non era sempre vantaggiosa perche in questo sistema di intermediazione i più importanti fra essi tendevano a considerare gli industriali come semplici fornitori di merci, evitando relazioni commerciali esclusive e imponendo addirittura marchi propri, per godere di sostanziali margini di ricavo sugli acquisti all’ingrosso.
Durante la prima rivoluzione industriale l’ampliamento delle dimensioni dei mercati comportò una forte tensione fra gli industriali e i mercanti: un esito significativo di questo crescente conflitto di interessi è rappresentato dalle strategie di integrazione verticale (nella distribuzione)
� 20
messe in atto dagli imprenditori. Tuttavia l’intermediazione dei mercanti era necessaria, in particolare per quegli industriali che non potevano sostenere il peso degli investimenti inevitabili per lo sviluppo di vaste reti di distribuzione a lungo raggio. In questa fase l’integrazione verticale si realizzava come scelta strategica solo nei casi in cui fosse necessario per il produttore conservare il controllo su un mercato o affermare il marchio con il proprio nome.
In questa fase si presentò come decisiva la capacità di sfruttare in maniera efficiente una molteplicità di canali di finanziamento a breve e lungo termine, a partire dai patrimoni personali, dalle risorse familiari o della cerchia prossima di conoscenti, fino al credito delle istituzioni locali. Le ricchezze familiari, spesso rappresentate dalle proprietà fondiarie, confluivano nel finanziamento dell’attività imprenditoriale insieme ad altre voci di reddito, come il prestito su pegno. Il patrimonio personale rappresentava il serbatoio di risorse indispensabile. La ricchezza fondiaria e immobiliare, infatti, conferiva all’imprenditore la solida reputazione capace di garantirgli il credito presso le banche o altri soci finanziatori.
I circuiti di credito operativi nell’ambiente locale erano un’altra fonte di finanziamento caratteristica dei primi stadi della grande trasformazione. L’operazione di fondava sulla conoscenza diretta del richiedente e della consistenza delle risorse patrimoniali a garanzia dell’investimento, quindi la prossimità geografica era essenziale.
CAPITOLO 6
Nelle fabbriche gli imprenditori combinavano capitale fisso (edifici e macchinari) e capitale circolante (materie prime e semilavorati, salari) per produrre grandi quantità di beni standardizzati destinati al mercato interno e a quelli esteri. Nonostante le differenze organizzative caratteristiche delle diverse aree geografiche, il sistema presentava significative omogeneità strutturali e l’impatto di tutte queste novità sull’economia europea non lascia dubbi circa lo sviluppo rivoluzionario in atto, con ripercussioni sugli assetti politici e sociali ottocenteschi.
La fabbrica si impone come un modello completamente diverso dai precedenti luoghi di lavoro, per alcune ragioni:
-al suo interno si radunava un consistente numero di lavoratori;
-vi era una netta separazione tra unità di produzione e di consumo;
-elevata specializzazione del lavoro: a ogni operaio venivano assegnate poche mansioni (a volte un’unica operazione) nello svolgimento del processo produttivo.
-meccanizzazione di alcune fasi del processo di produzione. Le macchine, per la loro maggiore complessità tecnica, richiedevano la presenza di lavoratori specializzati nella manutenzione. A
� 21
differenza del passato, il lavoratore non era più proprietario dei mezzi di produzione e questo comportava diversi problemi organizzativi inerenti all’uso corretto delle macchine e alla disciplina degli operai, da risolvere attraverso un sistema regolato di addestramento e supervisione.
-superamento dei vincoli localizzativi. Le macchine utilizzate in questo periodo richiedevano l’applicazione di quantità di energia superiore rispetto al passato, un’energia che doveva essere a basso costo e continuamente disponibile, quindi di origine inanimata. Forti vincoli d’insediamento, capaci di definire l’iniziale geografia dei bacini industriali, vennero superati dall’adozione della macchina a vapore, che trasformava l’energia termica in forza motrice immediatamente disponibile.
La nuova modalità di produzione, però, comportava disagi non indifferenti, perché sottraeva lavoratori all’agricoltura mentre relegava il lavoro artigiano in nicchie di mercato sempre più ristrette, man mano che i beni standardizzati a basso prezzo conquistavano fasce sempre più ampie di consumatori.
Allora perché la fabbrica? Quali vantaggi ha?
-La spiegazione tecnologica insiste sulla possibilità di sfruttare rendimenti (moderatamente) crescenti al crescere della scala produttiva. Si tratta inoltre di macchinari sempre più ingombranti e complessi.
-I costi di transazione sul mercato erano troppo elevati, rendendo inefficiente il putting-out system.
-Secondo l’interpretazione marxista sono le esigenze di disciplina, controllo e sfruttamento a spiegare l’iniziale diffusione del sistema di fabbrica e del proletariato, i cui interessi di classe erano opposti a quelli della borghesia.
-La fabbrica nasce come risposta alla domanda di nuova conoscenza generata dalla complessità tecnologica (formazione del capitale umano).
Come spiega Polanyi la fabbrica?
Egli introduce il concetto di “formazione del mercato”: è la società che decide di dar luogo al mercato del lavoro, fornendosi delle macchine come strumento di propaganda.
Il mercato del lavoro viene “creato” perché funzionale ad un’ulteriore espansione della produzione di fabbrica.
A livello macroeconomico le maggiori trasformazioni segnavano: il ritmo della crescita, la quantità dei flussi di commercio internazionale, il contributo dell’agricoltura e dell’industria alla formazione del PIL.
� 22
A livello micro, invece, la diffusione di nuove tecnologie e forme organizzative generava una serie di questioni che presto arrivarono a coinvolgere l’interesse generale al punto di richiedere l’intervento dei governi nazionali. Il sistema di fabbrica imponeva infatti la creazione di strutture produttive funzionali all’elevata intensità di investimenti e i proprietari si trovarono a sperimentare varie soluzioni nel layout degli stabilimenti, ma anche nell’organizzazione e nella disciplina della manodopera: si trattava di definire le regole di comportamento per una forza lavoro pendolare, composta da persone di età, sesso ed estrazione sociale diversi, al fine di rendere veloce e scorrevole il funzionamento del ciclo produttivo.
Dal punto di vista dei lavoratori, l’inserimento nel sistema di fabbrica comportava spesso un profondo cambiamento delle abitudini e degli stili di vita. Il risultato era la rinuncia a una relativa libertà nella scelta dei tempi di lavoro e riposo a seguito dell’introduzione nel processo dei turni scanditi da orari fissi. Gli imprenditori dovevano anche impedire l’assenteismo di massa di questa forza lavoro di origine contadina nei momenti del raccolto o di maggior impegno nell’attività agricola.
Tale stravolgimento dello stile di vita non poteva realizzarsi senza creare tensioni nelle diverse società europee; nuovi problemi di adattamento fisico e psicologico si aggiungevano infatti alle difficoltà concrete che i lavoratori erano obbligati ad affrontare, come i lunghi spostamenti giornalieri per raggiungere il luogo di lavoro o la permanenza in affollati dormitori e, per tutti, lo sradicamento dalle comunità locali e dalle reti familiari che avevano garantito in precedenza un certo grado di sicurezza e protezione. All’isolamento e alla precarietà sociale delle nuove condizioni di lavoro si aggiungevano infine le difficoltà di integrazione per i lavoratori “stranieri” nelle ostili comunità locali dove le fabbriche erano insediate.
I costi sociali della fabbrica, per quanto elevati, vengono visti come necessari per raggiungere un benessere sociale futuro maggiore. Nella maggior parte dei casi fu il singolo imprenditore a trovare soluzioni a questi problemi (anche per evitare che fosse lo Stato ad imporgliele). Alla fabbrica venivano così affiancati alloggi e dormitori per i lavoratori provenienti da villaggi lontani e, in seguito, spacci per l’acquisto di generi di prima necessità, come cibo e vestiti, mentre “villaggi operai” cominciarono a sorgere presso gli impianti produttivi di maggiori dimensioni, spesso con l’intervento finanziario dell’imprenditore stesso. In Gran Bretagna alcuni industriali filantropi avevano contribuito già nel XVIII secolo alla creazione di comunità di lavoratori (i “villaggi modello”) in cui fornivano agli operai alloggio e altri servizi, cercando di diffondere una cultura positiva di sobrietà e impegno nel lavoro. Un esempio interessante è stato quello di Saltaire, il villaggio fondato nel 1853 che includeva case, scuole, aree ricreative (biblioteca e sala da concerto) e altri servizi.
Questo sistema, ben descritto dal termine “paternalismo”, consolidava il rapporto personale e familistico fra l’imprenditore e i suoi lavoratori, e in molti paesi europei, dove l’industrializzazione costringeva all’inurbamento masse di lavoratori agricoli, era considerato un modo per mantenere vivi i legami e i valori della tradizione contadina, compresi la fiducia e il rispetto
� 23
dovuti al proprietario terriero. A Crespi d’Adda,con il villaggio operaio edificato in Lombardia alla fine del 1870, queste scelte portarono alla creazione di una nuova comunità molto coesa, all’interno della quale erano soddisfatte le necessità della vita quotidiana. Il villaggio includeva le case degli operai, le ville dei dirigenti, la chiesa, il cimitero, lo spaccio, l’ospedale e i bagni pubblici. L’imprenditore abitava invece in una grande villa, quasi un castello, collocata in una posizione dominante rispetto al villaggio.
Con il castello o senza, company town e villaggi operai crescevano attorno alle fabbriche in Europa e in America, con le imprese e le famiglie proprietarie a esercitare un ruolo guida nella vita sociale e civile della comunità.
Sempre in questa fase storica di cambiamenti sociali, si andava affermando in Europa una classe sociale nuova, la borghesia industriale, destinata ad assumere la leadership politica ed economica e a produrre una legislazione mirata ad attenuare gli aspetti più aspri della vita in fabbrica. A partire dall’Inghilterra e dalla Germania, le nuove regolamentazioni sul lavoro delle donne e dei bambini, sulle assicurazioni obbligatorie e il mutuo soccorso si diffusero in tutta Europa.
La borghesia industriale tentava per questa via di introdurre una moderata redistribuzione dei vantaggi che traeva dal processo di industrializzazione, con interventi a sostegno di un miglioramento delle condizioni di vita della società in generale, ma anche promuovendo una cultura favorevole alle trasformazioni in atto; in questo modo la classe dirigente affermava la propria “egemonia” (secondo la definizione di Antonio Gramsci), riducendo gli spazi di conflitto, per stabilizzare un assetto economico industriale senza compromettere il proprio potere e la nuova distribuzione del reddito e della ricchezza.
Molti lavoratori consideravano offensivo il paternalismo e l’alto livello di controllo del nuovo sistema, che appariva con evidenza a favore dei capitalisti e delle loro imprese, e il desiderio di tornare al periodo precedente era diffuso. La determinazione di alcuni gruppi di operai a combattere contro il sistema di fabbrica per recuperare un certo controllo sul proprio lavoro mise in moto lotte sindacali e movimenti politici che, attraverso l’Ottocento e il Novecento, sono arrivati fino all’odierna “grande recessione”.
� 24
CAPITOLO 7
L’ultimo quarto del XIX secolo ha visto sorgere nei Paesi industriali più avanzati le grandi imprese (large corporation).
Per la loro dimensione e complessità queste organizzazioni richiedono, per la prima volta nella storia, una struttura di governo formata da manager salariati, non proprietari, portatori di specifiche competenze tecniche.
I prerequisiti fondamentali per il passaggio dalla fabbrica della prima rivoluzione industriale alla grande impresa moderna della fine dell’800, sono da ricercare: -nei progressi tecnologici; -nell’allargamento dei mercati. Una grande varietà di processi innovativi, nei settori meccanico, elettrico e chimico, ha investito le economie statunitensi ed europee dopo il 1870. La navigazione, la ferrovia, il telegrafo e il telefono hanno consentito alle imprese di compiere il salto dimensionale, di raggiungere mercati molto più vasti facendo affidamento su relazioni sicure e costanti con i fornitori e i clienti. Il telegrafo, inventato nel 1844, era già utilizzato commercialmente tre anni dopo. Il telefono, inventato dall’americano Bell nel 1876, all’inizio era considerato complementare al telegrafo, ma presto si è rivelato migliore del primo. L’arrivo della ferrovia rappresenta la svolta decisiva. Con la progressiva espansione della rete europea, le società ferroviarie assunsero le dimensioni di grandi imprese. In Germania l’impatto fu ancora più significativo: le crescenti necessità finanziarie delle società ferroviarie furono all’origine della “banca universale” (uno dei maggiori protagonisti dello sviluppo industriale tedesco) e in aggiunta le ferrovie erano anche il maggior cliente di quei settori che in breve tempo arrivano ad esercitare un ruolo chiave per la nazione (siderurgia e meccanica). Anche in Italia le ferrovie contribuirono a creare il mercato nazionale, esprimendo una crescente domanda verso i settori emergenti meccanico e siderurgico. Nello stesso periodo carbone e vapore stavano trasformando anche il trasporto sull’acqua. Il primo battello a vapore realizzato per il trasporto commerciale, il Claremont, era alimentato da un motore inventato da Watt. Nel secondo Ottocento l’uso del vapore rivoluzionò anche la navigazione oceanica. La costruzione delle reti ferroviarie e telegrafiche ha portato alla creazione di mercati veramente nazionali, poiché le società erano nella condizione di poter soddisfare velocemente (e in modo affidabile) la clientela in ogni angolo del Paese. Questa possibilità ha rappresentato un forte incentivo all’aumento della capacità produttiva delle imprese, che potevano ora contare sulle garanzie di un regolare servizio di spedizione per grandi volumi di merci, rispettando le scadenze di consegna senza subire il condizionamento delle variabili meteorologiche. L’esito della rivoluzione dei trasporti e delle comunicazioni fu in definitiva: -un abbassamento dei costi (i prezzi calarono, a seconda della tipologia di merci, da tre a 5 volte); - una velocizzazione nella distribuzione dei beni; -un aumento dei flussi nel commercio internazionale (prima globalizzazione: fenomeno di integrazione commerciale molto forte che giunge al suo culmine all’inizio della Prima guerra mondiale).
� 25
La costruzione delle infrastrutture richiedeva capitali. I canali per convogliare capitali verso questa nuova attività furono perfezionali nella seconda metà dell’Ottocento, sia in Europa che negli USA. Negli Stati Uniti, la cospicua quantità di capitali necessaria aveva contribuito alla creazione delle banche di investimento specializzate. Grandi istituti, come quello di J.P Morgan, avevano concentrato i propri investimenti nelle ferrovie, facendo spesso da tramite anche per i capitali europei che trovavano vantaggioso finanziare il sistema americano di trasporti e comunicazioni. Le maggiori istituzioni finanziarie sostenevano la crescita delle società ferroviarie attraverso fusioni e acquisizioni; la finanza americana sviluppò così dopo il 1850 i moderni metodi di compravendita dei titoli. Lo sviluppo delle ferrovie, infine, impose nuove forme nell’assetto della proprietà delle grandi imprese emergenti e, soprattutto, nelle strutture di governo aziendale. Le compagnie ferroviarie si trovavano a dover gestire enormi investimenti e numerosissimi dipendenti: il coordinamento delle attività era quindi vitale per poter fornire un servizio di trasporto sicuro ed efficiente. La varietà e la mole dei compiti di natura dirigenziale ha presto dato luogo ad una frammentazione della proprietà aziendale e ad una sistematica divisione dei ruoli: se da un lato emergeva la posizione di numerosi azionisti a definire l’assetto della nuova proprietà, dall’altro vi erano i manager salariati, incaricati a tempo pieno dell’amministrazione dell’impresa. Le società ferroviarie e telegrafiche in continua crescita avevano necessità di reclutare un numero crescenti di manager a tempo pieno per coordinare, controllare e valutare le diverse unità operative in cui si articolava la compagnia, definendo in questo modo anche un “modello americano” nella gestione della forza lavoro: ancora una volta gli USA facevano da battistrada innovando l’organizzazione manageriale. L’estensione complessiva della rete di trasporti statunitense, quasi tutta a binario unico, faceva si che fosse un imperativo per ogni singola compagnia dotarsi di una gerarchia manageriale dedicata alla programmazione e al controllo di precisione della circolazione dei propri treni: un coordinamento efficiente era essenziale per la velocità, la regolarità e la sicurezza di un sistema di traffico che movimentava una grande varietà di merci fra centinaia di località diverse. Nelle società più grandi le decisioni operative erano sempre più spesso affidate a manager che non possedevano azioni della compagnia: proprietà e direzione (controllo) dell’impresa arrivarono così a definire posizioni e ruoli nettamente separati. Man mano che la complessità dell’attività aumentava, poi, i manager cominciarono a ripartirsi i compiti e a delegare gli impegni a dirigenti intermedi, dedicati a coordinare e sovrintendere le diverse attività funzionali di ogni divisione. La distinzione di line e staff venne presto adottata nelle compagnie ferroviarie per definire la struttura dei ruoli, funzionale e flessibile, che rese possibile la gestione di queste complesse organizzazioni. L’organizzazione manageriale delle società ferroviarie vide in questi decenni una continua ricerca di miglioramenti e registrò considerevoli successi: complessità e dimensioni della rete spinsero le compagnie ad adottare sistemi organizzativi basati su divisioni territoriali indipendenti diretti da general manager, i quali controllavano le attività dei vari dipartimenti funzionali e rispondevano ad un centro direzionale responsabile delle decisioni strategiche. Queste competenze manageriali (organizational capabilities) vennero trasferite anche ad imprese di altri settori grazie all’apporto di imprenditori e manager che avevano iniziato la loro carriera nelle società ferroviarie prima di intraprendere iniziative industriali autonome. È questo il caso di Andriew Carnegie, il quale fu il primo a sfruttare le economie di scala nella produzione dell’acciaio. � 26
Il settore ferroviario, non da ultimo, ebbe un ruolo da pioniere anche nel definire l’ambito delle relazioni fra lavoratori e impresa. Inoltre fu il primo segmento dell’economia americana nel quale il governo federale intervenne per regolarne la competizione. Le grandi compagnie ferroviarie si trovarono infatti ad affrontare su larga scala alcune delle questioni classiche nel campo delle relazioni industriali: la ricerca e l’assunzione della manodopera, la formazione e la gestione della stessa. Le grandi compagnie ferroviarie statunitensi furono le prime a introdurre un sistema continuo di assunzione dei lavoratori, a istituire salari fissi e le prime forme di assicurazione e pensione per i dipendenti, e a definire una chiara gerarchia aziendale (con percorsi di carriera prestabiliti). Gli scioperi erano comuni, ma il management americano mantenne a lungo la posizione di unica fonte legittima di autorità, in un sistema che non permetteva ai lavoratori di esprimere posizioni comuni o di avere un peso nelle scelte operative. I sindacati non ottennero, infatti, alcun riconoscimento ufficiale fino alla prima guerra mondiale, e la contrattazione collettiva era di fatto assente. È ancora nell’ambito delle ferrovie statunitensi che si osservano i primi tentativi di controllo della concorrenza attraverso accordi di cartello. Nel decennio 1870 infatti fu istituita una federazione in cui vennero fissate nel dettaglio la ripartizione dei profitti, le procedure di controllo e le sanzioni. La stabilità del sistema restava tuttavia precaria ed erano molto vantaggiosi gli incentivi a disattendere gli accordi. L’appoggio legislativo sembrava indispensabile per dare sostanza agli accordi e costringere le compagnie a rispettarli. Il supporto politico a questa posizione si rivelò tuttavia debole e, quando il Congresso decise di adottare una normativa, non solo rifiutò il riconoscimento ai cartelli ferroviari, ma li dichiarò illegali.
CAPITOLO 8
Verso la fine dell’800 i nuovi sistemi di trasporto e comunicazione hanno rapidamente messo in moto la trasformazione di interi settori dell’economia, a partire dalla distribuzione delle merci. Mentre nuovi venditori prendevano il posto dei commercianti tradizionali, empori e grandi magazzini guadagnavano velocemente popolarità nel corso della seconda metà del secolo, proponendo innovazioni quali l’entrata libera, i prezzi fissi, il vasto assortimento di beni, le vendite in saldo rese possibili dal rapido avvicendamento dell’inventario. Le nuove forme di vendita al dettaglio, dopo il successo riscosso negli USA e in Francia, negli ultimi decenni del secolo fecero la loro comparsa anche negli altri paesi europei. Le catene di vendita al dettaglio e il commercio per corrispondenza erano cresciuti velocemente all’inizio del XX secolo sottraendo importanti quote di mercato ai piccoli rivenditori tradizionali, grazie alla possibilità di operare economie di scala e di diversificazione. Il maggiore impatto della rivoluzione delle infrastrutture si registrava però sul versante della produzione: nell’arco di un periodo relativamente breve la nascita delle grandi imprese industriali aveva impresso una spinta determinante allo sviluppo delle prime tre grandi nazioni industrializzate, gli USA, la Germania e la Gran Bretagna, che alla fine dell’800 vantavano i due terzi della produzione manifatturiera mondiale. Nel 1870 erano state introdotte numerose innovazioni nei processi produttivi di settori come quello meccanico, chimico ed elettrico, ora completamente disponibili per l’applicazione industriale in una grande varietà di nuovi settori e imprese (produzione di cibo e bevande, distillazione di gas e liquidi, chimica, farmaceutica, siderurgia, meccanica, raffinazione del petrolio).
� 27
Questo complesso di innovazioni, correntemente definito “seconda rivoluzione industriale”, si distingueva dalla precedente fase di cambiamento industriale perché coinvolgeva volumi produttivi significativamente accresciuti, ma anche per il ritmo del cambiamento molto più rapido. Il vantaggio competitivo derivava dal perseguimento di consistenti economie di scala, grazie alla riduzione dei costi di produzione e distribuzione per grandi volumi di merci, associate ad altrettanto elevate economie di diversificazione ottenute all’interno di una singola unità operativa capace di produrre e distribuire beni differenti. Le tecnologie della seconda rivoluzione industriale ebbero un impatto non uniforme sui vari rami dell’industria, al punto da creare fra i settori un profondo dualismo destinato a durare per tutto il Novecento, e a marcare il confine fra quelli dominati dalla grande impresa e gli altri. Già all’inizio del XX secolo le maggiori imprese industriali presenti negli USA, in Germania e in UK erano concentrate nei settori in cui resteranno dominanti fino agli anni Settanta (settori “core”): alimentare, chimico, petrolifero, metallurgico, meccanico e dei mezzi di trasporto. Al contrario, nei comparti in cui i processi di meccanizzazione erano più semplici (come nell’abbigliamento, nell’industria conciaria eccetera), né i volumi prodotti né la velocità dei processi produttivi avevano subito un drastico cambiamento (settori “peripheral”). In tutti questi settori ad alta intensità di lavoro l’innovazione tecnologica era rappresentata dal perfezionamento e dalla messa a punto dei macchinari già in uso, ma non portava alla realizzazione di grandi impianti capaci di potenti economie di scala. Al contrario, nei settori in cui gli imprenditori furono abili a sfruttare i vantaggi delle nuove tecnologie della seconda rivoluzione industriale, le grandi imprese si diffusero rapidamente, in particolare in quei comparti in cui la produzione di grandi quantità in un unico impianto era cosa ben necessaria. Per queste aziende moltiplicare la capacità produttiva significava abbassare i costi unitari attraverso le economie di scala. Le economie di scala e diversificazione potenziali sono date dalle caratteristiche fisiche dei mezzi di produzione. Le economie di scala e diversificazione realizzate richiedono necessariamente l’evoluzione organizzativa, cioè il triplice investimento (lezione chandleriana). -investimenti in produzione: L’iniziale investimento di capitale nei settori avanzati della seconda rivoluzione industriale e i costi fissi necessari a mantenere operativi gli impianti erano molto elevati e potevano essere compensati solo attraverso l’utilizzo pieno e continuo degli stabilimenti. Due componenti risultavano quindi decisive nella determinazione dei costi e dei profitti: la capacità produttiva installata e il throughput, cioè la quantità di materie prime effettivamente immesse nel processo produttivo in una data unità di tempo. L’unica via per ottenere il massimo vantaggio derivava quindi dal mantenimento di un flusso elevato e costante dei materiali nello stabilimento. Il primo esempio riguarda l’ascesa della Standard Oil. All’inizio del decennio 1880 erano 40 le società operative nel settore petrolifero, legate da un’alleanza che consentiva loro di esercitare il controllo della produzione. Erano entità indipendenti dal punto di vista legale e amministrativo, ma ognuna era legata alla Standard Oil Company di Rockfeller attraverso scambi di azioni e altri stratagemmi finanziari. Sebbene questo cartello consentisse loro di esercitare il monopolio sulla produzione di petrolio, nel 1882 le società decisero di collegarsi formalmente dando vita allo Standard Oil Trust. Il maggior vantaggio di questa operazione era rappresentato dal fatto che il trust forniva gli strumenti legali necessari alla creazione di un ufficio centrale capace di trarre pieno vantaggio dalle economie di scala. Il primo compito di questo organismo riguardava il piano di riorganizzazione dei processi di produzione basato sulla chiusura o la ristrutturazione di alcune raffinerie e la costruzione di impianti nuovi; un secondo ordine di interventi era dedicato al coordinamento del flusso dei materiali non solo all’interno delle numerose raffinerie, ma � 28
anche dai pozzi petroliferi alle raffinerie e da queste ai clienti finali. In poco tempo, la riorganizzazione così guidata dal trust riuscì in pratica a dimezzare il costo medio di produzione. Se la Standard Oil aveva investito nella costruzione di grandi raffinerie per trarre vantaggio dalle economie di scala, i produttori tedeschi di coloranti realizzarono investimenti anche maggiori, per sfruttare sia le economie di scala che di diversificazione. Settori con questi tratti distintivi diventavano facilmente oligopoli, con poche grandi imprese in competizione fra loro sui mercati mondiali. Conseguenze importanti dei nuovi impegnativi investimenti si registrarono nell’organizzazione del lavoro in fabbrica. Alla fine del XIX secolo si diffuse l’idea di un’”organizzazione scientifica” del lavoro proposta da Taylor. Egli sosteneva il perseguimento di una ONE BEST WAY attraverso: -Uso sistematico delle macchine -Standardizzazione della produzione -Raccolta e codificazione di tutte le conoscenze tacite, fino ad allora esclusivo patrimonio dei lavoratori -Selezione scientifica dei lavoratori per poterli assegnare alle diverse fasi produttive -Divisione nello stabilimento fra operai e direzione -Suddivisione delle fasi di lavoro in una serie di compiti elementari. Gli aumenti salariali, resi possibili dai profitti addizionali derivanti da questa organizzazione scientifica, avrebbero compensato gli operai per la disumanizzazione del loro lavoro. Il taylorismo divenne una realtà con l’introduzione della catena di montaggio (assembly line) nella produzione automobilistica della Ford. Ford produsse, a partire dal 1908, il modello “T” cioè un tipo di automobile pensato per diventare un prodotto di massa. La sua idea era che poteva essere lo stesso operaio l’acquirente delle automobili, grazie ai salari alti percepiti alla Ford (in cambio delle ferree modalità di lavoro imposte nei reparti) e grazie al prezzo relativamente contenuto delle auto, le quali potevano essere acquistate anche a rate (forma di paternalismo).
Si ebbe, quindi in questo periodo, la vera innovazione Schumpeteriana: l’imprenditore è colui che è in grado di creare un nuovo mercato, in questo caso un mercato di massa (un mercato di massa per un prodotto di massa).
-investimenti in distribuzione:
Per rendere effettive le economie di scala e di diversificazione le imprese hanno dovuto raggiungere un alto livello di integrazione verticale (a monte e a valle) per mantenere un costante throughput nel processo produttivo, evitando quindi ogni ostacolo o ritardo nell’approvvigionamento o nella distribuzione che potesse intaccarne la regolarità. Quando i canali di distribuzione esistenti hanno iniziato a perdere convenienza, mostrando insufficienze nella capacità di vendere e distribuire le grandi quantità di merci prodotte dai moderni stabilimenti industriali, divenne necessario per le grandi imprese operare un investimento nelle attività di distribuzione.
� 29
Esempi di integrazione precoce nella distribuzione si trovano nelle imprese che impiegano processi produttivi continui (sigarette, fiammiferi, farina, cereali, minestre e cibi in scatola, bevande), ma anche in quelli che producono beni deperibili. Alcuni prodotti nuovi, inoltre, richiedevano strutture di distribuzione rinnovate e l’utilizzo di competenze specifiche di marketing e commercializzazione. La personalizzazione delle caratteristiche di ogni articolo richiedeva specifiche conoscenze sulle modalità di vendita , installazione e manutenzione; talvolta erano richieste anche speciali strutture di trasporto e deposito, o specifici piani di finanziamento per l’acquisto.
Mentre gli industriali avevano le risorse per offrire tutti questi servizi collegati alla vendita dei loro prodotti, i grossisti solo raramente potevano assumere in proprio i costi di dimostrazione, manutenzione, riparazione e offrire anche facilitazioni di pagamento ai clienti. Furono quindi le maggiori imprese del settore che cominciarono ad aprire punti vendita gestititi direttamente. La decisione di internalizzare la distribuzione rappresentava un altro vantaggio per le società, in quanto garantiva un flusso costante di informazioni relative ai gusti, alle preferenze e alle esigenze dei consumatori. Investendo nelle funzioni distributive, le imprese andarono incontro a una trasformazione strutturale assumendo personale per gestire gli ordini, supervisionare la pubblicità, organizzare le spedizioni, coordinare l’ installazione, la manutenzione e la riparazione delle macchine, approntare i piani di finanziamento per i clienti. I settori pionieri nell’effettuare tali investimenti furono: a) macchine innovative e complesse (macchine prodotte su larga scala mediante la tecnica della fabbricazione a parti intercambiabili) per le quali vi era la necessità di “inventarsi” servizi specializzati di sostegno alla vendita. La prima impresa ad integrare distribuzione e marketing fu la Singer Co., fabbrica di macchine per cucire, ad uso domestico ed industriale. Nei suoi negozi vi erano macchine da cucire esposte per una dimostrazione. b) beni confezionati semideperibili a basso prezzo come ad esempio l’industria delle sigarette. La creazione di una rete distributiva nazionale stimolava lo sviluppo di un sistema di approvvigionamento altrettanto vasto: il mantenimento di alti volumi di produzione imponeva infatti un sistema di fornitura efficiente e stabile di materie prime e un’accurata programmazione dei flussi di materiali. Vennero a crearsi, quindi, uffici centrali con personale responsabile dei rifornimenti e degli acquisti, capace di individuare le fonti materie prime e contrattare con i fornitori le caratteristiche, i prezzi e le scadenze di consegna. L’integrazione a monte, tuttavia, non era essenziale da fare come quella a valle. L’integrazione permise alle aziende di eliminare gli intermediari e di assicurarsi contro ogni possibile interruzione del processo produttivo, causa di gravi perdite economiche. -investimenti nel management Competenze tecniche e capacità di lavoro in gruppo erano alcune delle componenti indispensabili per formare un team di dipendenti interno all’organizzazione capace di sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dalle innovazioni tecnologiche della seconda rivoluzione industriale. Ogni manager, all’interno di una cornice definita dall’imprenditore, gode di autonomia decisionale in un segmento importante di attività.
� 30
Le gerarchie manageriali vennero inizialmente organizzare sulla base di dipartimenti, ognuno dedicato a una specifica funzione. Al vertice di ogni dipartimento vi erano i dirigenti di livello intermedio, responsabili del coordinamento e del controllo delle attività dei manager di livello più basso, e del sistema di incentivi che spingeva questi ultimi ad ottenere i risultati migliori. I manager di primo livello dirigevano le unità operative dell’impresa ed erano incaricati della supervisione dei compiti svolti dai lavoratori all’interno delle varie unità (U-FORM, impresa unitaria multifunzionale). I dipartimenti funzionali erano organizzati secondo lo schema line e staff: i manager di line avevano potere esecutivo ed erano impegnati in attività correlate alla produzione, mentre i manager di staff lavoravano dietro le scene, svolgendo funzioni consultive relative alla gestione della contabilità e del personale, al controllo della qualità e al coordinamento dei depositi. Uno dei dipartimenti più importanti si occupava del controllo finanziario: coordinava la distribuzione delle risorse fra le varie unità operative, ma aveva anche il compito di garantire la trasmissione costante e veloce di informazioni all’interno dell’impresa; il flusso di informazioni forniva al management gli strumenti necessari a monitorare le prestazioni e decidere la ripartizione delle risorse a seconda delle necessità delle varie unità operative. Per svolgere al meglio questi compiti i dipendenti dell’ufficio deputato al controllo finanziario elaborarono e adottarono procedure uniformi e innovative di contabilità e verifica, assunsero la responsabilità di redigere i rapporti finanziari da presentare al pubblico, intrattennero le relazioni con l’esterno svolgendo il compito della raccolta di nuovo capitale, del pagamento degli interessi e dei dividenti sui titoli. Il risultato di questo processo fu che l’impresa divenne essa stessa una sorta di entità politica. Le dinamiche della competizione, sempre più aspra fra la fine dell’800 e i primi decenni del 900, e la progressiva saturazione dei mercati hanno stimolato le grandi imprese a ricercare e sperimentare nuove strategie di crescita. Per esempio, una società decideva di operare un’integrazione orizzontale acquisendo imprese o fondendosi con altre aziende che in gran parte realizzavano gli stessi processi per produrre beni destinati ai medesimi mercati; altre optavano invece per l’integrazione verticale, assorbendo unità coinvolte in attività collocate a monte o a valle del proprio processo produttivo, per poter competere sulla base di un superiore livello tecnologico, organizzativo o di qualità del prodotto. Altre, infine, hanno utilizzato le proprie risorse e le proprie abilità organizzative per entrare in nuovi mercati, intraprendere nuove attività o espandersi in nuove aree geografiche.
� 31
CAPITOLO 9
Differenze qualitative e temporali segnavano l’affermazione delle grandi imprese nelle diverse nazioni. Gli USA, favoriti dalla dotazione di materie prime e da una popolazione in continua crescita, furono i primi ad approfittare di queste opportunità e acquisirono la posizione di leader nello sfruttamento delle nuove tecnologie. Nelle nazioni nord europee lo sviluppo delle nuove forme d’impresa fu più lento. Le opportunità offerte dalla seconda rivoluzione industriale sono state sfruttate in maniera diversa dalle tre maggiori nazioni industriali: USA, Germania e Gran Bretagna. Per comprendere a fondo le differenze è necessario considerare: -le caratteristiche dei mercati -la regolamentazione della competizione economica da parte dei governi -gli atteggiamenti sociali nei confronti della grande impresa e le risorse culturali disponibili e come questo contesto nazionale ha influito sui modi e tempi del triplice investimento. DIFFERENZIALE DELLA CONTEMPORANEITA’ (Pollard): uno stesso cambiamento, adottato nello stesso momento, in paesi diversi porta a conseguenze diverse a seconda del livello di sviluppo iniziale del Paese. GLI STATI UNITI La grande impresa si era affermata negli USA in tutti i settori in cui lo sviluppo tecnologico lo aveva reso possibile. Le caratteristiche di queste imprese erano differenti da quelle che le avevano precedute per una serie di motivi: -erano società per azioni e non partnership -perseguivano sia l’integrazione verticale che l’espansione orizzontale (diventando in molti casi multinazionali) -vi era una separazione netta tra proprietà e controllo. Tuttavia in alcuni casi le famiglie proprietarie non scomparvero dalle strutture di governante delle corporation. Nei consigli di amministrazione allora erano presenti sia membri provenienti dall’interno dell’impresa (inside director) sia altri di provenienza esterna (outside director): i secondi rappresentavano la proprietà ed erano in maggioranza, ma non avevano né il tempo, né le competenze, né le informazioni necessarie ad amministrare l’impresa. Erano quindi costretti a dipendere dagli inside director, manager stipendiati presenti in azienda a tempo pieno, i quali prendevano le decisioni strategiche, ma anche quelle relative alla loro successione ai vertici della società. Fra i giganti emergenti all’inizio del secolo si annoveravano la Standard Oil, la Remington, l’American Tobacco, La DuPont, la Singer e, fra le imprese del comparto alimentare, la Heinz e la Cambpell. Il mercato nordamericano aveva le dimensioni di quello europeo continentale ed era estremamente dinamico grazie alla crescita esponenziale della popolazione e al progressivo incremento del potere d’acquisto dei consumatori. L’altro fattore determinante per il consolidamento della grande impresa da ricercare all’interno dei cambiamenti della pubblica opinione e nelle scelte adottate dal legislatore statunitense. Mentre il paese si andava affermando come primo nei livelli del consumo di massa, e la maggioranza degli americani vedeva con favore il miglioramento degli standard di vita, si manifestavano anche i primi segnali di diffidenza. La large corporation, infatti, minacciava alcuni dei valori fondanti del Paese, quali la fiducia nella libera competizione e la convinzione che nella gara per la conquista della ricchezza e del potere tutti dovessero partire con le stesse opportunità. Il gruppo di pressione più ascoltato nella “battaglia antitrust” era quello dei piccoli imprenditori e, fra questi, i più agguerriti erano i commercianti.
� 32
I primi due decreti antitrust furono: -Interstate Commerce Act (1887) -Scherman Act(1890) il quale vietò tutti i tipi di accordi collusivi tra imprese. Queste lobby continuarono ad ottenere un certo successo così che, nel 1911, i tribunali decretarono lo scioglimento di imprese del calibro della Standard Oil e dell’American Tobacco. Il tema del controllo e della regolamentazione dei big business divenne l’argomento chiave delle elezioni presidenziali del 1912. Due anni dopo, il vincitore Wilson, fece approvare dal Congresso il Clayton Antitrust Act e l’istituzione della Federal Trade Commission, due strumenti essenziali per rafforzare la precedente legislazione contro gli accordi interaziendali. È tuttavia impossibile ignorare l’esistenza di un “paradosso americano” : anche se l’intenzione delle forze politiche e della magistratura era di limitare la crescita delle large corporation, nella realtà la legislazione antitrust provocò fin dall’inizio l’effetto opposto. La proibizione legale per le imprese di stringere accordi, infatti, portò ad un’ondata di fusioni. In questo periodo di assiste alla formazione di nuove gigantesche entità aziendali, le quali manifestano capacità superiori dal punto di vista organizzativo e produttivo. Gli USA furono il primo paese democratico al mondo. Negli anni a cavallo fra il XIX e il XX secolo il clima socioculturale degli USA si presenta particolarmente favorevole all’emergere di differenti istituzioni (sindacati, partiti politici, gruppi d’interesse, associazioni professionali). Tutte queste istituzioni “moderne” rappresentavano l’esito positivo dei tentativi condotti dalla classe media urbana e dalla classe lavoratrice di stabilire un nuovo ordine basato sull’efficienza, la stabilità e i controlli sistematici all’esercizio del potere. Le grandi imprese sono cresciute anche grazie al fondamentale contributo del sistema educativo e formativo. Qui l’istruzione superiore seppe adattarsi velocemente alle esigenze dell’industria. La prima business school fu istituita nel 1881 alla University of Pennsylvannia; 27 anni dopo anche la Harvard University lanciava la sua business school. Alla vigilia della prima guerra mondiale la struttura dei nuovi settori industriali degli Usa era oligopolistica, cioè dominata da tre-cinque enormi imprese di dimensione nazionale, le quali competevano sul piano funzionale e strategico per le quote di mercato e per i conseguenti profitti. Il dato importante è che la piccola dimensione non divenne obsoleta negli USA. Anzi, molte piccole aziende furono in grado di trovare una collocazione all’interno dei mercati, accanto alla grandissima dimensione delle maggiori società, affermandosi con successo. Il principale vantaggio che queste potevano offrire era quello della flessibilità, che permetteva loro di differenziare la propria offerta e di adattare velocemente le linee di produzione per rispondere ai cambiamenti della domanda e delle esigenze dei consumatori. GERMANIA Prima del 1914 la grande azienda in Germania aveva caratteri simili a quelli della large corporation americana, ma anche evidenti tratti originali. In particolare la proprietà continuava a esercitare un peso nella direzione dell’impresa e a decidere gli investimenti necessari all’espansione, ma questi metodi di management, fondati sulle tradizioni familiari o trasmessi da una persona all’altra, si stavano via via rilevando inadeguati. L’immissione di un management adeguato alle nuove prospettive tecnologiche ed economiche fu allora la risposta adeguata, sia pure con differenze fra settore e settore (le famiglie non cederanno mai del tutto la proprietà come in UK).
� 33
Diversamente da quanto stava avvenendo negli Stati Uniti, infatti, la grande corporation non assunse in Germania il ruolo di leader in tutti i settori: a partire dalle ferrovie, il fenomeno della crescita dimensionale di era esteso ai settori elettromeccanico, siderurgico, chimico e della chimica pesante, mentre era quasi assente nella produzione dei beni di consumo per due motivi, un reddito pro capite nazionale relativamente basso e perché le grandi imprese e americane avevano già velocemente occupato questi mercati. Al contrario, già all’inizio del 1880, le industrie elettromeccaniche tedesche come Siemens e AEG avevano uguagliato quelle americane. La Germania aveva inoltre una posizione dominante nella meccanica pesante, un comparto che richiedeva grandi capitali iniziali ed evidenziava frequenti problemi di gestione del cash-flow. Queste caratteristiche spiegano anche il ruolo fondamentale svolto dalle banche universali tedesche. In Germania la relazione fra le imprese e le banche universali aveva assunto dall’inizio tratti che la differenziavano dalla situazione statunitense e da quella inglese. Nella crescita della ricchezza nazionale era stata infatti centrale la funzione delle banche: sulla base delle loro valutazioni di erano creati flussi di investimento verso settori e imprese specifici e, in qualità di azionista, la banca nei settori in cui aveva deciso di investire arrivava a esercitare un ruolo critico nella stessa direzione delle imprese. Diversamente dagli USA, dove il mercato interno (esteso e dinamico) rappresentava il principale target delle imprese, per l’industria tedesca erano i mercati esteri a giocare un ruolo critico nel loro successo. Le esportazioni furono quindi il motore principale per la crescita industriale della Germania, in particolare per i settori chimico e meccanico. La combinazione di un mercato interno in crescita e di mercati esteri sempre più estesi offriva sufficienti stimoli agli imprenditori tedeschi per attuare grandi investimenti, innovare e puntare alla crescita dimensionale delle imprese. Inoltre non vi era nessuna pressione da parte del governo e dei tribunali nei confronti delle modalità operative dei big business: in un periodo di soli tre decenni, a partire dal 1875, il numero dei cartelli creati era raddoppiato. In effetti, in Germania era del tutto assente una legislazione specifica contro i monopoli e le pratiche monopolistiche. Il pieno riconoscimento legale degli accordi ha così limitato l’estendersi delle fusioni (IG) e delle acquisizioni e il processo di concentrazione è stato più contenuto di quello sperimentato in America con il MERGER MOVEMENT. Anzi, in aggiunta, nel 1897 la Corte Suprema ha sancito che nel momento in cui i cartelli apportano benefici alla società nel suo complesso, dovrebbero essere approvati per legge. La presenza dei cartelli non ha limitato la competizione fra le imprese. Le grandi aziende partecipanti ai cartelli, infatti, avevano un forte incentivo a perseguire le economie di scala e di diversificazione, a individuare i processi produttivi più efficienti e ad integrarsi verticalmente per ridurre i costi unitari, in quanto ciò avrebbe permesso loro di aumentare il differenziale fra i prezzi stabiliti dal cartello e i propri costi di produzione. Inoltre, cartelli e esportazioni potevano convivere poiché i primi permettevano una pratica nota come DUMPING: cioè le imprese vendevano sul mercato estero a prezzi molto più bassi (sottocosto) rispetto a quelli applicati internamente tramite i cartelli, che gli garantivano infatti un sovraprofitto. Nel caso tedesco è importante anche sottolineare lo sviluppo di eccellenti istituzioni educative di livello superiore: a partire dalla fine del XIX secolo le università tedesche hanno ospitato alcuni dei migliori dipartimenti di ricerca e centri di studio scientifico e tecnologico al mondo. Sempre grazie ai cartelli, infatti, vi erano un margine di autofinanziamento superiore (derivante dal sovraprofitto) che permetteva un livello di finanziamento superiore alla ricerca. Lo Stato ha rivestito un ruolo determinante, manifestando una precoce attenzione agli esiti positivi degli investimenti capaci di creare collegamenti fra la ricerca scientifica e l’industria.
� 34
Altrettanto importante per la rapida crescita economica nazionale si è rivelata la presenza, in alcuni settori, di forti associazioni imprenditoriali che hanno consentito la realizzazione di piani di crescita e ristrutturazione a lungo termine. Per esempio, le camere di commercio svolgevano importanti programmi di qualificazione dei lavoratori, ma davano anche un contributo fondamentale alla definizione di standard produttivi da estendere a livello nazionale. Grazie a una particolare abilità nell’amalgamare gli interessi dell’industria, delle università e delle associazioni professionali, la Germania vide per prima la crescita di una classe media formata da ingegneri, tecnici e ricercatori, capace di guidare il Paese nel processo di industrializzazione e modernizzazione economica. RATHENAU È un imprenditore familiare. I punti principali del suo pensiero sono: -Stato regolatore/pianificatore (organizzazione dell'industria in associazioni orizzontali settoriali e verticali, sindacati professionali e industriali, nazionalizzazione delle banche, regolazione dei consumi, produzione industriale pianificata) - libera concorrenza -sogno di una società senza classi, in cui gli operai non sono schiavi delle macchine. Secondo lui, inoltre, le imprese devono essere organizzate per settori (Associazionismo delle imprese). Ha una concezione istituzionalistica e non contrattualistica dell’impresa: “Il compito di un’azienda è fare andare i battelli sul Reno e non pagare i dividendi agli azionisti”. Il fine ultimo dell’impresa, quindi, è fare il bene della società. Negli USA, al contrario, l’impresa viene vista come un insieme di contratti (come quelli tra azionisti e manager). L’impresa, quindi, deve fare esclusivamente gli interessi degli azionisti. GRAN BRETAGNA La grande impresa aveva assunto in Gran Bretagna tratti differenti da quelli finora descritti: era concentrata nei settori dei beni di largo consumo e, in alcuni casi, si era deciso di non investire né nella produzione, né nella distribuzione di massa, né nel management. Durante gli anni a cavallo fra il XIX e XX secolo il big business inglese spiccava per la limitata integrazione verticale e per la persistenza di un buon numero di famiglie proprietarie, le quali lasciavano poco spazio alla creazione di estese gerarchie manageriali. Se, da un lato, la persistenza al comando delle famiglie è stata spesso considerata come un sintomo di arretratezza industriale, bisogna anche ricordare che il contesto che caratterizzava la Gran Bretagna alla fine del secolo rendeva più razionale per gli imprenditori l’adozione del paradigma del triplice investimento. In generale le imprese inglesi sembravano godere dei vantaggi di un ampio mercato, sia interno sia internazione. Nel 1870 la Gran Bretagna aveva infatti il reddito pro capite più alto al mondo e il più elevato tasso di urbanizzazione: i 10 milioni di abitanti del “quadrilatero d’oro” compreso fra Londra, Cardiff, Glasgow ed Edimburgo rappresentavano la prima “società dei consumi”, mentre nello stesso periodo le esportazioni britanniche ammontavano a quasi il 30% del reddito nazionale. Il consumo è quindi un consumo di tipo “urbano”, estremamente variegato e differente per classi, il quale non da spazio alla possibilità di commercializzare beni standardizzati. Inoltre, a un esame più attento dei dati, si scopre come: -il mercato interno fosse poco dinamico -la Gran Bretagna esportasse ancora solo prodotti tipici della Prima riv. Industriale (che molte volte non le permettevano di coprire le importazioni) -> L’urbanizzazione e la ricchezza sono per
� 35
l’Inghilterra un elemento di rigidità: ostacolano l’integrazione e la diffusione dei prodotti della Seconda Rivoluzione Industriale -le città non richiedessero un’espansione o una ristrutturazione (non divenendo così i principali clienti delle industri moderne) Le ragioni che hanno reso la grande impresa inglese diversa dalle dirette concorrenti straniere non sono però ancora esaurite: un’altra differenza importante riguarda infatti la regolamentazione. In UK la legge né sanzionava né impediva gli accordi per il controllo della competizione. Prevaleva un atteggiamento di “vivi e lascia vivere”, in quanto l’impresa non era un elemento di eccessivo disturbo per il commercio tradizionale (prototipo del liberalismo economico anglosassone). La stessa ondata di fusioni che aveva colpito l’industria negli USA si rilevava negli stessi anni anche in Inghilterra, ma il numero delle aziende coinvolte e il volume dei capitali interessati furono significativamente minori. Nel Regno Unito le società nate dalle fusioni erano rimaste “federazioni di imprese”, di piccole dimensioni, le quali mantenevano come obiettivo dichiarato quello di assicurare a ogni azienda partecipante il mantenimento della propria quota di mercato, nonché assoluta autonomia gestionale. Anche la relazione fra la grande corporation e il sistema d’istruzione ha avuto un’evoluzione differente in UK, dove la risposta delle istituzioni di formazione superiore alle esigenze delle nuove imprese industriali è stata molto lenta (società basata sull’aristocrazia in cui un uomo non può studiare ingegneria, ma solo greco e latino). Nel 1910 erano poco più di 1100 gli iscritti ai corsi di ingegneria in Inghilterra, mentre la Germania, per la stessa specializzazione universitaria, contava su 16000 studenti solo per il primo anno. Alcuni studiosi hanno attribuito questi aspetti della peculiare situazione inglese a una profonda rivolta contro la società industriale da parte delle élite intellettuali e di vasti strati dell’opinione pubblica. Le evidenze empiriche non sono comunque tali da supportare una simile teoria. Certo è che, nelle imprese familiari, i proprietari si mostravano molto riluttanti a cedere o a condividere il controllo dell’azienda e, come conseguenza, gli investimenti da loro operati erano notevolmente inferiori rispetto a quelli realizzati parallelamente in Germania e in America. La “terza generazione” di imprenditori inglesi ha palesato infine una forma di resistenza culturale alle necessità tecnologhe e organizzative imposte dalla nuova rivoluzione industriale. Anche se la Gran Bretagna aveva ormai perso il primato industriale (declino vittoriano), diversi settori mantenevano posizioni forti, come quello della finanza internazionale (tramite il quale riusciva a mantenere in equilibrio la bilancia dei pagamenti).
A causa del livello tecnologico raggiunto dalle nazioni più avanzate, i Paesi che hanno scelto la strada dell’industrializzazione negli ultimi due decenni dell’800 hanno dovuto aprirsi un varco fra i forti concorrenti. Questo ha comportato anche un fitto intreccio fra imprese e Stato, il quale ha sostenuto la grande impresa con sovvenzioni, protezionismo, commesse e salvataggi, fino ad arrivare, in alcuni casi all’impegno diretto come imprenditore. L’esito di questo processo è stato un mutamento nella strategia delle imprese: mentre in Inghilterra, Germania e USA le ragioni della crescita dimensionale erano state quasi esclusivamente economiche, per la grande impresa dei Paesi ritardatari si possono individuare numerosi esempi di “crescita strategica” guidata da obiettivi politici o perseguita da società interessate ad avere un maggior potere negoziale nei confronti dello Stato. Lo Stato, quindi, ha costituito un fattore sostitutivo. GERSHENKRON e i fattori sostitutivi: i Paesi ritardatari sono stati avvantaggiati nello sviluppo industriale poiché godevano del vantaggio dell’arretratezza, il quale gli permetteva così di non
� 36
ripetere gli stessi errori del free mover. Per sfruttare tale vantaggio, però, doveva intervenire un fattore sostitutivo dell’imprenditorialità avutasi nella prima rivoluzione industriale.
�
FRANCIA (situazione intermedia) Prima del conflitto mondiale quasi mancavano in Francia large corporation paragonabili per dimensione a quelle statunitensi. Le maggiori società del paese erano concentrate soprattutto nei settori non manifatturieri, come il minerario, l’elettrico, i trasporti e le banche, e in alcuni rami industriali, come le lavorazioni siderurgiche e la chimica. È possibile che i problemi più seri per la crescita delle imprese siano venuti dal lato del finanziamento, ma il tema del rapporto fra banche e industria in Francia è ancora oggetto di dibattito fra gli studiosi; mentre è certo che quasi tutte le maggiori società del Paese erano ancora possedute e controllate da famiglie, e questo può aver rallentato gli investimenti nella produzione e nella distribuzione di massa. All’inizio del 900 anche la Francia registrava l’arrivo dei big business: mentre un gran numero di società restava di piccole dimensioni a direzione familiare, alcune imprese cominciavano ad assomigliare alle moderne corporation americane, tedesche e inglesi. Le imprese francesi crescevano investendo nelle nuove tecnologie, professionalizzando le strutture amministrative e sviluppando competenze organizzative tali da permettere loro di raggiungere e mantenere nel lungo periodo una posizione di leadership nei rispettivi settori. L’industria siderurgica, sia pure con imprese più piccole a causa della minore disponibilità di materie prime sul territorio nazionale e di un mercato interno meno ricettivo, era la più dinamica e testimoniava l’emergere dei primi esempi di capitalismo manageriale e di produzione di massa nel Paese. Alla vigilia della guerra mondiale le large corporation in Francia erano concentrate sia nei settori maturi che in alcuni comparti nuovi, come il petrolifero, l’automobilistico, l’elettronico e la produzione dell’alluminio. L’economia Francese stava quindi procedendo nella stessa direzione delle economie più avanzate. RUSSIA L’intervento del governo in Russia è stato decisivo per la promozione e il sussidio alle iniziative locali, attraverso l’imposizione di dazi a protezione del mercato nazionale, e l’attrazione degli investimenti esteri. Ancora allo Stato si deve attribuire l’iniziativa diretta della costruzione di quelle infrastrutture fondamentali al processo di industrializzazione e modernizzazione in un Paese tanto vasto, a cominciare dalle ferrovie che rappresentarono la prima forma di big business e fornirono un massiccio stimolo alla crescita di altri settori, come il metallurgico e il meccanico. Lo Stato finanziò infatti direttamente la costruzione di intere linee: all’inizio del XX secolo il 70% della rete ferroviaria era amministrata dallo Stato. Le prime grandi società industriali, create per iniziativa russa o di investitori stranieri, erano concentrate nei settori ad alta intensità di capitale: siderurgico, meccanico, petrolifero, della gomma, dei trasporti e delle costruzioni navali. Come in Germania e in UK, anche in Russia le grandi imprese tendevano a formare accordi di cartello che il potere centrale non cercò mai di � 37
vietare. Fu lo stesso intervento del governo a modificare un accordo informale fra le imprese operanti nella raffinazione dello zucchero in un cartello ufficiale. All’inizio del XX secolo l’area attorno al fiume Don vantava alcuni fra i maggiori stabilimenti per la lavorazione dei metalli al mondo. Nonostante ciò, il progresso sperimentato dagli ambienti industriali non si estese al resto del sistema economico nazionale, il quale restava radicato nell’agricoltura di villaggio e nel commercio al minuto. GIAPPONE Il Giappone è stato il primo paese non occidentale a raggiungere una posizione di primo piano nel panorama economico internazionale. Il governo ha attivamente promosso il processo di industrializzazione, assumendosi il compito di fondare e gestire imprese in diversi settori e favorendo l’arrivo di tecnici stranieri quali consulenti. Sempre all’iniziativa del governo facevano capo diversi sussidi all’attività industriale. Nonostante l’ampio raggio d’azione dell’intervento pubblico, lo Stato non era l’unico protagonista della crescita economica giapponese: le imprese private ebbero infatti un ruolo fondamentale assumendo la gestione delle aziende create dal governo, quando questo comprese che non poteva sostenerne lo sviluppo fino alla grande dimensione. L’istituzione centrale dell’industrializzazione giapponese è stata quindi lo zaibatsu, il gruppo industriale diversificato, posseduto e controllato da ricche famiglie. La configurazione tipica dello zaibatsu era quella della diversificazione in vari settori industriali correlati. Il progresso economico giapponese è stato senza dubbio importante e ha aperto la strada alla fenomenale crescita industriale del Paese nella seconda metà del XX secolo, ma la ristrettezza del mercato nazionale e il faticoso sviluppo di competenze tecnologiche adeguate alla competizione internazionale hanno impedito alle imprese giapponesi di raggiungere livelli di efficienza pari a quelli raggiunti dal big business nelle nazioni più avanzate. ITALIA Nei decenni che precedono lo scoppio del primo conflitto anche l’economia italiana ha visto l’avvio di un vigoroso processo di industrializzazione. La diffusa presenza di piccole imprese nei comparti tradizionali coesisteva, infatti, con una precoce affermazione di strutture oligopolistiche nei settori dell’industria siderurgica, meccanica ed elettrica. La modesta dotazione di risorse del paese, combinata con la difficoltà di raggiungere la frontiera tecnologica internazionale, ha reso quasi inevitabile la creazione di intrecci fra la grande imprese e lo Stato. Gli strumenti dell’intervento pubblico erano quelli ben noti: protezionismo, commesse, favori e sussidi; a questi i governi italiani aggiunsero, come contributo originale, il “salvataggio industriale”, utilizzato ben quattro volte nel corso del cinquantennio successivo al 1880. La crescita delle grandi imprese private, per esempio la Fiat per l’industria automobilistica, era vincolata dai limiti del mercato interno, che ne condizionava a tal punto lo sviluppo, rendendole inadeguate a un confronto con le large corporation delle nazioni più avanzate.
� 38
CAPITOLO 10
Alla fine della prima guerra mondiale gli Stati Uniti erano il paese industriale più sviluppato a livello mondiale: le grandi imprese americane erano in parte il risultato di percorsi di crescita interni, in parte l’esito di fusioni. Le imprese nate dalla fusione erano compressi di valore ben superiore alla semplice somma delle parti iniziali, perche il processo di fusione aveva comportato la chiusura degli impianti inefficienti e la costruzione di nuovi stabilimenti, realizzati tenendo conto della tecnologia più avanzata per sfruttare adeguatamente le econome di scala e di diversificazione. Un segnale sicuro del successo della fusione era la drastica diminuzione dei costi unitari di produzione e la conseguente espansione delle quote di mercato. La formula organizzativa e di gestione caratteristica della grande azienda americana era, in generale, la U-form, nella quale erano individuate funzioni come la produzione, il marketing, la logistica, le risorse umane, la finanza e i servizi legali. Spesso queste funzioni contavano sulla supervisione quotidiana dei membri del consiglio di amministrazione: il management e il consiglio coincidevano e l’autorità era fortemente centralizzata. La configurazione multi-unitaria comprendeva impianti produttivi, centri di distribuzione, negozi, laboratori e uffici insediati in tutto il paese. Il compito di armonizzare tutte queste unità di produzione e di distribuzione era complesso e impegnativo. Negli USA i problemi che ne derivavano erano stati risolti nel corso del quarantennio precedente la prima guerra mondiale. I “pionieri” avevano acquisito le necessarie competenze tecniche e manageriali mettendo a punto il nuovo disegno organizzativo, e avevano delineato chiari percorsi gerarchici relativi all’autorità e alle comunicazioni interne all’impresa. Significativi cambiamenti organizzativi erano poi intervenuti negli anni Venti, quando il ruolo del manager professionale aveva acquisito un’importanza crescente: da questa fase era infine emersa la moderna impresa multi divisionale. Il debutto di questa nuova forma di struttura aziendale si fondava sia su ragioni interne all’impresa sia su motivazioni esterne. Nel corso del 1920, il PIL e la domanda aggregata avevano cominciato a stabilizzarsi. Le imprese non avrebbero più potuto contare solo sui fattori esterni come la crescita della popolazione, la costruzione delle ferrovie e l’urbanizzazione; per la loro espansione diventava essenziale compensare la caduta della domanda. Contemporaneamente, il processo di crescita e le fusioni avevano portato alla creazione, in molte aziende, di un eccesso di risorse interne: persone, attrezzature, know-how e competenze. Ai manager competeva quindi l’onere di selezionare queste risorse e farne un uso ottimale. In alcuni settori, come l’elettromeccanico e il chimico, la crescita dei dipartimenti di ricerca e sviluppo schiudeva la possibilità di elaborare nuovi prodotti basati su tecnologie originali (solo in questo periodo, con l’istituzionalizzazione della R&S si inizia a fare ricerca di base, senza avere in mente un’idea di prodotto). In casi di questo tipo, la crescita dell’impresa non si fondava su condizioni esterne, quanto piuttosto sugli sviluppi interni alla stessa azienda. Per i manager, quindi, risorse sottoutilizzate all’interno della società costituivano un continuo stimolo all’espansione. Le tre strategie perseguibili sarebbero state: -l’integrazione orizzontale (acquisizione di altre imprese nello stesso settore): non viene perseguita a causa della legislazione antitrust che attaccava i monopoli e le posizioni dominanti. -l’internazionalizzazione: non viene perseguita poiché vi erano politiche a protezione del mercato interno; -la diversificazione correlata (alternativa scelta).
� 39
La diversificazione in atto poneva molte imprese direttamente in prima linea nella nuova e importante svolta organizzativa. L’espansione delle linee di produzione, già difficile da gestire nel quadro della tipica struttura piramidale della U-form centralizzata, cominciava a creare tensioni all’interno delle imprese. Particolarmente disorientato appariva ora il top management di fronte alla prospettiva di avviare e governare un crescente numero di linee di prodotto diverse, senza il tempo per mettere a fuoco le decisioni strategiche generali. Un ruolo pionieristico nella soluzione di questi problemi venne svolto dalla DuPont e dalla GM. I vertici di queste corporation compresero l’importanza di concedere ai manager un certo grado di libertà operativa nella gestione dei rispettivi mercati. Furono quindi definite divisioni indipendenti basate sulle diverse linee di prodotto o su aree geografiche; le nuove divisioni erano dotate delle funzioni di line e staff necessarie ad operare efficacemente; il vertice dirigente non risultava più impegnato nelle funzioni operative ordinarie (al contrario poteva concentrarsi sulla supervisione, sul coordinamento, sulla valutazione e sull’allocazione delle risorse per l’intero complesso). Per ricoprire efficacemente questo ruolo strategico, il “quartier generale” era composto da uno staffa adeguato a monitorare l’attività di tutte le divisioni. Lo staff erano in grado di sovrintendere al processo di diversificazione, trasferendo le risorse finanziarie, tecniche e manageriali da una divisione all’altra. I legami fra il quartier generale e le divisioni garantivano che l’impresa multi divisionale (M-form) si ponesse come il prodotto di una naturale evoluzione. La struttura multi divisionale, una volta messa alla prova, si diffuse nel sistema industriale statunitense nel corso degli anni quaranta e divenne il modello organizzativo adottato dalle altre nazioni per competere alla pari con gli USA. All’inizio del 1940 il pessimismo di Schumpeter non sembrava giustificato. Schumpeter aveva descritto il capitalismo industriale basato sulla grande impresa e aveva espresso la preoccupazione che quest’ultima avrebbe finito per soffocare le scintille di imprenditorialità che egli associava all’egemonia borghese. Il grande economista non aveva capito che l’impresa multi divisionale era l’esempio realizzato dell’abilità del modello capitalistico americano di garantire che lo spirito imprenditoriale potesse essere diffuso all’interno di un’intera organizzazione burocratica. La prospettiva di Chandler, invece, sembra quella capace di abbracciare tutti i temi della crescita. Il suo approccio alla storia della grande azienda, molto vicino all’impostazione analitica della Penrose, gli permette di considerare sia l’integrazione verticale sia quella orizzontale. GENERAL MOTORS La soluzione multi divisionale non ha certo rappresentato per ogni impresa un esito, semplice e universale, di successo. Henry Ford, per esempio, aveva un’avversione per gli organigrammi e la burocrazia aziendale e fu incapace di compiere questo passaggio. Nel 1921 Ford era di gran lunga il numero uno al mondo nella produzione automobilistica: copriva il 55,7% del mercato, mentre la GM occupava, ben distanziata, la seconda posizione con una quota del 12,3%. Costituita nel 1908 la GM era il risultato della fusione di diverse aziende pioniere nel settore automobilistico. Per Durant l’obiettivo della fusione non era ridurre i costi attraverso la razionalizzazione della capacità produttiva, quanto, piuttosto, ristrutturare gli impianti in vista di un ulteriore aumento della produzione. Sfortunatamente le previsioni eccessivamente ottimistiche di Durant sulla crescita della domanda e la sua incapacità di integrare le varie società in maniera razionale conducevano la GM in una situazione di crescente difficoltà finanziaria già nel secondo decennio del secolo. Nel 1920 il maggior azionista della GM, il gigante della chimica DuPont, destinava Pierre DuPont a rilevare la posizione di Durant, mentre decideva di affidare la gestione operativa dell’impresa a Alfred Sloan. In un breve periodo dei � 40
primi anni Venti, Sloan e DuPont trasformarono l’eclettico insieme di unità operative in un’impresa multi divisionale coordinata. La GM era alla fine articolata in divisioni indipendenti destinate alla produzione di automobili, autocarri e altri veicoli commerciali. Ogni divisione era quindi dotata di una propria organizzazione per la produzione e la distribuzione. Così ristrutturata, la GM superò presto la Ford. Se il motto di Ford era “di ogni colore purché sia nero”, la filosofia di Sloan era invece riassunta nella frase “un automobile per ogni borsa (portafoglio) e per ogni scopo”. La produzione automobilista di GM era ripartita in 5 divisioni, ognuna mirata su un diverso livello di reddito dei consumatori. Sloan comprese che il mercato automobilistico stava cambiando, e l’obiettivo non poteva più essere a lungo quelli di vendere alla clientela la prima automobile. La GM voleva al contrario indurre il cliente a pensare all’acquisto di una nuova auto in sostituzione dei vecchi modelli. La società doveva quindi concentrarsi nel miglioramento dello stile, del comfort, delle prestazioni dei vari modelli, proposti in diversi colori. Quando Ford cominciò a perdere terreno, reagì licenziando alcuni manager in posizioni chiave per l’impresa. Sloan arrivò subito ad assumerli con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il suo team di dirigenti di alto livello. A partire dal 1921 Ford stesso aveva ripreso ad occuparsi della direzione operativa del suo impero, ma i risultati non lo confortavano: la sua società era in grado di produrre solo lo stesso modello di automobile, e con gli stessi metodi, ormai non più all’avanguardia. Alla fine del 1929 l’inversione delle quote di mercato era completata: alla Ford restava il 31,3%, mentre la GM saliva al 32,3%. L’anno 1940 fu quello della caduta fatale: la quota di mercato della Ford crollava al 18,9%, inferiore rispetto al 23,7% della Chrysler, mentre GM deteneva quasi la metà del mercato (47,5%). Solo dopo la morte di Ford la società che portava il suo nome si dimostrò capace di riconquistare alcune delle posizioni perse, copiando la forma organizzativa della GM e assumendo manager di alto profilo. La soluzione multi divisionale ebbe successo perché rispondeva al problema dell’allocazione del potere decisionale in una grande e complessa impresa moderna. Se il potere era conferito solo ai massimi livelli, tutta l’organizzazione ne soffriva, a causa della mancanza di una veloce circolazione delle informazioni e della scarsa motivazione a innovare. La ristrutturazione aziendale andava misurata sulle esigenze di ogni impresa. Aree di potere personale e compromessi abbondavano e influenzavano le strutture di comando alla GM: i proprietari puntavano a escludere i capi delle divisioni dal quartier generale, per concentrare il potere in un comitato esecutivo formato dai manager di alto livello e da pochi rappresentanti degli azionisti. Il loro obiettivo era il controllo dell’impresa: la GM delegava la responsabilità al top management, preservando allo stesso tempo i diritti di deroga dei grandi azionisti, i quali mantenevano il potere di veto sulle decisioni manageriali bloccando il finanziamento delle stesse. Alcuni esponenti del vertice manageriale consideravano con cautela l’idea di separare completamente la pianificazione strategica da quella operativa (day by day): nella loro visione il punto più importante era creare consenso all’interno delle divisioni e stimolare lo spirito imprenditoriale fra i ranghi dei manager di medio livello. Così facendo, il top management della GM pensava di coinvolgere i manager delle divisioni nella pianificazione strategica e nelle decisioni riguardanti l’allocazione delle risorse. Questa preferenza era fondata su un profondo senso pratico: i top manager sapevano che le divisioni si sarebbero senza dubbio opposte a ogni iniziativa frutto di un’imposizione dall’esterno. Erano quindi pronti a scendere a
� 41
compromessi e a concedere la partecipazione di coloro che operavano nelle divisioni alle decisioni strategiche in cambio di consenso e supporto. Il problema relativo a chi dovesse essere incluso nel processo di pianificazione strategica non era l’unica questione pressante di divergenza fra i proprietari e management: i dirigenti si opponevano al diritto di veto della proprietà sui nuovi investimenti. La battaglia fra proprietari e manager su chi dovesse guidare la trasformazione organizzativa della società era inoltre influenzata da vincoli istituzioni e tecnici. Il primo era la politica antitrust del governo: alla fine degli anni Quaranta il Dipartimento di giustizia iniziò una battaglia legale contro DuPont, costringendolo a cedere la partecipazione. L’altro fattore era rappresentato dallo stesso sviluppo della GM: gli enormi profitti accumulati dalla compagnia avevano di fatto cancellato la forza di pressione della proprietà, consentendo ai manager di avere il denaro necessario per fare quello che desideravano. Fino a quando il denaro necessario per fare nuovi investimenti era stato scarso, la proprietà della GM aveva insistito per l’applicazione della formula della M-form caratterizzata sia dalla separazione tra strategia e gestione, sia dal controllo proprietario attraverso l’allocazione delle risorse finanziarie. Questa impostazione aveva impedito all’esecutivo di coinvolgere i vertici delle divisioni nell’attività decisionale del quartier generale, obbligando Sloan a scegliere mezzi informali per sviluppare il consenso all’interno dell’organizzazione, così, i manager delle divisioni erano ammessi al meeting del quartier generale, ma non era stato possibile garantire loro il diritto di voto (UNICA COSA IMPORTANTE CHE FECE SLOAN). In realtà, questo periodo di storia della GM è stato relativamente breve, proprio grazie agli straordinari profitti. Il top management aveva quindi ottenuto un deciso indebolimento del potere della proprietà basato sul controllo della leva finanziaria, consentendo infine la partecipazione diretta dei manager di divisione al processo decisionale e all’allocazione delle risorse. I proprietari della GM furono in grado di riprendere il controllo dell’impresa solo quando la performance della società iniziò a registrare un arretramento, negli anni fra il 1956 e il 1958, quando venne infine adottata la versione pura della M-form. La nuova struttura, creata nel 1958, 1
ristabiliva il potere di potere di veto degli azionisti e imponeva una rigida separazione fra le divisioni e il quartier generale. Il nuovo gruppo dirigente non avanzò tentativi di coinvolgere i livello medi nella definizione strategia, e tanto meno cercò di convincere i manager di divisione ad accettare le decisioni prese al vertice. Il risultato fu un clima di crescente sfiducia e diffuso dissenso: da un lato si avvertiva l’animosità dei manager operativi, che diventavano sempre meno collaborativi nella fase di realizzazione delle politiche proposte dal quartier generale, indipendentemente dall’efficacia di queste nuove scelte rispetto alla situazione precedente; dall’altro, invece, la presenza del top management diventava sempre più invasiva, coi i suoi membri che cercavano di aggirare l’opposizione dei manager di medio livello occupandosi direttamente dei dettagli operativi. Invece di aumentare l’efficienza e migliorare la governante della GM, l’adozione della M-form nella sua versione più aderente alla teoria finì per causa la distruzione del consenso e portò a un lento e lungo declino della società. Vantaggi M-form: -Migliore possibilità di accedere alle informazioni -Migliore possibilità di dare incentivi ai manager -Migliore capacità di svolgere attività in settori diversi (strategia di diversificazione correlata) ƒ -Decisioni prese al livello più basso della scala gerarchica
La forma pura della M-‐form venne proposta da Williamson. Egli analizza la M-‐form sempre nell’oEca che l’impresa serva per ridurre i cosH di 1
transazione, guardando quindi all’impresa mulHdivisionale come a una specie di mercato interno dei capitali. Secondo Williamson deve esserci una rigidissima separazione fra divisioni e quarHer generale� 42
Svantaggi M-form: -Come individuare i criteri (geografici, tecnologici, prodotti) nella scelta delle divisioni? ƒ -Dimensione ottimale delle divisioni ƒ -Scelta di quali ambiti vanno pianificati dal centro ƒ -Problemi gestionali, contabili e amministrativi: la necessità di nuovi strumenti di analisi Separazione fra controllo e proprietà, il ruolo dei manager: indipendentemente dall’esito del caso GM, la comparsa della forma multidivisionale ha rappresentato un fattore importante nell’affermazione dell’impresa manageriale, con la separazione fra controllo e proprietà. All’inizio degli anni Trenta, Berle e Means riconoscevano chiaramente questa trasformazione e il suo impatto sul concetto di proprietà, sottolineando il divorzio tra coloro che governano un sistema e quelli che ne detengono la proprietà. Nel volume, The Modern Corporation and Private Property, i due autori evidenziano il fatto che le grandi compagnie ad azionariato diffuso erano diventate la forma economia dominante nel mondo moderno. Sono i primi a parlare di public company (proprietà azionaria talmente frazionata da sembrare pubblica. Nasce cos’ il fenomeno dei BOARDS COZY WITH MANAGEMENT, cioè dei consigli di amministrazione accomodanti , permissivi nei confronti del management) .Facilitando il trasferimento delle quote di proprietà, era stato possibile concentrare la ricchezza di numerosi individui in aggregati di grandi dimensioni, un dato che aveva modificato in profondità le relazioni fra l’impresa e i suoi proprietari, separando gli azionisti dal controllo della compagnia. L’opinione di Berle e Means sull’azione dei manager era pessimista: erano infatti convinti che gli alti gradi dell’azienda potessero dimostrarsi completamente indipendenti dalla proprietà, e capaci di perpetuare il loro potere al punto di non dover giustificare con nessuno le loro scelte. I manager sarebbero stati in grado di deviare il flusso dei profitti a proprio esclusivo vantaggio, disponendo le cose in modo da poter perseguire obiettivi che avrebbero portato loro prestigio, potere e soddisfazione personale, piuttosto che concentrarsi sugli interessi della maggioranza degli azionisti. Invece di essere parti complementari o integrate del medesimo sistema, per Berle e Means la proprietà ed il controllo erano collocati su posizioni opposte, al punto che l’una operava contro l’altro. La questione fondamentale era stabilire dei confronti di chi i membri di ogni gruppo fossero da considerare responsabili. Secondo gli autori, erano tre le possibili risposte al quesito. La prima era fondata sulla fiducia che l’interesse e la responsabilità dei manager dovessero riferirsi esclusivamente agli azionisti; la seconda consisteva nel riconoscere ufficialmente che i dirigenti governavano l’impresa a vantaggio dei propri interessi; la terza si basava sul riconoscimento del principio secondo il quale le moderne società non erano solo al servizio dei proprietari (o degli individui che si occupavano della loro gestione) ma, piuttosto, dell’intera comunità. La risposta al problema del controllo societario (azionisti contro manager) doveva quindi spostarsi su un piano diverso, mettendo al centro il valore sociale dell’impresa e gli interessi degli stakeholder: dipendenti, fornitori, distributori, clienti, fino a estendere il campo alla comunità intesa nel modo più ampio (IMPRESA CON COSCIENZA SOCIALE. Grazie a loro, infatti, nasce la CRS). Questa posizione trovava una consonanza positiva con il clima creato dal New Deal di Roosevelt e con lo stato d’animo del Paese durante la peggiore depressione economica della sua storia. Per far fronte a tale crisi il New Deal aveva risposto innanzitutto con il National Recovery Act, che cercava di disegnare una forma di capitalismo basato su una maggiore cooperazione fra le parti e una nuova regolamentazione dell’attività economica. Nonostante il fallimento e l’abbandono del NRA nel 1935, era rimasta una forte percezione che qualcosa di importante fosse cambiato. Questa situazione spingeva Burnham a scrivere The managerial Revolution, nel quale � 43
riconosceva la nuova posizione di potere raggiunta dai manager e addirittura preannunicava l’avvento di un’economia statunitense pianificata, convergente con quella della Germania nazista e dell’Unione Sovietica. La politica americana incentiva l’idea della public company poiché è molto vicina alla democrazia. Anni prima, e in un contesto completamente diverso, Rathenau era arrivato a conclusioni simili, dichiarando che l’impresa e lo Stato avrebbero dovuto integrarsi nella società, allo stesso modo in cui i vari gruppi che componevano l’impresa avrebbero dovuto integrarsi per porsi al servizio della comunità. Come Berle e Meand, Rathenau era attento al fenomeno del graduale ritirarsi degli azionisti dalla gestione quotidiana dell’impresa. Rathenau individuava due tipi di azionisti: quelli che avevano operato un investimento permanente dei loro capitali, e quelli che acquisivano azioni con intenti puramente speculativi. Era convinto che gli obiettivi del primo gruppo potessero coincidere con quelli del management, ma pensava che il secondo gruppo rappresentasse un rischio continuo di conflitto di interessi, perché quel tipo di azionisti era interessato solo ai guadagni sul breve periodo, mentre le imprese volevano accumulare e reinvestire gli utili. Rathenau sosteneva una legislazione capace di limitare i diritti degli azionisti. Per Rathenau era inconcepibile che l’impresa potesse sacrificare se stessa a vantaggio degli interessi privati di azionisti che a breve non avrebbero avuto più alcun legame con la compagnia. La grande impresa non sarebbe più stata un’organizzazione portatrice di interessi regolati dal diritto privato, bensì una componente fondamentale dell’economia nazionale e, in quando tale, una parte della comunità (L’IMPRESA E’ LA SOCIETA’). Per Rathenau il potere generato all’interno dell’azienda e concentrato nel suo vertice dirigente implicitamente caricava quest’ultimo di una responsabilità sociale: nella sua visione, era come se questa responsabilità sociale fosse stata affidata ai manager da tutti i gruppi componenti l’impresa e, quindi, da tutta la comunità. Rathenau, come Berle e Means, arrivava alla conclusione che gli interessi di un’impresa possono essenzialmente essere integrati nell’organizzazione e anche allineati a quelli della comunità. Per Rathenau l’obiettivo era raggiungere la sicurezza che i manager aderissero alla regolamentazione e ai vincoli posti dal potere pubblico. L’esito, cioè l’indebolimento della proprietà, era per Rathenau solo un’evoluzione naturale provocata dalla presenza della grande azienda, ma anche un preciso obiettivo della politica, e uno degli elementi fondanti della “nuova economia”, nella quale l’impresa avrebbe posto se stessa al servizio degli interessi collettivi, assumendo il ruolo di pilastro nella conservazione e nella difesa dello Stato nazionale.
� 44
CAPITOLO 11
Il 25 dicembre del 1925 alcune imprese chimiche tedesche, fra le maggiori del Paese (Agfa, Bayer e BASF) definivano un accordo formale che aveva come esito una federazione chiamata I.G.Farben (I.G. stava per Interessen Gemeinschaft, comunità di interessi). La I.G. Farben diventava così la maggiore società chimica in Europa e una delle più grandi a livello mondiale. Tecnicamente, non era un cartello, ma una fusione, con un imponente quartier generale a Francoforte. Uno dei principali obiettivi della sua creazione era il recupero della leadership mondiale che l’industria chimica tedesca aveva perso dopo la grande guerra. L’importanza assoluta della I.G.Farben è testimoniata dal fatto che prima dello scoppio del secondo conflitto, il vertice aveva stretto alcuni accordi di cartello segreti a livello internazionale, per esempio con i leader della Standard Oil e della DuPont. Un’altra conseguenza della creazione del gigante chimico tedesco ebbe ripercussioni a livello europeo: negli anni seguenti alla sua costituzione venivano infatti creati raggruppamenti simili di imprese in UK e in Francia, rispettivamente con la Imperial Chemical Industries (ICI) nel 1926 e la Rhone-Poulenc nel 1928. Questo processo di aggregazione attraverso fusioni e federazioni aveva alla base diversi fattori di natura sia economica che politica. Nell’industria chimica i gruppi di imprese servivano da un lato a stabilizzare i profitti e dall’altro a ridurre i costi unitari attraverso le economie di scala e di diversificazione. Un tratto costante era infatti l’unificazione delle attività di R&S, delle competenze scientifiche e dei brevetti. Allo stesso tempo agivano però importanti motivazioni politiche. Immediatamente dopo la riorganizzazione, la I.G.Farben iniziava un’aggressiva politica di acquisizioni all’estero, per penetrare mercati promettenti. Il primo obiettivo era il mercato britannico: acquisire la British Dyestuffs Corporation (BDC). La mossa tedesca era considerata inaccettabile dal governo britannico, il quale decise di operarsi per promuovere una fusione esclusivamente “inglese”: questa si concretizzò nel 1927 con la creazione dell’ICI, il risultato della fusione della BDC con altre quattro società chimiche del Paese. La prima guerra mondiale aveva rappresentato una cesura netta nel percorso di sviluppo economico dell’Occidente. La guerra aveva evidenziato la decisa modernizzazione in corso nei settori di punta delle economie europee più avanzate. I comparti tessile e della lavorazione del ferro, che avevano dominato la prima rivoluzione industriale, perdevano progressivamente terreno a favore dei settori ad alta intensità di capitale della seconda: chimico, elettrico e siderurgico. Quasi ovunque lo sforzo bellico aveva imposto la creazione di grandi organizzazioni , e alcune imprese erano cresciute al punto che difficilmente avrebbero potuto adattarsi alle condizioni produttive del tempo di pace. Alla vigilia del secondo conflitto, fra i 50 maggiori gruppi industriali per capitalizzazione a livello internazionale, 32 erano in USA, 11 in UK e 4 in Germania. Il caso ICI rappresenta con molta chiarezza le caratteristiche dell’ambiente economico, culturale e politico in cui si trovava a operare la “corporation europea” nel periodo infrabellico. Le decisioni politiche avevano assunto una connotazione protezionista, corporativa e sempre più interventista, sia nei governi democratici sia in quelli autoritari; gli accordi e i cartelli erano tollerati sia a livello nazionale sia internazionale: questo contesto aveva dato forma alla grande impresa europea. Come era accaduto negli Stati Uniti, gli imperativi della nuova ondata tecnologica obbligavano gli imprenditori e i governi europei a considerare le nuove pratiche organizzative, finanziarie e competitive. Gli imprenditori europei che operavano nei settori più avanzati si trovarono a
� 45
mettere in atto politiche di sviluppo e integrazione, a ricercare appropriate fonti di finanziamento e di materie prime, a organizzare e disciplinare la forza lavoro, ad aprire nuovi canali di distribuzione per i beni che stavano cominciando a produrre in scala ben maggiore rispetto al passato. Il panorama in cui si svolgevano tutti questi processi era però inevitabilmente diverso da quello in cui gli imprenditori e i manager americani avevano operato. La storia europea aveva prodotto un ambiente culturale meno favorevole per le imprese e per i rapporti fra queste e lo stato e questo clima influenzava le occasioni e le decisioni imprenditoriali. La diffusione del modello dell’impresa manageriale in Europa avvenne più lentamente a causa dei fattori culturali, della struttura dei mercati e delle politiche industriali adottate dai governi. Nella prima metà del XX secolo l’Europa sprofondò nella crisi e nel caos: due guerre mondiali, una crisi economica, le dittature, il nazionalismo economico degli anni Trenta non potevano non avere conseguenze. Un altro elemento che ha contribuito in modo determinante a forgiare le caratteristiche delle imprese europee è rappresentato dalla dimensione contenuta e dallo scarso dinamismo dei mercati nazionali. Le aree periferiche del continente (Italia meridionale e anche le province rurali francesi) erano ancora gravate da una diffusa arretratezza sociale ed economica, e da un esteso dominio dell’agricoltura. Queste regioni quindi non solo esprimevano livelli di domanda molto contenuti, ma la struttura dei consumi era antitetica a quella delle società in cui si andavano manifestando i moderni consumi di massa. Ciò era evidente nei settori alimentari, ma anche in quelli dell’abbigliamento, delle calzature e dei mobili, nei quali prevalevano la piccola e media scala di produzione. Incrementi delle esportazioni e degli investimenti diretti al’estero avrebbero potuto stimolare questi sistemi nazionali relativamente stagnanti. Tuttavia, nel periodo tra le due guerre segnato dall’azione di regimi economici autarchici, non era facile costituire grandi imprese internazioni competitive: la guerra aveva lasciato il mercato europeo frammentato in economie nazionali protette, all’interno delle quali era consentita solo una limitata penetrazione di investimenti e prodotti stranieri. Oltre alle requisizioni e alle nazionalizzazioni, nel periodo bellico si verificava un esteso esproprio degli investimenti esteri dei Paesi sconfitti. Così, il denso network costruito in Europa dalla compagnie tedesche veniva smantellato dagli alleati vittorioso. In alcuni casi l’internazionalizzazione delle compagnie era iniziata prima della guerra, quando ci si rese conto che il mercato interno non avrebbe potuto sostenere la crescita di grandi imprese integrate. Molte società olandesi e svizzere furono capaci di diventare multinazionali prima della grande guerra, come la Nestlè. Negli anni fra le due guerre, poi, le imprese inglesi continuarono ad operare a un livello internazione superiore rispetto alla media europea. Le istituzioni pubbliche ebbero in Europa un ruolo importante nella definizione delle regole relative alla competizione e alle strategie imprenditoriali, con effetti anche molto diversi da Paese a Paese. Innanzitutto, le istituzioni giuridiche assunsero una funzione importante nella regolamentazione dei mercati e della concorrenza. Gli europei erano molto più tolleranti nei confronti dei comportamenti “collusivi” rispetto agli americani, i quali avevano introdotto la legislazione federale antitrust. I cartelli erano la norma in Germania e lo Stato sosteneva gli accordi fra imprese come un importante strumento di politica industriale. Nel periodo fra le due guerre, la cartellizzazione si diffondeva in tutta Europa, diventando una componente essenziale delle politiche economiche approntate sia dai regimi dittatoriali dia dai governi democratici.
� 46
I cartelli consentivano ai partecipanti di godere di una relativa stabilità dei prezzi e della domanda. Il controllo sui prezzi e sulle quote di mercato poneva però un serio freno al potenziale espansivo delle imprese, disincentivando il perseguimento di strategie d’integrazione e sviluppo. D’altro canto, però, gli accordi stabili sui prezzi rappresentavano per le imprese un incoraggiamento a raggiungere l’efficienza al loro interno, per mantenere i costi operativi il più possibile bassi e avvantaggiarsi quindi dei prezzi concordati. Da un punto di vista sociale, nella cultura europea i cartelli rappresentavano una buona alternativa alle grandi concentrazioni industriali tipiche dello stile americano, e questo era particolarmente vero in Paesi come la Germania, nei quali la grande impresa e il Finannzkapital godevano di scarsa popolarità nel dibattito politico e sociale. La stabilità delle quote di mercato consentiva quindi alle aziende un’accurata pianificazione degli investimenti, mantenendo relativamente in equilibrio il livello dell’occupazione. Nel corso dei turbolenti anni fra le due guerre i cartelli si diffusero velocemente. Le imprese erano infatti spinte a ricercare un elevato coordinamento con l’obiettivo di ridurre i margini di incertezza. Alla fine degli anni Trenta quasi tutte le imprese leader europee erano associate a un cartello internazionale. In diversi casi il governo era il maggior cliente per le grandi concentrazioni industriali, in particolare per i comparti direttamente correlati alla sicurezza nazionale; in altri casi, con ordinativi, protezione, tariffe e anche aiuti finanziari, il supporto statale mirava alla creazione di una moderna ed efficiente base industriale in Paesi che scontavano una debole domanda interna. Questo era il caso evidente dell’Italia, dove l’attitudine interventista dello Stato aveva dato il tono all’industrializzazione nazionale dai sui inizi: lo Stato italiano era direttamente proprietario di alcune delle strutture di servizi più importanti del Paese e, dalla metà degli anni Venti, era diventato de facto un influente azionista in diverse compagnie industriali (in particolare nei settori capital intensive) attraverso i vari “salvataggi” compiuti per evitare alle imprese italiane il rischio di bancarotta e fallimento. Questa politica continuava all’inizio degli anni Trenta, quando, con la fondazione dell’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) lo Stato italiano diventava in assoluto il maggiore investitore del paese. In alcuni casi questa operazione spianava la strada alla razionalizzazione di interi comparti industriali, con l’adozione delle tecnologie più avanzate. L’esperienza italiana può essere considerata un caso eccezionale, con rare imitazioni da parte delle altre nazioni europee. Il caso ICI, invece, esemplificava un’altra modalità di intervento, meno invasiva e diretta. In Europa si potevano così rinvenire fra le due guerre diversi modelli di supporto pubblico alle imprese, e ognuno aveva un impatto diretto differente sulle forme assunte dalle strutture capitaliste in ogni contesto nazionale. Un secondo fattore determinante nella configurazione assunta dalla grande impresa europea fra le due guerre era rappresentato dalla struttura dei mercati dei capitali e dal loro impatto sulle strategie finanziarie aziendali. In UK, mentre le banche regionali e locali finanziavano la maggior parte delle piccole imprese operanti nei settori tradizionali, un dinamico mercato azionario aveva occupato una posizione di rilievo a supporto delle più significative iniziative imprenditoriali nell’industria e nel commercio. Questo vivace mercato convogliava le risorse necessarie a promuovere lo sviluppo di un sostanzioso numero di importanti fusioni e acquisizioni nei settori avanzati. Era questo, per esempio, il caso della Dunlop che a partire dagli anni venti introduceva una struttura divisionale adeguata a sostenere una strategia di progressive acquisizioni e relativa diversificazione. In altri casi il processo di crescita veniva gestito attraverso la costituzione di una federazione di imprese con a capo una holding: in questa struttura organizzativa una finanziaria controllava direttamente un gran numero di � 47
consociate, spesso sistemate in una struttura piramidale che impiegava dense reti di governo, formate da consigli di amministrazione incrociati (interlocking directorate). Anche se quotate in Borsa, molte imprese industriali britanniche rimanevano largamente personali, con esponenti della famiglia del fondatore a occupare numerosi posti nei consigli di amministrazione. Le holding britanniche, che consentivano alle famiglie di mantenere un ruolo tradizionale nelle imprese, non erano M-form integrate e decentrate, ma un sistema federativo. Molte fusioni non erano altro che cartelli, all’interno dei quali si realizzava una divisione collusiva del mercato. In Germania lo sviluppo delle grandi imprese fu sostenuto dal mercato azionario, insieme a un consistente autofinanziamento e ad un efficiente sistema bancario, articolato in grandi istituti di credito. Le banche “universali” avevano forgiato il mercato finanziario tedesco. Le banche più grandi investivano in titoli industriali ed erano anche influenti nei consigli di amministrazione attraverso il voto dei loro fiduciari. A partire dalla fine dell’800 le banche erano diventate la componente chiave del capitalismo tedesco, in qualità di importanti creditori e influenti azionisti. In molti casi esse erano in grado di indirizzare le scelte delle società, selezionando e controllando da vicino la leadership aziendale. In Francia e in Italia, le famiglie imprenditrici nei settori ad alta intensità di capitale furono in grado di mantenere uno stretto controllo sulle loro imprese, conservando la pozione di vertice, ricorrendo in misura relativamente limitata al mercato azionario e accentuando la dipendenza dal credito fornito dalle banche più importanti. Un altro ambito in cui si rese evidente la differenza fra Europa e USA è quello che riguarda le relazioni fra capitale e lavoro, sia dalla prospettiva della partecipazione dei lavoratori, sia da quella delle pratiche manageriali. Nella cultura economica europea i colletti bianchi (gli impiegati) e le tute blu (gli operai) rappresentavano componenti fondamentali per l’impresa. La partecipazione dei lavoratori al governo dell’azienda era un tratto caratteristico dell’esperienza europea successiva al primo grande conflitto. Un clima culturale favorevole aveva incoraggiato, nella Germania di Weimar, la partecipazione diretta dei lavoratori alla gestione delle imprese, fino al periodo nazista. I consigli di fabbrica erano gli organismi attraverso i quali i dipendenti potevano ottenere informazioni relative alle politiche dell’impresa e comprendere gli obiettivi e gli indirizzi dei vertici aziendali. Queste pratiche di partecipazione riemersero dopo la seconda guerra mondiale. In altri Paesi europei, come l’Italia e la Spagna, la partecipazione dei lavoratori aveva assunto forme diverse. Sotto regimi autoritari che limitavano le libertà sindacali, il confronto formale fra i dipendenti e i dirigenti era considerato uno strumento per mantenere sotto controllo il conflitto di classe. Era questa la soluzione dell’Italia fascista, che negli anni Trenta introduceva il sistema delle “corporazioni”, istituzioni legali che miravano a mantenere il confronto fra capitale e lavoro su una base settoriale, e servano a regolare i potenziali conflitti trattando i due contenti come formalmente equivalenti. Anche se il riconoscimento era puramente formale, la forza lavoro europea manteneva una posizione di rilievo nella cornice aziendale. I lavoratori si presentavano infatti con una decisa identità politica e una forza organizzativa sindacale rilevante. In generale, i lavoratori americani erano meno sindacalizzati e meno interessati a un coinvolgimento diretto nella vita aziendale rispetto ai colleghi europei. La differenza risale al fatto che in quasi tutte le grandi aziende europee la forza lavoro aveva mantenuto un certo controllo sul processo produttivo in fabbrica, un processo guidato dagli operi specializzati, che godevano di un alto grado di autonomia. L’introduzione delle moderne tecniche gestionali americane in Europa venne così filtrata : esse subirono un processo di adattamento profondo all’ambiente europeo. Alcuni tentativi di � 48
introdurre in Europa i metodi scientifici dell’organizzazione del lavoro, però, ebbero luogo con un certo successo. Europa e USA si differenziavano nettamente anche per quanto riguarda la composizione del gruppo dirigente nelle imprese. In America le carriere manageriali rappresentavano una via di elevazione e mobilità sociale, ed erano quindi molto attraenti per i giovani appartenenti alle classi medie e agli strati superiori delle classi lavoratrici; le discipline manageriali erano inserite nei corsi di formazione specializzati, offerti da istituzioni ad hoc o dalle business school. In Europa, al contrario, erano disponibili pochissimi corsi specificatamente diretti alla formazione dei dirigenti. L’addestramento avveniva generalmente dei luoghi di lavoro (on-the-job) e i percorsi di carriera interni all’azienda portavano impiegati, addetti alle vendite e persino operai a posizioni di leadership. Una parziale eccezione era rappresentata dagli ingegneri, gli unici dipendenti di alto livello con una formazione specifica in grado di intraprendere una carriera manageriale. Nel periodo fra le due guerre le imprese europee erano rimaste in media più piccole delle concorrenti americane, si mostravano meno interessate a promuovere la separazione fra proprietà e controllo, erano meno diversificate. Le società erano meno disposte ad assumere manager professionali e ad adottare sistemi formali di decentramento del potere e delle responsabilità. Il percorso seguito dall’Europa includeva la progressiva diffusione della H-form (struttura a holding), la quale si dimostrava flessibile e adattabile a diverse situazioni. L’H-form rese possibile l’integrazione verticale e orizzontale, consentendo ai proprietari di raccogliere risorse finanziarie destinate ai processi di integrazione, senza perdere la posizione di potere nell’impresa e nelle consociate.
CAPITOLO 12
Fra il 1820 e il 1870 il PIL giapponese crebbe con una media annua vicina allo 0.2%, contro l’1% registrato in Europa. Nei quattro decenni seguenti, fino allo scoppio della guerra, il Giappone segnava un indice di sviluppo annuo dell’1,5% mentre il tasso di crescita europeo restava invariato. Dietro a questi andamenti scorgiamo l’affascinante storia di un rapidissimo sviluppo economico nazionale, tanto più interessante se consideriamo il generale isolamento che aveva segnato la storia del Giappone fino alla metà dell’Ottocento, quando gli USA e le potenze occidentali imposero al Pese l’apertura al commercio internazione attraverso i “trattati ineguali”. L’anno 1868 segna l’inizio della cosiddetta “Rivoluzione Meiji” (o restaurazione Meiji) con la quale un gruppo di oligarchi, aristocratici e samurai prese il controllo del governo nazionale. Questa seguiva a due secolo e mezzo durante i quali l’imperatore (tenno) era stato confinato a un ruolo simbolico, mentre un leader politico e militare, lo shogun della dinastia Tokugawa, esercitava il potere effettivo. Quella della rivoluzione Meiji è considerata convenzionalmente come la data d’inizio della storia del Giappone moderno. Il Giappone nel periodo Tokugawa era sostanzialmente chiuso alle influenze esterni: l’ostilità della classe dominante verso gli stranieri comportò l’esclusione degli occidentali e l’interruzione di ogni flusso e scambio commerciale, di capitale umano e tecnologia. All’isolamento si accompagnava una forte rigidità sociale: la società giapponese premoderna era divisa in caste, che consentivano una mobilità minima. I contadini componevano la parte preponderante della forza lavoro, dedita in maggioranza alla risicoltura. Artigiani e commercianti costituivano, invece, la seconda e la terza casta. L’aristocrazia e l’elite militare, i samurai, appartenevano infine alla casta superiore.
� 49
Alcune dinastie di mercanti, come i Mitsui e i Sumitomo, cominciarono ad occupare posizioni sempre più importanti nell’economia nazionale, stabilendo strette relazioni con il potere politico e fornendo efficienti servizi bancari e finanziari. Il ruolo economico e le relazioni privilegiate consentirono a questi mercanti di acquisire privilegi nel commercio con l’estero. Le fortune così accumulate saranno poi all’origine dei futuri investimenti nell’industria. Il Giappone vantava inoltre un efficiente sistema educativo basato su migliaia di scuole primarie diffuse su tutto il territori nazionale. Anche la presenza di un forte governo centrale rappresentava un vantaggio, perché abituava la popolazione a politiche economiche pervasive, esemplificate dall’accurata regolazione della base monetaria nazionale. Il Paese, infine, era dotato di un’efficiente rete di infrastruttura (strade e sistemi di irrigazione). Dopo la svolta politica radicale della rivoluzione Meiji, il principale obiettivo del nuovo governo divenne la modernizzazione economica, considerata necessaria per mantenere lo status di nazione indipendente. Un diffuso e acceso sentimento nazionalistico incoraggiava inoltre aggressive politiche d’intervento, messe in atto da una capace burocrazia. L’obiettivo esplicito della nuova classe dirigente diventava quindi innestare un processo di catching up per “riprendere” l’Occidente. La strategia della modernizzazione era articolata in diversi ambiti; dalla costruzione delle infrastrutture all’acquisizione e diffusione delle tecnologie più recenti, dallo sviluppo di una politica industriale basata sull’intervento diretto dello Stato all’introduzione di riforme monetare e fiscali. Il processo di modernizzazione delle istituzioni era condotto attraverso l’imitazione dei modelli occidentali: la marina giapponese e i servizi postali furono plasmati secondo l’esempio britannico, mentre la Francia offriva i parametri per la riorganizzazione del sistema giudiziario e dell’istruzione scolastica primaria; l’esercito giapponese fu riformato a imitazione di quello tedesco e, infine, il sistema bancario fu “importato” dagli USA. L’impegno giapponese rivolto alla formazione di un capitale umano di alta qualità attraverso la riforma e il potenziamento del sistema scolastico ottenne risultati straordinari. Alla fine del 1870 veniva istituito a Tokyo un moderno sistema universitario che includeva uno dei maggiori Politecnici al mondo, il governo giapponese decideva inoltre di finanziaria regolarmente i viaggi di istruzione dei giovani laureati negli USA e in Europa, mentre importava le competenze maturate oltreoceano assumendo molti docenti, tecnici e altri esperti stranieri. Fra il 1870 e il 1880 il governo individuò come prioritaria l’acquisizione delle tecnologie e conoscenze straniere per avviare imprese pubbliche nei settori tipici della prima rivoluzione industriale. Nonostante la rilevanza di questo flusso di tecnologie e conoscenze di importazione, il successo operativo di queste imprese di proprietà dello Stato fu limitato: gli “impianti pilota” si rilevarono inefficienti, malamente gestiti e sottoutilizzati. La loro reale funzione era però quella di promuovere la graduale diffusione della tecnologia, in una situazione economica che scontava la totale assenza di iniziative private. Posto questo obiettivo, gli sforzi intraprese dal governo Meiji ebbero in realtà successo, portando alla luce il talento imprenditoriale latente della popolazione. Quando la base industriale nazionale cominciò a mostrare una robusta consistenza, fu messa al servizio delle ambizioni militari espresse dalla politica nazionalistica del piccolo Paese asiatico. L’impegno militare sostenne la spinta per la crescita endogena della dotazione industriale e di tutta l’economia nazionale. Si affermava la crescente importanza dei settori moderno, come il chimico, il siderurgico e il meccanico. Grazie alle commesse militari e all’incoraggiamento alla formazione di cartelli, gli anni fra le due guerre vedevano un ulteriore incremento di potenza nei settori ad alta intensità di capitale. � 50
I successi dell’iniziativa privata convinsero il governo giapponese a ridurre il proprio impegno diretto in alcuni settori dell’economia: lo Stato cominciò a vendere gli impianti pilota agli imprenditori privati a prezzi favorevoli. Fra gli acquirenti vi erano diversi commercianti, i quali decidevano di impiegare le ricchezze accumulate negli scambi, diversificando così il loro impegno imprenditoriale. La storia della Mitsubishi esemplifica al meglio questo percorso. A partire da una tradizionale attività di commercio marittimo, il gruppo inizia la diversificazione entrano nel settore minerario per assicurarsi l’approvvigionamento del carbone necessario come combustibile delle navi; arriva poi al settore cantieristico acquisendo un impianto di proprietà statale; il successivo investimento è nella siderurgia, motivato dal progetto di provvedere in proprio alle materie prime e alle produzioni di base necessarie ai cantieri navali; infine, tale strategia di integrazione verticale, spinge il gruppo ad entrare nel settore delle assicurazioni. Imprese come la Mitsubishi erano chiamate zaibatsu, o “gruppi finanziari”. Negli anni fra le due guerre gli zaibatsu si diffusero nei settori ad alta intensità di capitale, come in quelli ad alta intensità di lavoro, nei servizi finanziari, nel settore bancario e in quello assicurativo. Gli zaibatsu erano diversi dalle imprese M-form americane e dalle europee H-form, perché mostravano un controllo centrale inferiore alle prime e superiore alle seconde. La loro particolare struttura proprietaria e organizzativa consentiva di sviluppare un set diversificato di attività, alcune delle quali condividevano un nucleo tecnologico, mentre tutte avevano in comune le fonti di finanziamento. Fra le due guerre i grandi gruppi imprenditoriali giapponesi assunsero una struttura definita multi-subsidiary, basata su una serie di consociate o holding sottoposte al pieno controllo della famiglia proprietaria di ogni zaibatsu. Le holding erano attive in svariati settori ed erano a loro volta al vertice di altre catene di controllo piramidali. Una sezione particolarmente importante di questa complicata struttura era rappresentata dalla shosha, la trading company del gruppo, che forniva servizi d’intermediazione e assicurava la liquidità finanziaria a tutto lo zaibatsu. Il controllo familiare su ogni gruppo era assicurato e rafforzato dall’uso della leva azionaria, combinata con altri meccanismi di incrocio delle partecipazioni e dei posti nei consigli di amministrazione delle società. All’inizio del decennio 1930 i primi quattro zaibatsu possedevano circa dieci controllate di primo livello, da cui dipendevano imprese attive in ogni comparto, dal tessile all’elettrico, fino alle holding del settore minerario, di quello ferroviario e alle acciaierie. Lo zaibatsu Mitsui, il maggiore, controllava così più di cento consociate. La house bank di ogni gruppo agiva sia come creditore sia come azionista, ma ogni istituto aveva anche un ruolo centrale di “stanza di compensazione”, quando decideva come allocare le risorse in modo opportuno fra le varie società appartenenti allo zaibatsu. Dal punto di vista organizzativo, ogni gruppo basava la sua capacità di gestire centinaia di società e migliaia di dipendenti sul decentramento delle strutture produttive. A differenza delle grandi imprese integrate statunitensi, l’espansione dei gruppi giapponesi avveniva di norma attraverso la creazione di nuove consociate, talvolta in settori completamente nuovi: lo zaibatsu poteva così crescere per via di un’espansione interna, attraverso l’integrazione verticale o la diversificazione, indipendentemente dall’esistenza di una tecnologia comune fra le società affiliate. Gli zaibatsu svolsero indubbiamente una funzione cruciale nello sviluppo economico giapponese, ma non deve essere sottostimato il contributo di altre iniziative imprenditoriali di piccole e medie dimensioni sparse in tutto il Paese. La piccola azienda “imprenditoriale” era spesso attiva in settori con uno specifico contenuto artigianale. La disponibilità di forza lavoro a � 51
basso costo e la diffusione dei motori elettrici rappresentavano i fattori decisivi per spiegare la persistenza della piccola dimensione nel sistema produttivo giapponese. Le attività industriali di dimensioni piccole e medie non erano totalmente indipendenti, ma spesso collegate ai maggiori zaibatsu da lunghe catene fondate su relazioni di subcontracting. I grandi gruppi diversificati giapponesi arrivarono preso a dotarsi delle gerarchi manageriali e delle strutture organizzative indispensabili per gestire le loro attività sempre più complesse e decentrate. L’affermazione delle gerarchie manageriali proseguì per tutto il decennio 1930. Nel periodo precedente il secondo conflitto, la separazione fra proprietà e controllo all’interno dei grandi gruppi era realizzata attraverso la nomina di un bantò, una sorta di general management che tecnicamente non apparteneva alla famiglia proprietaria, ma le era legato da anni di dipendenza e da un vincolo speciale di fedeltà. In questo modo, lentamente, la proprietà di era distaccata dalle funzioni operative, al punto che, già alla fine del primo conflitto, per la maggior parte degli zaibatsu si più parlare di “famiglie regnanti”, ma che non governano. Il processo di diversificazione ed espansione in atto era quindi guidato da manager stipendiati, i quali mantennero durature posizioni di vertice nei proprio gruppi. I ranghi di questo management di alto livello erano formati da elementi provenienti dall’amministrazione pubblica, giovani laureati, tecnici e ingegneri. Fra questi dirigenti, diversi avevano svolto parte della loro formazione all’estero; erano inoltre portatori di un accesso spirito nazionalista, che li spingeva ad affermare la supremazia del Paese attraverso la sua potenza economia. Parallelamente, si andava formando il proletariato industriale e questo poneva le compagnie di fronte al problema di motivare, gestire e disciplinare una vasta forza lavoro. I dirigenti degli zaibatsu arrivarono quindi a promuovere programmi di welfare, assicurazioni, istruzioni e altri servizi estesi anche alle famiglie dei lavoratori. I programmi di formazione interna, e una struttura salariale basta su un sistema di premi legati alle performance e ai profitti, permisero ai manager di motivare la forza lavoro e garantirne l’obbedienza all’impresa. Nel corso degli anni Trenta l’accentuazione delle politiche nazionalistiche ha avvicinato l’esercito ai vertici dei grandi gruppi industriali. Fra il 1930 e il 1935 le risorse destinate alla spesa militare crescevano da meno di un terzo a circa la metà dell’intera spesa pubblica, con effetti di slancio per i settori capital intensive. Nel 1938 i vertici militari assumevano il pieno controllo dei settori industriali strategici. Parallelamente, i manager dei maggiori zaibatsu erano impegnati ad acquisire all’esterno le conoscenze tecnologiche più avanzate, ponendo particolare attenzione alle pratiche di reverse engineering, vale a dire lo studio e l’imitazione delle tecnologie occidentali per migliorare la qualità e l’efficienza dell’industria nazionale. Nel settore elettromeccanico, per esempio, la Toshiba sviluppa una stretta relazione con la General Electric. Il governo intanto operava a sostegno della modernizzazione tecnologica nazionale, incanalando verso il sistema industrial le scoperte e le conoscenze sviluppate nei laboratori di ricerca statali. In seguito la preparazione e la gestione della guerra divella priorità del governo, anche sul versante della produzione industriale strategica. Il coordinamento e la pianificazione della produzione e dell’allocazione delle materie prime, sul modello della Germania nazista, venivano realizzati attraverso accordi di partnership fra le imprese, sotto il controllo del Ministero per il Commercio e l’Industria, il quale cominciò a esercitare una pervasiva influenza su tutto l’apparato industriale nazionale.
� 52
La presenza di un terreno di coltura imprenditoriale estremamente variegato ha fornito nuove opportunità di espansione anche ai grandi gruppi, come dimostra la storia di una delle compagnie giapponesi più famose, la Toyota. Fondata da Sakichi Toyoda nel 1867, produceva all’inizio telai meccanici e, in seguito, automatici, i quali migliorarono la produttività nel settore tessile. Il successo industriale e commerciale dell’iniziativa era fondato sull’accordo dell’impresa con lo zaibatsu Mitsui, che commercializzava su larga scala la sua produzione.
CAPITOLO 13 Alla fine del decennio 1930 i settori industriali capital intensive erano ormai presenti in tutto il mondo e contribuivano a sostenere la crescita del PIL in molti Paesi. Uno degli esiti più evidenti di questa rivoluzione tecnologica era la presenza diffusa della grande impresa. Spiccavano tre aspetti distintivi della large corporation: -l’ampia articolazione delle strutture organizzative; -la presenza di un collegio elettorale complesso che intrecciava le esigenze, spesso conflittuali, di attori diversi (i manager, gli imprenditori, gli azionisti, i lavoratori, le comunità locali e lo Stato); -l’importanza strategica, sempre più marcata, della funzione di R&S. A partire dagli anni Venti, i dipartimenti di R&S avevano supportato le strategie di diversificazione delle grandi imprese sviluppando nuove soluzioni tecnologiche e nuovi prodotti. Il processo di innovazione aveva progressivamente assunto una fisionomia istituzionale e diventava parte di network scientifici e tecnologici nazionali e internazionali. Il processo di “istituzionalizzazione dell’innovazione” era particolarmente accentuato nelle economie americane e tedesche. Il primo esito tangibile di tale dinamica fu l’aumento numerico dei centri di ricerca e dei laboratori. Dal punto di vista organizzativo, questo incremento dell’attività di R&S portava alla sistematizzazione del processo di innovazione: la pratica prevalente nei primi tempi, affidata al caso e all’intuizione individuale, veniva progressivamente sostituita dalla ricerca collettiva. La ricerca arrivava quindi ad assumere il carattere di risorsa strategica: il possesso delle più avanzate conoscenze scientifiche e di una tecnologia superiore era fondamentale per la competitività sui mercati interni e internazionali. Per proteggere le loro conquiste di punta, le imprese si servivano di un sistema di brevetti, e dalla validità di questa protezione dipendeva la loro capacità di produrre profitti. La forte spinta verso le strategie di integrazione verticale portava quindi all’interno dell’organizzazione tutte le attività di ricerca, con l’obiettivo di mantenere il controllo su alcune risorse “sensibili”, che non potevano essere affidate all’outsourcing e che, soprattutto, dovevano essere valorizzate dall’interdipendenza con altre importanti funzioni interne. Gli alti costi di ricerca e sviluppo cominciarono quindi a incidere in maniera marcata sui budget di investimento delle imprese: questo poteva creare difficoltà in particolare quando lo sviluppo di una nuova tecnologia implicava un’elevata incertezza e rendimenti differiti nel tempo. Nelle nazioni guida della seconda rivoluzione industriale i centri di R&S delle maggiori imprese operavano come snodi di una rete che comprendeva soggetti diversi: le università private, i politecnici e i laboratori gestiti e finanziati dallo Stato, da istituzioni ad hoc o dall’esercito. Il flusso di invenzioni e innovazioni generato dal lavoro di tutti questi gruppi produceva una serie di esternalità positive a beneficio del settore industriale, che si avvantaggiava in questo modo della ripartizione dei crescenti costi della ricerca di base.
� 53
Si formava così un complesso “sistema nazionale dell’innovazione”, in cui diverse istituzioni erano chiamate a cooperare per rendere il processo innovativo efficiente e produttivo. Il “sistema nazionale” di R&S più sofisticato ed efficiente era senza dubbio quello statunitense: negli anni fra le due guerre questo poggiava sui laboratori delle grandi imprese, la cui principale attività consisteva nell’applicazione pratica dei risultati della ricerca pura svolta nell’ambito di istituzioni universitarie come il MIT. Le stesse grandi aziende finanziavano questa ricerca di base. Accanto ai centri universitari e ai dipartimenti aziendali operavano poi i laboratori di ricerca privati e indipendenti, spesso fondati da ex docenti universitari, che svolgevano ricerche su commissione. Da ultimo, ma solo raramente prima della seconda guerra mondiale, figuravano progetti di ricerca intrapresi dal governo federale, la cui azione aveva luogo essenzialmente a tre livelli: -l’erogazione di fondi agli istituti di ricerca e ai laboratori universitari; -le politiche mirate attraverso le commesse che, soprattutto a scopo militare, sostenevano lo sviluppo di tecnologie specifiche; -l’azione delle agenzie federali, le quali indirizzavano la ricerca di base e applicata. Ad esempio, il National Research Council (NRC) era un’istituzione pubblica in stretto rapporto con gli ambienti industriali che cominciò ad operare con lo scopo di promuovere e organizzare la cooperazione fra i diversi centri di ricerca, pubblici e privati. Il funzionamento dei “sistemi nazionali dell’innovazione” venne seriamente messo alla prova durante il secondo conflitto mondiale. Questo impose ai paesi coinvolti un intenso sforzo di mobilitazione industriale, con il rapido accantonamento di gran parte dei vincoli di bilancio che avevano frenato la ricerca in tempo di pace. Negli USA, tra il 1940 e il 1945, gli stanziamenti federali per la ricerca crescevano da 80 mln a oltre 1 miliardo di dollari. Venne inoltre istituito l’Office of Scientific Research and Development (OSRD), il cui compito era indirizzare i fondi pubblici agli istituti di ricerca. Durante la guerra gli Stati Uniti e la Germania furono così in condizione di procedere sulla via dell’avanzamento tecnologico in diversi settori della ricerca applicata all’ambito militare, tra cui il chimico, il farmaceutico, quello del trasporto aereo, l’elettronico, e quelli votati allo studio dei “nuovi materiali”, come le fibre sintetiche e le materie plastiche. Innovazioni simili potevano emergere indipendentemente l’una dall’altra in diversi Paesi. Le più efficienti fra queste avrebbero poi avuto effetti importanti in guerra e anche dopo, come nel caso del radar o del jet. In altri casi, le emergenze derivate dalla guerra stimolavano indirettamente la selezione e l’applicazione di nuove tecnologie, per esempio a causa della scarsità di alcune materie prime per le quali si rendeva necessario individuare validi sostituti. È questo il caso delle ricerche che portarono all’introduzione della gomma sintetica, dopo che l’invasione giapponese nel Sud-est asiatico aveva provocato difficoltà nell’approvvigionamento della gomma naturale. Anche le fibre e i polimeri sintetici, sviluppati prima della guerra dalla DuPont in America e dall’I.G. Farber in Germania, trovarono un’applicazione come sostituti della seta. Nel periodo postbellico si intensificava la R&S in quegli ambiti caratterizzati dalla big science, nei quali l’attività innovativa era il frutto di progetti su larga scala, sia in termini di budget sia per il livello delle risorse umane e delle strutture di ricerca impegnate. Nei settori della big science si imponeva una convergenza tra i programmi di ricerca legati alla spesa militare e quelli avviati dalle imprese private con fini puramente commerciali, incoraggiando queste ultime a destinare risorse sempre più abbondanti alla R&S. Le nuove tecnologie sviluppate a livello industriale nel secondo dopo guerra (microelettronica, internet, jet, energia nucleare…) sono accumunate dallo sforzo di superare i precedenti limiti di � 54
spazio, tempo e materia. La terza rivoluzione industriale ha visto la creazione di settori completamente nuovi e di nuove opportunità di mercato che hanno indotto cambiamenti radicali in tre ampi cluster dell’attività economica: -comunicazioni (affermazione di internet e dei moderni sistemi di telecomunicazione); -trasporto (era del trasporto aereo di massa) -fisica della materia: le potenzialità ancora indefinite delle applicazioni in questo campo si erano già concretizzate con la produzione della bomba atomica. I programmi di ricerca per l’utilizzo dell’energia atomica a fini pacifici iniziarono, subito dopo la guerra, in tutte le nazioni sviluppate. Come già era avvenuto nel corso delle precedenti rivoluzioni industriali, anche alla base dello sviluppo di tutti i settori coinvolti nella terza rivoluzione vi era la disponibilità di una general purpose technology: il transistor. Il semiconduttore si rivelava infatti come la componente fondamentale di tutti i prodotti e i processi tipici della terza ondata tecnologica. Semiconduttori, circuiti integrati e microprocessori sono componenti indispensabili per i settori impegnati nell’innovazione dei trasporti e delle comunicazioni. Il primo transistor veniva realizzato alla fine del 1947 da Shockley. Questa nuova tecnologia, immediatamente resa disponibile sul mercato dalla AT&T, consentì la sostituzione delle valvole e dei commutatori elettromeccanici, rimuovendo la maggiore strozzatura all’espansione del sistema telefonico nazionale. L’applicazione più importante dell’invenzione di Shockley fu però una scoperta successiva: il circuito integrato. Negli Stati Uniti, l’ampia gamma delle applicazioni offerte dai semiconduttori attirava l’attenzione dei responsabili della Difesa, in particolare in quei settori militari coinvolti nei programmi spaziali e missilistici. Nel 1955 circa il 40% della produzione di transistor era destinata a scopi militari, con una tendenza in crescita. Alla fine degli anni 70, quando l’industria statunitense dei semiconduttori comincerà a manifestare serie difficoltà nel competere con quella giapponese e del Sud-est asiatico, sarà ancora una volta il governo a incoraggiare la ricerca in questo campo, promuovendo la costituzione della Sematech, un consorzio tra le principali aziende del settore, il cui duplice scopo era la condivisione delle informazioni e il coordinamento della produzione. Intorno al 1955, le tecnologie della terza rivoluzione industriale avevano cominciato a generare nuove opportunità economiche. L’impatto di queste nuove tecnologie è reso efficace dalla definizione di Vernon, che imputa ad esse un “restringimento dello spazio” (shrinking of space), vale a dire la riduzione delle distanze fisiche e l’eliminazione delle barriere al movimento di persone, merci, capitali, risorse, conoscenze e informazioni. Nell’ultimo quarto del XX secolo si è poi assistito ad una nuova globalizzazione, testimoniata innanzitutto dall’incremento del volume e dell’intensità del commercio mondiale. Parallelamente al cospicuo incremento dell’interscambio fra i Paesi industrializzati, si è registrato anche un crescente aumento del commercio fra questi e le economie in via di sviluppo. Le nuove tecnologie della terza rivoluzione industriale hanno dato origine a una gamma differenziata di risposte imprenditoriali. Le aziende consolidate hanno dovuto rinnovare le loro strategie per riaffermare la posizione di first mover, mentre si aprivano spazi e opportunità per nuove attività imprenditoriali. Questi sviluppi sono ben rappresentati nell’industria elettronica. Nel settore dei mainframe, prima, e dei personal computer in seguito, infatti, il mercato era controllato quasi totalmente dalle imprese statunitensi; fra le prime dieci comparivano: GE, AT&T, IBM e CDC (Control Data Corporation). La CDC fu fondata dopo la seconda guerra mondiale da William Norris. Guadagnò una forte posizione di mercato nell’elaborazione scientifica dei dati, sviluppando contemporaneamente un’aggressiva strategia di integrazione verticale tramite l’acquisizione di aziende più piccole. Tale strategia le consentiva di controllare � 55
la produzione di tutti i componenti necessari, fino a diventare un importante fornitore anche per le altre società nel settore. IBM assunse, invece, il ruolo di first mover nel settore dei computer, grazie agli investimenti strategici in capitale umano e in R&S operati a partire dai primi anni Cinquanta. A sostegno dell’impresa si adoperava indirettamente anche il governo statunitense, il quale, oltre a essere il maggior cliente, ne finanziava i programmi di ricerca e la sperimentazione dei nuovi prodotti, procurando in definitiva all’IBM un vantaggio costituito da solide barriere all’entrata in un mercato nuovo e promettente. Alla fine IMB sovrastava gli altri competitor, con un fatturato 10 volte superiore a quello dell’immediata inseguitrice, la Remington Rand, coprendo praticamente tutti i segmenti del mercato. I problemi relativi all’incompatibilità fra i computer IBM e i software sviluppati da altri produttivi, però, rendevano difficile la gestione di tutti i prodotti, limitando di fatto la possibilità di ottenere economie di scala. IBM allora adottò una nuova strategia basata sulla produzione di una famiglia di computer compatibili, dotati di un’interfaccia standard, che le avrebbe consentito di mantenere e rafforzare le posizioni sull’ampia gamma dei segmenti già conquistati. A questo scopo, nel 1963, IBM lanciò System 360, il quale divenne lo standard mondiale nel settore del mainframe. Le economie di scala realizzate nella progettazione del software, nella produzione dei computer, nel marketing e nella rete di vendita e assistenza rappresentavano a quel punto formidabili barriere all’entrata: la quota di mercato mondiale dominata dall’IBM (70%) lasciava tutti i competitor in posizioni marginali, mentre la concorrenza dei grandi produttori di elettronica di consumo, come GE, aveva perso terreno fin dall’inizio, attardata nello sfruttamento della vecchia tecnologia delle valvole. Il settore dei semiconduttori era dominato, invece, da imprese relativamente piccole, talvolta attive in comparti non direttamente correlati con quello elettronico, ad esempio la Motorola o la Texas Instruments. Presto comunque, con la maturazione della tecnologia e il passaggio dai semiconduttori ai microchip, si ebbe una mutazione delle regole del gioco a svantaggio di queste piccole imprese. Gli impianti di produzione dovevano, infatti, diventare sempre più grandi e costosi, e le economie di scala sempre più elevate, con il risultato di un crollo dei costi medi unitari che induceva un processo di concentrazione in tutto il comparto e l’eliminazione dei produttori marginali e meno efficienti: di trenta produttori attivi negli anni Sessanta nella Silicon Valley, ne rimasero sette nel 1980. Non tutte le imprese, però, subirono lo stesso impatto nella fase di trasformazione. La Intel, per esempio, fondata da Bob Noyce e Gordon Moore (famoso per aver affermato che la capacità di un circuito integrato era destinata a raddoppiare ogni due anni) puntò subito alla crescita dimensionale dedicandosi alla produzione di massa dei chip di memoria. Nel 1972 collocò sul mercato una memoria cancellabile e riscrivibile che diventò in breve il prodotto leader dell’azienda. Da quel momento la Intel fu protagonista di una continua crescita. L’introduzione delle nuove tecnologie ha avuto un impatto rilevante sulle strategie e sulle strutture delle imprese. La grande impresa è uscita rafforzata dalla rivoluzione tecnologica, diventando sempre più globale. La crescente rilevanza dei settori ad alta intensità di tecnologia e di conoscenze, con forti investimenti in ricerca e sviluppo, ha enfatizzato l’importanza dei processi di apprendimento e diffusione della conoscenza all’interno dell’organizzazione. Gli investimenti in capitale intangibile diventavano vitali per tutte le aziende. In un importante saggio dedicato al ruolo della grande impresa nello sviluppo economico moderno, Chandler e Hikino hanno sottolineato come una delle modalità con cui le imprese maggiori hanno contribuito alla crescita delle economie moderne sia stata proprio la loro abilità di funzionare come nodi centrali in una rete formata da piccole e medie imprese, una rete in � 56
continua espansione grazie alla globalizzazione economica in atto e alla riduzione dei costi d’informazione.
CAPITOLO 14
Quando ha termine il secondo conflitto mondiale, gli Stati Uniti erano ormai da diversi decenni la maggiore potenza economica del pianeta. Negli Stati Uniti la nascita e il continuo sviluppo della large corporation in tutti i comparti nei quali la tecnologia lo rendeva possibile erano senz’altro favoriti: dall’eccezionale disponibilità di fattori naturali, dall’elevato dinamismo del mercato interno e dall’azione antitrust la quale, impedendo le collusioni, costringeva l’impresa alla crescita. La supremazia americana venne rafforzata dalla seconda guerra mondiale. L’industria non subì alcun danno dal conflitto, e addirittura beneficiò di finanziamenti statali senza precedenti a sostegno della difesa nazionale, i quali stimolarono le produzioni già consolidate e si concretizzarono in risorse per la ricerca e nella domanda di prodotti avanzati nel campo del trasporto aereo, dell’elettronica, dei materiali sintetici e dei farmaci. Durante gli anni Cinquanta e Sessanta, spinto anche dalla competizione con l’Unione Sovietica, lo Stato continuò ad investire massicciamente nella formazione e nella ricerca. Lo sviluppo era sostenuto, inoltre, da un’abbondanza di capitale e da una domanda nettamente orientata verso i consumi di massa, che incoraggiava le produzioni a basso costo e la standardizzazione. All’inizio degli anni Sessanta erano pochi i settori nei quali gli Stati Uniti non risultassero in posizione di prima fila a livello mondiale. Erano infatti leader in rami d’avanguardia come i semiconduttori e i computer, ma anche in comparti più consolidati, quali i mezzi di trasporto e i beni di consumo confezionati. Primeggiavano nelle telecomunicazioni, nei prodotti per la difesa, per l’intrattenimento e il tempo libero. Spinti dalla consapevolezza di una superiorità tecnica e organizzativa rispetto alle altre nazioni, e favoriti da una sicura egemonia culturale nel mondo occidentale (sempre più diffusi erano la comprensione e l’uso della lingua inglese), gli investimenti esteri statunitensi raggiunsero un’intensità tale, dopo il 1960, da far parlare di “sfida americana”. Tuttavia, già negli anni Cinquanta, si potevano notare i segni di un certo rallentamento. All’interno del Paese la domanda dei consumatori sembrava aver raggiunto una certa stabilità e le innovazioni determinate dalla guerra parevano aver toccato il loro limite, mentre investimenti senza precedenti in aree correlate a quella originaria incrementavano nettamente la concorrenza fra le aziende appartenenti a settori diversi. Questi elementi causavano un certo disorientamento tra imprenditori e manager: alcuni intensificarono la ricerca di processi e prodotti migliori, altri ricercarono opportunità di investimenti e profitti in campi per i quali le loro imprese non possedevano capacità tecnico-organizzative. Si verificarono quindi fusioni e acquisizioni prive di criteri razionali. C’erano anche altre ragioni che spingevano alla diversificazione non correlata: dopo l’approvazione della legge Celler-kefauver nel 1950, l’azione antitrust si era fatta severa contro le operazioni di integrazione orizzontale e verticale, mentre la normativa fiscale appariva più benevola verso le fusioni e le acquisizioni. Alla fine degli anni Sessanta la crescita attraverso fusioni e acquisizioni era diventata una vera e propria mania. Dall’ondata di fusioni e acquisizioni emerse un nuovo tipo di impresa, la conglomerata, che si distingueva dalla multidivisionale in quanto il suo tratto distintivo era quello di operare in settori non correlati fra loro. La diversificazione, di per sé, era stata una caratteristica costante nella
� 57
strategia delle aziende americane, durante tutto il percorso di crescita dimensionale che le aveva viste protagoniste. Tuttavia questa diversificazione si era sempre tradotta nell’acquisizione di aziende già operanti (o nell’avvio di iniziative industriali ex novo) in settori industriali strettamente correlati con il business iniziale. Il grado di diversificazione raggiunto dalle aziende americane negli anni 50 e 60 era quindi anomalo, in quanto derivava dalla straordinaria situazione economica degli USA: la supremazia nella produzione economica internazionale permetteva alle imprese americane di conseguire elevati profitti; una parte di essi veniva distribuita agli azionisti sottoforma di dividendi, ma ai top executive restavano comunque quantità considerevoli di utili non distribuiti da poter reinvestire, con l’obiettivo di ottenere da questi investimenti dei profitti a lungo termine e stabilmente crescenti. Molte aziende approfittarono della ricostruzione postbellica in Europa e in Giappone per espandersi sui mercati esteri. Non tutti i comparti produttivi però si prestavano a operazioni di internazionalizzazione, e anche le imprese che avevano trovato opportunità all’estero disponevano di altre opzioni per investire i propri utili non distribuiti. Ciò era particolarmente vero per i settori in fase di forte sviluppo tecnologico: negli anni 50, aziende come IBM e Xerox s’impegnarono in operazioni all’estero, ma i loro utili furono usati anche per costruire strutture di R&S all’avanguardia. Esistevano però anche delle società in settori industriali maturi per le quali non erano giustificabili investimenti sui mercati esteri o iniziative di ricerca e sviluppo. Si trattava di imprese siderurgiche, chimiche automobilistiche eccetera. I manager delle più importanti società nei settori maturi destinarono quindi gli utili non distribuiti alla realizzazione di strategie di diversificazione in settori non correlati, e con elevati tassi di crescita. L’esperienza della Armco Steel, fondata nel 1900 e arrivata a essere una delle maggiori aziende siderurgiche a integrazione verticale degli USA, è un esempio eloquente: la società aveva vissuto un periodo favorevole durante la guerra e nei primi anni del dopoguerra con la ricostruzione dei Paesi europei ma, alla fine degli anni Cinquanta, il ciclo favorevole si era esaurito. I vertici dell’impresa inaugurarono allora una strategia di diversificazione che sarebbe durata quasi vent’anni. Dopo un’iniziale espansione in settori correlati, il processo di diversificazione fu spinto sempre più lontano: fu acquisita una società di assicurazioni e poi ci fu l’entrata nel settore immobiliare. Un’altra azienda operante in un settore maturo che proseguì una strategia di diversificazione ad ampio raggio, trasformandosi in una conglomerata, fu la General Mills. Nata nel 1928 dalla fusione di sette società, in seguito aveva assorbito diverse decine di altre aziende, acquistando una posizione di assoluto rilievo nella produzione e distribuzione di farine e prodotti inscatolati. Durante la guerra la società si mise a produrre materiale bellico e questa esperienza convinse il management che l’impresa aveva capacità sufficienti per crescere anche al di fuori della propria industria di base. Nel dopoguerra la General Mills continuò l’attività nel campo delle produzioni per la difesa, inclusi i prodotti elettronici per l’esercito, fabbricò piccoli elettrodomestici e acquisì impianti chimici. Naturalmente esistevano altri fattori strutturali che favorivano lo sviluppo delle conglomerate, uno di essi era, per esempio, l’aumento avvenuto nella pressione fiscale sui profitti dell’impresa. La possibilità di risparmi fiscali era una delle attività attrattive principali della strategia di conglomerazione: ad esempio era spesso conveniente bilanciare i profitti di un’impresa con le perdite di un’altra appena acquisita. Fra le trasformazioni strutturali che fornirono la base per l’espansione delle imprese conglomerate, una delle più rilevanti fu una vera e propria rivoluzione avvenuta nel campo delle scienze manageriali. I concetti e i metodi sviluppati durante il periodo bellico vennero infatti successivamente applicati anche ai problemi gestionali dell’economia civile. La valutazione dei � 58
progetti di investimento, la scelta dei finanziamenti, la localizzazione degli impianti, il controllo della produzione e la gestione del magazzino venivano ora condotti con metodi matematici e statistici. Utilizzabili in qualsiasi situazione, le nuove scienze manageriali promettevano di ridurre i costi finanziari e manageriali delle acquisizioni non correlate e rappresentavano il principale presupposto “ideale”alla base della nascita delle conglomerate. Negli anni 50 e 60 le conglomerate furono al centro di un dibattito, non sempre in termini positivi. Particolarmente criticata era la trasformazione dei top executive delle imprese conglomerate da responsabili a tutto campo dell’efficienza della produzione e della distribuzione, in dirigenti interessati esclusivamente ai ritorni finanziari che ci si poteva aspettare dal capitale investito nelle diverse entità componenti il complesso aziendale. A intervenire in prima linea in difesa del modello della conglomerata furono gli studiosi di management. Essi concentrarono l’attenzione su quelli che sembravano essere i maggiori punti di forza della conglomerata rispetto ad altri tipi di impresa. Il primo era senz’altro la riduzione del rischio; in secondo luogo c’era il minor costo del capitale, dato che la conglomerata poteva raccogliere sia il capitale di rischio sia il capitale di debito, a costi inferiori rispetto a quelli della singola impresa; infine c’era la possibilità di una migliore utilizzazione delle risorse manageriali, sia per quanto riguardava l’assunzione di numerosi esperti specializzati, che le imprese più piccole non avrebbero potuto permettersi, sia per la possibilità di applicare con profitto il talento e le capacità del top management a un maggior numero di imprese. Vi era poi la constatazione che, per il periodo 1958-1966, il nuovo modello di impresa sembrava vantare ottime prestazioni. In realtà i tempi d’oro non durarono a lungo. Gli anni Settanta furono un periodo di crisi economica per molti Paesi, e in particolare per gli USA, che, al fine del decennio, si trovarono nella situazione di ristagno inflazionistico (stagflazione): elevati tassi di disoccupazione, produttività calante, alti tassi d’interesse e inflazione crescente. Era sempre più difficile gestire in modo redditizio società appartenenti a settori di attività troppo diversificati. I problemi maggiori furono individuati nella struttura amministrativa sviluppa dal management delle conglomerate, assai diversa rispetto a quella di una classica multidivisionale, i top executive, infatti, disponevano di una conoscenza piuttosto esigua delle imprese acquisite. Inoltre, mentre le aziende diversificate in campi correlati avevano staff centrali per funzioni critiche come la produzione, il marketing e la R&S, la conglomerata ne era priva. Il quartier generale delle conglomerate era di dimensioni limitate e si dedicava quasi esclusivamente alla funzione finanziaria e alla gestione delle acquisizioni, mentre le funzioni legate all’economia reale venivano lasciate alle imprese acquisite. Il ruolo di supervisione del quartier generale veniva così ridotto essenzialmente alla fissazione degli obiettivi per le diverse unità e alla valutazione dei risultati ottenuti su basi strettamente quantitative (management by numbers). Un top management incompetente e incapace di comprendere i processi tecnologici e i mercati in cui operavano le aziende facenti parte della conglomerata, la sostanziale ingovernabilità di aggregati che contavano decine e decine di divisioni diverse, portarono all’inizio degli anni 70 a un serio declino della conglomerata statunitense. L’impatto della conglomerata sul sistema delle imprese statunitense si rivelò in ultima analisi particolarmente negativo. Bisogna ammettere che le conglomerate non erano mai state particolarmente numerose, tuttavia la loro importanza era accresciuta dalla collocazione tra le più grandi imprese del Paese. Un caso esemplare è rappresentato dalla vicenda della Radio Corporation of America (RCA), costituita nel 1919 dalle imprese pioniere della tecnologia della radio e della radiodiffusione, allo scopo di mettere in comune tutti i brevetti posseduti. All’inizio degli anni Trenta la RCA diventava una società autonoma. Grazie al vasto patrimonio brevettuale � 59
di cui godeva, costantemente incrementato dalle grandi strutture di ricerca interne, la RCA sfruttava in pieno la domanda generata dalla seconda guerra mondiale, non tanto di prodotti già affermati, quanto di radar, sonar e altri congegni elettronici. Contemporaneamente l’azienda cominciò a diversificarsi diventando una first mover nel nuovo mercato della televisione: prima sviluppò la tecnologia di riproduzione in bianco e nero e, in seguito, realizzò la prima televisione a colori. Dopo la guerra, con l’avvento dei transistor e dei computer, la RCA diventava definitivamente una delle maggiori imprese americane. David Sarnoff si ritirò nel 1970, sostituito dal figlio Robert, il quale impresse una svolta strategica all’azienda, avviando un percorso di crescita attraverso la diversificazione in nuovi settori, spesso molto lontani da quello originale dell’elettronica di consumo. Le motivazioni alla base di questo cambio di strategia furono diverse: -un decreto dell’antitrust aveva appena imposto alla RCA e ad altre imprese di mettere gratuitamente a disposizione della concorrenza i propri brevetti; -la concorrenza da parte dei produttori europei e giapponesi di elettronica di consumo si andava intensificando; -il desiderio di continuare a godere degli elevati livelli di profitto garantiti, prima, nel monopolio tecnologico nel campo della radio e, in seguito, dallo sviluppo e dalla commercializzazione del televisore. Fra il 1968 e il 1974 la RCA acquisì la Hertz (autoveicoli), la Banquet (cibi congelati), la Coronet (tappeti) e la casa editrice Random House. Diventò così una conglomerata di grandi proporzioni, entrando quasi immediatamente in una spirale di crisi industriale e finanziaria. Durante la seconda metà degli anni Settanta l’azienda, pesantemente indebitata in seguito alle acquisizioni degli anni precedenti, non riusciva a controbattere efficacemente alla crescente concorrenza dei produttori di elettronica di consumo europei e giapponesi. La crisi aziendale iniziò ad essere combattuta con tagli di costi e cessioni di rami aziendali, che tuttavia andarono a colpire quasi esclusivamente la divisione elettronica, mentre si tentava il rilancio della strategia di diversificazione non correlata tramite l’acquisizione, nel 1978, della società finanziaria CIT. Il peso ormai insostenibile dell’indebitamento e il progressivo deterioramento della capacità della RCA di sviluppare e commercializzare con successo nuovi prodotti elettronici, portarono al collasso dell’azienda. Acquisita nel 1986 dalla GE, la RCA venne infine smembrata e le singole parti smantellate o vendute al miglior offerente. Le conglomerate non avevano fatto registrare gli andamenti positivi previsti dai loro creatori, ed era ormai chiaro che erano diventate ingestibili per i loro stessi manager. A partire dagli anni 80 iniziò così un vasto movimento di ristrutturazione, con lo scopo di ridurre lo spettro delle attività o addirittura di tornare al core business (per poter recuperare la competitività perduta). Talvolta questo processo avveniva sull’onda di una grave crisi aziendale, come nel caso della Armco, in altri casi la DE-CONGLOMERAZIONE era una scelta autonoma del management mirante ad aumentare la redditività e l’efficienza complessive dell’impresa. La General Mills, per esempio, dopo essere arrivata ad occuparsi di abbigliamento, giocattoli, arredamento, gioielli, calzature e prodotti chimici, iniziò a modificare il proprio portafoglio di attività in direzione di una rifocalizzazione sul core business degli alimenti di largo consumo. Nel decennio successivo questo genere di operazione raggiunse un picco, caratterizzandosi però per un orientamento molto più speculativo (risultato soprattutto dell’azione di banchieri e intermediari finanziari che puntavano a elevati profitti nell’immediato, senza preoccuparsi della sorte delle imprese). Il tentativo di creare valore laddove non esisteva, attraverso alchimie finanziare, scalate ostili e continue ristrutturazioni, face molte vittime. In questo quadro, con un governo poco impegnato in specifiche politiche industriali, gli Stati Uniti persero terreno in settori cruciali. Nel 1971 si registrava il primo deficit commerciale del secolo. Venivano ora allo � 60
scoperto alcuni lati deboli concernenti il capitale umano: gravi problemi affliggevano la base del sistema formativo. Non esistevano buone scuole professionali, una lacuna che non veniva colmata dalla formazione aziendale, come invece avveniva in Giappone. Tutto ciò diffondeva una sorta di “analfabetismo funzionale” nella forza lavoro americana. Gli USA, però, conservarono formidabili posizioni di forza nei settori cruciali per la difesa, come l’aerospaziale, le telecomunicazioni e i computer. Inoltre, non tutti i rami dell’industria erano preda di irrazionali ristrutturazioni: nella chimica, per esempio, imprese come la DuPont scelsero di concentrarsi nelle specialità a più alto valore aggiunto. Gli USA quindi restavano esportatori nella chimica e riuscendo a resistere con successo all’intensificarsi della competizione internazionale.
� 61