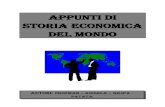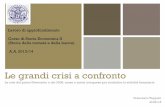Storia Economica
Transcript of Storia Economica
-
STORIA ECONOMICA
a.a. 2011/2012
Cinzia Lorandini
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
Prerequisiti:
Conoscenza di fondo delle vicende storiche dellet moderna e contemporanea
Capacit di lettura dei problemi macro e microeconomici
Scopo del corso:
Presentare una chiave di lettura storica dei fenomeni economici
che consenta di coglierne la complessit,
nonch linterrelazione tra i fatti economici e quelli di
natura istituzionale e politica,
al di l delle interpretazioni puramente teoriche.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
Struttura del corso
Premessa metodologica: il ruolo della storia economica e il suo rapporto con le altre discipline storiche ed economiche
Le economie europee dancien rgime: un esame di carattere statico
Le trasformazioni nellorganizzazione produttiva europea nel contesto del vecchio regime economico: dal sistema curtense al Verlagssystem
Prerequisiti del processo di industrializzazione e prima rivoluzione industriale
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
DallInghilterra allEuropa continentale: la diffusione del processo di industrializzazione
I First comers: i casi europei pi significativi di industrializzazione precoce
Francia
Belgio
Svizzera
I Late comers: leconomia dei Paesi ritardatari sulla strada dellindustrializzazione
Germania
Austria-Ungheria
Russia
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
Il caso italiano: un decollo tardivo verso lindustrializzazione
Il declino inglese e lascesa dei Paesi extraeuropei
USA
Giappone
Leconomia internazionale nella seconda met dellOttocento e la prima globalizzazione
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
Bibliografia di riferimento :
C.M. Cipolla, Storia economica dell'Europa pre-industriale, Bologna, Il Mulino, 2002, parte I
R. Cameron, L. Neal, Storia economica del mondo. Dalla preistoria ad oggi, Bologna, Il Mulino, 2002, capp. I, III, V-XII
Modalit desame: scritto e orale
Per gli studenti 509 che devono conseguire solo 3 CFU: E. De Simone, Storia economica. Dalla rivoluzione industriale
alla rivoluzione informatica, Milano, Franco Angeli, 2006, capp. I-V
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
Perch si studia la storia economica?
In generale, analisi diacronica di un qualsiasi fenomeno.
In senso proprio, la storia mira ad analizzare ed interpretare il passato umano.
Che cos' la storia?
Alcune considerazioni di metodo
Necessit di una scomposizione del materiale da studiare:
indagini circoscritte per periodo o per territorio indagini circoscritte ad un aspetto parziale della realt
storie speciali (partizione artificiosa)
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 8
La storia economica una storia speciale, di origine relativamente recente.
Compie un'analisi diacronica dei fatti economici realmente accaduti.
Analizza le vicende degli uomini, riuniti in societ, in quanto
producono, distribuiscono e consumano ricchezza
Che cos leconomia?
Leconomia la scienza che studia come i singoli e la societ scelgono di impiegare risorse scarse che potrebbero avere usi
alternativi allo scopo di produrre vari tipi di beni e di distribuirli per il consumo, nel presente o nel futuro, tra gli
individui e i gruppi della societ.
(P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Economia, Bologna, Zanichelli, 19872, p. 4)
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 9
La storia economica presenta alcune analogie con leconomia o economia politica (le problematiche affrontate, gli strumenti concettuali), ma anche importanti differenze:
non analizza in astratto le leggi economiche
interessata a comprendere le vicende economiche del passato in tutta la loro complessit e specificit
deve tenere conto di numerose variabili, anche di quelle non economiche, non misurabili e irrazionali
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 10
La Storia economica, secondo l'accezione di Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), deve:
fornire un supporto culturale di fondo a chiunque voglia confrontarsi in maniera consapevole con le tematiche economiche
porre in posizione critica di fronte ad ogni interpretazione puramente teorica e modellistica
consentire di cogliere la complessit dei fenomeni economici
offrire una terza dimensione, quella della profondit, alle vicende economiche e sociali che l'umanit sta vivendo
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 11
Lindagine storico-economica
La formulazione del problema
Lindividuazione delle fonti
primarie (preterintenzionali o intenzionali, scritte o orali) e derivate (storiografia)
Lanalisi critica delle fonti
interpretazione letterale
interpretazione sostanziale
determinazione dellautenticit e del grado di attendibilit
La ricostruzione storica
paradigma interpretativo di riferimento
selezione di dati e fatti
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 12
Fonte: Archivio di Stato di Trento, Archivio Salvadori, vol. 1041, Spedizioni 1747
Krefeld
senza spese
libbre (1 libbra di
Vienna = 560 g)
Valentino e
Isidoro
Salvadori
fiorini (1 fiorino
di Vienna = 60
carantani)
libbra piccola o
sottile di
Trento = 336 g
Centinaio =
100 libbre
per
Cos, dove e
come viene
prodotto?
Perch una
postazione
daziaria a Lavis?
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 1
Una questione fondamentale:
perch certe nazioni sono ricche e altre povere?
La storia economica aiuta a capire le origini dei diversi livelli di sviluppo e ad isolare i fattori fondamentali dello sviluppo economico.
Come misurare i diversi gradi di sviluppo?
Reddito, PIL o PNL globale/pro capite
indici qualitativi (durata media della vita, tasso di mortalit infantile, numero di medici per mille abitanti etc.)
Human Development Index (PIL + istruzione + aspettativa di vita)
alla ricerca di altri indicatori: PIL verde, Genuine Progress Indicator (GPI), Gross National Happiness
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
Crescita: aumento sostenuto del totale di beni e servizi prodotto da una certa societ (PIL)
Sviluppo: crescita + cambiamento strutturale od organizzativo delleconomia
Progresso: un termine che presuppone considerazioni di tipo etico-morale
Crescita, sviluppo, progresso
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
La performance delleconomia mondiale (1000-2001) (A. Maddison, The World Economy: Historical Statistics, Paris, OECD, 2003)
2681042
6149
1000 1820 2001
Popolazione (milioni)
436667
6049
1000 1820 2001
PIL pro capite ($ 1990)
117 695
37194
1000 1820 2001
PIL mondiale (miliardi $ 1990)
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
Le differenze dello sviluppo: 1000-2001 (Maddison 2003)
100
5100
10100
15100
20100
25100
30100
1000 1820 2001
Europa Occ.
Stati Uniti
Giappone
America
Latina
Europa Or.
ex URSS
Asia
Africa
PIL pro capite ($ 1990)
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
Determinanti dello sviluppo economico
Produzione e produttivit
Produzione: processo di combinazione dei fattori
produttivi finalizzato alla realizzazione di beni e servizi
Produttivit: rapporto tra il risultato del processo di produzione e i fattori in esso impiegati
Fattori di produzione lavoro terra capitale capacit imprenditoriale
Tecnologia, istituzioni, cultura
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
Struttura economica e mutamenti strutturali
Struttura economica: dipende dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei settori delleconomia
primario = agricoltura secondario = manifattura terziario = attivit residuali
I mutamenti strutturali sono segnati dal cambiamento del settore prevalente
Storicamente si sono avute queste fasi:
PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
Un modello di trasformazione strutturale
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1750 1800 1850 1900 1950 2000
Y, L (in %)
Terziario
Agricoltura
Industria
-
Per un approfondimento bibliografico si veda:
P. MALANIMA, Economia preindustriale: mille anni: dal IX al XVIII secolo, Milano, Bruno Mondadori, 1997
2. LE ECONOMIE EUROPEE DI ANCIEN RGIME
Unanalisi di carattere statico
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Qualunque sistema economico pu venire osservato dal punto di vista della DOMANDA o dellOFFERTA: si tratta di due aspetti della stessa realt. Chi esprime la DOMANDA ? La popolazione: necessit dunque di analizzare la struttura demografica di una qualsiasi societ che si intenda studiare dal punto di vista economico. Strumento di analisi: i CENSIMENTI, disponibili per solo dal secolo XIX. Le valutazioni (stime) per i secoli precedenti lasciano notevoli margini di incertezza. Da tali valutazioni emerge che la popolazione europea tra il secolo XIV e la met del secolo XVIII rimase fondamentalmente bassa.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
La popolazione europea (1000-2000)
0
100
200
300
400
500
600
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
mil
ion
i
Crescita medievale
Peste nera Ripresa
Crisi del sec. XVII
Fase rivoluzionaria
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Inizi secolo XIV 80.000.000 ab.
1348 pandemia di peste met secolo XIV 60.000.000 "
fine secolo XV 80.000.000 "
inizio secolo XVIII 115.000.000 "
A cosa dovuta la lenta crescita della popolazione?
Bisogna considerare i fattori demografici:
i tassi di natalit non sono bassi (oscillano tra il 35 e il 45); elevati anche i tassi di mortalit (mediamente tra il 25 e il 35)
ordinaria - prevalentemente infantile (da 150 a 350 neonati muoiono prima dellanno e altri 100-200 bambini prima dei 10 anni) e senile
catastrofica - causata da guerre, epidemie e carestie
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
La causa pi dirompente di mortalit il presentarsi di unepidemia (tifo, febbre tifoide, dissenteria, vaiolo, peste)
* la peste il flagello pi terribile
* la pandemia del 1347-1351 miete 30 milioni di persone in Europa (pi del 30% degli abitanti)
* la peste del 1630-31 fa scendere la popolazione dellItalia settentrionale da 4.000.000 a 2.900.000 ab.
In presenza di eventi catastrofici il saldo della popolazione risulta pesantemente negativo
La popolazione europea era relativamente ridotta e relativamente fluttuante
Esisteva un pesante squilibrio tra risorse e popolazione
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
La legge di Malthus
Thomas Robert MALTHUS (1766-1834): Saggio sul principio della popolazione (1798)
La legge di Malthus
Tempo
Y, Pop.Y.
Pop.
La popolazione cresce in progressione geometrica (2, 4, 8 ), mentre le risorse crescono in progressione aritmetica (1, 2, 3). Ad un certo punto quindi la crescita della popolazione si arresta inevitabilmente.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Per capire la domanda che pu esprimere una popolazione indispensabile valutarne BISOGNI e DESIDERI. Che cosa distingue i bisogni dai desideri? Quantit e qualit dei bisogni dipendono: * dal totale della popolazione * dalla struttura per et, sesso, professione della popolazione * da fattori geo-fisici * da fattori socio-culturali Quando una persona libera di esprimere la propria DOMANDA, ci che conta sul mercato non sono i BISOGNI, ma i DESIDERI. I DESIDERI sono praticamente illimitati, le RISORSE invece con cui farvi fronte sono limitate: ci impone delle scelte.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Perch un DESIDERIO divenga DOMANDA EFFETTIVA deve essere sorretto da POTERE D'ACQUISTO * solo allora registrato dal mercato Il potere d'acquisto fornito dal REDDITO, che pu essere: * corrente * cumulato (patrimonio) Il REDDITO si procura partecipando all'attivit produttiva (salari, profitti, interessi, rendite). Le diverse forme di reddito servono ad esprimere sul mercato la domanda effettiva. Il reddito della popolazione attiva serve a tradurre in domanda effettiva i desideri della popolazione totale: * popolazione attiva * popolazione dipendente
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
La societ europea dancien rgime era una societ fondamentalmente povera. famiglie reddito risparmio risparmio totale 5% 30% 30% 9% 10% 30% 3% 0.9% 20% 20% 1% 0.2% 65% 20% -- -- Forte contrasto tra la miseria della massa e la ricchezza di pochi: il reddito era distribuito con forti sperequazioni. Esisteva una massa notevole di mendicanti (dal 5 al 20% della popolazione urbana), che sopravvivevano grazie al trasferimento di una parte di reddito altrui (carit e beneficenza).
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Il reddito, una volta formato, pu essere trasferito:
per via volontaria (carit e donazioni; dono; dote; gioco) per via coatta (imposte; bottini di guerra; furti e rapine) Non sempre redistribuzione della ricchezza significa perequazione.
Il livello mediamente basso del reddito ostacolava la formazione del risparmio; la concentrazione della ricchezza lo favoriva.
Mediamente una societ preindustriale risparmiava tra il 2 e il 15 % del proprio reddito.
Non necessariamente, per, il risparmio si trasforma in investimento: se rimane sterilizzato, non si trasforma in domanda di beni capitali.
Il reddito speso per beni e servizi entra in circolo fornendo nuovo reddito sotto forma di salari, profitti, interessi ecc., a chi partecipa alla produzione di beni e servizi
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
I vari profili si intersecano luno con laltro. Esaminata la DOMANDA, resta da considerare come essa trovasse una risposta sul mercato: deve essere analizzato il SISTEMA PRODUTTIVO. Un sistema produttivo alimentato dallINPUT e origina lOUTPUT. LINPUT un insieme di elementi eterogenei detti FATTORI DI PRODUZIONE.
Domanda effettiva
di beni di consumo di servizi di beni capitali
interna privata -> LEGGE DI ENGEL interna pubblica estera
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Risorse naturali
Terreni coltivabili, depositi minerali, patrimonio boschivo, fonti di energia
Lavoro
va determinato il rapporto di dipendenza (popolazione dipendente/attiva)
non sempre chiaramente classificabile (es. combinazione di attivit agricole e di carattere manifatturiero)
quantit-qualit del lavoro dipendono da: giorni lavorativi effettivi, ore per giornata, condizioni fisiche e psicologiche, grado di istruzione e preparazione tecnica
Capitale
Capitale fisso: edifici (a scopi produttivi), bestiame, attrezzi e mezzi di trasporto.
Capitale circolante: scorte di materie prime, semilavorati o prodotti finiti. la forma dominante di capitale fino alla prima rivoluzione industriale.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
La risposta va cercata nella dialettica tra domanda e offerta. Posto che:
la societ doveva primariamente cercare di soddisfare i bisogni essenziali,
la tecnologia a disposizione degli operatori economici era limitata,
i livelli di produttivit erano in genere estremamente contenuti,
allorigine della distribuzione della popolazione attiva, che vede prevalere il settore primario, sta la bassa produttivit di tutti i fattori di produzione.
NellEuropa dancien rgime, lAGRICOLTURA predomina sia in termini di reddito prodotto che di forza lavoro occupata. Perch?
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
3. Dal superamento del sistema curtense allaffermazione del Verlagssystem
Per un approfondimento bibliografico si veda: F.F. Mendels, Proto-industrialization: The First Phase of the
Industrialization Process, in The Journal of Economic History, 32, 1972, pp. 241-261
P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM, Industrialisierung vor der Industrialisierung, Gttingen, 1977 (trad. it.: Lindustrializzazione prima dellindustrializzazione, Bologna, Il Mulino, 1984)
S.C. OGILVIE, M. CERMAN (eds.), European protoindustrialisation, Cambridge, Cambridge University Press, 1996
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
Il reddito prevalente nella societ dancien rgime era quello prodotto nel settore agricolo, organizzato in et medievale nel sistema curtense.
La societ curtense rappresentata da una serie di rapporti interpersonali: * possono essere rapporti di convenienza * ma anche rapporti determinati da azioni coercitive Compresenza accanto al feudo dei diritti comunitari. Caratteristica del feudo la limitatezza del mercato: si produce prevalentemente per lautoconsumo.
Feudalesimo
Sistema curtense
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
Esistono pochi stimoli allincremento della produzione:
c poca flessibilit economica
mancano le opportunit
sono presenti vincoli e restrizioni
Bassa la produttivit basso il livello dei redditi (reali)
Anche in ambito urbano il livello dei salari, rispetto a quello dei prezzi, era contenuto.
Sistema funzionale in un periodo caratterizzato da:
incertezza politica e frequenti violenze;
relazioni di mercato limitate;
basso livello della tecnologia;
popolazione scarsa e dispersa sul territorio.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 1
Le forze di cambiamento
Principali innovazioni:
la rotazione triennale;
I Cereali primaverili
orzo/avena
Semina: primavera Raccolto: estate
II Cereali vernini
frumento/ segale
Semina: autunno Raccolto: estate
III Maggese
anno di riposo,
il terreno rimane incolto;
pascolo comunitario
laratro pesante a ruote;
luso dei cavalli per il tiro;
maggior impiego del ferro per gli strumenti agricoli;
diffusione dellallevamento e di nuove colture.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
Nel Medioevo la MANIFATTURA non era affatto unattivit insignificante.
Rivestivano una notevole rilevanza:
settore tessile
settore metallurgico
Ruolo fondamentale di Gilde e Corporazioni nella regolamentazione dellartigianato urbano.
Non mancavano alcune manifestazioni di manifattura accentrata.
La rotazione triennale e le altre innovazioni portarono ad un incremento della produzione, e quindi:
intensificarsi dei rapporti di mercato;
crescita della popolazione;
facilitazione alla formazione di centri urbani.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
Rinascita della vita urbana
- evidente interazione tra citt e campagna
- miglioramento della produttivit agricola (surplus)
- crescita demografica e aumento delle relazioni di mercato (gradualmente scompare il modello curtense)
- la citt si afferma come centro di scambi e come sede di un potere amministrativo che si svincola in parte da quello feudale.
Le citt, dopo la crisi del Trecento, cominciano a riprendersi nel XV secolo.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
Il mercante-imprenditore
Figura nata in tarda et medievale.
Opera soprattutto nel settore tessile e protrae a lungo il proprio ruolo, fino alla soglia dellindustrializzazione.
Si tratta di un intermediario tra il produttore a domicilio e i mercati; dispone di liquidit e di collegamenti commerciali che gli consentono di organizzare una rete produttiva anche in ambito rurale.
Talvolta fa svolgere la fase finale di preparazione di un manufatto in un laboratorio centralizzato.
La sua azione pu assumere due diversi connotati:
quello del KAUFSYSTEM
quello del VERLAGSSYSTEM
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
Nel Kaufsystem, o sistema dellacquisto, il mercante si limitava a commissionare lesecuzione di un determinato tipo di manufatti a dei laboratori domestici.
Procedeva poi a ritirare i manufatti realizzati in tali laboratori, comprandoli.
Il produttore pertanto manteneva la propria indipendenza nella fase della lavorazione.
Nel Verlagssystem, o putting-out system sistema dellanticipazione - il mercante-imprenditore forniva il capitale circolante e, a volte, il capitale fisso.
Il produttore a domicilio pertanto finiva per essere un operatore che agiva su commessa, trasformando materia prima fornita dal Verleger, che metteva a sua disposizione anche gli strumenti di lavoro e commercializzava il prodotto finito.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
La manifattura era pertanto dominata dai mercanti, e in particolare dal mercante-imprenditore: il VERLEGER Tra XVII e XIX secolo si diffonde in Europa la manifattura rurale. Caratteristiche: a) forza lavoro dispersa, generalmente rurale; b) ruolo propulsivo del Verleger (mercante-imprenditore) che fornisce materia prima e vende il prodotto sul mercato; c) dimensione familiare dellimpresa.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
La protoindustria una tappa del processo evolutivo che porta allindustrializzazione? Non necessariamente.
Fase 1: attivit agricola Fase 2: attivit agricola + protoindustria Fase 3: industrializzazione, ma anche ritorno allagricoltura
Motivi della diffusione di questo modello (Verlagssystem): a) spinta della domanda: c una maggior richiesta di manufatti, in particolare tessili, a prezzi contenuti; b) spinta dellofferta: alcuni imprenditori cercano di liberarsi dai vincoli corporativi ; c) necessit di una maggiore flessibilit.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 8
0
5
10
15
20
25
Milioni kmq
Spagna Portogallo Olanda Francia Inghilterra
Estensione degli imperi coloniali (inclusa la madrepatria)
1600
1790
1870
Si estendono enormemente gli orizzonti geografici e i mercati. Le scoperte geografiche ebbero conseguenze importanti sullevoluzione delleconomia europea. Nel 1492 Cristoforo Colombo, con lappoggio della corona di Spagna, raggiunge le isole caraibiche, convinto di essere arrivato in India. Nel XVI secolo, proprio grazie agli effetti delle scoperte geografiche, la Spagna e il Portogallo divennero le principali potenze europee.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 1
In seguito alle scoperte geografiche cresce il volume del commercio internazionale e cambiano consumi e tipologie di scambio.
America Tacchini Tabacco, cacao, pomodori, mais, patate
Lo scambio colombiano
Europa Cavalli, bovini, pecore, maiali Caff, canna da zucchero
Il commercio fu il settore di gran lunga pi dinamico delleconomia europea tra XV e XVIII secolo.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
Il baricentro del commercio europeo si sposta dal Mediterraneo al Mare del Nord e allAtlantico; ai prodotti di lusso si affiancano prodotti di largo consumo. Negli scambi intercontinentali si afferma anche il commercio pi aberrante: quello degli schiavi.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Tonnellate
1501-
1520
1521-
1540
1541-
1560
1561-
1580
1581-
1600
1601-
1620
1621-
1640
1641-
1660
Importazioni spagnole di metalli preziosi americani
ORO
ARGENTO
Un prodotto supera per importanza tutti gli altri: largento
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
Attraverso il pagamento dei debiti e le spese belliche in Italia, Germania e Paesi Bassi, il commercio e il contrabbando, i metalli preziosi si diffondono in tutta Europa, causando un aumento dei prezzi.
Teoria quantitativa della moneta (equazione di I. Fisher): MV=PQ
M = quantit di moneta V = velocit di circolazione della moneta P = livello dei prezzi Q = quantit delle transazioni Evidentemente un aumento di M provoca un aumento di P. Non solo laumento di moneta, ma anche la crescita generale della popolazione e i limiti della produttivit agricola provocarono un forte aumento dei prezzi.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
I prezzi dei prodotti alimentari crescono pi degli altri per linsufficiente crescita della produttivit dellagricoltura a fronte dellaumento della domanda.
In generale, nel periodo 1450-1650 si ebbe una certa diffusione tecnologica, ma, salvo alcune eccezioni, questa non avvenne con ritmi incalzanti. Il settore manifatturiero restava largamente dipendente da unagricoltura a bassa produttivit.
1453: stampa a caratteri mobili, inventata da Johann Gutenberg
Secoli XV XVI: diffusione dellaltoforno
Diverse applicazioni dellenergia idraulica (mantici, magli meccanici, varie tipologie di mulini)
Nuove tecniche e strumenti di navigazione
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
4. Prerequisiti al processo di industrializzazione e prima rivoluzione industriale
Per un approfondimento bibliografico si veda: E. A. WRIGLEY, La rivoluzione industriale in Inghilterra.
Continuit, caso e cambiamento, Bologna, Il Mulino, 1992
P. HUDSON, La rivoluzione industriale, Bologna, Il Mulino, 1995
J. MOKYR, Leggere la rivoluzione industriale. Un bilancio storiografico, Bologna, Il Mulino, 1997
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
Rivoluzione industriale: un termine di successo (Arnold Toynbee, Lectures on the Industrial Revolution, 1884), entrato nelluso comune per indicare le trasformazioni socio-economiche avvenute tra 1760 e 1830 in Inghilterra, e con tempi diversi nelle altre economie. Ma corretto? Lindustrializzazione non il risultato di un cambiamento improvviso e violento, ma frutto di un graduale processo di trasformazione. La storiografia economica accompagna oggi con un aggettivo prima o inglese la tradizionale dizione rivoluzione industriale. Viene spesso usata la definizione processo di industrializzazione.
Rivoluzione industriale: un concetto vecchio?
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
Prerequisiti allavvio del processo di industrializzazione
Un insieme di situazioni e fenomeni, generalmente di natura pi culturale e politico-istituzionale che non economica, contribuiscono a creare il clima che render possibile, nel lungo periodo, laffermarsi del processo di industrializzazione lo sviluppo dellumanesimo; laffermarsi del metodo scientifico; la riforma protestante; lascesa degli stati nazionali; le scoperte geografiche e lo sfruttamento dei nuovi territori; lo sviluppo del commercio internazionale.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 8
Requisiti diretti e fattori concomitanti nel manifestarsi del processo di industrializzazione
La prima rivoluzione industriale e pi in generale il processo di industrializzazione sono indubbiamente fenomeni complessi.
Si possono tuttavia individuare alcuni elementi di fondo che li caratterizzano.
In sintesi tali elementi possono essere schematizzati in alcuni passaggi che si riscontrano con il procedere del processo di industrializzazione:
applicazione diffusa e sistematica della scienza e della conoscenza empirica al processo di produzione;
superamento della produzione per lautoconsumo e sua destinazione al mercato, con tendenza alla specializzazione;
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 9
crescita dimensionale e spersonalizzazione delle aziende;
impiego massiccio del capitale a completamento ed anche in sostituzione del lavoro umano;
nascita e sviluppo di nuove classi sociali, sulla base dei ruoli assunti nel processo di produzione;
cambiamento strutturale, con spostamento della quota prevalente di reddito prodotto e di occupati dal settore primario a quello secondario e, in un secondo tempo, terziario;
crescita significativa dei poli produttivi urbani e concentrazione in essi dellorganizzazione produttiva pi rilevante;
trasferimento oltre che della produzione anche di una consistente quota della popolazione dalle aree rurali a quelle urbane.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 10
La presenza di questi elementi indica che in atto il processo di industrializzazione.
Il processo di cambiamento venne influenzato in Inghilterra primo Paese a percorrere la strada dellindustria-lizzazione da una serie di trasformazioni:
trasformazioni demografiche (la rivoluzione demografica);
trasformazioni nel settore primario (la rivoluzione agraria/agricola);
trasformazioni nellambito dei trasporti e delle comunicazioni (la rivoluzione dei trasporti).
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 1
In che modo la crescita demografica pu incidere sul processo di industrializzazione? Interviene sul rapporto tra offerta e domanda, contribuendo a creare condizioni di mercato del tutto nuove: per quanto riguarda lOFFERTA, aumenta la disponibilit di manodopera per la produzione manifatturiera; per quanto concerne la DOMANDA, si incrementa la domanda complessiva di beni di consumo, compresi quelli manifatturieri.
Popolazione in Gran Bretagna e Irlanda (x 1000)
0
10000
20000
30000
40000
50000
1701 1751 1781 1801 1821 1841 1861 1881 1901 1931
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
Guardando al forte incremento demografico della Gran Bretagna e a quello inizialmente contenuto dellIrlanda, seguito dalla seconda met degli anni Quaranta da un vistoso decremento, si devono cercare le cause di tale fenomeno.
Da che cosa dipesa e quali sono state le componenti della crescita?
Incremento dei tassi di natalit?
Decremento dei tassi di mortalit?
Tassi di natalit e mortalit in Inghilterra e Galles
(per mille)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1780-
90
1790-
1800
1800-
10
1810-
20
1820-
30
1830-
40
1840-
50
1850-
60
1860-
70
1870-
80
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
La crescita della popolazione pi che non ad un incremento delle nascite pare imputabile ad un allungamento dellet media della vita. E ci appare anche visibile dalla diminuzione dei tassi di mortalit evidente fin dallinizio del processo di industrializzazione, anche se seguito da fasi incerte tra il 1820 e il 1870.
Quali i fattori alla base della diminuzione del tasso di mortalit? Incertezza nelle valutazioni: lievi i progressi della scienza medica (profilassi antivaiolosa); miglioramento delle condizioni di vita (alimentazione e igiene) In particolare, si esauriscono le punte di mortalit straordinaria tipiche dellantico regime. Nel caso irlandese: peggioramento nel rapporto tra risorse e popolazione e avvio del fenomeno migratorio dal 1848.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
5. La prima rivoluzione industriale: le trasformazioni nellagricoltura, nei trasporti e nel
commercio
Per un approfondimento bibliografico si veda:
D. Grigg, La dinamica del mutamento in agricoltura, Bologna, Il Mulino, 1985
S.P. Ville, Trasporti e comunicazioni, in D.H. Aldcroft, S.P. Ville (a cura di), Leconomia europea 1750-1914. Un approccio tematico, Milano, Vita e Pensiero, 2003, pp. 171-200
J. Foreman-Peck, Il commercio estero e la crescita economica, ivi, pp. 201-232
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
Rivoluzione agraria e rivoluzione agricola
Il termine rivoluzione agraria indica la trasformazione dei rapporti di propriet che ebbe luogo in Inghilterra tra Sei- e Ottocento, con una forte contrazione dei campi aperti (open fields) e delle terre comuni (common lands) a favore della diffusione delle propriet recintate (enclosures)
tale processo favor una coltivazione pi intensiva della terra e laffermarsi dell individualismo agrario
0
200
400
600
800
1000
1702-
29
1730-
49
1750-
59
1760-
69
1770-
79
1780-
89
1790-
99
1800-
09
1810-
19
1820-
29
1830-
39
1840-
Numero degli atti parlamentari di recinzione (Enclosures )
in Inghilterra
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
Il termine rivoluzione agricola indica la trasformazione che si ebbe in Inghilterra nel campo delle tecniche agronomiche, e che ebbe riflessi importanti sullaumento della produttivit del settore, sia per unit di superficie che per unit di forza lavoro.
Quali gli elementi di fondo di questa trasformazione? eliminazione del maggese, resa possibile dallutilizzo attento di variet fertilizzanti (legumi e piante da foraggio che fissano lazoto atmosferico)
Il ciclo di Norfolk
I frumento
II rape
III orzo
IV trifoglio
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
Il risultato fu una riorganizzazione della zootecnia e - grazie anche allintroduzione di nuove tecnologie agricole un netto incremento della produzione
Lavvio dello sviluppo urbano allarg la domanda di prodotti alimentari Parallelamente: lincremento della produttivit agricola favor, con la sua offerta, lo sviluppo urbano e industriale
In sintesi, quale rapporto si pu individuare tra laumento della produttivit agricola e il processo di industrializzazione? Sostentamento di una popolazione urbana in crescita Espulsione di manodopera dallagricoltura (anche se non nellimmediato) Aumento dei redditi agricoli, e conseguentemente
aumento della domanda di beni strumentali per lagricoltura aumento degli introiti fiscali accumulazione di capitale
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 8
59% 57%56% 56%
52%
46% 45%
23%
Irla
nda
Sviz
zera
Dan
imar
ca
Ger
man
ia
Fran
cia
Belg
io
Ola
nda
Gra
n Br
etag
na
Incidenza del settore primario sull'economia
di alcuni paesi intorno al 1850
Inizio della rivoluzione agricola in alcuni paesi Fiandre, Brabante XVII secolo Inghilterra 1690-1700 Francia 1750-1760 USA 1760-1770 Svizzera 1780-1790 Germania, Danimarca 1790-1800 Austria, Italia*, Svezia 1820-1830 Russia, Spagna 1860-1870 *Mentre la Pianura Padana poteva vantare unagricoltura evoluta gi nel XVI secolo, gran parte dellItalia meridionale era estremamente arretrata.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 9
La rivoluzione dei trasporti
Rilevanza del capitale fisso sociale. Fino al Settecento le strade inglesi hanno la fama di essere le peggiori dEuropa. La loro manutenzione venne affidata in molti casi a iniziative private, autorizzate a chiedere il pagamento di un pedaggio. Nel secondo Settecento circa 1.000 miglia di nuove strade a pavimentazione Mc Adam, Telford e Metcalf.
0
10000
20000
30000
40000
Km
1750 1770 1836
Anni
Km di strade a pedaggio in Inghilterra
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 10
Nonostante i miglioramenti della viabilit ordinaria, ancora troppo poco rispetto alle esigenze manifestate dal nuovo sistema produttivo e distributivo. Importante la navigazione costiera. Tra gli anni 60 e 70 del Settecento ha forte rilevanza la realizzazione di canali: a fine 700 esistono 3.200 Km di vie dacqua navigabili si consolida loperato delle Societ per azioni
Le conseguenze sono: diminuzione dei costi di trasporto e delle scorte liberazione di forza-lavoro e di energia animale Importanza anche delle infrastrutture portuali
Fondamentale importanza assume in Inghilterra il commercio internazionale
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 11
manufatti
legname, pece, canapa, ferro svedese, vino, seta, grano
coloniali, tessuti
zucchero, tabacco, cotone
armi, ferram., alcolici, stoffe
Inghilterra
Indie occ. e America sett.
Oriente
Europa
Africa occ.
spezie, t, caff, seta, cotone
oro, avorio
schiavi
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 12
Le trasformazioni nellattivit mercantile e il ruolo del commercio internazionale nel favorire il processo di industrializzazione
Importanza della maturazione professionale degli operatori mercantili che si sanno svincolare dallazione delle grandi compagnie monopolistiche Rilevanza, nei confronti dellattivit mercantile, dei sistemi di difesa attiva (marina) e passiva (assicurazioni) Messa a disposizione del sistema produttivo di materie prime e semilavorati di provenienza estera, e di mercati di sbocco Creazione di una rete di istituzioni commerciali e finanziarie Diversificazione nellimpiego dei profitti da parte dei mercanti: interesse per le attivit agricole, e in un secondo tempo anche per quelle estrattive e manifatturiere
Nel terziario, come nel primario, c spazio per laccumulazione originaria di capitale
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 13
Lo sviluppo urbano, prima che industriale, sviluppo commerciale
Lettura contraddittoria dello sviluppo demografico urbano, secondo i paradigmi marxiani e le recenti ricerche di demografia storica. Secondo linterpretazione marxiana la crescita delle citt sarebbe connessa con lespulsione di forza lavoro dalle campagne conseguentemente al progredire delle enclosures. Lanalisi di demografia storica ha evidenziato una crescita naturale delle regioni rurali, che soltanto a processo di industrializzazione maturo alimentarono la crescita sociale delle citt.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 1
6. La prima rivoluzione industriale e le trasformazioni nel settore manifatturiero
Per un approfondimento bibliografico si veda:
A. Lougheed, Industria e mutamento tecnologico, in D.H. Aldcroft, S.P. Ville, Leconomia europea 1750-1914. Un approccio tematico, Milano, Vita e Pensiero, 2003, pp. 145-170.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
Cotonificio
Caratteristiche: dipendenza dal mercato internazionale; bene di consumo a domanda elastica
tessitura 1733: spoletta o navetta
volante di Kay
filatura 1764: Spinning Jenny
di Hargreaves
1769: filatoio idraulico o water frame
di Arkwright -> sistema di fabbrica
I SETTORI DEL PRIMO SVILUPPO INDUSTRIALE
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
1774: Mule Jenny di Crompton
tessitura 1785: telaio meccanico di Cartwright
raccolta della materia prima
1793: cotton gin o sgranatrice
di cotone di Whitney
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
Un nuovo paradigma energetico
Secondo Wrigley, con la Prima rivoluzione industriale si passa da uneconomia organica (energia ricavata principalmente dalla vegetazione di campi, pascoli e boschi) a uneconomia minerale
Ma forse sostiene Malanima - pi opportuno parlare di economia vegetale vs. economia fossile Economia vegetale: limiti allaumento della produzione e
della produttivit agricola; minori ricadute sullambiente -> sostenibilit nel lungo periodo, ma in presenza del vincolo malthusiano
Economia fossile: aumento della produzione, ma anche dellimpatto ambientale; limitatezza dello stock di fonti energetiche -> problema della sostenibilit nel lungo periodo
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
Settore siderurgico
Caratteristiche: disponibilit di risorse interne; beni intermedi
impiego del coke 1709: Darby
puddellaggio e laminatura 1783: Cort
Tonnellate di metallo trattabili in 12 ore - sistema tradizionale al maglio: 1 t - sistema di Cort: 15 t
02004006008001000120014001600
Tonn. x 1000
1740 1760 1780 1800 1820 1839
Anni
Produzione di ghisa di prima fusione in Inghilterra
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
La combinazione di queste innovazioni port ad un aumento della produzione e alla diminuzione dei costi, diffondendo luso del ferro. Fondamentale fu poi la rilevanza della pompa di Newcomen (1712) e soprattutto della macchina a vapore di JAMES WATT (1769)
La crescita dellindustria fu caratterizzata da un forte aumento della produttivit, nella quale svolse un ruolo primario linnovazione tecnologica
Ferro, carbone, macchina a vapore e cotone costituiscono i capisaldi della rivoluzione industriale inglese, per lelevato
tasso di innovazione tecnologica, le nuove forme di organizzazione del lavoro, lestensione dei mercati di sbocco, le
forti ricadute su tutta leconomia.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
Un ruolo basilare ebbero anche le realizzazioni ferroviarie. La ferrovia per, che in gran parte dellOccidente sarebbe stata una delle cause dellavvio del processo di industrializzazione, in Inghilterra segn piuttosto il punto darrivo di unindustrializzazione gi matura.
Protagonista del suo avvio fu George Stephenson: nel 1825 progett la locomotiva per il trasporto tra le miniere di Stockton e Darlington nel 1830 quella usata per la prima, vera ferrovia da trasporto del mondo: la Liverpool-Manchester
Nel 1851, lesposizione londinese di Crystal Palace mostr al mondo il livello raggiunto dallindustrializzazione inglese
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 8
A quellepoca in Inghilterra si producevano i due terzi del carbone mondiale, circa la met del ferro, il 70 % dellacciaio, circa la met
del tessuto di cotone prodotto industrialmente, il 40 % di macchinari e attrezzature
Questo processo aveva portato con s profonde trasformazioni nel modo di vivere e di produrre
Reddito globale e pro-capite in Inghilterra a prezzi
costanti (1801-1851)
0
100
200
300
400
1801 1811 1821 1831 1841 1851
In
dic
e (
18
01
=1
00
)
Reddito globale
Reddito pro-capite
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 9
Tra 1801 e 1851 la popolazione inglese era passata da 10,7 a 20,9 milioni di persone e il tenore di vita, anzich peggiorare, come in antico regime, era complessivamente migliorato.
Ripartizione per attivit della popolazione (valori percentuali) 1811 1841 Agricoltura e pesca 33,1 22,3 Manifattura, edilizia, miniere 30,2 40,5 Commercio e trasporti 11,6 14,2 Burocrazia e libere professioni 13,3 8,5 Servizi domestici 11,8 14,5
Il livello di vita della popolazione miglior, non mancarono per i costi sociali, con importanti conseguenze nel medio-lungo periodo.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 1
7. DallInghilterra allEuropa continentale: le differenziazioni nel processo di industrializzazione.
I Paesi first comers
Per un approfondimento bibliografico si veda:
D.S. LANDES, Prometeo liberato. Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nellEuropa occidentale dal 1750 ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 1978, pp. 164-253
S. POLLARD, La conquista pacifica. Lindustrializzazione in Europa dal 1760 al 1970, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 147-318
P. MATHIAS, Riflessioni sul processo di industrializza-zione in Europa, in G.L. FONTANA (ed.), Le vie dellindustrializzazione europea, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 35-63
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
In termini empirici si pu definire sviluppata nel corso dellOttocento lEuropa a nord dei Pirenei e delle Alpi e a occidente dellElba. Una molteplicit di fattori hanno interagito nel determinare un avvio precoce o ritardato del processo di industrializzazione.
Chiave di lettura diffusionista o dellimitazione La localizzazione del processo di industrializzazione sul continente europeo avvenne seguendo le modalit inglesi. Lindustria continentale si allarg per cerchi concentrici.
I primi paesi continentali a partecipare al processo di industrializzazione furono: - relativamente vicini allInghilterra; - dotati di risorse naturali (carbone, ferro) e di unagricoltura relativamente avanzata; - caratterizzati dalla presenza di esperienze protoindustriali di un certo rilievo; - relativamente aperti agli scambi.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
Tutto ci ha fatto emergere una chiave di lettura del processo di industrializzazione del continente europeo che parlava di imitazione senza varianti.
Leconomista americano Walt W. Rostow allinizio degli anni 60
teorizza il passaggio da una societ agricola ad una industriale attraverso il susseguirsi di stadi di sviluppo:
1. Societ tradizionale 2. Fase di transizione 3. Fase di decollo take off 4. Fase di maturit 5. Fase dei consumi di massa
Non chiaro, per, come si passa da uno stadio allaltro. Il processo di imitazione pu tuttavia presentarsi anche con
varianti, come messo chiaramente in luce da Alexander Gerschenkron, attento nella sua analisi in particolare ai Paesi ritardatari sulla strada dello sviluppo.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
Introduce il concetto di arretratezza relativa e di vantaggi dellarretratezza. Valuta anche i fattori sostitutivi (stato, banche) capaci di sostituire i prerequisiti inglesi e di determinare il catching up, lagganciamento dei ritardatari ai primi. Interessante anche la lettura proposta da Sidney Pollard, che sottolinea come a decollare non sia tanto la nazione, quanto piuttosto la regione. Presenta poi il ruolo che nei Paesi di seconda ondata hanno rivestito diversi fattori definiti di interferenza. Questi - ad es. le ferrovie hanno determinato quello che chiama differenziale della contemporaneit. Altri studiosi come Douglas North sottolineano limportanza delle istituzioni nel rendere le scelte economiche pi efficienti, o - come Paul David - evidenziano la dipendenza dal sentiero di sviluppo la path dependence proprio di ogni Paese.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
Il primo Paese continentale ad industrializzarsi fu il BELGIO
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
Godeva di una serie di condizioni favorevoli :
posizione: prossima allInghilterra, vicina ad aree relativamente sviluppate, potenziali mercati di sbocco
risorse: carbone, ferro, corsi dacqua
attivit protoindustriali
A queste condizioni di partenza si aggiunsero delle caratteristiche specifiche:
Diffusione della tecnologia e dellimprenditorialit di origine inglese (dinastia imprenditoriale dei Cockerill)
Politica economica (lo stato belga favor lo sviluppo nazionale)
Costruzione di unimportante rete ferroviaria
Nascita di un efficiente sistema finanziario
Diffusione della forma giuridica delle societ anonime
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
0%
2%
4%
6%
8%
1830 1860 1890 1910
Quota delle esportazioni belghe sul commercio
internazionale europeo (1830-1910)
La precoce industrializzazione belga fu favorita da: una compenetrazione tra iniziative private e azione pubblica una concentrazione del potere economico e politico nelle mani della corte e di un gruppo ristretto di imprenditori
Il Belgio fu il primo paese industrializzato del continente, e mantenne a lungo una posizione di preminenza
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 8
Nellindustrializzazione della SVIZZERA gioca un ruolo positivo la valorizzazione di capacit professionali preindustriali Precoci investimenti in capitale umano Solida tradizione nella meccanica di precisione Consolidata esperienza nelle attivit commerciali
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 9
Caratteristiche dellindustrializzazione elvetica: industria dislocata in unit di dimensioni medio-piccole convivenza con un settore primario evoluto capacit delle aziende di autofinanziarsi
A met Ottocento compaiono le prime grandi imprese sostenute da un efficiente sistema bancario Ne nasce un sistema produttivo vocato alla specializzazione e indirizzato allexport nei settori:
Meccanica di precisione
Chimica e farmaceutica
Alimentare di qualit
Tessile di nicchia
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 1
Il caso della FRANCIA costituisce un esempio di sviluppo industriale caratterizzato inizialmente da una bassa crescita demografica. A ritardare lindustrializzazione contribuirono gli eventi rivoluzionari e le successive guerre napoleoniche.
Popolazione: tassi di crescita contenuti, e livello di urbanizzazione piuttosto basso
Agricoltura: si era ampiamente diffuso un modello di piccola-media propriet rurale (paysannerie), scarsamente attenta al mercato
Risorse: scarsa disponibilit di carbone, costi di estrazione elevati
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
Trasporti: buona la rete stradale; non molto estesi i canali; ma data lampiezza del territorio piuttosto costosi i trasporti interni; fondamentale dunque il ruolo della ferrovia
Tecnologia: numerose le invenzioni francesi con applicazione nei settori produttivi (dal tessile, alla siderurgia, alla chimica)
Manifatture: caratterizzate, almeno fino agli anni 70 dellOttocento, dalla piccola dimensione delle aziende (specialmente nei settori tessile e alimentare), essenzialmente di carattere familiare e fondate sullautofinanziamento.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
Gli anni tra il 1895 e la prima guerra mondiale (belle poque) segnarono comunque un periodo di forte crescita per leconomia francese, caratterizzato dallemergere di settori innovativi: automobile, alluminio, industria idroelettrica.
% annuo - + 0,39 + 0,88 + 1,47 + 1,01 + 1,35 + 1,84 + 0,45 + 0,87 + 1,81
indice 100 110 129 148 163 185 219 229 249 294
periodi 1781-90 1803-12 1825-34 1835-44 1845-54 1855-64 1865-74 1875-84 1885-94 1895-04
Il tasso di crescita del reddito pro capite relativamente lento.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
Lindustrializzazione tedesca
Punti di debolezza iniziali: la suddivisione politica (314 stati nel 1789); il netto prevalere dellagricoltura; la presenza dello Junkerismo a Est; i conflitti di stampo corporativo; la scarsa mobilit sociale.
Elementi iniziali di dinamismo:
Lo Zollverein e la creazione di un solido mercato interno
La creazione di una rete di canali e, dagli anni Trenta, unestesa rete ferroviaria
Solida formazione per il capitale umano. Attenzione allinnovazione tecnologica
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
Lo Zollverein
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
Col maturare del processo di industrializzazione si verific: a) un pi intenso sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie; b) lattivazione di un sistema bancario innovativo: le Universalbanken (banche miste); c) il consolidarsi della deutsche Technologie.
Nella seconda met dellOttocento crebbero tutti i settori industriali tradizionali, ma grazie alla tecnologia avanzata e allallargarsi del mercato interno si svilupparono soprattutto: il settore chimico (carbochimica) il settore elettrico il settore meccanico, in particolare la meccanica di precisione il settore ottico
La Germania divenne protagonista della seconda rivoluzione industriale e diede vita alla prima forma organizzata di welfare state
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
A partire dagli anni 70, per far fronte ai rischi di crisi e ai pericoli di uneccessiva concorrenza reciproca, le grandi industrie tedesche si organizzarono in cartelli, spartendosi settori di mercato e stabilendo precisi limiti di prezzo.
Alla vigilia della prima guerra mondiale, la Germania aveva preso il posto dellInghilterra come nazione leader dello sviluppo economico europeo. Aveva assunto una posizione di primato: nella produzione di acciaio nel settore elettrico nel settore carbochimico e farmaceutico nel settore ottico
Importante, anche se non determinante per lo sviluppo, fu la politica economica bismarckiana, attivata specie dopo il 1879.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 1
Per un approfondimento bibliografico si veda:
S. POLLARD, La conquista pacifica. Lindustrializzazione in Europa dal 1760 al 1970, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 329-420
A. GERSCHENKRON, Il problema storico dellarretratezza economica, Torino, Einaudi, 1965
A. LEONARDI, Leconomia di una regione alpina, Trento, Itas, 1996, pp. 115-141
8. I paesi ritardatari (late comers) sulla strada dellindustrializzazione
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
Diversi Paesi dellEuropa continentale - nellarea mediterranea, in quella balcanica e in quella orientale - arrivarono con ritardo sul tragitto dellindustrializzazione.
La Russia, il Paese pi esteso e maggiormente dotato di risorse naturali di tuttEuropa, rappresenta il caso pi eclatante di sviluppo tardivo.
Elementi di carattere ostativo ad un precoce sviluppo: grandi distanze e lontananza dai punti nevralgici dello sviluppo; struttura sociale di carattere rigidamente feudale; persistere della servit della gleba e forza delle comunit di villaggio (mir); la debolezza del mercato; la scarsit del capitale.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
Nel 1861 introdotta dallalto una legge che abolisce la servit, ma i nuovi proprietari si dimostrano incapaci di attivare unagricoltura di stampo capitalistico.
La crescita dellagricoltura legata ai proprietari pi prosperi (kulaki). Questa componente del mondo rurale, nonostante il peso delle imposte fondiarie, si potenzia: * acquisendo le terre dei nobili indebitati * esercitando lusura
La nuova riforma agraria del 1906 toglie potere ai mir e rafforza la propriet individuale, ma non risolve il problema delle tensioni sociali nelle campagne.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
Se lagricoltura si evolve lentamente e con notevoli contraddizioni, lindustria rimane caratterizzata da bassi livelli di produttivit e costi di produzione elevati, nonostante il forte balzo in avanti che si registra nellultimo ventennio dellOttocento.
Lavvio dellindustrializzazione risulta legato
allintervento dello Stato: settore principale di intervento la realizzazione di una rete ferroviaria (con motivazioni sia amministrative che strategiche)
agli investimenti stranieri, a loro volta favoriti dalle politiche statali (gold standard, protezionismo, sussidi alle imprese)
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
Caso emblematico di sviluppo contrastato e ritardato quello della Monarchia Asburgica. Dopo Russia e Germania costituiva la terza "potenza" dellEuropa continentale.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
Diversit nello sviluppo economico: area sviluppata centro-settentrionale (austro-boema) area alpina, in bilico tra sviluppo e sottosviluppo area slava meridionale e orientale: arretrata
Importanza, nel Settecento, delle riforme teresiano-giuseppine di ispirazione cameralistico-mercantilistica: politica economica volta allaffermazione dello Stato abbattimento delle barriere interne incoraggiamento allattivit manifatturiera in una logica di autarchia economica promozione del capitale umano (Allgemeine Schulordnung 1774) si avvia una razionalizzazione dellagricoltura
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
Una serie di tensioni sociali - e il timore di sbocchi rivoluzionari alla francese - ostacola dopo Giuseppe II una svolta industrialista.
Durante la Restaurazione e nel periodo del VORMRZ - prima del marzo 1848 - si verifica una cristallizzazione della situazione economica e sociale, e viene attuato un rigido protezionismo economico.
Esistono spinte contrastanti tra chi aspira allindustrializzazione e chi vuole mantenere una situazione di stallo: emblema dei contrasti la linea ferroviaria Linz-Budweis (1825-1832) fino al 1860 a trazione animale
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 8
La rivoluzione del '48 introduce per - nonostante la sua sconfitta - dei significativi mutamenti: la GRUNDENTLASTUNG -> emancipazione dei contadini la GEWERBEFREIHEIT -> libert di scegliere la professione la GEWERBEORDNUNG assunta nel 1859 come ordinamento delle imprese industriali
Le tappe dello sviluppo industriale, oltre che dalla politica economica, risultano condizionate anche da altri fattori: * la disponibilit interna di capitali (spesso attratti dai titoli del debito pubblico, pi che da impieghi produttivi) * l'afflusso di capitale straniero, importante in particolare per lo sviluppo ferroviario
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 9
Fondamentale importanza per lavvio dellindustrializza-zione assumono le realizzazioni ferroviarie.
L'avvio dell'industrializzazione non parte per dall'industria pesante, ma da quella leggera: * importanza del settore tessile (cotonificio, linificio, lanificio) * rilevanza del settore alimentare (zuccherificio, produzione di birra, industria molitoria)
Forte espansione nel periodo detto GRNDERZEIT (1867-1873): tale fase non sopravvive al crack della Borsa di Vienna segue un periodo di profonda depressione (che accomuna lAustria a tutto lOccidente europeo) per 20 anni si verifica un rallentamento complessivo della produzione
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 10
Dalla crisi si esce solo negli anni Novanta: durante la c.d. belle poque si registra una crescita delle produzioni agricole, ma soprattutto l'avvio dello sviluppo industriale. Un ruolo significativo viene assunto dalle banche miste e dai cartelli, secondo il modello tedesco.
Alla vigilia della guerra lAustria pi che mai paese cerniera tra Europa sviluppata ed Europa arretrata.
Non si sanano per le forti divergenze territoriali: accanto ad unarea pienamente inserita nellEuropa sviluppata si trova unarea ancora arretrata.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 1
Per un approfondimento bibliografico si veda:
S. ZANINELLI, Leconomia nella storia dItalia del secolo XIX, Torino, Giappichelli, 1997
V. ZAMAGNI, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dellItalia 1861-1981, Bologna, Il Mulino, 1990
9. LItalia dell800: le caratteristiche economiche di un Paese ritardatario
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
Il primo problema da porsi riguarda la liceit dell'utilizzo, per il primo 800, della categoria ECONOMIA ITALIANA forti diversificazioni territoriali, non solo tra i diversi Stati netto prevalere di unagricoltura fortemente diversificata in ambito manifatturiero predominio del tessile (setificio) non ci sono tracce significative di unattivazione del sistema di fabbrica
Il sistema economico della penisola si regge su un EQUILIBRIO AGRICOLO COMMERCIALE nonostante la debolezza delle infrastrutture di comunicazione.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
Il primo 800 - periodo francese - generalmente valutato in termini negativi data la subalternit delle economie italiane alle mire francesi. Sarebbe erroneo cercare una presunta industria italiana; bisogna invece partire dal settore agricolo e dal suo rilievo. Due tipi di indirizzi caratterizzano questo periodo: difesa della propriet libera e spazio allindividualismo agrario potenziamento della produzione di semilavorati che possono risultare funzionali allindustria francese
Difficolt nel commercio internazionale per il blocco con lInghilterra. Contemporaneamente, per, anche prospettive di miglioramento grazie al codice civile e di commercio napoleonici.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
Non migliora poi lo stato delle comunicazioni, basate essenzialmente sul piccolo cabotaggio. Marginale anche il ruolo dellintermediazione creditizia: sono presenti in questa fase solo banchieri privati.
La pace porta anche una forte depressione dei prezzi. La tendenza DEFLAZIONISTICA causa una grave caduta delle produzioni agricole (ma non della produzione gelsibachicola) i governi introducono misure protezionistiche
Grande invece limportanza complessiva degli operatori economici stranieri collocano nuove unit produttive allinterno della penisola in aree protette da alti dazi e prive di imprenditorialit
Il capitale interno non manca, ma viene investito in titoli del debito pubblico e in immobili. Le risorse disponibili si orientano verso le varie agricolture, senza per provocare incrementi nella produttivit.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
LItalia prima dellunificazione
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 6
Passaggio dallItalia pluristatuale a quella monostatuale e unificazione, nel 1861, delle strutture politico-amministrative.
Problemi e prospettive economiche dellunificazione - creare un mercato integrato (costi dellunificazione); - ridurre gli squilibri interni; - consolidare la posizione internazionale.
Gli scambi risultano regolati da un sostanziale LIBEROSCAMBISMO
Altra scelta immediata quella dellunificazione del debito pubblico
Nel 1862 viene introdotta la lira italiana (sistema bimetallico) Non viene invece unificato il sistema di emissione: permangono 5
istituti di emissione destinati, nel 1870, a divenire 6
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 7
Cresce il divario tra lespansione industriale europea e la stazionariet italiana.
Nel quinquennio postunitario viene attivata una massiccia spesa pubblica, dando priorit agli impegni di carattere militare e alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione, soprattutto ferroviarie. Si fa massiccio ricorso allemissione di titoli del debito pubblico. Si impone al Paese un livello di spesa superiore alle sue possibilit crisi finanziaria del 1866, corso forzoso (1866-1883) e successivo risanamento della finanza pubblica
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 8
Gli anni Settanta si aprono in Europa con le avvisaglie della prima grave crisi strutturale delleconomia occidentale dopo il decollo dellindustrializzazione (1873-1895) anche lItalia colpita dalla crisi, che crea grossi problemi soprattutto allagricoltura convergenza tra gli interessi agrari e quelli industriali: viene meno il dogma liberoscambista
1878 prima, moderata, tariffa protezionistica 1887 nuova tariffa doganale
Primi segnali di vivacit in ambito industriale: emergono i settori metallurgico, meccanico e chimico 1884: stabilimento siderurgico di Terni la produzione di acciaio - fino al 1885 di 3-4.000 t annue - passa nel 1889 a 157.000 t (contro i 3 milioni di GB e i 2 milioni della Germania)
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 9
Gli anni 1889-1894 sono stati definiti i pi neri delleconomia del nuovo Regno diminuisce la produzione industriale non si contraggono invece la produzione e i redditi agricoli non peggiora pertanto sensibilmente il tenore di vita, che era peraltro di basso profilo
La tendenza allespansione della spesa, per la politica estera di potenza e per le elargizioni a pioggia, riportano in disavanzo il bilancio dello stato dal 1886. Seguono anni di crisi bancaria e di rientro allestero di capitali precedentemente investiti in Italia.
-
Le perdite subite dagli speculatori immobiliari si trasferiscono sulle banche
Al centro della bufera le banche a modello francese
Credito mobiliare e Banca generale nel 1894 sono costrette alla liquidazione
colpito anche il cuore del sistema: le banche di emissione
scandalo della Banca romana 1894: dalla fusione della Banca Nazionale nel Regno con le due banche di emissione toscane nasce la BANCA DITALIA, che assume la liquidazione della Banca romana La crisi fa precipitare la situazione finanziaria e nel 1894 lItalia esce dal Gold Standard (torner alla convertibilit nel 1927)
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 11
A livello mondiale si colgono nel frattempo i sintomi della belle poque: si sta sviluppando la seconda rivoluzione industriale. In Italia tale fase coincide con let giolittiana il punto di svolta collocato nel 1896
PIL in Italia 1861-1920 (milioni di lire 1938)
99246
85019
66364608735745952344
1861-70 1871-80 1881-90 1891-00 1901-10 1911-20
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 12
Muove i primi passi lindustria elettrica che si avvale di investimenti stranieri e della tecnologia tedesca.
I fattori che consentono il take off industriale italiano: unofferta elastica di capitali finanziari e lavoro
la riorganizzazione del sistema bancario: 1894 COMIT; 1895 CREDIT (le due banche miste, basate sul modello tedesco, divengono le pi importanti banche italiane)
la liberazione di risorse finanziarie prima utilizzate per coprire disavanzi nel bilancio dello stato
limportazione di tecnologia straniera, alimentata dalle partite invisibili (la bilancia dei pagamenti correnti fino al 1907 si chiude con attivi anche considerevoli)
Anche dopo la crisi del 1907, il trend delleconomia italiana si mantiene positivo.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 13
Durante gli ultimi anni del secolo si risveglia la produzione agricola. Eccezionale lespansione dellindustria, specie di quella produttrice
di beni di investimento e intermedi. Ci sono per delle sfasature: eccesso di popolazione rispetto alle risorse diffusa sotto-occupazione agricola esplosione del fenomeno migratorio, specie dalle campagne (nel
quindicennio prebellico lasciano definitivamente lItalia circa 6 milioni di persone)
si consolida il carattere dualistico delleconomia italiana
5 27168
992
1580
3615
2194
1851-60 1861-70 1871-80 1881-90 1891-00 1901-10 1911-20
Lemigrazione italiana 1851-1920 (dati in migliaia)
-
11. Il declino inglese e lascesa degli USA
Per un approfondimento bibliografico si veda:
M.J. WIENER, Il progresso senza ali. La cultura inglese e il declino dello spirito industriale (1850-1980), Bologna, Il Mulino, 1985
P.A. TONINELLI, Nascita di una nazione. Lo sviluppo economico degli Stati Uniti (1780-1914), Bologna, Il Mulino, 1993
A.D. CHANDLER, Dimensione e diversificazione. Le dinamiche del capitalismo industriale, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 87-145
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Cause del declino inglese furono:
lascesa industriale di altre nazioni, che si fondava in parte su nuove tecnologie e nuovi settori;
gli svantaggi del first mover: tecnologie obsolete ma ancora funzionanti;
il parziale esaurirsi della spinta innovatrice in Gran Bretagna, dovuta anche ad un minor dinamismo imprenditoriale;
Il modello inglese: cotone, ferro, carbone, macchine. A met Ottocento la sua spinta espansiva va tuttavia esaurendosi, mentre altri Paesi si affacciano in modo dinamico sulla strada dellindustrializzazione.
Il declino del first comer: la Gran Bretagna
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
la mancata adozione di alcune innovazioni istituzionali
nella formazione del capitale umano: scarso peso allistruzione tecnica
in ambito finanziario: le banche non sostengono adeguatamente le industrie
nelle forme e dimensioni dimpresa: lenta affermazione della grande impresa manageriale
nel ruolo dello Stato: poco attivo nel promuovere lo sviluppo
i costi della leadership
la forte dipendenza dal commercio estero, che poteva essere condizionato dalle decisioni protezionistiche degli altri paesi, e la relativa esiguit del mercato interno
Il processo di industrializzazione, per lungo tempo fenomeno essenzialmente europeo, si afferm prepotentemente negli Stati Uniti e, in un secondo momento, anche in Giappone.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Un caso spettacolare di crescita economica: gli Stati Uniti
Partendo da una situazione relativamente svantaggiata, sia in termini di popolazione che per quanto riguarda la struttura economica, nel corso dellOttocento si avviano ad essere la prima potenza economica mondiale.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Processo di sviluppo differente da quello inglese, soprattutto per quanto riguarda la scarsit relativa di fattore lavoro, con un maggior impiego di capitale e risorse nei processi produttivi.
Popolazione degli Stati Uniti
4
40
100
0
20
40
60
80
100
120
1790 1870 1915
Abitanti
(milioni)
Una chiave di lettura: popolazione e risorse
Immigrazioni costanti: nativi dAmerica, in costante diminuzione, relegati nelle riserve indiane; crescente numero di afro-americani, forte afflusso di europei e crescente rilevanza anche degli asiatici melting pot La frontiera e un Paese nuovo
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Lenorme disponibilit di terreno costituisce una differenza fondamentale rispetto al caso europeo Coltivazione su ampie estensioni, impiego di macchinari e possibilit di espandersi continuamente su terre altamente fertili Incremento notevole della produttivit per addetto Le diversit climatiche e del suolo consentono un processo di specializzazione regionale
Unagricoltura forte
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1821
-25
1826
-30
1831
-35
1836
-40
1841
-45
1846
-50
1851
-55
USA
Resto del mondo
Importazioni di cotone dellInghilterra
(milioni di libbre per quinquennio)
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Il ruolo complessivo dellattivit agricola resta a lungo rilevante, anche quando gli Stati Uniti sono ormai diventati la prima nazione industriale del mondo. Nel 1900 un terzo del PIL USA ancora di origine agricola.
La quota di prodotti agricoli (cotone, cereali) sulle esportazioni Usa sempre piuttosto elevata Con la fine della guerra civile (1865) e il miglioramento dei trasporti, lexport USA concorre a causare la Grande depressione europea
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1849-58 1869-78 1879-88 1889-98 1899-08 1909-18
% manufatti su exp
%manufatti su imp
Struttura del commercio estero USA
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Fattori del successo americano
Risorse Trasporti Tecnologia
Lenorme estensione territoriale americana e la ricca dotazione di risorse rispetto alla popolazione presente costituisce un elemento costante di sostegno ai processi di sviluppo
La realizzazione di una rete efficiente di trasporti assume particolare significato per la costruzione del mercato interno
Fondamentale la diffusione di tecnologie volte a risparmiare fattore lavoro
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Un ruolo primario nellindustrializzazione americana spetta alle ferrovie, il cui sviluppo, partito in contemporanea con quello inglese, enorme.
Rete ferroviaria (km)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Europa Gran Bretagna USA
1840
1870
1914
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Anche nel caso statunitense, la ferrovia non importante solo perch sa garantire una rete di trasporti efficienti.
Essa contribuisce anche allo sviluppo dellindustria meccanica e siderurgica che, con la fine della guerra civile (1861-1865), sostituisce lInghilterra nella fornitura di binari, locomotori e
carrozze per il mercato interno.
Il settore siderurgico diviene la pi importante industria americana in termini di valore aggiunto.
Si verifica una crescita costante dellaccumulazione del capitale, ma anche, a partire dalla fine della guerra civile, un intenso sviluppo tecnologico.
Cresce, pi che altrove, il rapporto tra capitale e lavoro.
Lindustria
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Origini dellindustria americana:
uno dei motivi scatenanti della guerra dindipendenza americana fu la limitazione della possibilit di produrre manufatti, che dovevano invece essere importati dallInghilterra;
con lindipendenza (1776), dibattito tra favorevoli a uno sviluppo guidato dallagricoltura e dal commercio, e chi invece sosteneva la centralit del settore manifatturiero;
prevalsero i secondi, anche se si arriv alla guerra civile (1861-1865).
Lavvio del processo di industrializzazione si ha negli anni 20, nel
New England, con la lavorazione del cotone.
linizio della crescita del sistema industriale americano.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Lindustria USA si distinguer per: consistenti dimensioni degli impianti produttivi; attenzione alla tecnologia; costruzione per parti intercambiabili, e nuove forme di organizzazione del lavoro (taylorismo, catena di montaggio); acquisizione di capitali sul mercato azionario.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1870 1881-85 1896-00 1906-10 1913
USA
Inghilterra
Germania
Altri
Produzione industriale in % della produzione mondiale
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
La possibilit di creare un apparato legislativo basato sulle esigenze di una comunit nuova e dinamica
Il ruolo della grande impresa (corporation) organizzata per sfruttare al meglio le risorse
Il dinamismo derivan- te dalla volont di affermazione di una societ plurietnica
Elementi distintivi dello sviluppo americano furono:
e il modello T
Henry Ford
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Con gli anni 80 gli Stati Uniti divennero la prima nazione industriale del mondo, e furono, con la Germania e grazie anche alla disponibilit di risorse petrolifere, i protagonisti della seconda rivoluzione industriale.
Elementi caratterizzanti di tale nuova ondata industriale furono: il motore a scoppio (a combustione interna) il settore chimico il settore elettrico
In conclusione, gli Stati Uniti conobbero nel corso dellOttocento una crescita spettacolare, che li port a diventare, allinizio del nuovo secolo, la prima potenza economica mondiale.
Lagricoltura restava comunque unattivit importante, sia per numero di addetti che per valore della produzione.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Non emerge dalle scelte adottate dal governo americano alcuna politica di welfare
la big corporation che assume su di se i compiti di attuare scelte di tipo assistenziale e previdenziale per i propri dipendenti attraverso diverse modalit di welfare aziendale
Chi escluso dalle cerchie aziendali deve per procurarsi volontariamente le forme di tutela
Restavano per dei problemi aperti: sul fronte della sicurezza sociale, della disoccupazione temporanea, delle ricorrenti crisi finanziarie, della disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, della tutela dei lavoratori.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 1
12. Lascesa del Giappone
Per un approfondimento bibliografico si veda:
M. MORISHIMA, Cultura e tecnologia nel "successo" giapponese, Bologna, Il Mulino, 1984
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 2
Il Giappone
Paese di civilt avanzata, caratterizzato dalla presenza di grandi citt e mercati ben organizzati. Con una classe dirigente (samurai) colta, ma estranea alle attivit economiche.
Come la Cina era tuttavia chiuso ai contatti con lOccidente. 1853-1854 imposizione dei trattati ineguali, che determinano lapertura verso lOccidente reazioni xenofobe riforme istituzionali (restaurazione Meiji 1868) prende lavvio lindustrializzazione attraverso limportazione delle istituzioni occidentali
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 3
Decollo difficile causa lo squilibrio tra risorse e popolazione. La carenza di materie prime e materiale energetico rendeva difficile laffermazione dellindustria in termini competitivi sul mercato mondiale.
La bilancia commerciale risultava deficitaria causa la necessit di importare le materie prime.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 4
Per riequilibrare la propria bilancia commerciale il Giappone ricorse allesportazione di un proprio staple (prodotto base) fornitogli dalla manifattura tradizionale: la seta importanti anche le esportazioni di t Alla ricerca di risorse il Giappone intraprese la strada delle guerre coloniali con la Cina (1894-95) con la Russia (1905)
I settori industriali che si affermarono per primi furono: quello tessile quello siderurgico-meccanico, dopo lintroduzione di moderate misure protezionistiche
Importante per lo sviluppo industriale giapponese fu la nascita degli zaibatsu, imprese di carattere familiare che agivano sinergicamente (Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo).
Dopo il 1870 il reddito pro capite crebbe a tassi simili a quelli europei.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini 5
Il successo economico giapponese nel Novecento
Nel Novecento il Giappone cresce e si sviluppa fino a raggiungere posizioni di punta.
Le tappe della crescita giapponese non coincidono con quelle dello sviluppo occidentale, ma sono strettamente legate ad esso.
Successo lento e graduale, dovuto ad una serie di fattori tanto endogeni, quanto esogeni:
importazione di modelli e tecnologie estere
protezionismo e colonialismo
scarso coinvolgimento nella I GM e nella crisi degli anni Trenta (pesanti invece le conseguenze della II GM e le successive imposizioni dei vincitori: abolizione degli zaibatsu e sostituzione con i keiretsu) politiche di coordinamento pubbliche (MITI)
integrazione banca-impresa
disciplinamento sociale e innovazione tecnologica
-
Per un approfondimento bibliografico si veda:
A.D. CHANDLER, T. HIKINO, Il contributo della grande impresa alla crescita delleconomia moderna, in: A.D. CHANDLER, F. AMATORI, T. HIKINO (eds.), Grande impresa e ricchezza delle nazioni 1880-1990, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 33-66
P. BAIROCH, Economia e storia mondiale: miti e paradossi, Milano, Garzanti, 1996
F. FAURI, Lintegrazione prematura. Le relazioni economiche europee dalla met dellOttocento alla grande guerra, Bologna, CLUEB, 2005
13. Leconomia occidentale tra seconda rivoluzione industriale e prima globalizzazione
-
Era in atto la c.d. seconda rivoluzione industriale: diffusione dellelettricit invenzione del motore a scoppio che utilizza per il proprio funzionamento un derivato dal petrolio affermarsi della chimica organica
Inizio del XX secolo: - due grandi aree industrializzate: Europa nord-occidentale e Stati Uniti nord-orientali; - in altre aree europee (compresa lItalia del nord) lindustrializza-zione era ancora agli esordi.
Si tratta di innovazioni pi complesse di quelle della I rivoluzione industriale; richiedono, per essere create e adottate, conoscenze scientifiche e tecnologiche pi elevate epoca degli ingegneri
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
dopo linvenzione di Edison della lampada ad incandescenza (1879) lelettricit comincia a diffondersi; quando poi grazie agli studi di Galileo Ferraris si riesce a trasportare lenergia a distanza, si aprono nuove prospettive per lo sviluppo industriale;
applicazioni: lilluminazione, la trazione ferroviaria e tranviaria, lelettrochimica, lelettrometallurgia, la motorizzazione della piccola industria;
lutilizzo del carbone tuttavia non viene sminuito, rimanendo predominante in alcuni Paesi dotati di importanti giacimenti.
Cambia il paradigma energetico (la storia dellenergia la storia dello sviluppo industriale)
-
La seconda rivoluzione industriale richiede: grandi capitali si affermano le banche miste si consolidano le borse economie di scala si afferma la grande impresa (USA Germania)
In questo contesto si diversifica, specializzandosi, il ruolo della banca: si presentano, in realt diverse, vari modelli di istituzioni di intermediazione finanziaria e creditizia. Assumono un ruolo sempre pi preciso le banche centrali: non solo banche di emissione hanno anche il ruolo di supervisione sul sistema bancario rivestono la funzione di prestatore di ultima istanza
Seconda rivoluzione industriale, banca e imprese
La diversificazione dei sistemi finanziari
-
Si diffondono le Societ per azioni bancarie: le banche commerciali le merchant banks inglesi, le investment banks americane e le banques daffaires francesi le Universalbanken tedesche
Si affermano le Casse di risparmio
Trovano modo di affermarsi, partendo dalla Germania, anche le banche cooperative, che assumono due diversi modelli:
le Banche popolari fondate da H. Schulze Delitzsch
le Casse sociali di credito fondate da F.W. Raiffeisen
Grazie allinsieme di queste diversificate espressioni bancarie, si
crea un potente reticolo di riciclo finanziario del risparmio.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Due sistemi finanziari alternativi per il finanziamento delle grandi iniziative industriali:
quello anglosassone (market-oriented), che conferisce il primato alla Borsa
le grandi imprese rispondono solo al mercato borsistico, quindi solo ai propri azionisti
le informazioni aziendali sono rese note solo al mercato borsistico
quello tedesco (bank-oriented), orientato prevalentemente alla Banca (la banca mista)
esiste uninterconnessione tra imprese e banche
c la possibilit della detenzione di pacchetti azionari incrociati
c un controllo da parte delle banche che possiedono informazioni riservate - sulle imprese
-
La propriet non pi in grado di esercitare il controllo dellimpresa si afferma la figura del manager
La Corporation, grazie alle economie di scala e allorganizzazione scientifica del lavoro: aumenta la produttivit del lavoro abbassa i costi unitari di produzione spiazza la concorrenza in tutti i settori dove si possono standardizzare i prodotti
Big Business: laffermazione della grande impresa
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
1870-1914: la prima globalizzazione
Quali flussi prendere in considerazione per unanalisi della globalizzazione?
Merci, Capitali, Lavoro
Il grado di integrazione di questi mercati a livello internazionale e nazionale definisce il manifestarsi della globalizzazione nelle sue diverse fasi.
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Si afferma in maniera definitiva la navigazione a vapore Si conosce una grandiosa espansione del mezzo ferroviario, specie negli USA Fa la sua prima comparsa il mezzo aereo (1903 esperimento di volo dei fratelli Wright)
Non si muovono solo persone e merci, ma anche capitali e notizie viaggiano ad una velocit prima sconosciuta.
Migliorano i trasporti e le comunicazioni
Il telegrafo: 1866 posa del primo cavo telegrafico transatlantico
-
Storia economica a.a. 2011/2012 - Cinzia Lorandini
Il mercato delle merci
1865: ferrovie e navigazione a vapore diminuiscono le distanze - i cereali americani giungono in Europa in quantit crescente
Arriva in Europa la Grande Depressione (1873-1896) ondata di protezionismo
Durante la belle poque, attenuazione dei dazi protezionistici: trattati di commercio, ampio ricorso alla clausola della nazione pi favorita
Differenza prezzo del grano tra Chicago e Liverpool:
1870: 60% 1914: 15 %
Per alcuni beni omogenei (cereali, ferro etc.) la riduzione dei costi di trasporto conduce ad una convergenza dei prezzi; non vale per tutti i beni, tutti i paesi e tutti i mercati interni dei paesi
-
05000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
UK
Fran
cia
Ger
man
iaU
SA
Imp.
Asb
.
Rus
sia
Ital
ia
1880
1900
1913
75000
110000
210000
0
50000
100000
150000
200000
250000
Mondo
Totale import-export 1880-1913 (milioni di li