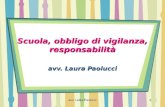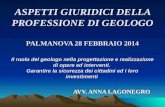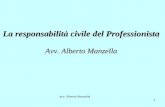Sezione I civile; sentenza 18 ottobre 1982, n. 5413; Pres. Sandulli, Est. Corda, P. M. Zema (concl....
Click here to load reader
-
Upload
alessandro-nigro -
Category
Documents
-
view
230 -
download
2
Transcript of Sezione I civile; sentenza 18 ottobre 1982, n. 5413; Pres. Sandulli, Est. Corda, P. M. Zema (concl....

Sezione I civile; sentenza 18 ottobre 1982, n. 5413; Pres. Sandulli, Est. Corda, P. M. Zema (concl.conf.); Banca nazionale del lavoro (Avv. Nicolò) c. Fall. soc. Carman-Ormi (Avv. Carbone,Forlati). Cassa App. Venezia 20 gennaio 1981Author(s): Alessandro NigroSource: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 1 (GENNAIO 1983), pp. 69/70-71/72Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176819 .
Accessed: 28/06/2014 09:53
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Impugnazioni civili, n. 7; 12 febbraio 1982, n. 883, cit.) — per 11 caso che il rito risultante in definitiva non appropriato sia stato
seguito dall'appellante in corrispondenza dell'erronea qualifica zione data dal primo giudice al rapporto controverso; e non si
vede ragione per cui lo stesso criterio non debba valere quando
l'errore, anziché nella inesatta qualificazione del rapporto, sia
consistito nella non ritenuta o non rilevata necessità di adottare,
per una controversia esattamente qualificata, un determinato rito;
la regola formale trova, anzi, in questo secondo caso — in cui,
in ipotesi, la scelta del rito è del tutto priva di implicazioni so
stanziali — maggior ragione di vedersi affermata.
Resta dunque in definitiva chiarito che tutti gli atti proces suali dei due gradi del giudizio di merito debbono nella forma
necessariamente adeguarsi al rito prescelto dall'attore con l'intro
duzione del giudizio in prime cure fino a quando non intervenga un apposito provvedimento correttivo del giudice e, successiva
mente a questo, adeguarsi a quello con esso adottato, senza alcuna
possibilità, nell'un caso e nell'altro di anticipazioni o deroghe,
per quanto, in ipotesi, astrattamente giustificate, da parte di al
cuno dei contendenti; e che tale regola non può non concernere
in particolare anche l'atto di appello, dal momento, vi è ancora
da osservare, che esso, intervenendo in un processo già in corso,
si pone in essere in condizioni obiettivamente diverse, quanto alle implicazioni della iniziativa che vi dà luogo, dall'atto intro
duttivo del giudizio di primo grado e del tutto identiche, per
converso (e nessuno infatti ha mai sostenuto il contrario) a quelle di ogni altro atto del processo.
Anche il criterio seguito dalla sentenza della sezione lavoro del
12 dicembre 1981, n. 6581, che, come si è visto, pur seguendo in
principio l'indirizzo che viene ora confermato, fa salvo l'atto di
appello proposto in difformità dal rito (erroneamente) osservato
in prime cure quando con esso vengano anticipatamente osser
vate le forme del rito che in definitiva verrà a risultare appro
priato alla natura della controversia, non può dunque che es
sere disatteso.
Nel caso in ispecie, pertanto, facendosi questione del rito solo
sotto il profilo della forma dell'atto d'impugnazione — che nel
rito speciale si propone (negli stessi termini — oltretutto — sta
biliti dal rito ordinario, salvo il caso, previsto dall'art. 434 c.p.c.,
di notifica della sentenza eseguita all'estero) con la presenta zione di un ricorso al giudice ad quem, anziché con la notifica
all'altra parte di una citazione ad udienza fissa — non può che
darsi atto della ritualità dell'appello proposto dal Montalbano in
conformità al rito delle parti e dal giudice (pacificamente) os
servato in prime cure e senza deviazioni seguito anche in se
condo grado fino alla pubblicazione della stessa sentenza che di
chiarava la necessità dell'osservanza del nuovo rito speciale, me
diante deposito della stessa in cancelleria senza che fosse stata
data lettura in udienza del suo dispositivo. In questa conclusione, resta evidentemente assorbito l'esame del
terzo motivo del ricorso, che denunzia violazione e falsa appli
cazione degli art. 156 e 157 c.p.c. per il mancato accertamento
da parte del giudice a quo della sanatoria della pretesa inam
missibilità dell'appello, da ravvisarsi nel raggiungimento dello
scopo dell'atto attraverso il pacifico svolgimento del giudizio di
appello in tutto il suo corso.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in rela
zione al motivo accolto con conseguente rinvio della causa per
nuovo esame — in ragione della inderogabilità assoluta della
competenza delle sezioni specializzate agrarie — allo stesso giu
dice a quo, il quale dovrà nella sua decisione attenersi ai principi
sopra esposti.
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 18 otto
bre 1982, n. 5413; Pres. Sandulli, Est. Corda, P. M. Zema
(conci, conf.); Banca nazionale del lavoro (Avv. Nicolò) c.
Fall. soc. Carman-Ormi (Aw. Carbone, Forlati). Cassa App.
Venezia 20 gennaio 1981.
Fallimento — Revocatoria fallimentare — Accreditamenti in con
to corrente bancario — Conto scoperto — Revocabilità — Con
to con provvista costituita da apertura di credito — Revoca
bilità — Limiti (Cod. civ., art. 1843, 1844; r. d. 16 marzo
1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 67).
/ versamenti in conto corrente bancario hanno natura di paga
menti e sono, quindi, revocabili a norma dell'art. 67, 2° com
ma, 1. fall, soltanto nell'ipotesi di conto « scoperto » (quando
cioè la banca abbia anticipato somme oltre i limiti del fido),
mentre nell'ipotesi di conto corrente munito di provvista co
stituita da un'apertura di credito (c. d. conto « passivo ») non
è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito
esigibile della banca verso il correntista e i versamenti, con
sistendo in semplici operazioni contabili di accreditamento di
rette a ripristinare la provvista, non hanno funzione soluto
ria e non sono, perciò, suscettibili di revocatoria, eccettuati
i casi di specifica imputazione a titolo di pagamento e quelli in cui la banca abbia anticipatamente chiuso il conto in pa
reggio recuperando in proprio favore, con prelievo dalla prov vista del correntista, una somma pari al fido utilizzato da que st'ultimo. (1)
X
(1) La sentenza leggesi in Foro it., 1982, I, 2779, con nota redazio nale di G. Silvestri: ne riproduciamo la massima per pubblicare la nota di A. Nigro.
• ♦ •
Scoperto di conto, conto corrente assistito da apertura di
credito e revocatoria fallimentare delle rimesse.
1. - La Cassazione è tornata a pronunziarsi sul complesso e tormen tato problema della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente: e lo ha fatto, dico subito, prospettando l'unica soluzione (a mio avviso) convincente ed adeguata alla normativa sostanziale, e
fallimentare, in materia. È noto che l'indirizzo giurisprudenziale e dottrinale favorevole alla
assoggettabilità alla revocatoria fallimentare delle rimesse effettuate nel conto corrente, con saldo debitore, dell'imprenditore poi fai lito è sorto e si è consolidato con riferimento, specificamente, al la ipotesi del c. d. scoperto di conto, contraddistinto dalla assen za di un formale rapporto avente per effetto quello di costituire a favore del correntista un « credito disponibile » verso la banca
(apertura di credito, anticipazione bancaria), ed alla ipotesi, del tu He
analoga sotto il profilo che qui interessa, del c. d. sconfinarnentó dni fido concesso con un formale rapporto; solo in un secondo moment' il principio della revocabilità è stato esteso — dalla Cassazione, ma
soprattutto dalla giurisprudenza di merito e da parte della dottrina —
alla (diversa) ipotesi del conto corrente (« passivo ») assistito d
apertura di credito o da altro formale rapporto di concessione d credito (per un aggiornato quadro degli orientamenti della giurispru denza e della dottrina in argomento, sia consentito rinviare ad A. Ni
gro, in Giurisprudenza bancaria (1980-1981), Milano, 1982, 50 ss. e in
Giurisprudenza bancaria (1981-1982), in corso di pubblicazione). Questo passo ulteriore però — come rilevavo in una precedente oc
casione (Revocatoria delle rimesse in conto corrente e posizione della banca nei rapporti di concessione di credito, in Giur. comm., 1980, I, 290 ss., ed ora in C. M. Mazzoni e A. Nigro, Credito e mone
ta, Milano, 1982, 367 ss.) — appare quanto mai discutibile. In
fatti, nel caso dello scoperto di conto o dello sconfinamento, il saldo debitore a carico del correntista costituisce sicuramente un credito della banca esigibile in qualsiasi momento: un credito a fronte del
quale obiettivamente le rimesse che affluiscono sul conto vengono ad avere un effetto, non già di ripristino della disponibilità, ma di ridu zione od estinzione dello stesso, con conseguente loro (inevitabile) re
vocabilità, in quanto appunto atti solutori, ai sensi dell'art. 67 1. fall,
(né sembra, noto per inciso, seriamente difendibile la tesi « corretti
va », proposta da taluni autori e da qualche sentenza di giudici di
merito, in base alla quale sarebbero revocabili solo quei versamenti
o accreditamenti il cui importo complessivo non superi la differenza
fra il massimo di « scopertura » raggiunto dal conto nel periodo c. d.
sospetto ed il saldo finale: tesi priva di qualsiasi consistente supporto
logico e normativo e che non ha in effetti trovato, almeno finora, echi rilevanti). Non cosi, invece, nel caso del conto corrente assistito
da apertura di credito. Qui le rimesse sul conto (pur « passivo ») hanno
obiettivamente, ed esclusivamente, una funzione di ripristino della di
sponibilità; e, d'altra parte, nel corso del rapporto non sussiste in
realtà alcun debito, neppure non scaduto, a carico del correntista: è
solo alla chiusura del rapporto stesso che l'eventuale saldo negativo costituirà un debito verso la banca. Di qui, l'impossibilità di qualifi care le rimesse affluenti nel conto in questione come atti solutori; di
qui, la loro non revocabilità ex art. 67 1. fall. 2. - Con la sentenza che si annota, la Cassazione si è collocata
esattamente in tale ordine di idee, riprendendo, in termini però assai
più nitidi e sicuri, un orientamento che si era andato già profilando in sue precedenti pronunzie (sentenze nn. 5836/1978 e 709/1980, pun tualmente ricordate nella motivazione).
E, cosi', essa ha nettamente distinto le due situazioni, talvolta con fuse dalla precedente giurisprudenza, del conto corrente scoperto, da un lato, e del conto corrente passivo assistito da apertura di credito, dall'altro. Ha evidenziato l'« assoluta diversità » della funzione che, nelle due situazioni, vengono ad avere i versamenti o gli accredita
menti sul conto: « nel caso del conto scoperto — è precisato ralla
sentenza — stante l'immediata esigibilità del credito della h .nca, il
versamento diviene automaticamente pagamento ... ; nel caso .i conto
semplicemente passivo, invece, proprio perché difetta l'esigibilità del
credito, il versamento non può essere considerato pagamente ». In cri
tica, direttamente, dell'impostazione seguita nella sentenza cassata, ma
anche, indirettamente, di sue precedenti pronunzie (Cass. nn. 4216/1976,
3603/1975, 3415/1975), ha poi escluso che l'apertura di credito possa essere « scomposta » in tanti atti distinti di concessione di credito, attraverso i singoli atti di utilizzazione del conto da parte del cor
rentista, e corrispondentemente di rimborso, attraverso le singole ri
messe, con conseguente carattere solutorio (e quindi revocabilità) di
queste ultime, giustamente sottolineando al riguardo l'erroneità del
This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA
l'argomento che volesse trarsi dall'art. 1844 c. c. (a norma del quale « se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca »); cosi come ha escluso la possibilità di ritenere revocabili le rimesse in quanto, co
munque, « atti a titolo oneroso » depauperatori del patrimonio, cor rettamente rilevando che le rimesse in se e per se non sono né one rose né gratuite: diventano onerose se sono dirette a colmare uno
scoperto, cioè a pagare un debito esigibile; non lo diventano se sono dirette a creare un rapporto di provvista, in relazione al quale è in effetti la banca a porsi come vera e propria debitrice nei confronti del correntista.
3. - Naturalmente, in questa impostazione — l'unica, ripeto, coe rente ed adeguata al sistema — emerge in tutta la sua portata la non facile questione di stabilire, in concreto, quando si abbia scoperto di conto (coft conseguente assoggettabilità a revocatoria fallimentare delle rimesse che in esso affluiscono) e quando, invece, conto cor rente assistito da apertura di credito (con conseguente non assoggetta bilità a revocatoria delle rimesse).
Il c. d. scoperto di conto, infatti, è una figura dai connotati assai
incerti, anche per il non univoco linguaggio della prassi bancaria. In
particolare, esso può risultare o da un accordo banca-cliente, inne stato sul rapporto di conto corrente, in base al quale il cliente è autorizzato a superare i limiti della disponibilità esistente, entro un
importo massimo; oppure da un comportamento autonomo della banca
che, di fatto, esegue ordini di pagamento impartiti dal cliente (nor malmente attraverso assegni) al di là di fondi disponibili. Si tratta, come è evidente, di due situazioni che, in sé riguardate, appaiono su scettibili di essere diversamente costruite: nel primo caso, c'è un pre ventivo impegno da parte della banca di consentire l'utilizzazione di
somme fino ad un certo limite, configurandosi cosi un rapporto con caratteri assai vicini (o addirittura identici) a quelli dell'apertura di
credito; nel secondo caso, si tratta di erogazioni effettuate dalla banca
spontaneamente e dalle quali, anche se protratte nel tempo, non si
può far derivare un vincolo per la banca a (continuare a) concedere credito.
Se si guarda però al concreto atteggiarsi del rapporto fra le parti, globalmente considerato, non è difficile constatare come questa distin zione si attenui fino praticamente a scomparire. In entrambi i casi,
infatti, la concessione di credito da parte della banca viene in realtà
conformata in modo da assumere comunque un ruolo strumentale, accessorio rispetto allo svolgimento del conto corrente, da cui ri
sulta quindi assorbita ed al cui regolamento (legale e pattizio) ri
mane assoggettata: e assoggettata specificamente alla regola propria del conto corrente bancario, consacrata anche nelle norme bancarie
uniformi, in base alla quale ad ognuna delle parti è sempre riservato
il diritto di esigere l'immediato pagamento del saldo a suo favore. Ed è qui allora, più che nel maggiore o minore grado di « forma
lizzazione » del rapporto di concessione di credito, che deve collo carsi la linea di demarcazione, ai fini della revocatoria delle rimesse, fra scoperto di conto e conto corrente assistito da apertura di credito
Se il rapporto è strutturato in modo da assicurare la possibilità per la banca di ottenere l'immediata restituzione, senza dilazioni di alcun ge nere, delle somme utilizzate dal correntista o pagate per conto di
questo, in modo, cioè, da assicurare l'immediata esigibilità in qua lunque momento del credito della banca, si è in presenza di uno
scoperto di conto. Si è invece in presenza di una apertura di credito a tempo indeterminato quando l'esigibilità del saldo a favore della
banca è condizionata quanto meno alla scadenza del periodo di preav viso ex art. 1845, ult. comma, c. c., se non addirittura al decorso dei
quindici giorni ex art. 1845, 2° comma. 4. - Se il nitido e convincente orientamento ora assunto dalla Cassa
zione si consoliderà, non vi è dubbio che ne potranno derivare rile
vanti (e benefici) effetti sul piano della condotta operativa delle banche.
Come avevo avuto modo di notare nello scritto prima ricordato, le
banche hanno mostrato una sempre più spiccata preferenza per le con
cessioni di credito attraverso il meccanismo dello scoperto di conto
(nelle forme sopra viste) anziché con regolari contratti, quali l'apertu ra di credito, l'anticipazione bancaria, ecc. E- ciò per la maggiore elasti
cità e duttilità di tale strumento, che, per un verso, può evitare tu lune procedure interne (l'istruttoria prevista dalla legge bancaria), per altro verso, e soprattutto, rende possibile alla banca manovrare a sua completa discrezione la posizione del cliente, ampliare o restrin
gere il fido, interromperlo e chiedere rimborso delle somme erogate, senza l'« impaccio » di termini di preavviso o di restituzione. Questo « vantaggio » per la banca si traduce però, ovviamente, in uno « svan
taggio » per l'utente del credito, che viene a trovarsi cosi esposto al
rischio di una revoca improvvisa e immotivata del fido, con obbligo di restituzione immediata, la quale potrebbe provocare — e, nella
realtà, spesso ha provocato — danni anche gravissimi a suo carico.
L'assoggettabilità a revocatoria fallimentare delle rimesse affluenti su conto corrente scoperto e, per converso, la non assoggettabilità a revocatoria delle rimesse affluenti su conto corrente assistito da aper tura di credito appare allora suscettibile di costituire un formida bile incentivo per un più corretto uso, da parte della banca, dello
strumento del conto corrente, con il ripristino, per le concessioni di
credito, degli schemi contrattuali appositi (apertura di credito, ecc.), beninteso nella loro configurazione normativa tipica, in una logica di
comportamento più rispettosa, oltre che delle procedure di eroga zione del credito previste dalla legge bancaria, della posizione e degli interessi dell'altro contraente.
Alessandro Migro
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 7 set
tembre 1982, n. 4844; Pres. U. Miele, Est. Santosuosso, P.
M. Leo (conci, conf.); Cinque (Avv. Giorgianni, S. Marino)
c. Morano (Avv. Acri). Conferma App. Catanzaro 13 otto
bre 1979.
Stato civile — Dichiarazione di nascita — Soggetti legittimati (R.d. 9 luglio 1939 n. 1238, ordinamento dello stato civile, art. 70).
Rinvio civile (giudizio di) — Azione di rettificazione del nome
imposto a neonato da persona non legittimata — Compito del
giudice di rinvio — Limiti (Cod. proc. civ., art. 383, 384; r.d. 9 luglio 1939 n. 1238, art. 70).
L'art. 70 dell'ordinamento dello stato civile, nel prescrivere che « in mancanza » del padre la dichiarazione di nascita è resa
dagli altri soggetti indicati in via subordinata, richiede un im
pedimento serio alla tempestività della dichiarazione, non es
sendo sufficiente una mera assenza temporanea. (1) Il giudice di rinvio, chiamato a pronunciarsi a seguito della sen
tenza di cassazione che ha dichiarato ammissibile l'azione di
rettificazione del nome di un figlio legittimo, proposta dal pa dre per violazione dell'ordine legale di priorità dei soggetti abilitati alla dichiarazione di nascita ed alla scelta del nome
(nella specie, la dichiarazione era stata fatta dalla levatrice, che non agiva quale procuratrice della madre, in mancanza
dì un serio impedimento del padre a compiere una dichiara
zione tempestiva), deve limitarsi a disporre la rettificazione del
l'atto di nascita con l'attribuzione al figlio del nome scelto dal
padre, restando riservata alla sede contenziosa la risoluzione
dell'eventuale conflitto tra i genitori circa la scelta del nome
da imporre al figlio. (2)
Svolgimento del processo. — Franco Morano ed Emanuela
Cinque, sposati il 28 ottobre 1972, furono autorizzati a vivere
separatamente con provvedimento 10 gennaio 1974 dal presi dente del Tribunale di Cosenza, a seguito del ricorso per sepa razione personale presentato dal Morano.
Questi con ricorso 27 aprile 1974 esponeva al Tribunale di Catanzaro di avere appreso soltanto il 12 dello stesso mese che la moglie aveva dato alla luce il 9 aprile una bambina nell'ospe dale civile di quella città; che due giorni dopo (11 aprile) l'oste trica capo dell'ospedale aveva fatto la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile, indicando i nomi di Consuelo ed Elena, e ciò nel presupposto che il padre era « fuori sede ». Tanto premesso il Morano chiedeva che, ai sensi degli art. 167 ss. ordinamento stato civile il tribunale disponesse la rettifica zione di detti nomi in quello di Carmelina, da lui scelto nel l'esercizio del suo potere primario previsto dall'art. 70 1. cit.
Il tribunale, disposta la comparizione delle parti interessate, e sentiti il p. m. e la madre della neonata, che concludevano
per il rigetto della domanda, riteneva improponibile la risolu zione di una controversia sulla titolarità e l'esercizio del potere di imporre il nome nell'ambito di un procedimento di rettifica zione degli atti dello stato civile. Analogamente decideva la cor te d'appello sul reclamo proposto dal Morano.
Senonché questa pronuncia veniva cassata dalla Suprema cor te con sentenza 28 ottobre 1978, n. 4922 (Foro it., Rep. 1979,
(1-2) Cass. 28 ottobre 1978, n. 4922, della cui interpretazione si discute, è riassunta in Foro it.. Rep. 1979, voce Stalo civile, n. 18; mentre App. Catanzaro 13 ottobre 1979, massimata nel Rep. 1981, voce cit., nn. 23, 24, è riportata per esteso in Giur. merito, 1981, 653.
Sul problema della rettificazione del nome v. Cass. 9 maggio 1981, n. 3060, Foro it., 1982, I, 1378, che, contrariamente a Cass. 4922/ 1978, ha ammesso la rettifica non già per il mancato rispetto dell'or dine di priorità stabilito dall'art. 70 r. d. 9 luglio 1939 n. 1238, ben sì' per la violazione degli art. 316-317 nel testo anteriore alla riforma del 1975, che attribuivano la potestà sui figli (e quindi, secondo l'inter pretazione della corte, il diritto di imporre il nome) al padre.
Tale posizione, se opera certamente una semplificazione dell'atti vità processuale, non sfugge al dubbio di un eccessivo allargamento dell'ambito del giudizio di rettifica. Sul punto cfr. M. Finocchiaro, Di saccordo tra : genitori, imposizione del nome al neonato e rettifica zione degli atti dello stato civile, in Giust. civ., 1979, I, 666, che, dopo aver derivato la titolarità del diritto di imporre il nome dalla spet tanza della potestà parentale, osserva (in riferimento a Cass. 4922/ 1978) come l'istante mirasse, in realtà, a far riconoscere che egli ne era stato illegittimamente spogliato: domanda, questa, «che solo con estrema difficoltà ... può qualificarsi di ' rettificazione degli atti dello stato civile ' ».
In riferimento ai poteri di indagine della Cassazione in occasione di ricorso contro sentenza pronunciata in sede di rinvio v. Cass. 13 novembre 1981, n. 6013, Foro it., Rep. 1981, voce Cassazione civile, il. 323; 8 aprile 1981, n. 2020, ibid., n. 322; 25 gennaio 1979, n. 566, id., 1980, I, 211.
This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions