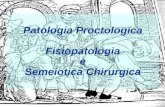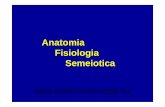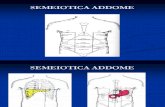Patologia Proctologica Fisiopatologia e Semeiotica Chirurgica
semeiotica
-
Upload
chiarapetraroli -
Category
Documents
-
view
1.410 -
download
8
Transcript of semeiotica

CAPITOLO 2 – ANAMNESI
DEFINIZIONE- Raccolta ordinata di informazioni sulla storia medica del paziente e sui motivi che l’hanno portato dal medico. 1. ANAMNESI FAMILIARE – Gli obiettivi di questa indagine sono:
Svelare un'ereditarietà patologica. Accertare una fonte familiare di contagio(es. tubercolosi, epatite ecc.). Riconoscere situazioni anormali nell’ambiente familiare(scarsa alimentazione).
2. ANAMNESI PERSONALE FISIOLOGICA Nascita, allattamento e primi atti dell’infanzia – il parto avviene normalmente al 9º mese
di gravidanza con un parto normale,detto parto eutocico,invece se insorgono difficoltà nell’espletamento del feto si parla di parto distocico che può portare ad una anossia cerebrale con gravi conseguenze. La prematurità, cioè la nascita prima dei 9 mesi,può essere un rischio per il feto. L’allattamento può essere materno, baliatico(da una balia) o artificiale Nei primi atti dell’infanzia si vede l’epoca nella quale il bambino ha messo i denti (dentizione),i primi passi(deambulazione),le prime parole(fonazione). Si vede anche lo sviluppo staturale e il profitto scolastico.
Pubertà – indica l’inizio della maturazione sessuale con acquisizione dei caratteri sessuali secondari, è più precoce nelle femmine. Il menarca esprime la comparsa della prima mestruazione che avviene intorno ai 12-13 anni, ma varia tanto. La regolarità dei flussi mestruali fornisce informazioni molto utili.
Servizio militare Matrimonio e gravidanze – domande sul numero delle gravidanze, sulle modalità dei parti,
eventuali aborti,comparsa della montata lattea ecc. Menopausa – la cessazione dei flussi mestruali con comparsa di manifestazioni
vasomotorie e nervose. Abitudini alimentari e voluttuarie – eccessiva alimentazione abuso di alcool, il fumo
3. ANAMNESI LAVORATIVA Patologia da lavoro da inalazione di polveri – le pneumoconiosi che provocano fibrosi
polmonare con insufficienza respiratoria.(es. silicosi, antracosi,asbestosi) Patologia da lavoro industriale – intossicazione chimica da metalli come mercurio,
cadmio, cromo e da cancerogeni chimici. Patologia da lavoro agricolo Patologia da lavoro medico – diverse infezioni.
4. ANAMNESI PATOLOGICA Anamnesi patologica remota – raccoglie in ordine cronologico le malattie, le operazioni
chirurgiche ed i traumi sofferti in passato dal paziente. L’anamnesi medica individua le malattie che hanno lasciato un'immunità assoluta e cosi non si possono più manifestare. L’anamnesi chirurgica individua alcuni disturbi dovuti alla ablazione chirurgica come sindromi da gastroresezione e il “domani doloroso” del colecistectomizzato.

Anamnesi patologica prossima – chiarire i motivi che hanno portato il paziente dal medico e si possono essere subiettivi o sintomi, obiettivi o segni.
Anamnesi farmacologia
FUNZIONI BIOLOGICHE E SINTOMI
1. SONNO- è una delle più importanti funzioni ritmiche dell’organismo. Nel ritmo sonno-veglia è interessato il sistema reticolare attivatore dove una sua attivazione porta uno stato di veglia ed un suo affaticamento porta allo stato di sonno. Durante il sonno si realizzano per 3-4 volte le fasi REM(rapid eye moviment) che si accompagnano con un rilassamento muscolare e diminuzione della pressione arteriosa(PA).La serotonina ha un ruolo essenziale nel mantenimento del sonno, invece le catecolamine(noradrenalina e dopamina) del stato di veglia. I disturbi del sonno comprendono:
Insonnia - che può essere primitiva dovuto o a una deficienza dei centri diencefalo-mesencefalici o ad un esaltamento della eccitabilità della corteccia cerebrale come da abuso di alcune sostanze(caffeina, teobromina) e negli stati di fatica fisica e mentale. L’insonnia fatale è una malattia autosomica dominante(AD). Le insonnie secondarie sono determinate da un anormale apporto sensitivo-sensoriale al talamo.
Ipersonnia – sono gli stati di esaltamento della funzione ipnica e in casi più gravi si parla di letargia. Nella narcolessia(sindrome di Gelineau) il sonno si istituisce durante l’esecuzione di azioni volontarie. Molte malattie che portano a deperimento dell’organismo si accompagnano con ipersonnia(diabete mellito, cachessia) o molte encefaliti nei stadi più avanzati.
Inversione del ritmo sonno-veglia – molto frequente nelle encefaliti. Sonno parziale –se c’è una dissociazione fra sonno psichico e muscolare come nel caso
quando il paziente cammina dormendo(sonnambulismo) o è sveglio ma in stato di completo rilassamento muscolare(cataplessia).
2. SETE – regola l’assunzione dei liquidi e si manifesta per l’impoverimento in acqua delle cellule. L’assunzione di grandi quantità di acqua si chiama polidipsia e può essere primitiva dovuta a disfunzione dei centri cerebrali di controllo o secondaria dovuto a un deficiente contenuto d’acqua nelle cellule ed un aumento della pressione osmotica dovuta a diminuita ingestione di liquidi o un aumento delle perdite di acqua a causa di sudorazione profusa, vomiti e diarree profuse,profusa emorragia,poliuria(diabete insipido,diabete mellito,morbo di Addison).
3. FAME- le sensazioni di fame e sazietà sono condizionati dai centri ipotalamici sensibili al livello di glucosio nel sangue. L’ipoglicemia stimola tali centri che evocano le contrazioni gastriche da fame. Esagerate contrazioni gastriche come nelle gastriti ipersecretive o ulcere gastro-duodenale determinano un fastidioso senso di fame. I disturbi della fame comprendono:
Iperoressia o bulimia - L’esaltato senso di fame può essere conseguenza di ipoglicemia (iperplasia o tumori del pancreas endocrino), lesioni nervose centrali (encefaliti, meningiti, tumori dell’ipotalamo o dell’ipofisi),cause psichiche o psichiatriche. A un'iperoressia che si accompagna a uno stato consuntivo due sono le condizioni da considerare:l’eccessiva perdita di materiali energetici (diabete mellito con glicosuria

massiva)e l’esaltazione dei processi ossidativi (ipertiroidismo nel Basedow e negli adenomi tossici)
Anoressia - La diminuzione del senso di fame (disappetenza) può verificarsi per cause banali non patologiche. L’anoressia è la perdita totale del senso di fame che può manifestarsi a causa di un carcinoma gastrico (anoressia per cibi carnei), anemia ipocromica essenziale,anemia perniciosa(per atrofia gastrica),cirrosi epatica,distruzione dell’ipofisi(morbo di Simmonds) e cause psicologiche(anoressia mentale).
4. DIURESI – è la quantità di urina eliminata nelle 24 ore che in condizioni normali si aggira sui 1000-1200 ml. La diuresi è regolata dal flusso ematico renale(1,2 l/min), dal filtrato glomerulare e dal riassorbimento tubulare idrico. Le alterazioni quantitative della diuresi comprendono:
Poliuria – si intende una diuresi superiore ai 2 litri nelle 24 ore. La poliuria può essere fisiologica dovuto a ingestione di liquidi(diminuisce la secrezione di ADH), esposizione al freddo,consumo eccessivo di birra che consente cosi l’eliminazione di acqua in eccesso rispetto al fabbisogno. Il peso specifico dell’urina è molto basso. La poliuria patologica può essere dovuto a cause prerenali come nel diabete mellito(diuresi osmotica),diabete insipido e riassorbimento di grandi versamenti sierosi;a cause renali come nella fase di guarigione della gromerulonefrite acuta,fase poliurica dell’insufficienza renale cronica e insufficienza tubulare;a cause extrarenali come nella poliuria dei cardiaci in fase di riassorbimento degli edemi.
Oliguria – si intende una diminuzione della diuresi al di sotto di 1 l nelle 24 ore. L’oliguria può essere fisiologica dovuto a scarsa introduzione di liquidi o eccessiva sudorazione (aumenta la secrezione di ADH). In questi casi la densità delle urine sarà elevata in quanto il rene concentrerà in un ridotto volume le scorie ed i soluti da eliminare. L’oliguria patologica dovuta a cause prerenali come insufficienza,cirrosi epatica in fase ascetica,diarree profuse,occlusioni intestinali;a cause renali come riduzione del filtrato(gromerulonefrite acuta),ostruzione dei tubuli(sindrome da schiacciamento,trasfusioni incongrue),eccessivo riassorbimento tubulare(tubulonefrosi acute,vascolari,tossiche); a cause postrenali come per ostruzione delle vie urinarie da calcoli, tumori e flogosi.
Anuria – si intende la totale soppressione della secrezione renale di urina o l’emissione di pochi ml nelle 24 ore. Tutte le condizioni che provocano oliguria possono determinare anche anuria.
5. MINZIONE –è l’atto fisiologico che porta alla eliminazione dell’urina dalla vescica. I fisiologici 1200-1500 ml che costituiscono la diuresi totale giornaliera sono eliminati di norma nel corso di 3-5 minzioni (frequenza maggiore nel bambino).Le alterazioni della minzione comprendono:
Ritenzione urinaria - impossibilità alla minzione dovuta ad un ostacolo vescicale o uretrale oppure a deficiente contrattilità del muscolo detrusore. Si distingue una ritenzione acuta che è dolorosa, dovuta a un calcolo che si impegna nell’uretra,l’urina ritenuta distende le pareti e determina cosi un senso di peso e dolore,spasmo dello sfintere,paresi del detrusore; ritenzione cronica che si istituisce lentamente come nell’ipertrofia prostatica, neoplasie vescicali,tumori dell’uretra,tumori della prostata,cause nervose. L’ostacolo alla minzione può essere dovuto a cause meccaniche(neoplasie,calcoli) e cause nervose. Stimolo efficace per l’inizio della minzione è la distensione vescicale che attiva le vie simpatiche del sacrale che vanno al midollo con le radici L1 e L2 e cosi vengono trasmesse al cervello che poi manda segnali per il rilascio dello sfintere vescicale.
Incontinenza urinaria – è l’emissione involontaria di urina dovuta a lesioni organiche dello sfintere vescicale (interventi chirurgici, traumi,prolasso vaginale) e lesioni del sistema nervoso (sclerosi multipla,tumori midollari,ictus cerebrale ecc.). L’enuresi notturna è una particolare varietà di incontinenza che si verifica più spesso nei bambini.

Pollachiuria – è l’aumento di frequenza dello stimolo ad urinare (8-10 volte/dì) ed ogni minzione è costituita da piccole quantità di urina, dovuta a colica renale da calcoli,cistiti e cistopieliti,papillomi e carcinomi vescicali,ipertrofia prostatica,tumori degli organi contigui.
Nicturia – è la condizione in cui la quantità di urine emessa durante la notte supera quella emessa durante il giorno. Costituisce un importante e precoce sintomo dell’insufficienza cardio-circolatoria: durante il riposo aumenta il flusso ematico renale, aumenta il filtrato glomerulare, aumenta la produzione di urina,ma compare anche nell’ipertrofia prostatica.
Disuria – è una generica difficoltà alla minzione. La minzione imperiosa è uno stimolo irresistibile a urinare, che spinge il soggetto a soddisfare immediatamente la necessità, pena l’emissione involontaria dell’urina (cistiti, compressioni estrinseche della vescica, malattie del midollo).L’emissione ritardata dell’urina dovuto ad una anormale condizione dello sfintere e getto corto e privo di forza (il paziente si bagna le scarpe) caratteristico nell’ipertrofia prostatica.
Stranguria – è l’emissione dolorosa dell’urina dovuta a uretriti,cistiti,tumori della vescica. Si distingue una stranguria iniziale che precede l’emissione dell’urina(cistiti) e una stranguria terminale che si manifesta alla fine della minzione.
Ematuria – è la perdita di sangue con le urine. Si distinguono ematurie macroscopiche come uretrali(cateterismi indaginosi, cistoscopie),vescicali (cistiti, poliposi, neoplasie, calcoli),renali (nefrolitiasi,neoplasie,Tbc,glomerulonefriti acute) e ematurie microscopiche che sono evidenti solo all’esame del sedimento urinario dovuto a stesse cause.
Emoglobinuria – è la perdita di Hb con le urine in corso di crisi emolitiche.
6. ALVO – è la funzione fisiologica dell’evacuazione delle feci. Normalmente nell’adulto la defecazione avviene una volta nelle 24 ore e permette l’espulsione di una quantità di feci pari a 120-150 gr. Il ritmo della defecazione è strettamente personale. Le variazioni dell’alvo comprendono:
Occlusione o ileo – indica l’arresto della funzione alvina con mancata emissione di feci e gas. Si distingue un ileo meccanico dovuto ad un'ostruzione del lume intestinale che rende la peristalsi impotente alla progressione delle feci e dei gas per ostacoli intrinseci (tumori intestinali,fecalomi,calcoli voluminosi,parassiti) o ostacoli estrinseci (tumori endoaddominali,aderenze,ernie,volvoli) e un ileo paralitico(dinamico):determinato dalla paralisi riflessa della muscolatura liscia(peritoniti,traumi,trombosi delle arterie mesenteriche,sequele di interventi chirurgici).Nell’ileo l’alvo chiuso a feci e gas con meteorismo,il dolore addominale e il vomito orientano bene la diagnosi.
Stipsi - evacuazione poco frequente e ritardate di feci scarse, molto consistenti dovuto a alimentazione incongrua(dieta povera di residui di cellulosa), condizionamenti psichici (ambientali),abuso di lassativi (esaurimento dell’eccitabilità del tubo intestinale),megacolon congenito (morbo di Hirschsprung),stenosi intestinali,malattie organiche del midollo spinale (distruzione del parasimpatico sacrale).Si dividono in stitichezze coliche(difetto di progressione nel colon) e dichezie(anormale accumulo di feci nel retto).
Diarrea – è l’aumento del numero delle scariche di feci poltacee, semiliquide o acquose dovute a una irritazione tossica o tossicoinfettiva del tubo digerente (gastroenterite, enterocolite),allergie intestinali (iperemia ed edema della parete intestinale),anormalità dei processi digestivi (insufficienza pancreatica, morbo celiaco),processi infiammatori intestinali cronici(morbo di Crohn,rettocolite ulcerosa,tubercolosi intestinale,malattia diverticolare),processi neoplastici(tumori dell’intestino tenue,tumori del retto,poliposi del colon).La dissenteria si differenzia dalla diarrea per l’emissione di materiale patologico quasi sempre acquoso (disidratazione) dovuto a dissenteria bacillare, amebica, colera, avvelenamenti con cibi guasti, alimenti contaminati da stafilococchi, salmonella, arsenico o fosforo.
Emorragie digestive – che comprendono : Ematemesi - sangue emesso con il vomito (varici esofagee, ulcere e neoplasie gastriche e duodenali),enterorragia - abbondante

perdita di sangue rosso vivo attraverso l’ano (ulcera duodenale, infarto intestinale, rettocolite ulcerosa) rettorragia - modesta perdita di sangue dall’ano (emorroidi, neoplasie del retto),melena-emissione di materiale fecale di colore nerastro contenente sangue parzialmente digerito.
7. VOMITO – è una rapida e forzata espulsione del contenuto gastrico attraverso la bocca. Ha una fase prodromica che comprende scialorrea, sudorazione,pallore,tachicardia e poi bradicardia e una fase espulsiva che comprende il rilasciamento della muscolatura dell’esofago e del cardias, contrazioni vigorose del diaframma e dei muscoli addominali e chiusura della glottide per impedire il passaggio del materiale nelle vie aeree. Nella maggior parte dei casi è proceduto dalla nausea una sensazione sgradevole di imminenza del vomito,invece il vomito a bocca di barile si manifesta senza nausea. In base ai caratteri del materiale vomitato si distinguono in vomito alimentare (stenosi piloriche), acquoso (vomito degli ulcerosi),biliare(occlusione intestinale),emorragico (ematemesi), caffeano (sangue nerastro parzialmente digerito),fecaloide (materiale fecale, occlusioni intestinali basse) ed è dovuto a:
Stenosi od occlusione– come nella stenosi pilorica, neoplasie gastriche,occlusioni intestinali.
Riflesso – dovuto ad irritazione meccanica o chimica(indigestione, ubriachezza,ingestione di cibi guasti,gastriti tossiche) ma anche malattie acute e croniche(peritoniti localizzate o generalizzate,coliche renali e biliari) e stimolazione del nervo vestibolare come labirintiti e chinetosi (mal di mare, di aereo, di macchina).
Centrale – dovuto a stimolazione chimica del centro del vomito dalla apomorfina, digitale, uremia,acidosi metabolica,insufficienza epatica o a sollecitazioni meccaniche del centro da edema cerebrale,tumori,traumi,idrocefalo
Iperemesi gravidica – dovuto alla gravidanza che si accompagna con nausea e vomito nei primi 3-4 mesi.
8. SINGHIOZZO – consiste in una convulsa e repentina inspirazione che determina una brusca negatività della pressione intratoracica con rumorosa chiusura dell’epiglottide. E’ un atto riflesso delle vie vagali e si osserva nelle pleuriti diaframmatiche, ascessi sub frenici, peritoniti ecc.
9. STARNUTO – è un atto involontario determinato da un'irritazione meccanica o chimica della mucosa nasale. Può essere conseguenza di una banale inalazione di polveri irritanti, una rinite acuta o allergica.
10. TOSSE – è un atto riflesso che ha lo scopo di liberare le vie respiratorie da corpi estranei.Preceduta da una veloce e profonda inspirazione, la tosse si manifesta con una rapida espirazione a glottide chiusa. Ha come arco afferente il nervo vago. Si può distinguere una:
Tosse umida – presenza di un processo infiammatorio catarrale o purulento a livello dei bronchi o polmoni come nel caso di una bronchite,bronchiectasie,ascesso polmonare,polmonite. La tosse si può presentare con vomito, con emottisi o con escreato schiumoso(edema polmonare acuto).
Tosse secca – dove l’atto riflesso non si accompagna ad espettorazione dovuta a inalazione di polveri,penetrazione di corpi estranei,laringite,stenosi mitralica,neoplasia della laringe, pleurite,pericardite.
Tosse inane – dovuto ad una tosse senza escreato a cause dell’estrema debolezza dei muscoli espiratori(cachessia, miopatia,neuropatia).

11. DISPNEA – esprime una condizione di difficoltà respiratoria i cui elemento soggettivo è la fame d’aria. La respirazione è regolata dal centro respiratorio bulbare e comprende una fase inspiratoria attiva con contrazione del diaframma e muscoli intercostali che espandono il polmone ed una fase espiratoria passiva dovuto alla elasticità della gabbia toracica.
12. SOSPIRO – è una lenta, prolungata e profonda inspirazione accompagnata da un restringimento delle corde vocali.
13. CARDIOPALMO – è la sensazione subiettiva del battito cardiaco. L’arteriopalmo è la sensazione del battito di determinate arterie(carotidi e aorta addominale) dovuto ad un aumento della pressione arteriosa differenziale. Il cardiopalmo è dovuto a tachicardia (ipertiroidismi, feocromocitoma,tachicardie parossistiche),aumento della gittata sistolica(insufficienza aortica), ipertrofia cardiaca(del ventricolo sn da insufficienza mitralica, ipertensione o del ventricolo dx da cardiopatie congenite).
14. DOLORE – è una sgradevole e complessa sensazione che origina per una stimolazione chimica o fisica di recettori specifici o per un'irritazione delle vie o dei centri deputati alla sensibilità dolorifica. I recettori del dolore sono distribuiti con densità variabile nelle zone algogene,cioè nei distretti del corpo dotati di sensibilità dolorosa. Gli impulsi dolorifici attraverso le fibre sensitive raggiungono i gangli radicolari poi va nelle corna posteriori del midollo dove si incrociano e con il fascio spino-talamico vanno al talamo e alla fine alla corteccia fronto-parietale.
Dolori a topografia tronculare – è dovuto a situazione algogene che interessano un tronco nervoso periferico e la zona superficiale dolente non coincide con un dermatomero ma con il territorio corrispondente al nervo colpito (nevralgie dove è possibile dimostrare la dolorabilità alla pressione dei punti di emergenza del tronco nervoso- punti di Valleix). La causalgia è una sindrome dolorosa che si manifesta dopo lesione traumatica di un nervo.
Dolori a topografia radicolare – è dovuto a situazioni algogene che interessano 1 o più radici spinali posteriori(nevralgia sciatica dovuto a compressione della radice spinale per una ernia discale ,+ alla manovra di Lasegue- flessione degli arti inferiori estesi sul tronco eseguita su paziente supino)
Dolore talamico – dopo un ictus cerebrale si può manifestare un dolore spontaneo alla metà controlaterale del corpo in associazione a coreo-atetosi post emiplegica.
Dolore degli arti – possono essere di origine ossea se il processo morboso interessa il periostio(periostiti, osteomi,malattia di Paget),di origine articolare(pioartro,artriti acute,osteoartrosi),di origine muscolare(miositi,fibrositi),di origine vascolare(occlusioni arteriose acute di un arto,varici profonde,tromboflebiti).
Dolore toracico – può essere un dolore parietale come nelle nevralgie intercostali, fratture costali,sindrome di Tietze(tumefazione di alcune articolazioni condrocostali) e i dolori dorsali da osteoporosi,osteomalacia ecc. Ma può essere anche un dolore viscerale come il dolore tracheo-bronchiale(bruciore retrosternale nella tracheobronchite acuta),il dolore pleurico che è di tipo puntorio- dolore epicritico,si accentua con gli atti respiratorie con la tosse e come dolore riferito viene percepito in sede sottomammaria e nei dermatomeri C4-C5 e T8-T11(pleura diaframmatica).Il dolore cardiaco di tipo radicolare si manifesta in caso di pericarditi, miocarditi,angina,infarto del miocardio,è percepito nella regione precordiale e si irradia alla spalla sn,alle parti mediali del braccio,dell’avambraccio e mano sn,alla regione laterale del collo ma anche all’epigastrio.
Dolore addominale – può essere evocato da un'anomala distensione dei visceri cavi,da stiramento dei meso,da irritazione del peritoneo parietale. Può essere un dolore di origine peritoneale che si presenta in zone epicritiche al di sopra del viscere dolente e in una zona di elezione all’epigastrio.(appendicite acuta-dolore nella fossa iliaca dx);di origine gastrica e intestinale come nella ulcera peptica(dolore epigastrico dopo 1-2h i pasti,invece nell’ulcera

duodenale il dolore viene prima dei pasti) e la pirosi(bruciore all’estremità inf. dello sterno dovuto a rigurgito gastroesofageo);di origine epato-biliare dove il dolore da distensione del fegato(fegato da stasi) e della colecisti(idrope) si avverte nell’ipocondrio dx e spalla dx(C4-C5),invece la colica biliare esordisce dopo i pasti nell’ipocondrio dx e metà dell’epigastrio e si irradia lungo la base dell’emitorace;di origine splenica da distensione della milza(splenomegalia) e si avverte nell’ipocondrio sn;di origine renale dove nella colica renale il dolore è avvertito nella loggia renale e si irradia in avanti e in basso verso la regione inguinale. La colica si associa a nausea,vomito,bradicardia,stranguria e disuria;di origine genitale(coito,priapismo,ejaculaione dolorosa).
15. CEFALEA – o mal di testa è dovuta a differenti modalità di interessamento delle strutture algogene del capo.
Cefalee di origine pericranica – stimolazione di strutture all’esterno del cranio. Cefalee rinogene – dovuta a sinusite acuta e cronica. Cefalee oculari – dovuto a glaucoma,vizi di rifrazione,cheratite erpetica. Cefalee nevralgiche – nevralgia trigeminale idiopatica o dopo herpes zoster. Cefalee di origine articolare – nella sindrome di Costen dovuta a disfunzione
dell’articolazione temporo-mandibolare. Cefalee di origine cranica – iperostosi frontale interna, mielosa. Cefalee di origine vascolare – cefalea di Horton nella arterite a cellule giganti. Cefalee di origine muscolo-tensiva – cefalea da tensione. Cefalee da origine endocranica – dovuta a ipertensione endocranica(meningiti,ematomi,
idrocefalo),ipotensione endocranica(post rachicentesi) e da malattie cerebrovascolari (ipertensione,feocromocitoma).
16. EMICRANIA – dolore localizzato nella metà dx o sn del capo e si distingue in : Emicrania vasomotoria – esordisce dopo la pubertà,di più nelle femmine ed è composta da
2 tappe una crisi preceduta da un’aura e la crisi di emicrania dovuta a vasodilatazione cerebrale.
Emicrania istaminica – si manifesta a crisi ricorrenti ed è scataneta dall’alcol,istamina. Emicrania allergica
CAPITOLO 3 ESAME OBIETTIVO GENERALE
1. TEMPERATURA – L’uomo appartiene agli omeotermi e presenta in condizioni normali una temperatura corporea che oscilla sui 37º C ed è regolata dai centri ipotalamici termoregolatori i quali di fronte a una variazione ipertermica rispondono con vasodilatazione cutanea e sudorazione,tachipnea e tachicardia,invece in caso di variazione ipotermica avremo una vasocostrizione cutanea,aumento dei processi metabolici e intensa attività muscolare involontaria(brividi). La temperatura corporea è misurata con il termometro clinico e la temp. ascellare e inguinale oscillano fra i 36º C e i 37º C,invece la temp. rettale e orale sono 0.3-0.5º C più alte. Si parla di febbre quando la temp. ascellare supera i 37º C e di iperpiressia se superano i 40º C. Il monitoraggio della temperatura corporea può essere visualizzato nel tempo graficamente attraverso la curva termica. A

seconda dell'andamento di quest'ultima si identificano diverse tipologie di febbre che sono più frequentemente legate a determinati quadri patologici.
Febbre remittente - quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura si abbassa senza raggiungere valori normali come nelle infezioni batteriche e virali.
Febbre intermittente - quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura torna su valori normali come nella sepsi,ascessi,peritonite,infezioni batteriche (tipica
della malaria terziana) Febbre continua - quando la temperatura si mantiene costantemente al di sopra
della norma con oscillazioni non superiori a 0.5° come nella sesta malattia,tifo.Ci sono degli sottotipi ai fini diagnostici come la febbre ricorrente(periodi di febbre continua di 3-4 giorni che si alternano a intervalli di apiressia-spirochetosi);febbre intermittente biquotidiana(leshmanie,gonococco),terziaria(p.vivax),quaternaria(p.malaria),quintana(ricketsie); febbre ondulante(fasi di incremento e decremento della temp. Iperpiressia con apiressia- brucellosi,tifo,linfoma di Hodgkin). La risoluzione della febbre può avvenire per crisi cioè brusca caduta con sudorazione profusa o per lisi cioè lenta e progressiva diminuzione. I sintomi che accompagnano la febbre sono il brivido,la sudorazione,tachicardia(10 pulsazioni per ogni grado). La febbricola è una febbre intermittente che non supera i 37.5-37.8º C e può essere conseguenza di lesioni tubercolari,adenomesenterite, focolai settici tonsillari ecc.
2. FACIES – in condizioni normali la facies dà utili precisazioni sulla costituzione individuale, su determinate tendenze e sul carattere. La facies composita è quella di una persona in perfetto equilibrio fisico e mentale. Le modificazioni della facies comprendono: 1-Facies acondroplasica – sproporzione fra il capo ed il volto con fronte sporgente e convessa e radice del naso infossata.
2-Facies acromegalica – dovuta all’anormale accrescimento delle ossa facciali come mandibola con diradamento dei denti,naso grosso e tozzo e labbra tumide.
F.ACROMEGALICA 3-Facies adenoidea – con coane nasali ristrette e labbro superiore sporgente.
4-Facies leonina – quando il morbo di Paget interessa la volta cranica che diventa grande,la faccia assume un profilo triangolare.

5-Facies ippocratica – dovuta a disidratazione estrema(peritoniti),è caratterizzata da occhi cerchiati ed incavati,labbra aride,naso affilato6-Facies nefritica – imbibizione edematosa del volto,di più nelle palpebre.7-Facies mixedematosa – tumefazione del volto che porta all’infossamento dei bulbi oculari.8-Facies lunaris – nel morbo di Cushing con volto rotondeggiante e colore
rosso-cianotico F.CUSHINGOIDE9-Facies sclerodermia – volto levigato amimico,senza rughe e ristringimento della rima labiale.Tutte sono facce dovuto ad alterazioni: scheletriche(2),neuro-muscolari(9,miastenia,tetanica),oculari(f.basedowiana),dei tessuti superficiali ( 5,7,8),del colorito della cute(f. mitralica).
F.BASEDOWIANA
3. DECUBITO – si intende la posizione che il paziente assume nel letto. Il decubito indifferente è quello di una persona normale che ne letto assume qualsiasi posizione,il decubito preferito è quello che il malato preferisce perché ne trae sollievo e il decubito obbligato è quello che il malato deve mantenere per non avere dolore come il decubito supino obbligato in caso di situazioni dolorose vertebrali(fratture,ernia discale) e processi infiammatori acuti peritoneali;il

decubito laterale preferito in caso di pleurite e ascessi polmonari;il decubito ortopnoico in caso di insufficienza congestizia sn a causa della dispnea dove il paziente si mette seduto per evitare la dispnea;la posizione di Blechman con ginocchia flesse e tronco piegato con pericardite essudativa;l’accovacciamento(squatting)che da segno di patologia cianotica ( accorciamento per ridurre la superficie corporea) nella tetralogia di Fallot;la posizione a cana di fucile in caso di meningite(gambe e coscia flesse) è un decubito laterale obbligato. L’opistotono, l’ortotono, l’emprostotono e il pleurostotono sono atteggiamenti obbligati di origine muscolare dove il paziente si presenta rigido con concavità dorsale,ventrale,laterale. L'astasia è la impossibilità di mantenere la stazione eretta(paralitica,cerebellare,extrapiramidale). La disbasia è una deambulazione anormale dovuto ad alterazioni degli organi di movimento ,da alterata regolazione. Nervosa e muscolare e
dovuto da a cause psichiche. OPISTOTONO
SQUATTING 4. PSICHE E SENSORIO – la coscienza è vigile quando le relazioni della vita di relazione sono conservate,è obnubilata quando i processi mentali sono lenti e confusi ed è perduta quando si realizza l’arresto globale di tutte le funzioni della vita di relazione. La lipotimia è un improvviso malessere associato a pallore,sudorazione fredda,ipoacusia(diminuizione mono o bilaterale della capacità uditiva) ed acufeni(suono o rumore che origina al di fuori dell’app.uditivo,soggettiva perché è udibile solo dal sogetto). La sincope è un'improvvisa perdita di coscienza di breve durata e che comprendono sincopi ipossiche(vasodepressive, cardiogene),ipoglicemiche,epilettiche ed isteriche. Il coma è una prolungata perdita della coscienza. 5. STATO DI NUTRIZIONE – La valutazione dello stato di nutrizione deve considerare molti aspetti come il peso rapportato alla statura,lo sviluppo del pannicolo adiposo sottocutaneo e lo sviluppo delle masse muscolari( 50% del peso nei maschi e 36% nelle femmine). Calcolo del peso ideale : 1 . Maschi - 48 Kg per i primi 150 cm + 2,7 Kg ogni 2,5 cm in più 2 . Femmine - 45 Kg per i primi 150 cm + 2,3 Kg ogni 2,5 cm in più.L’indice di massa corporea (IMC) è la misura del grasso corporeo in base al peso e all’altezza. Si applica ad entrambi i sessi. IMC = Peso corporeo in kg/altezza in m², cosi in base dell’IMC si possono distinguere i pazienti in sottopeso(< 18.5),normopeso(18.5 – 24.9),soprappeso(25 -29.9), obesità(30 – 40),grande obesità (> 40). Le alterazioni del peso comprendono:
Obesità – è un eccesso ponderale da accumulo di adipe, rispetto ai valori fisiologici correlati ai valori individuali e si può distinguere una obesità androide (collo, spalle, tronco),ginoide (fianchi, cosce, addome, mammelle) o mista ed è dovuta a varie cause, nell’obesità essenziale(la più comune) è determinata da esaltata funzione dei centri dell’appetito (iperoressia), nella sindrome di Cushing o a lesioni congenite o acquisite del sistema ipotalamo-ipofisario (distrofia adiposo-genitale, craniofaringiomi, adenoma ipofisario ecc.).
Magrezza – è un deficit ponderale da riduzione dei depositi adiposi e delle masse muscolari, che può giungere fino alla cachessia causata da magrezza costituzionale (condizione di alcuni individui sotto il peso fisiologico, ma sono in salute),ridotto

senso di fame (anoressia psichica, lesioni encefaliche),carenze alimentari che possono essere primarie(protratto deficit alimentare) o secondarie(sindromi da malassorbimento, da maldigestione),turbe endocrine(tireotossicosi, diabete scompensato).malattie consuntive(neoplasie, tbc, aterosclerosi generalizzata, cirrosi avanzata, malattie croniche).
CARATTERISTICHE DELLA CUTE
a—COLORITO :può essere espressione dello stato di sanguinamento(quantità e qualità del sangue circolante nei capillari superficiali.e le alterazioni possono essere distrettuali o generalizzati :
PALLORE: presente in tt gli stati anemici,si accompagna con colorazione delle mucose visibili(colorito giallognolo ecc).e c’è anche colorito pallido senza interessamento delle mucose per:pallore emotivo,freddo.ROSSO : causato da aumento deiR e e di Hb per vasodilatazione transitoria(emozione,caldo) o
permanente(alcolismo) POLIGLOBULIA
CIANOSI : colore violaceo della cute per Hb ridotta o Hb non ossidate > 5 gr/dl (valore normale fino a 2.5)nel sangue capillare.(NB.la cianosi si manifesta in base alla Hb ridotta per cui mentre nelle poliglobulie la soglia per raggiungerla è bassa,nelle anemie severe la cianosi potrebbe non manifestarsi per Hb ridotta non raggiunta la soglia.) Si verifica per difetto di ossigenazione(insuff.cardiaca o resp.)o per mescolanza di sangue arterioso e venoso(difetti cardiaci congeniti) In base alle cause si dividono in :C.CENTRALE : ridotta saturazione di ossigeno con estremità calde che si suddividono in :
1-CARDIACHE-malformazioni cardiache che determinano shunt dx-->sx : sangue venoso in circolo.(mano piedi volto)2-POLMONARI-condizioni che non permettono una normale ossigenazione del sangue negli alveoli polmonari(es riduzione di O2 inspirata ,patologie ostruttive delle alte e basse vie.)
PERIFERICHE –ovvero da rallentamento del circolo periferico con aumentata estrazione dei tessuti di O2,es.scompenso cardiaco dx.
In base alla distribuzione si distinguono in:
GENERALIZZATE-se tt il sangue contiene elevata quantità di Hb ridotta. Puo dipendereda una ridotta capacitò di Hb di legare O2( es.poliglobulia,metaemodlobinemia : quando nella molecola di

Hb il Fe è ossidato da Fe² a Fe³ si ossida e perde la sua funzione di legare reversibilmente l’O2 e perde anche la funzione del trasporto dell’O2.
DISTRETTUALI-da stasi del sangue generalmente del sistema venoso(ES.COMPRESSIONE,TROMBOSI)NB. associata ad altri segni come edema,alterazionE
della temp.cutanea,dolore ecc . C.LOCALIZZATA
E dalla pigmentazione : IPOPIGMENTAZIONE es albinismo(diffusa),vitiligine(a chiazze)o IPERPIGMENTAZIONE :melaninica(colorito nerastro della cute per abnorme deposizione di melanina es.nel morbo di Adison : ipocorticosurrenalismo )o da deposito di sostanze( ecchimosi : da stravasi di sangue, emocromatosi : da accumulo di emosiderina, ittero : accumulo di bilirubina)
M. di Adison Albinismo
VitiligineITTERO (fai dalle slight)b-STATO DI UMIDITà e TURGORE , SOLLEVABILITà IN PLICHE—lo stato ditono di elasticità della cute si apprezza sollevando la cute in piccole pliche.

Variazioni patologiche: IPERTROFIA-(callosità, elefantiasi,mixedema)ATROFIA (strie cutanee o smagliature)SCLEROSI(indurimento o anelasticità cm nella sclerodermia)
c-lesioni della cute PRIMITIVE-(costituiscono la manifestazione iniziale di un’effetto morboso: eritema macula, pupula ,ponfo bolla,flittene ,nodulo,vescica,squama,SECONDARIE-(conseguenza di un processo morboso):erosione , ragade,ulcera,piaga,cicatrice,gaangrena.
Eritema Papula Squama ulcerad-stato delle appendici cutanee
Sist.PILIFERO—valutazione della rappresentazione(ipertricosi,alopecia)e della distribuzione(androide,ginoide)Unghie—possibili alterazione per tube vescicolari o nervose(unghie a vetrino di orologio o a bacchetta di tamburo) 6. EDEMI – L’edema è un anormale accumulo di acqua negli spazi interstiziali,invece l’anasarca èun edema generalizzato con versamento trasudatizio nelle grandi cavità sierose(pleure, pericardio).
Edema generalizzato – l’accumulo di liquido sarà più notevole a livello del sottocute. La distribuzione non è uniforme ma sarà più evidente nei tessuti con distensibilità maggiore(palpebre) e dove opera di più la forza di gravità(arti inferiori) Esercitando con il dito una pressione sulle zone edematose si lascia un impronte la fovea. Le cause che portano a edema sono diverse come ostacolo allo scarico del cuore dx(pericarditi croniche),scompenso cardiaco congestizia,alterazione del bilancio dei liquidi con maggior ritenzione idrosalina(sindrome nefrosica) e abbassamento della pressione oncotica (proteinuria per danno renale,mancata sintesi per danno epatico). Edema distrettuale – gli edemi distrettuali da stasi venosa decorrono con dilatazione venosa e cianosi. Possiamo avere edema a uno dei 4 arti per occlusione trombotica della vena principale di scarico;edema a mantellina che interessa gli arti superiori,il volto ed è dovuto a difficoltà di scarica della vena cava superiore nell’atrio dx;edema alla metà inferiore del corpo con epatomegalia e ascite dovuto a un ostacolo alla vena cava inferiore;edema di Quincke che interessa il volto dovuto a difetto congenito dell’inibitore del complemento(angioedema ereditario). Linfedema – è un edema duro per proliferazione connettivale reattiva del tessuto sottocutaneo. Mixedema – è un'infiltrazione liquida dei tessuti contenente mucoproteine in elevata percentuale ed è dovuto a una grave insufficienza funzionale della tiroid
7. SISTEMA NERVOSO – L’organizzazione del sistema nervoso è fondata su 4 elementi che sono il

Neurone motore centrale (I neurone) Neurone motore periferico (II neurone) Sistema extrapiramidale Sistema cerebellare
I disturbi deficitari della motilità volontaria prendono il nome di ipocinesie e paresi o paralisi a seconda della gravità. Nella paresi il movimento volontario e’ del tutto abolito.
Paresi centrali – sono paresi spastiche e in loro il deficit della motilità volontaria si associa ad un aumento del tono dei muscoli colpiti ed una mancanza di grave compromissione del loro trofismo.
Paresi periferiche – sono paresi flaccide e in loro il deficit della motilità volontaria si associa a perdita del tono dei muscoli colpiti e a grave compromissione del loro trofismo.
I riflessi sono rappresentati da contrazione muscolare involontaria provocata dalla stimolazione di una determinata struttura sensitiva. L’alterazione è una spia preziosa per pensare ad una lesione del neurone motore centrale (esaltamento) o periferico (diminuzione-assenza). Si dividono in riflessi:
Propriocettivi (tendinei) - monosimpatici con un proprio centro spinale, vengono eccitati dalla percussione con un martelletto sul tendine di un muscolo.
Esterocettivi (superficiali) - polisimpatici, vengono eccitati da una stimolazione della cute con una punta smussa (riflessi addominali, cremasterico) della mucosa pezzetto di cotone (riflesso corneale),interruzione arco diastalico: areflessia
La paralisi è un'interruzione o distruzione delle vie di moto in qualsiasi punto del loro percorso o in qualunque loro struttura. Hanno caratteri diversi a seconda che la via di moto interrotta sia il I neurone (piramidale), II neurone (periferico). L’interruzione del primo neurone centrale provoca perdita dei movimenti volontari degli arti controlaterali alla lesione cerebrale;aumento del tono muscolare (paralisi spastica);esaltazione dei riflessi propriocettivi stesso lato paralisi (trofismo dei muscoli conservato);positività al segno di Babinski (estensione dorsale lenta dell’alluce allo strisciamento di una punta smussa all’esterno della pianta del piede). L’interruzione del neurone periferico provoca:paralisi omolaterale;perdita del tono muscolare (paralisi flaccida);deficit del trofismo (muscoli atrofici); abolizione dei riflessi propriocettivi. Per esempio la paralisi del ІІІ paio dei nervi cranici(oculomotore) darà una ptosi palpebrale e strabismo divergente(gli unici movimenti consentiti all’occhio sono quelli di rotazione esterna ad opera del nervo abducente e parziale rotazione verso l’alto ad opera del nervo patetico);paralisi del nervo abducente(VIII paio) provoca strabismo convergente(impossibilità di ruotare il bulbo oculare verso l’esterno) e diplopia;paralisi del nervo ipoglosso (XII paio) provoca paralisi della metà omolaterale della lingua con evidente atrofia ed eventuali movimenti fibrillari,la lingua se sporta viene deviata verso il lato malato per il prevalere del muscolo genioglosso del lato sano.La paresi è una lesione del motoneurone centrale non grave da provocare paralisi e il deficit piramidale è evidenziato con prove di Mingazzini per gli arti superiori e inferiori(arti superiori estesi -in caso di deficit piramidale si osserva graduale abbassamento arto paretico;arti inferiori sollevati discosti,flessi e paralleli in caso di deficit piramidale si osserva graduale abbassamento gamba paretica)e le due prove di Barrè per gli arti inferiori(paziente prono sul letto con le gambe flesse ad angolo retto sulle cosce. Dopo qualche secondo la gamba paretica si abbassa. Se il paziente è invitato a flettere con forza le gambe sulle cosce (Barrè II) l'iperflessione è possibile solo dal lato sano)Lesioni extrapiramidali - sono lesioni a carico di centri o vie extrapiramidali e comportano l'istituzione di caratteristiche manifestazioni motorie (corea, atetosi, ballismo, spasmi di torsione, tics, tremori) associate o meno ad alterazioni del tono muscolare.

Corea – sono contrazioni muscolari involontarie improvvise, rapide, disordinate, senza scopo, variabili, che determinano movimenti a grande raggio degli arti, contorsioni del tronco e improvvise smorfie con rotazione dei globi oculari.
Atetosi – sono lenti, tentacolari ed interessano prevalentemente le estremità distali, pur potendosi estendere a tutto l’arto ed al tronco,si manifestano su uno sfondo di ipertonia muscolare in cerebropatie spastiche.
Ballismo – sono ampi, squassanti, spesso localizzati ad un emisoma (emiballismo) sono correlati ad alterazioni organiche del corpo di Luys.
Spasmi – movimenti involontari lenti, energici e persistenti di un gruppo di muscoli,che comportano una fissazione del segmento interessato in determinata posizione.
Tics – movimenti improvvisi, involontari, passibili di inibizione volontaria sia pure con sforzo e riproducono un movimento stereotipato.
Tremore - Il tremore statico a piccole scosse(emozioni,feocromocitoma, ipertiroidismo) che non riconosce una causa extrapiramidale e il tremore statico a grandi scosse, tipico nel morbo di Parkinson,è di origine extrapiramidale,presente a riposo, cessa con il sonno, interessa gli arti superiori ed il capo.
Lesioni cerebellari – sono lesioni a livello del cervelletto come l'atassia che è un disturbo per il quale un determinato atto motorio si realizza senza l’armonia e la precisione fisiologica. Possiamo avere un'atassia spinale che è un atassia tabetica dovuta a un difetto di informazioni propriocettive da recettori osteotendinei ed una atassia cerebellare dovuta ad un difetto di coordinazione muscolare da parte del cervelletto. Per indicare se l’atassia e spinale o cerebellare si fa la prova di Romberg(stazione eretta a occhi aperti e poi a occhi chiusi,se l’atassia è spinale il paziente cadrà a terra).
ESAME OBIETTIVO DEL TORACE
1. RESPIRO – La funzione respiratoria ha lo scopo di far giungere alle cellule l’O2 necessario e di allontanare la CO2 e comprende una fase polmonare,una fase ematica e una tissutale. L’atto del respiro è composto di due fasi la inspirazione sostenuta dalla contrazione dei muscoli intercostali e del diaframma,è una fase attiva;la espirazione che è un atto passivo dovuto alla elasticità del polmone. A riposo gli atti respiratori(frequenza) sono 16-20/min. La bradipnea è dovuta a encefalopatia ipertensiva,meningite e in alcune intossicazioni esogene,invece la tachipnea può essere correlata a fatica,stati emozionali,ipersecrezione di catecolamine,dolore,ipertiroidismo.
2. DISPNEA – è una spiacevole sensazione subiettiva di difficoltà nella respirazione,cosi nella dispnea inspiratoria che richiede l’azione di muscoli ausiliari del respirazione;la dispnea espiratoria che richiede l’azione dei muscoli intercostali interni;dispnea mista dovuta a cause polmonari e cardiache;dispnea da sforzo e la dispnea a riposo. La dispnea può essere provocata da diverse cause come da :
Alterazioni dell’aria atmosferica – che si osserva in alta montagna dovuta a diminuzione della pressione parziale di O2 ed è accompagnata da tachipnea e poliglobulia. Alterazioni del centro respiratorio – dovuto ad un'anormale sollecitazione meccanica(traumi cranici) o chimica(ipercapnia,ipossia).

Di origine muscolare – osservata nella miastenia e nelle miopatie croniche. Alterazioni dell’apparato respiratorio – dovuta ad un'insufficienza respiratoria di tipo ostruttivo(asma bronchiale,enfisema) o restrittivo(polmoniti,atelettasia). Alterazioni dell’apparato cardiovascolare – dovuta ad un'insufficienza cardiaca (insuf. del ventricolo sn) dove il cuore sn non è in grado di emettere il sangue che giunge attraverso le vene polmonari.
SEMEIOTICA FISICA DEL TORACE
1. ISPEZIONE – Il torace è delimitato in alto dalla linea cervico-toracica(dal giugulo all’apofisi spinosa della VII cervicale passando sopra la clavicola),in basso dalla linea toraco-addominale(dall’appendice xifoide seguendo il perimetro della gabbia toracica fino all’apofisi spinosa della XII vertebra dorsale)e lateralmente dalle due linee omo-brachiali. Per indicare con precisione un punto qualsiasi sul torace sono state immaginate delle linee di repere verticali e orizzontali.
Fig1-Linee ascellari anteriore(4),media(5) Fig2-Linea angolo scapolare(7) e linea spondiloidea(8) e posteriore(6)Per l'identificazione degli spazi intercostali si trova l’angolo di Luis formato dall’unione del manubrio con il corpo dello sterno e si inserisce la II costa,cosi identifichiamo lo II spazio intercostale e si procede verso il basso contando gli altri spazi intercostale. Posteriormente possiamo trovare l’apofisi della VII vertebra cervicale(vertebra prominente).Rientrano nei limiti della norma il torace allungato(maggior evidenza delle fossette di Morheinham e scapola alata);torace picnico(prevalenza del diametro trasversale sul quello longitudinale);torace atletico(è ampio).

Fig3-Linea mediosternale(1),parasternale(2)e emiclaveare(3)
Fig4-Visione posteriore. Le regioni Fig5– Visione anteriore. Le regioni
Nella ispezione possiamo osservare diverse alterazioni della:
Reg. sottoclaveare
Reg. mammaria
Reg. ipocondriaca

Morfologia della gabbia toracica – dove le più importanti sono caratterizzate da deviazioni del rachide, soprattutto in senso latero-laterale(scoliosi),in senso anteriore(lordosi) e posteriore(cifosi),patologia dello sterno(pectus excavatum- torace imbutiforme).
Alterazioni della dinamica respiratoria – che comprendono dilatazioni toraciche come asimmetria della dinamica respiratoria per processi patologici pleuro-parenchimali monolaterali(versamento pleurico,pneumotorace spontaneo,enfisema);retrazioni toracica(toracoplastica,pneumonectomia,fibrotorace);ectasie venose toraciche;edemi toracici circoscritti(edema a mantellina nelle sindromi mediastiniche)
2. PALPAZIONE – si palpa il torace e si apprezza : Temperatura Eventuale presenza di enfisema sottocutaneo – si può apprezzare una sensazione di
crepititio(di neve asciutta) dovuto a traumi(ferite,fratture costali). Punti dolorosi – come i punti di Valleix e i punti frenici. Espansibilità – si valuta poggiando le mani a piatto sulle regioni sovraclaveari con i pollici
nelle linee paravertebrali e un emitorace può espandersi con ritardo rispetto al controlaterale (respiro obliquo) o può espandersi meno(respiro asimmetrico).
Fremito vocale tattile – è quella sensazione vibratoria che si apprezza sulla parete toracica ed è dovuto alle vibrazioni delle corde vocali che si trasmettono agli alveoli polmonari.
Fig6 – 1. fvt normale;2. diminuzione fvt per infezione laringea;3.dim fvt per enfisema;4.aum per addensamento polmonare;5. abolizione fvt per occlusione bronchiale;6. abolizione fvt per versamento pleurico.

3. PERCUSSIONE – il suono chiaro polmonare è il rumore evocato con la percussione di un torace normale,l’intensità del suono è correlata all’ampiezza delle vibrazioni. Si parla di suono ipofonetico od ottuso quando è ridotta l'ampiezza delle vibrazioni e si parla di suono di suono iperfonetico quando l’ampiezza è superiore,invece il suono timpanico(suono musicale che si ottiene percuotendo lo stomaco o l’intestino) si sente solo in alcuni casi come pneumotorace o caverne. La percussione può essere immediata che é esercitata senza interposizione di un dito che funga da plessimetro e viene utilizzata sulla clavicola(alterazioni degli apici polmonari) e sul torace,invece la percussione mediata è digito-digitale e può essere una percussione topografica superficiale(delimitare i confini) o profonda(cambiamenti di struttura).
Il margine anteriore del polmone dx si dirige in basso,raggiunge la linea mediosternale e continua
Fig7 – Campi di Kronig che si delimitano procedendo con la percussione medialmente e il suono chiaro polmonare ci dice se l’apice è aerato in modo normale.
Fig8 – Decorso dei margini polmonari

fino alla quarta costa,il margine anteriore del polmone sn all’altezza della quarta costa si portalateralmente e descrive un ampia curva(l’incisura cardiaca). Lo spostamento verso dx o sn dei margini polmonari anteriori si può avere per masse mediastiniche,versamento pleurico,atelettasia se avviene da un solo lato l’aumento delle dimensioni del cuore è la causa principale. I margini posteriori seguono un decorso rettilineo lungo la linea parasternale fino all’XI costa. Lo spostamento verso l’alto dei campi polmonari inferiori si ha nei versamenti pleurici, fibrosi polmonare, innalzamento del diaframma. Lo spostamento verso il basso dei campi polmonari è tipico dell’enfisema polmonare. Tale segno si accompagna una riduzione, fino alla scomparsa dell’aia di ottusità assoluta del cuore. È possibile, con la percussione evidenziare l’escursione dei margini polmonari tra massima espirazione e massima inspirazione. L’enfisema è causa di ipomobilità dei margini polmonari così come l’aumento di volume del contenuto addominale, le lesioni del nervo frenico e i versamenti pleurici. Nell’emitorace sinistro, anteriormente, si trova l’area di Traube che è una zona di timpanismo(che segna a dx il confine gastro-epatico,gastro-cardiaco,in alto il confine gastro- polmonare, a sn il confine gastro-splenico e in basso il confine
gastro-colico). La scomparsa dell’area di Traube è causata da aumento delle dimensioni del cuore, della milza e del lobo sinistro del fegato o per versamento pleurico sinistro. Le principali cause che portano a iperfonesi cioè cambiamento del suono chiaro polmonare sono il pneumotorace, l’enfisema polmonare e le grandi caverne,invece portano ad ipofonesi e ottusità(l’ottusità può essere apicale,basilare o lobare)i versamenti e ispessimenti pleurici,atelettasia polmonare,gli addensamenti polmonari(polmoniti,edema) e l’infiltrazione da processi neoplastici.
Perché si realizzi la linea di Damoiseau-Ellis il versamento deve essere essudativa. Al di sopra della linea si realizza la distensione degli alveoli responsabile di un'iperfonesi timpanica detta skodismo.
4. AUSCULTAZIONE – Il suono si origina in due settori distinti producendo rumori caratteristici: il primo comprende il laringe,la trachea e i bronchi e dà origine al soffio bronchiale e il secondo comprende gli alveoli polmonari e dà origine alle murmure vescicolare. I due fenomeni coesistono,ma fisiologicamente si riesce ad apprezzare solo il murmure vescicolare(mv). Alterazioni del MV si può avere per :difficile trasmissione per abbondante tessuto
Fig9. 1. Linea di Damoiseau-Ellis (limite superiore del versamento).2. Triangolo di Grocco (sub-ottusità dovuta allo spostamento del mediastino).3 .Triangolo di Garland (iperfonesi da enfisema relativo)
No fvt,ipofonesi e murmure vescicolare assente

adiposo(obesi);ostacoli alla espansione della gabbia toracica(malattie nervose e muscolari);diminuzione della distensibilità del parenchima polmonare. La presenza del soffio bronchiale attesta che il passaggio dell’aria attraverso i bronchi è conservata,mentre è abolita la ventilazione alveolare e questo può essere dovuto a polmonite,tubercolosi,caverne,versamenti pleurici e pneumotorace(in caso di collasso polmonare totale avremo il silenzio polmonare).
Fig10 – Punti di esplorazione con il fonendoscopio
Fig11 – 1. Normale(il soffio bronchiale è coperto dal rumore del dispiegamento alveolare: M.V.). 2. Soffio bronchiale in caso di polmonite (l’alveolo non si dispiega e si ascolta il soffio bronchiale). 3. Soffio bronchiale attenuato in caso di pleurite (l’alveolo non si distende e il soffio giunge attenuato dallo spessore del liquido)

Oltre il soffio bronchiale esistono altri tipi di rumori bronchiali che possono essere secchi come i ronchi(rumore profondo a bassa frequenza- caratteristico dei bronchiti),i sibili(rumore sibilante prolungata -caratteristico asma bronchiale),fischi; e umidi come i rantoli a grandi,medie,piccole bolle(polmoniti) e i crepiti(rantoli crepitanti tipici delle fasi iniziali e di risoluzione delle polmoniti); rumori pleurici(sfregamenti da pleuriti con scarso essudato, in genere TBC) . A volte sincroni con il polso in caso di pericarditi consensuali (sfregamenti pleuro-pericardici) .
ESAME OBIETTIVO DEL CUORE
1. ISPEZIONE – Il cuore occupa la parte mediana della cavità toracica,ha la forma di un cono appiattito in senso antero-posteriore. Si possono distinguere una faccia anteriore – superiore(sterno –costale)formata da vena cava superiore,aorta e atrio,ventricolo dx. e una faccia posteriore –inferiore (diaframmatica). La regione precordiale è quella zona della parete toracica anteriore che corrisponde alla proiezione del cuore e dei grossi vasi e in condizioni normali si può apprezzare solo l’itto della punta che è il ritmico sollevamento che si osserva al V spazio intercostale sn lungo la linea emiclaveare che interessa una superficie di circa 2 cm² che avviene durante la sistole dei ventricoli. L’itto della punta può fornire la segnalazione di alcune variazioni della frequenza cardiaca(tachicardie parossistiche);se non è visibile può essere indice di versamento pericardio,enfisema polmonare,miocarditi e infarto,invece è più evidente nella insufficienza mitralica,nei vizi aortici e nella ipertensione arteriosa(tutte portano a ipertrofia ventricolare sn). Oltre all’itto della punta si possono osservare altre pulsazioni come una pulsazione epigastrica in caso di ipertrofia ventricolare dx o un rientramento sistolico alla punta dovuta a mediastino pericarditi.2. PALPAZIONE – si palpa con il paziente supino o in decubito laterale.
3. PERCUSSIONE – nella percussione del cuore si distinguono un’aia di ottusità relativa che ci informa sulle dimensioni dell’organo cominciando dall’itto della punta,si fa la delimitazione del margine dx e si delimita la cupola epatica,l’angolo epato-cardiaco di Ebstein(che è retto ed acuto e diventa ottuso in caso di versamenti pericardici),poi il margine sn(II-V spazio). La presenza del margine cardiaco è segnalata dal cambiamento di suono da chiaro polmonare a sub-ottuso. Esiste pure un’aia di ottusità assoluta che corrisponde a quella zona del cuore non coperta dal margine
Fig12 – Palpazione dell’itto della punta

anteriore del polmone. Un ingrandimento dell’aia assoluta si osserva nei versamenti pericardici invece la scomparsa si vede nell’enfisema polmonare e nel pneumotorace sn.
Fig13 – Aia di ottusità cardiaca Fig14 – Misure normali
4. AUSCULTAZIONE – si fa a livello dei focolai clinici di auscultazione che non corrispondono con i focolai anatomici(eccetto quello polmonare).
(c’è anche il focolaio di Erb- III o IV spazio intercostale sulla parasternale sn dove si sentono meglio i
soffi da insufficienza cardiaca)
Fig15 – Focolai di auscultazione dove:A –Focolaio aortico sulla linea parasternale dx,II spazio intercostale P – Focolaio polmonare presso la linea parasternale sn,II spazio intercostale.T – Focolaio tricuspidale a livello del V spazio interc. in zona medio-sternale.M – Focolaio mitralico presso l’itto della punta.

I TONI CARDIACI – l’auscultazione del cuore offre a considerare per ogni battito la successione di due toni: I tono che precede di 0.1 s il battito del polso,ha intensità maggiore del II tono ed ha una durata di 0.08-0.15 s e il II tono che è più breve. La piccola pausa(silenzio sistolico) è l’intervallo di tempo tra I e II tono e corrisponde alla sistole,invece la grande pausa(silenzio diastolico) è l’intervallo tra II e I tono e corrisponde alla diastole.
Fig16 – Toni cardiaci
Le fasi della emodinamica del cuore comprende dopo lo svuotamento dei ventricoli,la pressione intraventricolare cade a zero e l’incremento della pressione atriale si determina l’apertura delle valvole atrioventricolari(mitrale e tricuspidale) e comincia cosi il riempimento rapido ventricolare che viene seguito dal riempimento lento e poi dalla contrazione atriale(presistole)il riempimento completo dei ventricoli e chiusura delle valvole atrioventricolari che segna l’inizio della contrazione ventricolare che fa aumentare la pressione intraventricolare che diventa più grande della pressione polmonare e aortica e ciò comporta l’apertura delle valvole semilunari. Alla fine della contrazione si ha la chiusura delle valvole e segue il rilasciamento diastolico. Il I tono corrisponde alla chiusura delle valvole atrioventricolari(prima componente principale) e dalla apertura delle valvole semilunari(seconda componente),invece il II tono corrisponde alla chiusura delle valvole semilunari (prima componente)e apertura delle valvole AV. La piccola pausa corrisponde alla sistole (contrazione ventricolare),la grande pausa alla diastole(rilasciamento e riempimento dei ventricoli). Avremo una diminuzione della intensità dei toni cardiaci in uguale misura I e II tono nel versamento pericardico,nell’enfisema polmonare e nella polisarcia(strato adiposo), ma anche una insufficienza miocardia determina una diminuzione dell’intensità dei toni dove il I tono diventa uguale al II e assumono un carattere sordo(parafonia). Ma se alla debolezza dei toni si associa una tachicardia che porta un'equidistanza dei toni possiamo ascoltare il ritmo pendolare o embriocardio. Un'accentuazione dei toni si può avere in soggetti magri e in caso di tachicardie,invece una accentuazione solo del I tono mitralico e si ha nei vizi della valvola mitralica e una accentuazione del II tono aortico si può avere per ipertensione arteriosa o sclerosi della valvola nei aortiti(segno di Allnari) e del II tono polmonare nell’ipertensione arteriosa polmonare(in tutti i casi si deve tener conto della presenza o non di protesi valvolari che producono toni di chiusura e apertura). Si parla di sdoppiamento,quando un tono è percepito come due componenti ben distinti,cosi lo sdoppiamento del I tono non è associato ad alterazioni cardiache anche se nei blocchi di branca è comune,invece lo sdoppiamento del II tono si apprezza

nell’ipertensione polmonare,vizi mitralici,cardiopatie congenite e blocco di branca dx. I ritmi di galoppo è un ritmo a tre tempi,cosi il III tono corrisponde al riempimento rapido dei ventricoli in protodiastole e un aumento di intensità corrisponde al galoppo ventricolare,invece il IV tono corrisponde alla presistole(contrazione atriale) e un aumento di intensità corrisponde al galoppo atriale. Il ritmo di treno è un ritmo a 4 tempi e tutti questi ritmi corrispondono a compromissione grave del miocardio ventricolare(miocarditi,infarto,ipertrofia del VS).
SOFFI CARDIACI – sono rumori patologici di elevata periodicità che si localizzano nella piccola pausa,grande pausa o entrambe. L’intensità dei soffi cardiaci è molto variabile(soffi dolci,aspri e forti). I soffi possono essere distinti in base alla loro intensità,una graduazione clinica proposta da Freeman e Levine(Grado I – molto lieve,non viene udito subito dopo adeguata concentrazione,può anche non essere udito;Grado II – viene generalmente udito;Grado III – viene sicuramente udito; Grado IV – moderatamente intenso e si associa ad un fremito;Grado V e VI – molto intenso). Del soffio cardiaco si deve precisare la cronologia(soffio olosistolico- occupa tutta la sistole;olodiastolico –occupa tutta la diastole;protosistolico e protodiastolico –occupa la prima parte mesosistolico e mesodiastolico –occupa la parte intermedia;telesistolico e telediastolico –occupa la parte terminale),il focolaio di elettivo ascolto(mitralici,tricuspidali,aortici e polmonari) e le linee di propagazione.
Fig17 – Altri tipi di rumori cardiaci1. Click di eiezione-si tratta di un rumore di alta frequenza,intensità sonora che vienemolto precocemente dopo il primo tono. E’ legato all’apertura brusca della valvola aortica stenotica.2. Schiocco d’apertura della mitrale:rumore diastolico udibile in corso distenosi mitralica, seguito da rullio.3.Clicks meso-sistolicipresenti in corso di prolasso della mitrale sono dovuti all’entrata in tensionedelle corde eccessivamente lunghe o insoprannumero. 4. Rumori delle valvole meccanichele biglie (non si impiantano più), i dischi ole alette delle valvole meccaniche produconodei rumori quando si aprono e
quando si chiudono

Fig19 – Tipi di soffi cardiaci
Fig18 – Zona di irradiazione

Soffi mitralici – possono essere soffi sistolici dovuti ad una insufficienza mitralica ed è un soffio olosistolico(può generare anche un fremito sistolico evidenziabile con la palpazione) che si propaga verso il focolaio polmonare e l’ascella sn;soffi diastolici dovuto a una stenosi mitralica che può essere olodiastolico o con rinforzi protodiastolico,ha le caratteristiche di un rullio presistolico,per accentuare il soffio basta fare la manovra di Azoulay(sollevamento passivo dei arti inferiori,si accentua per aumento del ritorno venoso), si apprezza il “claquement” di chiusura(rinforzo I tono) e di apertura della valvola mitralica; si può apprezzare anche il doppio soffio mitralico dovuto a un doppio vizio valvolare ma anche a dilatazione dell’atrio sn o ipertrofia del ventricolo sn. Soffi tricuspidali – possono essere sistolici dovuti a un'insufficienza tricuspidale (postumo di endocardite). Il rigurgito ventricolo-atriale determinerà un polso giugulare ed epatico,questo soffio può essere conseguenza anche di una ipertrofia del VD o AD;soffio diastolico per una stenosi più apprezzabile con la manovra di Carvalho(il paziente respira lentamente e profondamente e si fa l’auscultazione durante l’inspirazione). Soffi aortici – possono essere soffi sistolici dovuti a una stenosi aortica(soffio rude di V grado,palpabile con fremito sistolico e si propaga nei vasi del collo),stenosi sub-aortica e ectasia della aorta ascendente(soffio debole ma è seguito da un rinforzo del II tono- segno di Allbutt);i soffi diastolici dovuti ad insufficienza aortica e possono essere di caratteristiche diverse come il soffio di va e vieni(soffio sistolico rude e diastolico dolce,perché raramente si ascolta un soffio diastolico isolato);soffio a clessidra. Per la diagnosi di insufficienza aortica si deve vedere la sintomatologia dovuta al reflusso aorto-ventricolare(aumento della pressione arteriosa e polso celere –polso di Corrigan) e tutti i segni dovuti all’alterazione periferica(danza delle carotidi-segno di De Musset,polso capillare di Quincke,colpo di pistola,doppio soffio di Durosiez- nella arteria femorale e fenomeno di Hill e Flack –ipersfigmia degli arti inferiori). Soffi polmonari – possono essere sistolici dovuto a stenosi polmonare(dovuta a postumo di endocardite,molto raro;trilogia,tetralogia,pentalogia di Fallot che sono alterazioni congenite),stenosi infundibolare e ectasia dell’arteria polmonare. Sfregamenti pericardici – sono rumori di breve durata dovuti a depositi fibrinoso tra i due foglietti pericardici e la frizione provoca i rumori.

POLSO – La palpazione del polso fornisce dati di valore pratico sulle funzioni dell’apparato circolatorio. Come sappiamo le caratteristiche del polso sono legate a :
a) Frequenza cardiacab) Energia di contrazione del cuorec) Condizioni locali
Sono definiti polsi tutti i siti anatomici ove è possibile palpare, ascoltare e a volte osservare rami
arteriosi. Le arterie palpabili sono le seguenti:• Arteria temporale superficiale – si può osservare anteriormente e superiormente al dotto uditivo esterno, in corrispondenza della tempia, può avere un percorso serpiginoso. La sua tumefazione dolorosa è il sintomo principale dell’arterite temporale di Horton, malattia autoimmune. • Carotide comune (alla biforcazione) - Si apprezza al di sotto dell’angolo mandibolare, e al di sotto del capo clavicolare del muscolo sternocleidomastoideo. Posizionando le ultime quattro dita a martello sul margine del muscolo, si preme con delicatezza in direzione del piano osseo muscolare laterale alla trachea. In genere è l’ultimo
Fig20 – Insufficienza aortica

polso che sì “perde” anche in caso di grave aritmia. L’ascoltazione può mettere in evidenza soffi di provenienza sia cardiaca che da stenosi della biforcazione.• Succlavia - È possibile apprezzarla nella fossa sopraclaveare. La posizione delle mani è quella corretta. Anche a questo livello è possibile apprezzare soffi di provenienza cardiaca o vascolare. • Brachiale - lungo il margine mediale del muscolo bicipite (è il punto in cui si inserisce lo stetoscopio durante la misurazione della pressione arteriosa)• Radiale - sulla faccia laterale dell’epifisi distale del radio, si apprezza utilizzando le ultime quattro dita della mano destra.• Femorale (comune e superficiale) - Si può seguire il decorso dell’arteria femorale subito al di sotto del legamento inguinale dove da origine ai suoi due rami principali: la femorale superficiale che si prolunga poi nella poplitea e a livello di gamba nelle tibiali e la femorale profonda destinata a dare rami muscolari e anse anastomotiche per la femorale
superficiale. Si apprezza in alto al triangolo di Scarpa e distalmente,prima che si insinui nel
canale di Hunter o canale degli adduttori(il canale ha per parete inferiore i tendini del muscolo adduttore magno e successivamente, passa in un anello tendineo di questo muscolo per portarsi posteriormente al femore).• Poplitea - per un breve tratto scorre ricoperta dalla sola cute e sottocute e a contatto con il piano osseo dell’epifisi distale del femore. È in questo punto che possibile apprezzare il suo pulsare.• Tibiale posteriore –si apprezza posteriormente al malleolo mediale.• Pedidia o dorsale del piede –corrisponde alla regione dorsale mediana del piede.
La frequenza del polso è variabile,va da 130-140 battiti/min,nel bambino 90-100 e nell’adulto 60-80La tachisfigmia è un aumento del polso oltre gli 80 battiti/min e le principali cause sono la febbre (dove c’è un aumento di 8 pulsazioni per ogni grado),ipertiroidismo,embolia polmonare,miocarditi, pericarditi e insufficienza cardiaca. La bradisfigmia è dovuta a stimolazione del vago,shock e disturbi di conduzione seno-atriale e atrio-ventricolare.
ELETTROCARDIOGRAMMA – Normalmente le concentrazioni intra- ed extra-cellulari di ioni attivi, come Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Cl-, determinano una differenza di carica elettrica ai due lati della membrana cellulare. Tale differenza viene definita potenziale di membrana. Nelle cellule nervose e muscolari tale potenziale può essere di due tipi:
Di riposo – in condizioni di riposo ciascun miocita è polarizzato e il potenziale di riposo è di -50/-95mV.All’interno della cellula sono maggiori le concentrazioni di ioni K+, rispetto all’esterno, dove è maggiore la concentrazione di Na+. Di azione – consiste nella rapida modificazione delle cariche elettriche a livello della membrana cellulare. Con l’apertura di canali a livello della membrana, gli ioni Na+ e Ca+2 entrano nel citoplasma, mentre ioni K+ fuoriescono.

Dopo la depolarizzazione della membrana dovuta al potenziale d’azione avviene la ripolarizzazione che è composta da diverse fasi. Nella fase 1, detta ripolarizzazione rapida precoce, si verifica una corrente di ioni K+ in uscita dalla cellula, che tuttavia si arresta quasi subito. Nella fase 2, detta del plateau, la conduttanza della membrana ai vari ioni cade su valori piuttosto bassi; il potenziale rimane intorno a 0 mV . Nella fase 3, detta ripolarizzazione tardiva, si verifica l’attivazione delle correnti di ioni K+ in uscita dalla cellula, a cinetica rapida e lenta, che riportano il potenziale su valori negativi iniziali.La sommatoria dei potenziali di membrana di tutte le cellule miocardiche dà luogo all’attività elettrica cardiaca. La registrazione dell’attività elettrica cardiaca mediante elettrodi posti sulla cute, prende il nome di ElettroCardioGrafia (ECG).
Nodo seno-atriale
Potenziale d’azione del nodo SA
Nodo atrio-ventricolare
Fascio di His
Fibre di Purkinje
Fig21 – Attività elettrica del cuore
Fig22 - 1. Onda P - depolarizzazione atri2. Complesso QRS – depolarizzazione ventricoli3. Onda T – Ripolarizzazione ventricoliGli intervalli – 1. intervallo PQ (0.12-0.2 s)2. intervallo QRS (< di 0.1 s)3. intervallo QT (0.35-0.45 s)

Fig23 – ECG normale con 12 derivazioni

DERIVAZIONI – abbiamo le derivazioni standard di Einthoven che sono bipolari e sono D1 (braccio dx-braccio sn),D2(braccio dx-gamba sn) e D3(braccio sn-gamba sn). Più tardi sono state introdotte le derivazioni unipolari secondo Goldberger che sono aVR(braccio dx),aVL(braccio sn) e aVF(gamba sn) e le derivazioni precordiali come V1( IV spazio intercostale dx lungo la linea marginale dello sterno),V2( IV spazio sn),V3(tra V2 e V4),V4 (itto della punta),V5( V spazio sulla ascellare anteriore) e V6 (stesso livello di V4 sulla ascellare media).
Fig24 – Normale ECG Fig25 – Derivazioni unipolari e bipolari
Fig26 – ECG normale con 12 derivazioni

Fig26 – Generazione della onda P

Fig27 – Generazione di QRS(tratto R)

Fig28 – Generazione QRS

Fig29 – Generazione QRS(tratto S)

Fig30 – Generazione onda T

Fig31 – Sintesi attività elettrica del cuore

Fig32 – Battiti atipici

Fig33 – Variazioni della conduzione AV





ESAME OBIETTIVO ADDOME
1. SEMEIOTICA GENERALE DELL’ADDOME – L’addome è delimitato in alto dal diaframma, posteriormente dalle cinque vertebre lombari,lateralmente e un avanti dalla parete addominale che è costituita (dall’interno verso l’esterno) dal peritoneo parietale dai muscoli(retto,obliquo esterno ed interno) e dal pannicolo adiposo sottocutaneo. La parete dell’addome viene suddivisa in 9 zone dalle 2 linee emiclaveari,linea sottocostale(unisce parti più declivi dell’arcata costale) e linea bicrestoiliaca(che unisce le 2 spine iliache anteriori superiori) e queste zone sono:
In alto – ipocondrio dx,epigastrio,ipocondrio sn Al centro – fianco dx,mesogastrio,fianco sn In basso – regione iliaca dx,ipogastrio,regione iliaca sn
La proiezione dei visceri è la seguente:fegato(ipocondrio dx e parte dell’epigastrio),milza (ipocondrio sn),stomaco(ipocondrio sn e epigastrio),duodeno(epigastrio e regione ombelicale come una C a concavità rivolta verso sn dove la 1ª e 2ª porzione si trova nell’epigastrio e la 3ª porzione nel mesogastrio),pancreas(epigastrio e la coda nel ipocondrio sn),intestino tenue(mesogastrio e in parte nell’ipogastrio),cieco e appendice vermiforme(regione iliaca dx),colon(ascendente –fianco dx,traverso-limite tra epi e mesogastrio,discendente-fianco sn,sigma-ipogastrio e fossa iliaca sn),reni (si proiettano anteriormente nei due ipocondri).
Fig34 – Divisione topografica dell’addome

Fig35 – Proiezione degli visceri
A. ISPEZIONE – che comprende l’ispezione della :1. Forma – che può essere piana;globosa-la parete addominale protrude in avanti dovuta ad obesità,meteorismo-normale aumento dei gas nel tubo digestivo,pneumoperitoneo-raccolta di gas libero all’interno della cavità addominale,ascite; batraciano-a causa di ascite;avvallato-salienza delle arcate costali dovuto a cachessia e peritonite acuta.2. Presenza di reticoli venosi superficiali – che possono essere di tipo portale puro -dovuto a ipertensione portale e localizzato in sede periombelicale con corrente dal basso verso l’alto;di tipo porta–cava -dovuto a ipertensione portale,cirrosi con reticolo a forma di caput medusae e associato a varici esofagee,splenomegalia,emorroidi;di tipo cava da stasi – localizzato alla porzione inferiore dell’addome con corrente dall’alto verso il basso dovuto a ristagno della vena cava inferiore per scompenso congestizia e ascite;di tipo cava-cava -dovuto a occlusione della vena cava inferiore cosi il sangue fa vie collaterali superficiali e profondi.3. Movimento in rapporto con gli atti respiratori – la respirazione è addominale negli uomini e toracica nelle donne4. Presenza di cicatrici da pregressi interventi chirurgici 5. Cicatrice ombelicale – che può essere normointroflessa o estroflessa6. Presenza di ernie,prominenze locali e movimenti peristaltici visibili.
B. PALPAZIONE – serve a valutare la trattabilità,valutare eventuali punti dolorosi,apprezzare la forma degli organi endoaddominali e formazioni patologiche,eseguire le manovre semeiologiche
tipiche di organi e apparati. L’addome è trattabile,quando la mano a piatto si approfonda verso il
basso senza provocare dolore né resistenza della parete addominale,se questo non avviene si dice che l’addome è difeso, su tutti i quadranti o in uno particolare causata da una peritonite

generalizzata o circoscritta. Viene eseguita usando le dita della mano a piatto cominciando con una palpazione superficiale e poi profonda.
Punto Colecistico – è situato in corrispondenza dell’incontro del margine sterno del muscolo retto con l’arco costale dx (Xª costa). Disporre le punte delle dita della mano destra in prossimità del punto cistico affondandole leggermente dall’avanti all’indietro e dal basso all’alto, invitando il paziente ad eseguire una profonda inspirazione con abbassamento del diaframma.Area di Traube – è delimitata medialmente dal margine della piccola ala del fegato e l’apice cardiaco, superiormente dal margine inferiore del polmone inferiormente dell’arcata costale, lateralmente dalla milza. Corrisponde alla bolla gastrica. Si riduce nella splenomegalia, nel versamento pleurico nelle cardiomegalie.Punto Pancreatico – è situato in corrispondenza dell’incontro della bisettrice dell’angolo formato dalla linea xifo-ombelicale con l’ombelicale traversa, con il margine esterno del muscolo retto dx.Area Pancreatico -Coledocica (Chauffard-Rivet) - è quel area corrispondente alla parte media di quello spazio compreso tra la xifo-ombelicale e la bisettrice dell’angolo formato dalla ombelicale traversa e la xifo-ombelicale. E’ dolente alla pressione nelle affezioni coledociche.
- Punti dolorosi appendicolari -- Punti dolorosi appendicolari -
Punto di Mac Burney – è in corrispondenza dell’incontro del terzo medio col terzo distale che congiunge l’ombelico con la spina iliaca anteriore superiore (linea spino-ombelicale). Punto di Lanz - all’unione del terzo medio con terzo laterale della linea bisiliaca.Punto di Morris- è sulla linea spino-ombelicale dx a 4 cm dall’ombelico.Segno di Blumberg - dolore più vivo quando si rilascia improvvisamente la pressione esercitata con la mano (è indice di partecipazione della sierosa all’infiammazione appendicolare e peritonite).Segno di Rovsing - dolore della fossa iliaca dx con la pressione esercitata dal basso verso l’alto in corrispondenza del colon discendente dovuto a brusca distensione del cieco con conseguente stiramento delle strutture circostanti in stato di flogosi per l’improvviso aumento del contenuto gassoso.Punto di Brun - punto doloroso gluteo a metà fra inizio della fessura interglutea e la spina iliaca posteriore superiore.
Fig36 – Punti di dolorabilità addominale1 – Punto epigastrico2 – Punto colecistico(segno di Murphy)3 – Triangolo di pancreatico duodenale di Chauffard4 – Punto appendicolare di Mac Burney5 – Punto appendicolare di Lanz6 – Punto uretrale medio7 – Punto uretrale inferiore8 – Punto gluteo di Brun9 – Punto uretrale superiore(di Bazin)

Punto ureterale superiore – all’incrocio della ombelicale traversa col margine esterno del m. retto (punto paraombelicale di Bazin);Punto uretrale medio – all’incontro con la bisiliaca con la verticale innalzata sul lato del pube, dal punto di unione del terzo medio con il terzo mediale del legamento di Poupart (punto di Tourneux);Punto uretrale inferiore – si rileva con l’esplorazione rettale nell’uomo e l’esplorazione vaginale nella donna premendo sul punto di sbocco degli ureteri in vescica.Intrapubico di Bazy – al disopra del pube a 2-3 cm dalla linea mediana.
Manovra di Murphy – si dispongono le punte della dita della mano dx nel punto cistico e si affondano dall’avanti e verso l’alto,il paziente respira e il dolore farà cessare l’atto respiratorio,è positivo in caso di colecistiti acute e croniche e litiasi della colecisti.Dolorabilità del triangolo di Chauffard – che è dolorabile nell’ulcera duodenale,pancreatiti e litiasi del coledoco.Segno di Courvoisier-Terrier - concomitanza di ittero e colecisti distendibile dovuto a colelitiasi o carcinoma della testa del pancreas.Manovra di Giordano – consiste nella percussione della regione lombare eseguita con la mano a taglio e dà dolorabilità in caso di calcolosi renale,invece la dolorabilità dei punti ureterali dimostra una calcolosi dell’uretere.Segno del fiotto – in caso di ascite
C. PERCUSSIONE – il suono che si ottiene è un suono timpanico diffuso su tutto l’addome e si chiama timpanismo entero-colico ed è aumentato nel meteorismo e diminuito nelle formazioni addominali parenchimali,nell’ascite,versamenti e fecalomi o occlusioni intestinali alte.
D. ASCOLTAZIONE – può consentire l’apprezzamento del borborigma,un rumore idroaereo dovuto alla peristalsi e può essere accentuata dovuto a sub-occlusioni intestinali e diarrea;diminuita fino al silenzio (peristalsi assente) nell’ileo dinamico,peritoniti,neurologico,nell’ileo meccanico di lunga durata e a seguito di intervento chirurgico addominale. Si possono apprezzare anche rumori vascolari dovuti ad aneurismi dell’aorta addominale o stenosi dell’arteria renale.
FEGATO
Il fegato è situato nella parte superiore della cavità addominale,inferiormente al diaframma che lo ricopre come un ampia cupola e superiormente allo stomaco e alla massa intestinale,occupa tutto l’ipocondrio dx,parte dell’epigastrio e la parte più craniale dell’ipocondrio sn. E’ mantenuto in sede dalla vena cava inferiore e dal legamento rotondo. Del fegato si devono considerare una faccia anteriore – superiore convessa(in rapporto con il diaframma),una faccia posteriore – inferiore concava(in rapporto post. con il surrene,rene e pancreas, anter. con lo stomaco,il duodeno e il colon)un margine anteriore e un margine posteriore.
- Punti dolorosi ureterali -- Punti dolorosi ureterali -
- Manovre semeiologiche -- Manovre semeiologiche -

EPATOMEGALIE – che possono essere a fegato molle dolente dovuto a fegato da stasi acuta per insufficienza cardiaca,pericardite acuta e indolente per statosi epatica,diabete;a fegato duro con superficie regolare(fegato da stasi cronica,ittero emolitico,amiloidosi),con superficie irregolare a piccoli noduli(cirrosi) o a grossi noduli(metastasi dal fegato)
1. ISPEZIONE
2. PALPAZIONE – normalmente il margine anteriore non si apprezza in quanto non deborda molto dall’arcata costale. La palpazione va condotta procedendo dalla fossa iliaca dx verso l’alto. La palpazione in corrispondenza dell’arcata costale deve essere condotta in condizioni di respirazione profonda. Nei casi patologici il margine del fegato può essere: sottile, tagliente, arrotondato, dentellato, frastagliato, irregolare, bernoccoluto, di consistenza lignea, elastica, molle.Indicare l’eventuale dolorabilità.
3. PERCUSSIONE - Occorre delimitare il margine superiore del fegato (che in condizioni normali si trova a livello del IV spazio intercostale) e l’inferiore (in corrispondenza dell’arcata costale), per rilevare se il fegato è ingrandito o è ptosico. La scomparsa dell’area di ottusità assoluta del fegato indica la comparsa di aria o gas nella cavità peritoneale.
MILZA
1. ISPEZIONE2. PALPAZIONE – il paziente è in decubito laterale dx. La palpazione va condotta partendo sempre dal basso verso l’alto come per il fegato. A livello della arcata costale si può attuare la manovra ad uncino oppure la superficie palmare delle dita della mano destra esercita una lieve pressione sul quadrante addominale sinistro, al fine di percepire la discesa della milza, quando il paziente inspira profondamente.3. PERCUSSIONE – il polo superiore è all’VIII-IX° spazio intercostale, il polo inferiore sul margine inferiore della XI costa. Anche in questo caso la percussione va fatta con il paziente in decubito laterale dx.
Fig37 – Limite superiore e margine inferiore del fegato

Fig39 – Splenomegalia
Fig38 – Proiezione della milza