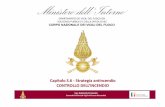selazione da cinemaespanso n 8 - capitolo 6
description
Transcript of selazione da cinemaespanso n 8 - capitolo 6
-
Antonie t ta Buonauro
172
sen dimostrava come la globalizzazione dei flussi di lavoratori fa-
cesse parte del medesimo processo in cui si inscrivevano lo sviluppo
della finanza globale e la circolazione globale di capitale, in cui
centri daffari e aree urbane impoverite si configuravano come com-ponenti antitetiche di ununica visione. Da Londra a Bombay, da Bangkok a New York, capitali globali e flussi migratori sembravano
uniti nel segno della disuguaglianza, una disuguaglianza che com-
plicava il rapporto con lalterit e che implicava per i Paesi occiden-tali un senso di colpa collettivo inscritto nella visione e nel racconto
mediatico e cinematografico della povert e del disagio dei Paesi
meno sviluppati.
The Impossible. Cronaca di una famiglia occidentale in un disa-
stro lontano
Uscito nelle sale cinematografiche alla fine del 2012, The Impos-
sible (Lo Imposible), blockbuster film ambientato nella Thailandia
dello tsunami, esemplifica in modo molto chiaro le dinamiche della
visione di un trauma collettivo e del confronto con lalterit e, in una certa misura, anche le relative implicazioni con il senso di colpa in-
scritto nel punto di vista della spettatorialit occidentale.
Ispirato allesperienza della sopravvivenza alla catastrofe del 2004 vissuta realmente da una famiglia spagnola, gli Alvarez-Belon,
che si trovavano sullisola di Sumatra proprio in quei drammatici giorni, il film stato distribuito in Spagna dalla Warner Bros e gi-
rato da Juan Antonio Bayona cineasta che gi aveva suscitato linteresse internazionale per il suo horror indipendente del 2007 The Orphanage registrando incassi record sul territorio iberico. Con un cast composto da due attori di fama internazionale come
Ewan McGregor e Naomi Watts, la sceneggiatura scritta da Sergio
G. Sanchez rivisitava la testimonianza di Maria Belon, madre della
famiglia coinvolta, proponendo al pubblico del film lesperienza della coppia composta da Maria e Henry Bennett, professionisti di
origine britannica trasferitisi in Giappone per motivi di lavoro, che
trascorrevano le vacanze natalizie nel paradiso tropicale tailandese
con i loro tre bambini.
Vincitore di vari riconoscimenti nazionali e internazionali e
frutto di un lavoro di preparazione durato circa due anni in sessanta
set cinematografici tra Spagna e Thailandia, The Impossible rico-
struiva in modo dettagliato larrivo dellonda oceanica nel resort in cui erano ospitati i protagonisti, seguendo da vicino soprattutto la sorte
Glic12Rettangolo
-
Trauma, cinema e media
173
toccata alla giovane madre e al suo primogenito, Lucas (Tom Hol-
land). Se gi nel 2010, era stato il regista americano Clint Eastwood,
con il suo Hereafter, a proporre per la prima volta lesperienza immer-siva della visione dello tsunami nel suo farsi attraverso una spettaco-
lare sequenza iniziale, The Impossible, collocandosi pienamente entro
i canoni nel genere cinematografico dei disaster movies, faceva di
quellesperienza il principale oggetto della sua narrazione, mante-nendo perci per tutta la sua durata uno squarcio aperto sullimpos-sibile, sul trauma collettivo, grazie ai mezzi concessi dalla tecnologia.
Riprendendo in parte il registro stilistico tipico del cinema
horror, lincipit del film mostrava alcuni momenti della vacanza dei Bennet (dal viaggio in aereo allarrivo negli scenari esotici tailandesi) non mancando di rimarcare nelle riprese subacquee dei bagnanti, negli idilli familiari, nei momenti di relax vissuti dai protagonisti una certa atmosfera sinistra che faceva da preludio alla tragedia
incombente. Cos, gli attimi di quiete che precedevano lirruzione dellonda oceanica nel resort in cui si trovavano i protagonisti erano gi carichi di una forte suspense, per cui ogni inquadratura sembrava
contribuire a configurare larrivo dellonda annunciato da un forte fragore come lirruzione di qualcosa di mostruoso, di cui si avvertiva il suono spaventoso, ma che non era possibile mettere a fuoco, dato
che lorizzonte risultava nascosto dalle costruzioni che separavano la spiaggia dalla piscina in cui i bambini giocavano con Henry. Ancora
fuori dal campo visivo della macchina da presa, quindi, londa si avvi-cinava abbattendo gli alberi sul litorale, per poi invadere le costruzioni
del resort e travolgere Henry con i due figli pi piccoli. Di loro tre a
questo punto si perdeva ogni traccia. La macchina da presa si spo-
stava infatti prima su Lucas, che saltava nella piscina un attimo prima
che fosse invasa dal mare, e poi su Mary (rannicchiata contro una ve-
trata), con la cui soggettiva si immergeva in apnea. Lo schermo nero
che seguiva, ancora indicante la coincidenza con il punto di vista della
donna, si coniugava poi con un totale annullamento anche dellaudio, suggerendo lidentificazione con lo stato semicosciente della donna. Pochi attimi pi tardi, uninquadratura la mostrava riemersa in su-perficie e aggrappata ad un albero. Qui, ampliando la prospettiva
dello spettatore, un campo totale, alternato al piano ravvicinato di
Mary che lanciava grida di terrore, mostrava da un punto di vista ae-
reo il drammatico scenario intorno alla donna.
Con uno stile estremamente dinamico, nelle sequenze dedi-
cate allo tsunami Bayona alternava primi piani, soggettive, campi
lunghi e movimenti di macchina in varie direzioni, per immergere
-
Antonie t ta Buonauro
174
lo spettatore nellesperienza traumatica. Proprio lalternanza tra il punto di vista della protagonista, e successivamente anche del gio-
vane Lucas, con una tale variet di angolazioni e modalit di ripresa
consentiva infatti di beneficiare di una prospettiva privilegiata sugli
eventi, producendo cos un avvicinamento, un accorciamento della
distanza da quella che iek avrebbe definito la materializzazione del Reale lacaniano, ovvero lesperienza indicibile del trauma.
Il percorso di Mary trascinata dalle acque non si concludeva
tuttavia con la sua riemersione a galla. Avvistato Lucas in cerca di
aiuto, ella si lasciava andare volontariamente al flusso sostenuto
delle onde che procedeva verso linterno della regione: cominciava cos una seconda immersione nello tsunami, terrorizzante tanto
quanto la prima. Trascinata via insieme a detriti di ogni tipo, Mary
si feriva alladdome: una ripresa subacquea ravvicinata mostrava limpatto del corpo della donna con dei rami sommersi e la conse-guente fuoriuscita del sangue che si disperdeva in acqua, mentre lei
gridava dal dolore cercando di aggrapparsi a sostegni di fortuna. I
tentativi di riavvicinamento, le peripezie e le apnee vissute da madre
e figlio facevano da filo conduttore di questa seconda e ultima im-
mersione nello tsunami, fino allarrivo di unaltra ondata che li avrebbe travolti. La soggettiva di Lucas, qui, conduceva ancora una
volta in apnea e dunque allidentificazione con il terrore della per-dita della madre, fino alla successiva riemersione, in cui la donna
appariva poco lontana, ferita e probabilmente svenuta.
interessante notare che The Impossible privilegiava il soggetto
femminile nel racconto, facendo in modo che fosse il corpo ma-terno di Mary, ferito, emaciato, traumatizzato, a mostrare i segni della mostruosit della natura e mettendo cos in scena non solo le
specificit della cultura traumatica descritta da Seltzer, ma anche
dellabiezione di Kristeva (pag. 119). Lasciando da parte le sorti toccate a Henry e i due figli pi piccoli, infatti, lintreccio sembrava concentrarsi su elementi corrispondenti ad alcuni dei simboli tipici
dellabiezione, che proprio nel rapporto madre-figlio, nel corpo femminile e nel concetto di violazione del limite trovava i suoi tratti distintivi. Se, come aveva sottolineato anche Barbara Creed in
un noto studio sul cinema horror, le abominazioni di cui fanno parte lalterazione corporea, il decadimento, la morte, il corpo fem-minile, i rifiuti corporei sono per antonomasia i luoghi di declina-zione dellabietto in relazione al soggetto umano sia sul piano sto-rico che religioso, nel caso di The Impossible ci sembra che non solo
levento stesso dello tsunami (interpretabile come ribellione della
-
Trauma, cinema e media
175
natura alladdomesticamento delluomo, come rovesciamento di un ordine e minaccia per la vita) fosse espressione macroscopica della-biezione, per esempio attraverso i suoi scenari lunari ricolmi di de-
triti, ma anche che, dal canto suo, il corpo di Mary rappresentasse
quella sfera dellabiezione pertinente alle funzioni biologiche del corpo. Laddove infatti, come scriveva Kristeva, labiezione fonda-mentale era il cadavere e tutto ci che ad esso rimandava, con le sue
ferite, il colorito cangiante della pelle e il decorso sempre pi vicino
alla morte, il personaggio interpretato da Naomi Watts incarnava
senza dubbio labietto nel film di Bayona.
I rifiuti cadono perch io viva, finch di perdita in perdita, non
mi resti nulla, e il mio corpo cada intero al di l del limite, ca-
dere, cadavere. Se la spazzatura significa laltro aspetto del li-mite, quello dove non sono e che mi consente di essere, il ca-
davere, il pi disgustoso dei rifiuti, un limite che ha invaso
tutto. Non sono pi io a espellere, io espulso16.
In questo senso allora pu essere letto anche il resto del film,
dove la conclusione delle sequenze dedicate allarrivo dello tsunami sulla terra ferma lasciava spazio a uno scenario apocalittico, fatto di
detriti, di corpi disseminati, di grida in lontananza. Placatasi la furia
delle acque Mary e Lucas si incamminavano in cerca di soccorso e,
sebbene fosse consolatoria la visione dei due riunitisi nonostante la
tragedia, il corpo martoriato della donna, che con il figlio aveva sal-
vato anche un altro bambino, tornava a portare al centro del rac-
conto simboli di abiezione. La visione della sua gamba lacerata in
queste sequenze faceva infatti il paio con quelle dellospedale stra-colmo di persone dove li avrebbero condotti i soccorsi e dove le con-
dizioni della donna sarebbero diventate sempre pi critiche. Qui,
distesa su un letto con le ferite in evidenza, in un momento di ap-
parente tranquillit, Mary improvvisamente cominciava a tossire
sembrando quasi soffocare, mentre mangiava uno spicchio di aran-
cia datole da Lucas. Sotto gli occhi terrorizzati del ragazzo e degli
altri pazienti la donna veniva mostrata in uno stato di evidente diffi-
colt respiratoria, che si sarebbe rivelato pochi attimi pi tardi pro-
vocato dai detriti inghiottiti durante lo tsunami, che ora venivano
16
J. Kristeva, Poteri dellorrore, cit., p. 5. Cfr. anche B. Creed, Kristeva, la femminilit, labiezione, in, Eretiche ed Erotiche, a cura di G. Fanara e F. Giovannelli, Napoli, Liguori, 2004, pp. 175183.
-
Antonie t ta Buonauro
176
espulsi suscitando reazioni di terrore e disgusto. Di nuovo, allora,
torna in mente la teoria kristeviana: con le sue ferite, con il suo de-
cadimento corporale e con il rigetto dei detriti, Mary incarnava
luniverso della madre, universo che nel contesto dellospedale en-trava in contatto con il simbolico, con lordine e la norma culturale, e dunque con sentimenti di disagio e vergogna.
Indugiando sui corpi martoriati, sui feriti e sui sopravvissuti di
ogni nazionalit che girovagavano senza meta in cerca dei propri
cari, la regia di Bayona sembrava rispondere ai canoni della cultura
del trauma di cui parlava Seltzer, nel momento in cui provvedeva il
pi possibile ad accorciare la distanza appropriata tra soggetto guar-
dante e oggetto guardato e al superamento del confine di separa-
zione tra sfera pubblica e desiderio privato, tra corpo e mondo e tra
corpo e tecnologia. Con i piani ravvicinati sulle scene di terrore o di
disgusto da un lato, e con le riprese subacquee e i campi lunghi che
inquadravano la desolazione sconfinata lasciata dallo tsunami
dallaltro, The Impossible si configurava come limmersione in uno scenario terrorizzante, rimandando al sogno freudiano da cui, come
aveva scritto iek, era preferibile svegliarsi. Un risveglio che nel film coincideva con la sequenza in cui, di nuovo in aereo, la fami-
glia Bennett faceva ritorno a casa. Miracolosamente ritrovatisi i turi-
sti occidentali potevano lasciarsi alle spalle lincubo vissuto, per tor-nare al mondo agiato e intatto da cui provenivano. In questo finale
allora, lalterit incarnata dalle popolazioni locali a cui una tale eva-sione non era concessa, si coniugava con il discorso delle disugua-
glianze tra Paesi, consentendo allo spettatore unidentificazione solo parziale con lhappy ending, disturbata da un sotteso senso di colpa (pagina 177).
Lo tsunami del Giappone tra premediazione, occidentalismo e
cultura del trauma
Nel documentario intitolato The Tsunami & the Cherry Blossom
(2011), la regista britannica Lucy Walker, gi pluripremiata autrice
di Waste Land (2010), metteva in scena le conseguenze dello tsu-
nami del 2011 nelle prefetture di Fukushima e di Myagi, ovvero le
conseguenze della devastazione impressionante e il lutto per la per-
dita degli affetti e dei luoghi di origine subiti dalla popolazione lo-
cale, ma anche la capacit di ricominciare a vivere e ricostruire che i
giapponesi sembrano aver inscritta nelle loro tradizioni, ed in par-
ticolare nellantica celebrazione della fioritura dei ciliegi, che nel 2011 fu preceduta di poco dal cataclisma (pagina 181).
-
Trauma, cinema e media
177
The Impossible, di A. Bayona (2012).
The Impossible, di A. Bayona (2012).
Alternando materiale reperito in rete e materiale girato in loco
con il contributo del direttore della fotografia Aaron Phillips, il film
di Walker si addentrava nei paesaggi lunari lasciati dal maremoto
raccogliendo i racconti dei sopravvissuti incontrati durante lesplo-razione, un percorso intimistico per molti versi che finiva per solle-
vare inevitabilmente una riflessione sul tema del rapporto tra bel-
lezza e terrore tipico del mondo naturale, impostosi cos tragica-
mente a quei testimoni, ma che non lasciava estraneo il resto del
mondo. Nominato al premio Oscar come miglior documentario nel
-
Antonie t ta Buonauro
178
2012 e vincitore di tre riconoscimenti nello stesso anno al Sundance
Film Festival e in diverse altre rassegne cinematografiche internazio-
nali, il lavoro di Walker si articolava, per una durata complessiva di
quaranta minuti, alternando alle interviste ai testimoni le immagini
del dramma nel suo farsi tratte da user generated contents immessi
nella rete, per poi concludersi con gli scenari incantati dei ciliegi in
fiore comparsi con larrivo della primavera, metafora della rinascita tipica dei cicli naturali, ma anche simbolo dello spirito dei morti nella
cultura giapponese. Dosando sapientemente il pathos di cui si carica-
vano le sequenze girate dai testimoni con i loro telefoni cellulari, qui
riportate con il loro sonoro originale, e gli scenari poetici dominati dai
colori rosati degli alberi in fiore, Walker sottolineava e rifletteva con il
suo film sul tema della transitoriet della vita e della bellezza, sul po-
tere distruttivo della natura che le proprio quanto quello creativo ed infine sulla convivenza dualistica di terrore e bellezza in natura,
che le testimonianze riportate nel film dimostravano di aver compreso
e di voler insegnare a chi non era stato colpito come loro da quei tra-
gici eventi. Per questo allora, i fiori di ciliegio acquisivano un valore
fondamentale come nella cultura giapponese, esemplificando
limportanza di celebrare la transitoriet delle cose, la loro caducit, senza che questa inficiasse il rapporto damore con esse. Anche quando i fiori cadono noi li amiamo, questo lo spirito dei giappo-
nesi, diceva uno dei testimoni, ricordando che la rinascita della na-
tura dopo il cataclisma lesempio pi grande per gli esseri umani, che ad essa devono adeguarsi e partecipare.
Il film di Walker non fu tuttavia lunico a trattare lo tsunami del 2011. Esso si colloc infatti allinterno di una rosa ampia di do-cumentari e materiali audiovisivi realizzati su Fukushima. Se i fatti
della Thailandia del 2004 avevano colto impreparato il pubblico
mondiale, dando luogo ad una veicolazione meno strutturata di te-
stimonianze e user generated contents, quello del 2011 fu invece og-
getto di molta pi attenzione da parte di diverse iniziative culturali.
Nel corso del 2012 pertanto, una serie di importanti manifestazioni
internazionali dedicarono uno spazio precipuo allo tsunami giappo-
nese, un tentativo di un elaborazione del trauma collettivo attraver-
so strategie rappresentative che costituivano testimonianze dellac-caduto. Cos, nel corso della Berlinale del 2012, i documentari sele-
zionati per un focus su Fukushima, No Mans Zone (2012) di Fu-jiwara Toshi, Nuclear Nation (2012), di Atsushi Funahashi, e Friends
After 3.11 (2011), di Iwai Shunji, raccontavano da un punto di vista
autoctono i postumi dello tsunami.
-
Trauma, cinema e media
179
The Tsunami and the Cherry Blossom, di L. Walker (2011).
The Tsunami and the Cherry Blossom, di L. Walker (2011).
Realizzato nei giorni immediatamente successivi all11 marzo, No Mans Zone dava voce ai sopravvissuti, mostrando i luoghi desolati delle terre evacuate e la sensazione di impotenza e di svilimento di
persone che non sapevano quando e come trovare un nuovo luogo in
cui vivere, dato che gli agglomerati urbani da cui provenivano, o quel
che restava di essi, sarebbero rimasti inagibili per periodi di tempo che
le autorit non erano in grado di definire. Con il titolo No Mens Land perci, Fujiwara Toshi non intendeva indicare soltanto un luogo, ma
anche uno stato mentale, per riflettere poi sul rapporto tra paura e
immagini, tra uomo e natura. Sulla stessa scia poi, Nuclear Nation
approfondiva le conseguenze dellincidente nucleare di Fukushima
-
Antonie t ta Buonauro
180
sulle cittadine limitrofe, per indagare sulle contraddizioni della ge-
stione politica e scientifica dellemergenza e pi in particolare sulloperato della TEPCO, societ detentrice della centrale danneg-giata dallo tsunami, le cui fuoriuscite provocarono ordini di evacua-
zione per circa 10.000 persone, tra cui i 1.400 sfollati di Futaba, centro
abitato situato a soli tre chilometri dai reattori, totalmente spazzato
via dal mare e investito successivamente da piogge radioattive. Fu-
nahashi, vincitore di menzioni e premi in festival di tutto il mondo,
gir il suo documentario tra gli sfollati concentrati in una scuola a
circa duecentocinquanta chilometri dalla loro citt, il primo campo
per rifugiati nucleari dopo Cernobyl. Oltre a documentare la quoti-
dianit straniante dei sopravvissuti in attesa di ascolto dalle autorit e
risarcimenti dalla TEPCO, una quotidianit fatta di code per il bagno
e per la somministrazione di cibo scadente, il film introduceva poi gli
spettatori nellesperienza del trauma collettivo partecipando al primo rientro consentito a quei sopravvissuti tra le macerie delle loro case,
un permesso di due ore, durante le quali, senza commenti n colonne
sonore, la presa diretta mostrava un paesaggio spianato, pieno di de-
triti, popolato da animali randagi e carcasse divorate dalle radiazioni e
dal mare.
Ancora ponendo laccento sul nucleare, ma essendo proteso soprattutto ad una riflessione, dellautore e degli spettatori, sul pre-sente e sul futuro del Giappone, Friends After 3.11 allindomani dello tsunami vedeva il suo autore, Shunji, attraversare i paesaggi
abbandonati dalle acque dopo il loro ritiro, dialogando con altri te-
stimoni o interrogandosi sullimpatto di quella catastrofe sul Paese, sullimmaginario collettivo, sulle aspettative di progresso e di pro-sperit riposte nellenergia nucleare e poi tragicamente disattese ed infine sulla possibilit di ripensare lidentit e il futuro del Giappone alla luce di quanto era accaduto.
Sulla furia della natura e sulle responsabilit umane si con-
centravano poi anche le foto del World Press Photo, prestigioso con-
corso annuale che nel 2012 dedicava una specifica sezione agli sce-
nari post-traumatici di Fukushima. Le foto premiate in quella circo-
stanza e scattate da fotoreporter di diverse nazionalit, come Paolo
Pellegrin, Lars Lindqvist, David Guttenfelder, Koichiro Tezuka e
Toshiyuki Tsuneari17
, diventavano ancora una volta la testimo-
17
Cfr. http://www.worldpressphoto.org/photo/2012-lars-lindqvist-gn-2?
gallery=2634.
-
Trauma, cinema e media
181
nianza di una riflessione sulla forza distruttrice della natura e sulla
conseguente crisi dei miti occidentali del controllo su questultima attraverso il progresso delle tecnologie e delle scienze. In questi
scatti che ritraevano navi arenate sulle aride spianate che furono ingolfate dalle acque dello tsunami, costruzioni demolite, telai di
automobili i beni simbolo delle societ contemporanee apparivano ridotti a carcasse prive di funzionalit, facendo da sfondo a sagome
umane piccolissime al confronto, come ad enunciare la spropor-
zione dimenticata dalle citt globali tra la potenza della natura in
cui esse sono inscritte e la possibilit di addomesticarla.
Pi dello tsunami del 2004, o quanto meno in modo diverso, il
tentativo compiuto in molti contesti di rappresentare il cataclisma
giapponese sembr allora puntare laccento sullesposizione gene-rale alla violenza dei disastri ambientali, intesa come fattore di ri-
schio non circoscrivibile a luoghi altri e da cui non dovevano rite-nersi al riparo i territori dei Paesi cosiddetti avanzati. Cos conno-
tata, questa rappresentazione sembrava rivolgersi alluditorio occi-dentale quasi pi che a quello direttamente colpito, ovvero a quelle
societ che si identificavano con un certo modello di avanzamento e
nelle quali la cultura del trauma, intesa come attrazione per imma-
gini scioccanti, acquistava anche il ruolo di fenomeno di premedia-
zione, come aveva intuito Richard Grusin18
. Nella prospettiva della
premediazione allora si potrebbero rileggere anche, da un lato,
lenorme produzione di user generated contents sullargomento e, dallaltro, il fenomeno dellelevata attenzione concessa dai mezzi di comunicazione agli eventi giapponesi (mai scemata del tutto al
contrario di quanto avvenuto per la Thailandia), in cui sembrano
rientrare a nostro avviso anche iniziative in un certo senso singolari,
come la mappatura di Fukushima post-tsunami compiuta, a grande
richiesta, da una gigante della rete come Google nel 2012. Le im-
magini fotografiche a cui si accede dal proprio laptop o smartphone
attraverso il sito dellazienda americana consentono in buona so-stanza un viaggio virtuale e autonomo a chi ne fruisce, unespe-rienza che si concilia con gli interessi della sfera pubblica patologica
di Seltzer, ma che daltro canto sembra anche rimandare ad un pre-cedente significativo proprio della storia del Giappone, che vale la
pena di menzionare a questo punto. Si tratta della raffigurazione
per mezzo di cartoline illustrate di uno dei pi devastanti terremoti
18
Cfr. capitolo precedente.
-
Antonie t ta Buonauro
182
che abbiano colpito la zona limitrofa a Tokyo nel secolo scorso, un
terremoto verificatosi nel 1923 nella prefettura del Kant. Zona
simbolo del progresso industriale nipponico nei primi decenni del
Novecento, il Kant divenne oggetto di raffigurazioni in cartolina inviate in lungo e in largo nel territorio nazionale come souvenir da
un luogo che prometteva orizzonti futuri di grande prosperit anche
al resto del Paese. Illustrazioni raffiguranti ferrovie, ampie strade
moderne, ponti attraversati da tram, mastodontici edifici dalle ar-
chitetture innovative, luoghi urbani popolati ma non caotici, costi-
tuivano il simbolo della produttivit coniugata ad una buona qualit
della vita, ovvero del benessere raggiunto attraverso il progresso, e in
questo modo registravano grandi successi di vendita.
Nel 1923 poi, il grande terremoto, e le varie altre scosse che lo
seguirono causando migliaia di morti, rasero al suolo i luoghi che
fino ad allora avevano rappresentato il fiore allocchiello di quella-rea del Paese. Proprio in quei giorni, sorprendentemente, di quella
devastazione vennero create immagini in cartolina raffiguranti i
luoghi-simbolo del Kant ormai ridotti ad un cumulo di macerie e
spesso riconoscibili solo con laiuto delle didascalie, o attraverso la comparazione con le precedenti raffigurazioni. Tali cartoline si ri-
velarono ben presto oggetto di unattenzione ancor pi massiccia di quella di cui avevano goduto le precedenti. Proponendo non solo gli
edifici crollati, ma anche scene di maggiore crudezza, come quelle
riguardanti il dramma nel suo farsi (per esempio gli incendi) o i
cumuli di cadaveri riversi nelle strade, esse si configurano tra i primi
esempi della fruizione di immagini tipica di una sfera pubblica pa-
tologica, costituendo un caso dai forti punti di tangenza con gli
eventi del 2011.
Come illustrano alcuni studi19
, infatti, esse consentono di ri-
flettere anche sul ruolo che oggi i nuovi media ricoprono rispetto
allesperienza dei traumi collettivi, e cio non solo di strumenti di interazione tra sopravvissuti (come tuttora avviene per esempio at-traverso luso dei social network durante le emergenze finalizzato a reperire informazioni dirette sulle sorti dei propri cari), ma anche di
strumenti sostitutivi dei medium figurativi ormai considerati obso-
leti, come le cartoline. Sollecitando il piacere voyeuristico da sempre
inscritto nella visione attraverso la veicolazione reiterata di imma-
19
Cfr. in particolare L. Hjorth e K.Y. Kim, The Mourning After: A Case
Study of Social Media in the 3.11 Earthquake Disaster in Japan, in, Television &
New Media, vol. 12, n. 6, pp. 552-559.
-
Trauma, cinema e media
183
gini recrudescenti, i social network e i database di video online fun-
gono infatti da strumenti sociali di elaborazione dei traumi attra-
verso la rappresentazione e il racconto per immagini, configuran-
dosi come i pi attuali luoghi di declinazione del fenomeno della
premediazione.
QRcode. dal sito The Great Kant Earthquake of 1923, prodotto della ri-
cerca di J. Charles Schencking.
QRcode. Da The Great Kant Earthquake of 1923, cartoline dopo il terremoto.