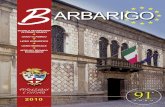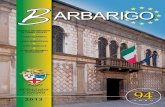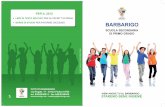San Gregorio Barbarigo: Più che un vescovo fu un apostolo
-
Upload
istituto-barbarigo -
Category
Documents
-
view
19 -
download
1
description
Transcript of San Gregorio Barbarigo: Più che un vescovo fu un apostolo

� Quando, sul finire del 1663, lasede di Padova divenne vacanteper la morte di Giorgio I Cor-
ner, il cardinale veneziano Pietro Otto-boni — più tardi, dal 1689 al 1691, pa-pa Alessandro VIII — commentò che,date le condizioni in cui la diocesi ver-sava, essa avrebbe avuto bisogno «di unapostolo più che di un vescovo». Non è,questa, l’unica voce critica sulla situa-zione della nostra chiesa nel primo Sei-cento: se è vero che lo slancio dell’im-mediata stagione post-tridentina si erasenza dubbio affievolito e che a pastorisolerti, anche se non di caratura ecce-zionale, come Marco II Corner, che res-se la diocesi per oltre trent’anni, dal1594 al 1625, si erano alternati uominimediocri, quando non moralmente di-
scutibili, come Marcantonio Corner (ve-scovo dal 1632 al 1635). Va pure dettoche questi anni non sono ancora statifatti oggetto di un’indagine storica ap-profondita.
Papa Alessandro VII Chigi credettedi trovare quell’“apostolo”nell’ancor giovane cardi-nale veneziano GregorioBarbarigo, ch’egli stesso,appena sei anni prima,aveva scelto come vescovodi Bergamo, che conosce-va assai bene da almenovent’anni e che molto sti-mava. Alla notizia che ilpontefice lo stava per pro-muovere alla grande e prestigiosa dio-cesi patavina, egli fece di tutto per op-porvisi. Infine, dopo un lungo travaglio,pervenne a questa risoluzione, che con-fidò al padre: «Se il papa lo vorrà fare,haverò piacere. Se non lo vorrà fare, ha-verò piacere perché sarà la volontà diDio, né io haverò perso niente».
Nel 1664, quando divenne vescovodi Padova, il Barbarigo non era ancoraquarantenne (era nato nel 1625), era ve-scovo da sette anni e cardinale da quat-tro. Non era diventato sacerdote miran-do a una carriera ecclesiastica in gradoallora di aprire ai nobili come lui oriz-zonti di facile successo; la sua scelta fuil frutto di un itinerario di ricerca spiri-tuale, condotto nell’intimità della pro-pria coscienza, davanti a Dio: lì com-prese di essere chiamato a far dono del-la sua vita agli altri, senza risparmio. Aifedeli di Bergamo aveva scritto: «Caris-simi, vi aspettate il pastore e noi procu-reremo l’abbiate quale l’attendete...Non ricusiamo la fatica, non schiviamola lotta... E per tutto comprendere in unaparola che tutto abbraccia diciamo: viameremo. Il distintivo del buon pastore
è la carità». Dopo appena due mesi e mezzo dal
suo ingresso in diocesi, il cardinale neiniziò la visita pastorale. Aveva fretta diconoscere il suo gregge, la cui salvezzaconsiderava condizione e garanzia della
sua. Cominciò il lungo iti-nerario nelle oltre trecentoparrocchie il 2 settembre1664, per concluderlo l’11giugno 1697, sette giorniprima della morte: lo ripetéquattro volte e vi fu impe-gnato per 29 anni su 33 diepiscopato padovano, sen-za rilevanti interruzioni.Conduceva la visita perso-
nalmente, accompagnato da pochissimicollaboratori; nonostante la scelta dellestagioni più favorevoli, i viaggi celava-no non poche insidie: nella zona setten-trionale per l’asperità delle montagne,con strade ridotte spesso a incerti sen-tieri, nel sud della diocesi per le fre-quenti inondazioni, che talvolta rende-vano indispensabile l’uso di precarieimbarcazioni.
Il Barbarigo pensava alla visita co-me a un’occasione di conversione, dirinnovata vita cristiana, di risveglio del-le coscienze. Era preparata da una mis-sione al popolo ed era scandita dalle ce-lebrazioni dei sacramenti,dalla predicazione del ve-scovo, dall’esame e dal-l’insegnamento della dot-trina cristiana cui egli stes-so si dedicava, dalle esor-tazioni al popolo e dai nu-merosi, spesso sfibranti in-contri individuali, in cuiassumeva la funzione diarbitro di contese o di con-fessore. Tutto ciò dona a quei momentiun carattere spiccatamente pastorale,nei quali la ricerca di un rapporto perso-nale con le anime prevale sull’aspettoispettivo e correttivo. D’altra parte, nel-la prima omelia pronunciata a Padova,il cardinale aveva spiegato ai fedeli chenon gli sarebbero pesate «né le visite,né le udienze, né le fatiche pastorali (...)perché non sono queste che aggravanole spalle dei vescovi»; a costituire ungravosissimo carico sarebbe stato benaltro: i peccati commessi nella sua dio-cesi che su di lui sarebbero ricaduti, leanime non salvate di cui avrebbe dovu-
to rendere conto a Dio. Questi pensieridel Barbarigo, oltre che una concezioneassai impegnativa del ministero episco-pale, rivelano una certa tendenza alloscrupolo, che si riaffaccerà angosciosanelle ore che ne precedettero la morte,sopraggiunta all’alba del 18 giugno1697.
Uno dei testimoni al processo dibeatificazione dichiarò che c’eraun’idea sulla quale il cardinale ritornavasenza esserne mai sazio, quella di «averdotto il clero e il popolo bene ammae-strato». L’idea del Barbarigo, non ge-niale, ma ardita per le fatiche che com-portava e assai feconda per i frutti cheavrebbe prodotto, quella che gli fecescrivere al padre «io vado pensando difarmi degli operai a modo mio» e che fadi lui il ri-fondatore del nostro semina-rio, fu quella d’introdurre nell’istituto,che funzionava a Padova da quasi unsecolo, ma che ospitava i chierici solofino al compimento dei 17 anni, un nuo-vo ordine di alunni, quello ch’egli chia-mò dei “chierici adulti”, per un corso distudi, corrispondenti all’attuale semina-rio maggiore, che li avrebbe accompa-gnati nella vita morale e spirituale finoall’ordinazione, preparandoli diretta-mente al ministero pastorale. L’esecu-zione di questo coraggioso e impegnati-
vo progetto domandava peril nuovo istituto una sedenuova; il vescovo la trovònel monastero soppresso diSanta Maria in Vanzo,ch’egli acquistò vendendopersino l’argenteria del suopalazzo.
Dall’apertura del nuovoseminario, il 4 novembre1670, nell’edificio dove tut-
tora si trova, ex priorato benedettino diSanta Maria in Vanzo, il Barbarigo nonsmise mai di seguirne da vicino la vita,occupandosi personalmente e con gran-de cura della scelta di superiori e pro-fessori, che faceva venire perfino dal-l’estero, dotandolo di una biblioteca epersino di una costosissima tipografia,fornita dei caratteri per le lingue orien-tali (ebraico, siriaco, caldeo, arabo, tur-co e persiano), il cui studio, da parte dialcuni almeno dei suoi chierici, egliconsiderava essenziale sia per compren-dere più a fondo la Sacra scrittura, siaper avere missionari per l’oriente mu-
Dopo appena due mesie mezzo dal suo ingressonella diocesi, il cardinale
ne iniziò la visitapastorale: aveva fretta
di conoscere il suogregge
Dall’apertura del nuovoseminario, il 4 novembre
1670, il Barbarigo non smise mai
di seguirne da vicinola vita occupandosi
personalmente della scelta dei professori
�cu
ltura
Più che un vescovofu un apostolo
17 - Il Seicento: l’età di san Gregorio Barbarigo
Arrivato a Padova non ancoraquarantenne, si prodigò con energia
infinita nelle visite pastorali,che interpretò come autentiche occasioni
di conversione, nella formazionedei sacerdoti, attraverso il potenziamento
del seminario, e nella costante curaper l’insegnamento della dottrina cristiana
�Fu un papa veneziano ch’era stato vescovo di Padova,Clemente XIII Rezzonico, a proclamare Gregorio Barbarigobeato a 64 anni dalla sua morte, nel 1761, riconoscendo lasua personale devozione per il predecessore sulla cattedrapadovana e intendendo additare ai pastori della chiesa, intempi difficili, un chiaro esempio di virtù. E fu GiovanniXXIII — eletto papa da patriarca di Venezia ma bergama-sco d’origine, proveniente, cioè, dalla prima diocesi rettadal Barbarigo — ad accogliere nel 1960 la preghiera delvescovo di Padova Girolamo Bortignon e dell’intero episco-pato triveneto di procedere alla canonizzazione del beatoGregorio, verso il quale la devozione del pontefice era bennota, direttamente per autorità apostolica, evitando quindil’apertura di un nuovo iter processuale.
Papa Roncalli volle dare all’evento una risonanza spe-ciale; evidenziò nel Barbarigo un’eccezionalità di rispostaal vangelo, cioè di carità, che in lui assunse il tratto delbuon pastore, e una singolarità che in lui si espresse inun’altra dimensione fondamenta-le, la “modernità”, cioè nella cor-retta lettura e nell’adeguata inter-pretazione dei caratteri e dei biso-gni della sua epoca. San GregorioBarbarigo — ci ricorda GiovanniXXIII — «non ritorna a noi dal fon-do di epoche dimenticate; ma adoltre tre secoli dalla morte è tutto-ra familiare (...), esemplare e in-coraggiante per tutti, come lo fuper gli ecclesiastici ed i fratelli deltempo suo».
18 � alleoriginidellafede LA DIFESA DEL POPOLO7 LUGLIO 2013
LA SANTITÀ Da Clemente XIII a papa Roncalli
Giovanni XXIII sottolineòla sua modernità pastorale

IL PERSONAGGIO Beata Giovanna Maria Bonomo
La grande mistica dell’umiltà
�In ricordo del vescovosanto, Gregorio Barbarigo, il
museo diocesano espone la suasedia cerimoniale, recentementerestaurata. Nel “suo” seminario,oltre a vari ritratti in cui il Barbari-go è effigiato in differenti età, per-fino quando aveva sei anni, è pre-sente anche la reliquia del cuoredel santo, in un reliquiario d’ar-gento realizzato dall’orafo vene-ziano Andrea Zambelli, come te-stimonia il suo punzone individua-to durante la campagna di inven-tariazione dei beni ecclesiastici.
Tra le opere d’arte seicente-sche esposte nel museo assumeparticolare rilievo la tela di GiulioCirello Sant’Agnese esortata asposare il figlio del prefetto, pro-veniente dalla chiesa di San-t’Agnese, oggi tristemente degra-data ad autorimessa. La chiesa,menzionata in un documento deiprimi del Duecento, era stata am-pliata e sopraelevata nel Seicento;in quegli anni l’interno, a navataunica, fu decorato con un ciclo distorie sulla vita della santa roma-na. In quattro teleri di dimensionisimili, collocati sulle pareti laterali
della navata, intervallate da duealtari, erano raffigurati: San-t’Agnese esortata a sposare il fi-glio del prefetto, Sant’Agnese ri-fiuta i doni, Sant’Agnese condottaal postribolo, Sant’Agnese al pati-bolo. La storia si concludeva conla pala d’altare raffigurante San-t’Agnese in gloria. Dei quattro te-leri si conserva il primo in museodiocesano, il secondo nella salaparrocchiale e una piccola palad’altare nella chiesa di San Nicolò.
Il Cirello, autore di tre dellequattro tele, era famoso – comescrive Andrea Nante nella schedapredisposta per la mostra “Dal-l’Adige alle Alpi. Tesori ritrovatidella chiesa di Padova” – comepittore di composizioni storiche acontenuto allegorico e in ritrattiencomiastici di forte vigore narra-tivo. «La scena si svolge in unospazio semiaperto, forse una log-gia oltre la quale, tra fumo d’in-censo, si scorge il cielo azzurro esi indovina la statua di Vesta, a cuila santa avrebbe dovuto tributareomaggio. Per conferire monumen-talità all’azione e per sostenere laripresa dal basso dell’insieme, il
pittore ha studiato un piano eleva-to di due eleganti gradini in pietra.(...) Il tono teatrale della scena èamplificato dal sontuoso tendag-gio rosato a coronamento del tro-
no del prefetto, quasi a chiusuradi un ideale boccascena, e dai co-stumi dei personaggi confezionatiin sete, velluti e damaschi».
�Lorenzo Brunazzo
� Accanto a Gregorio Barbarigo, tra ipersonaggi guida del Seicento, la chiesa
padovana venera una monaca benedettina ori-ginaria di Asiago e vissuta nel monastero diSan Girolamo a Bassano: la beata GiovannaMaria Bonomo (o Bonhomo). Nei decenni cen-trali del “grande secolo”, come ebbe occasio-ne di sottolineare mons. Pierantonio Gios, di-rettore della biblioteca Capitolare. Si verificaro-no mutamenti strutturali profondi nella societàveneta ed europea, che favorirono l’insorgeredi aspettative religiose altrettanto profonde. Inun contesto di instabilità economica e di ina-sprimento delle differenze sociali, accanto allerivolte popolari si diffusero tendenze millenari-stiche, correnti di spiritualità che indicavano inparticolari forme di raccoglimento e di pre-ghiera, in una vita cristiana più evangelica epiù intimamente vissuta il rimedio alla frustra-zione e all’angoscia. Questi focolai di entusia-
smo religioso presenti in tutta Europa, conob-bero una fulminea espansione anche nella Re-pubblica veneta con il movimento dei Pelagini,che facevano capo a un laico analfabeta bre-sciano di nome Giacomo Filippo Casolo, e aun’altra personalità carismatica e spirituale, laveneziana Cecilia Ferrazzi.
Nel monastero di San Girolamo a Bassanoera la fama di santità di Giovanna Maria Bono-mo che faceva accorrere schiere di sacerdoti,religiosi e laici. Soprattutto nei suoi ultimi annidi vita, tra il 1664 e il 1670, come scrive pa-dre Francesco Trolese, abate di Santa Giusti-na, in Santi e beati della diocesi di Padova, «sidedicò ampiamente alla guida spirituale dellepersone che ricorrevano sovente ai suoi consi-gli: si appellarono alla sua ricca esperienza re-ligiosa, tra gli altri, i sovrani Enrichetta MariaAdelaide di Savoia e Cosimo III de’ Medici, ol-tre a sacerdoti e religiosi in crisi ed esponentidella nobiltà di Padova, Vicenza e Venezia».
Se in quegli anni la chiesa aveva ormaiaccettato l’ortodossia della Bonomo, non erasempre stato così. Maria era nata ad Asiago il15 agosto 1606 e, rimasta giovanissima orfa-na di madre, aveva fatto esperienza precoce-mente della pratica dell’ascesi cristiana e dellavisione mistica. Entrata come educanda nelconvento delle Clarisse di Trento, era stata ri-chiamata in famiglia a 14 anni per essere av-viata alla vita matrimoniale. Ma la ragazzachiese fermamente di consacrarsi al Signoreper cui il 21 giugno 1621 fece il suo ingressotra le Benedettine di San Girolamo a Bassano,un monastero che brillava per l’osservanza ri-gorosa della regola benedettina. Fu un ingres-so nella vita monastica radicalmente differenteda quello di altre fanciulle del suo tempo co-
strette a farsi monache da strategie familiari oprestigio di classe.
L’esperienza di Giovanna Maria Bonomospicca anche per l’intensità del suo mistici-smo, che l’assimila a quello di altre grandi mi-stiche come santa Caterina da Siena e santaTeresa d’Avila. Stretti i voti di stabilità al com-piere del suo 16° anno, «percorse i classicigradi – come scrive ancora padre Trolese –della vita purgativa, illuminativa e unitiva fino aricevere, un venerdì del 1632, la “feritad’amore” nel petto e le stimmate». Una taleperfezione spirituale fu però “pagata” da gran-di tribolazioni nel corpo e nello spirito. Nono-stante che le manifestazioni prodigiose fosse-ro state giudicate da molti teologi in pienaconsonanza con la dottrina della chiesa, il mo-nastero fu sottoposto a visita canonica nel1643 e il vicario episcopale impedì alla religio-sa di comunicare con l’esterno, di scrivere let-tere e di accostarsi con frequenza al ministerodell’Eucaristia. Ella accettò con grande umiltàle limitazioni, confortata dalla convinzione che“tutto è amore”, «finché nel 1650 un interven-to miracoloso pose fine a quella inopportunadiscriminazione».
Anche il suo ultimo confessore, padre Do-menico Veggia, severo e un po’ prevenuto neisuoi confronti, finì col riconoscerne le virtù. Il15 giugno 1652 fu eletta badessa e poi prio-ra, cariche che ricoprì fin quasi alla morte, av-venuta il 1° marzo 1670. Fu proclamata beatada papa Pio VI il 9 giugno 1783. Asiago ricor-da anche un prodigio a lei legato: la statuaeretta in suo onore davanti alla casa natale ri-mase intatta nonostante il furioso cannoneg-giamento della zona durante la grande guerra.
�L. B.
Nella fotoin alto,
la sediadi san
GregorioBarbarigo
espostanel museodiocesano.A sinistra,
ritratto di sanGregorio
conservato inseminariomaggiore,
veduta “a volo
d’uccello” del seminario
eseguita nel 1740.
Sotto,il marchio
dellatipografia
delSeminario.
sulmano e per favorire l’unione dellachiesa greca con quella latina. La for-mazione che vi veniva impartita, deriva-ta dalla Ratio studiorum dei Gesuiti, eratale da non trovare davvero confrontinegli altri seminari italiani di quell’epo-ca.
Il versante dell’educazione cristianadei fedeli vide Gregorio Barbarigo im-pegnato con una determinazione non in-feriore. Per la preparazione scolasticadei giovani della nobiltà fondò al Tre-sto, presso Este, un collegio, con lo sco-po di renderli «abili al servizio di Dio edella Patria»; per quelli di condizionepiù disagiata, invece, aprì in città unasorta di ginnasio gratuito.
Il cardinale fu anche un instancabilepromotore delle scuole di dottrina cri-stiana, già presenti in diocesi ma chetrovò bisognose di riforma. Egli le strut-turò su base centrale e parrocchiale permezzo di minuziose regole, che affida-vano a ciascun membro della scuola ilproprio compito educativo: accanto aimaestri c’erano i “pescatori”, che anda-vano a raccogliere i fanciulli per le casee per le strade, i “portinari” che li acco-glievano, i “silenzieri” che li tenevano abada e i “cancellieri” che ne segnavanole presenze. Vi s’insegnava il catechi-smo di san Roberto Bellarmino, secon-do un programma accurato distribuito inclassi successive. Alla morte del Barba-rigo, queste scuole funzionavano in 314chiese curate su 320. Se per gli adultiera pure previsto nelle parrocchie unmomento di formazione domenicale di-stinto da quello dei ragazzi, per i dottiche vivevano in città egli pensò a unprogetto di “filosofia cristiana”, un cor-so triennale di lezioni a tema, tenuto dadiversi oratori la domenica, in cattedra-le.
�Stefano Dal Santo
1594 Inizia il trentennaleepiscopato di Marco CornerIl 12 dicembre 1594 inizia il trentennale episcopato di MarcoCorner, proveniente da Bergamo. Fu promotore e fondatore di “compagnie di dottrina christiana” esigendo cheanche nelle località più impervie si insegnassero i fondamenti della fede.
1625 Comincia un periodooscuro per la diocesiCon la morte di Marco Corner e soprattutto durante il lungoepiscopato di Giorgio Corner (1642-1663) inizia per la diocesi un periodo oscuro, e poco studiato,di degenerazione nepotistica e didecadenza morale e religiosa.
1664 Gregorio Barbarigo vienetrasferito a Padova da BergamoAlessandro VII il 24 marzo 1664trasferì dalla diocesi di Bergamo aquella di Padova il cardinale GregorioBarbarigo che per lui, oltre che stima,nutriva affetto paterno. Appena duemesi e mezzo dopo era già inpartenza per visitare le parrocchie.
1669 Primo attodel nuovo seminario vescovileCon 3.500 scudi il 30 marzo1669 il Barbarigo acquista il monastero soppresso di SantaMaria in Vanzo: dopo 18 mesi quinascerà il nuovo seminario che il 4novembre 1670 accoglie 106alunni che divennero presto 200.
1697 A 72 anni muoreil vescovo BarbarigoDopo 33 anni di infaticabile governodella diocesi, alle 5.30 di mattinamuore il vescovo Gregorio Barbarigo.Lascia un saldo e funzionante sistemadi governo diocesano capace di durarenel tempo e di esercitare la suainfluenza sulla società. �
data
rio
MUSEO DIOCESANO La tela di Santa Lucia eseguita da Giulio Cirello
Un racconto monumentale
19alleoriginidellafede �