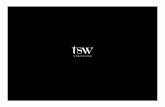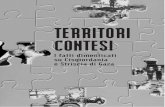Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territori minori in europa
Click here to load reader
-
Upload
centro-di-documentazione-europea-delluniversita-degli-studi-di-enna -
Category
Education
-
view
83 -
download
3
description
Transcript of Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territori minori in europa

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
IL RUOLO DELL’IDENTITÀ NELLO SVILUPPO
TURISTICO DEI TERRITORI MINORI IN EUROPA
Michele Sabatino Assistant Professor di Politica Economica nell’Università Kore di Enna
ABSTRACT: Il turismo ha sempre avuto e continuerà ad avere nel futuro un grandissimo potenziale dal
punto di vista culturale, politico ed economico. In Italia, malgrado la numerosa letteratura
specialistica e la ricchezza delle proprie risorse naturali e culturali, il turismo resta rilegato a un
ruolo di secondo ordine tra le priorità dei policy maker e non riesce ad esercitare quella funzione di
sviluppo che gli spetterebbe sia rispetto alla questione dei grandi poli turistici e culturali di attrazione
sia e soprattutto rispetto al patrimonio diffuso nei territori c.d. minori. L’articolo intende suggerire i
principali tratti di un percorso di sviluppo sostenibile attraverso l’analisi dei territori c.d. minori e/o
lenti. Allontanandoci da una visione esclusivamente economicistica si possono, infatti, individuare
nuove traiettorie di sviluppo sostenibile in cui le identità territoriali, la storia locale, il capitale
sociale, il patrimonio culturale e umano, diventano fattori strategici ed innovativi di qualsiasi politica
di sviluppo sostenibile. Tali fattori possono essere quindi le pre-condizioni in grado di generare
innovazione e sviluppo in un territorio. In definitiva l’articolo propone l’ipotesi di un sentiero di
sviluppo sostenibile da parte dei c.d. territori minori o lenti attraverso l’adesione ad un modello di
sviluppo fondato sullo stretto legame tra heritage e turismo, tra valore della cultura e del territorio e
rigenerazione socio-economica, tra tradizione ed innovazione in un approccio distrettuale in cui il
territorio, con la sua storia, tradizioni, identità costituisce un valore competitivo difficilmente
riproducibile
PAROLE CHIAVE: Identità locale, Territori “minori”, Turismo, Sviluppo locale, Capitale sociale
1. Introduzione
Il turismo ha sempre avuto e continuerà ad avere nel futuro un grandissimo potenziale
dal punto di vista culturale, politico ed economico. I viaggiatori internazionali nel 1980 erano
277 milioni e oggi superano il miliardo. Secondo le ultime stime dell'agenzia dell’ONU il
settore continuerà a crescere mediamente del 3,3% l’anno fino al 2030, con un’aggiunta di
oltre 40 milioni di nuovi turisti ogni 12 mesi e un totale di 1,8 miliardi di viaggiatori
internazionali tra meno di 20 anni, molti dei quali provenienti dalle economie emergenti:
Cina, Brasile, India e Russi in primis1. Crescita culturale, integrazione e sviluppo economico
rappresentano alcune delle opportunità che vanno considerate in questo scenario multipolare.
1 UNWTO, Tourism Highlights, 2012.

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
In Italia il turismo, malgrado la numerosa letteratura specialistica e la ricchezza delle
proprie risorse naturali e culturali, resta rilegata ad un ruolo di secondo ordine tra le priorità
dei policy maker e non riesce ad esercitare quella funzione di sviluppo che le spetterebbe sia
rispetto ai grandi poli turistici e culturali di attrazione sia e soprattutto rispetto al patrimonio
diffuso dei territori c.d. minori.
In questo contesto si intendono suggerire i principali tratti di un percorso di sviluppo
sostenibile attraverso l’analisi dei territori minori, che vengono definiti lenti. Una possibile
metodologia di lavoro è quella di partire quindi da una nuova visione del territorio, che
attribuisce valore alle identità, al capitale sociale e al patrimonio culturale autoctono,
analizzando le relazioni tra comunità locali, identità e politiche di sviluppo sostenibile.
Allontanandoci quindi da una visione esclusivamente economicistica si possono individuare
nuove traiettorie di sviluppo sostenibile in cui le identità territoriali, la storia locale, il capitale
sociale, il patrimonio culturale e umano, diventano fattori strategici ed innovativi di qualsiasi
politica di sviluppo sostenibile.
Particolare attenzione dovrà quindi essere rivolta alla nozione di identità locale e di
capitale sociale evidenziando lo stretto legame tra questi fattori che fanno riferimento ad
ambiti relazionali presenti in un determinato contesto territoriale. Tali fattori possono essere
le pre-condizioni in grado di generare innovazione e sviluppo in quanto il territorio non è solo
il luogo in cui si accumulano e sedimentano conoscenze e capitale ma nel quale
dinamicamente si rinnovano, si riproducono e di espandono.
L’ultima sezione del presente lavoro presenterà quindi le possibilità di un sentiero di
sviluppo sostenibile da parte dei c.d. territori minori o lenti attraverso l’adesione ad un
modello di sviluppo fondato sullo stretto legame tra heritage e turismo, tra valore della
cultura e del territorio e rigenerazione socio-economica, tra tradizione ed innovazione in un
approccio distrettuale in cui il territorio, con la sua storia, tradizioni, identità costituisce un
valore competitivo difficilmente riproducibile.

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
2. Identità locali, territori “lenti” e turismo
Negli ultimi anni diversi territori hanno attivato processi di sviluppo investendo sulla
valorizzazione delle identità locali, sull'attenzione per l'ambiente e per il patrimonio culturale
e umano, rendendo evidente la propria componente estetica e relazionale. Territorio e identità
permettono di creare nuove reti di relazione che vanno oltre i luoghi, verso modelli di
sviluppo locale e anche turistici che hanno bisogno di coesione sociale e autenticità ma che
promuovono sviluppo e competitività. Questi due fattori infatti, costituiscono quel patrimonio
intangibile, capace non solo di incrementarne il valore aggiunto, la competitività e la
visibilità, ma anche di promuovere il benessere della comunità locale.
Tali fattori sono gli elementi costitutivi di una nuova politica di sviluppo sostenibile a
favore del turismo dei territori c.d. “minori” o più precisamente, in una recente bibliografia,
“lenti”2. Questi territori, considerati marginali rispetto ai tradizionali flussi turistici ed
economici (vedi il caso dell’entroterra siciliano), riescono spesso ad individuare nel territorio,
nella sua peculiarità storica, antropologica e culturale, un fattore competitivo importante in
cui si rafforzano interessi e identità collettive e in cui la coesione sociale rappresenta un
valore aggiunto capace di promuovere distretti di qualità. Oggi viviamo una fase di ri-
personalizzazione dell’economia e quindi anche dello spazio fisico, che pone al centro i
significati elaborati dalle persone e conferiti ai luoghi3.
Recentemente numerosi territori del Sud d’Italia ma anche nel resto dell’Europa, anche
con il sostegno di risorse comunitarie, hanno attivato autonomi percorsi di sviluppo locale
attraverso la valorizzazione delle proprie identità locali, dell’ambiente naturale e del
paesaggio, delle tradizioni storiche ed enogastronomiche nonché dei beni culturali e artistici
raccontando se stessi nel tempo e nello spazio. Si tratta di territori che si contraddistinguono
per una alta qualità della vita e del paesaggio urbano e rurale, sistemi relazionali profondi e
ampi, cultura, tradizione, storia. Il sistema economico produttivo non è l’unico elemento in
grado di generare creazione di reddito ma si inserisce in un più ampio sistema di creazione
2 CALZATI, Territori lenti, nuove traiettorie di sviluppo, Milano, 2011. 3 BONOMI e RULLANI, Il capitalismo personale. Vite al lavoro. Torino, 2005.

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
della ricchezza locale nel quale sono compresi il patrimonio storico-artistico, il sistema delle
reciprocità umane e territoriali, la coesione sociale e il c.d. “capitale sociale”.
Tali territori c.d. “lenti” non evidenziano una situazione di ritardo o arretratezza
economica e sociale troppo marcata ma semplicemente mostrano tassi di sviluppo non
accelerati ma orientati alla crescita e alla qualità della vita. In alcuni di questi al centro del
sentiero di sviluppo non vi è solo la capacità del sistema produttivo di generare reddito e
occupazione dal settore manifatturiero tradizionale ma dalla combinazione di patrimonio
ambientale e artistico, capitale umano e relazionale, strumenti locali di gestione in grado di
generare crescita e ricchezza diffusa. Generalmente questi tipi di territori si
contraddistinguono per la bassa densità demografica, la presenza di un contesto rurale con una
antica tradizione agricola e una significativa percentuale di addetti nell’agricoltura, con un
patrimonio storico e artistico di qualità e una presenza diffusa di un sistema di piccole
imprese nel settore artigianale tipico. I modelli di sviluppo proposti sono quelli in cui si
segnalano attività agricole con produzioni tipiche di qualità, turismo sostenibile e diffuso di
attrattività e ospitalità (agriturismi, bed & breakfast, paesi-albergo, ect...), attività culturali
orientate alle tradizioni e alla storia locale, attività produttive di tipo artigianale
multisettoriale. Non sono riconoscibili quei territori in cui sono presenti modelli che si
fondono su un unico fattore di sviluppo quale appunto un polo industriale e produttivo,
squilibri demografici e condizioni di degrado ambientale significativo.
Non siamo lontani dalla messa in discussione del concetto di crescita come sinonimo di
“sviluppo” ma anzi dalla sua ri-definizione attraverso la consapevolezza di un concetto di
sviluppo più ampio e omnicomprensivo dove sono coinvolti la qualità della vita, gli aspetti
umani, culturali e relazionali. In questo ambito di discussione, ormai ad uno stadio avanzato,
si matura la consapevolezza della diversità tra crescita quantitativa di indicatori quali appunto
il PIL – Prodotto Interno Lordo o comunque in generale di qualsiasi grandezza quantitativa,
dal concetto di sviluppo in grado di individuare cambiamenti strutturali dell’economia e della
società e che comporta l’utilizzo di parametri di misurazione nuovi e diversi in grado di
misurare beni intangibili quali la fiducia, la coesione sociale, il grado di felicità e benessere, la
qualità della vita. Si tratta di utilizzare quindi strumenti di valutazione qualitativi e

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
quantitativi dell’economia (valutazione multicriteriale) in grado di cogliere la natura
multidimensionale dello sviluppo, inteso come sviluppo sostenibile, comprendendo gli aspetti
economici, ambientali, sociali, culturali, umani e relazionali.
I contributi teorici sono numerosi a partire da BRINKMAN secondo cui il problema vada
ricercato nell’errore teorico commesso dalla teoria neoclassica della crescita che reputa tuttora
che crescita economica e sviluppo economico siano concettualmente equivalenti, in quanto
non assegna allo sviluppo economico gli aspetti della dinamica del cambiamento tecnologico,
e quindi trascura il suo impatto sul sistema economico e l’importanza delle trasformazioni e
degli aggiustamenti istituzionali. BRINKMAN afferma che molto probabilmente il problema
dell’approccio neoclassico risieda nell’ossessione di voler costruire dei modelli in cui si fa
un’analisi statica tralasciando la spiegazione delle trasformazioni (lo sviluppo) che avvengono
tra le varie posizioni di equilibrio4.
L’approccio che si concentra sulla crescita è perciò un approccio limitato e imperfetto
che ignora il carattere multidimensionale e plurale dei problemi legati allo sviluppo. Solo
recentemente le contrapposizioni teoriche tra crescita/sviluppo, anche grazie alle nuove forme
di green economy e soft economy, si sono ridimensionate, con la consapevolezza di un
concetto di sviluppo più ampio non dimenticando la sostenibilità delle risorse del pianeta e
dell’ambiente.
Questa visione multidimensionale dello sviluppo, che richiede l’adozione di misure in
grado di rappresentare i vari aspetti dello sviluppo sostenibile (vedi la Commissione Stigliz
sulla misura delle prestazioni economiche e del progresso sociale - 2009), costituisce
l’approccio più adeguato a qualsiasi politica di sviluppo dei territori “minori” o “lenti”. I
territori lenti infatti miscelano diverse forme di innovazione, partecipazione e coesione che
possono consentire di uscire dai margini economici e statistici e posizionarsi come aree
distrettuali competitive in grado di promuovere uno sviluppo diffuso e sostenibile. Si tratta di
segnalare quei fattori immateriali quali appunto l’identità locale, le relazione di reciprocità, il
4 BRINKMAN, Economic growth versus economic development: toward a conceptual clarification, Portland State,
1995.

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
capitale sociale e i sistemi di governance istituzionali che sono in grado di generare un
percorso innovativo di sviluppo turistico locale.
In tale contesto la valorizzazione del territorio passa attraverso quegli elementi
intangibili come l’identità locale e il capitale sociale che costituiscono l’architrave culturale
su cui attivare nuove dinamiche di sviluppo locale e territoriale.
3. Il capitale sociale come elemento di sviluppo
Il capitale sociale è un concetto relativamente recente e utilizzato in vari contesti di
ricerca e di studio (economia, sociologia, scienze politiche, management e studi di sviluppo).
La complessità legata alla sua multidimensionalità e alla forte componente immateriale che lo
caratterizza ha condotto gli studiosi nel corso degli anni a sviluppare varie definizioni di
capitale sociale, seguendo talvolta approcci differenti. Gli autori principali sono BOURDIEU
COLEMAN, PUTNAM e FUKUYAMA.
BOURDIEU definisce il capitale sociale come “the aggregate of the actual or potential
resources which are linked to possessions of a durable network of more or less
institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition - or in other words to
membership of a group - which provides each of its members with the backing of the
collectivity-owned capital, a “credential” which entitles them to credit, in the various senses
of the word.”. Il suo approccio si concentra sul singolo individuo, il quale sviluppa una rete
stabile di relazioni più o meno istituzionalizzate al fine di perseguire i propri obiettivi e
migliorare la propria posizione sociale. Al contrario la visione di COLEMAN si concentra sui
gruppi sociali, le organizzazioni e le società. In questo caso il capitale sociale non è
considerato un’entità singola che risiede nell’individuo ma come un’entità collettiva che
risiede nella struttura delle relazioni sociali.
PUTNAM introduce il concetto di fiducia e partecipazione civica come elementi che
possono migliorare l’efficienza della società, determinando la considerazione del concetto di
capitale sociale nei temi politici e di sviluppo. L’autore definisce il capitale sociale come
“features of social organization, such as trust, norms, and networks, that can improve the
efficiency of society by facilitating coordinated actions”.

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
FUKUYAMA si concentra invece sui meccanismi di regolazione delle relazioni sociali e
definisce il capitale sociale come “the existence of a certain set of informal values or norms
shared among members of a group that permit cooperation among them”.
In prevalenza dunque le definizioni analizzate considerano il capitale sociale una risorsa
collettiva che dipende dalle relazioni che si instaurano all’interno dell’organizzazione sociale
e dalla loro stabilità nel tempo e dipendenza reciproca. Tali relazioni sociali innescano risorse
cognitive o normative che generano reti formali e fiduciarie in grado di stimolare la
cooperazione producendo valori simbolici.
Esistono varie classificazioni sviluppate negli anni dai vari studiosi per identificare le
dimensioni che compongono il concetto di capitale sociale. NAHAPIET e GHOSHAL
identificano tre dimensioni: strutturale, relazionale e cognitiva. KRISHNA e UPHOFF
considerano le dimensioni strutturale e normativa mentre CHOU e MODENA parlano di aspetti
strutturali e culturali (cognitivi).
È possibile dunque ricondurre i vari approcci presenti in letteratura a tre principali
dimensioni del capitale sociale:
- strutturale, legata alle forme di organizzazione sociale che permettono la relazione fra
gli attori di una comunità. Vengono definiti reti o network e permettono la eguale diffusione
della conoscenza al proprio interno generando una risorsa del sistema;
- normativa, riguarda i meccanismi che regolano le relazioni fra gli individui
ricollegabile a fattori quali la fiducia e la reciprocità che favoriscono la cooperazione
all’interno del sistema;
- cognitiva, i valori e le credenze che caratterizzano la cultura locale. PUTNAM sviluppa
il concetto di civicness inteso come lo sviluppo di valori etico-sociali condivisi conformando
il proprio interesse a quello della società.
Nella letteratura economica italiana il capitale sociale viene definito come
sedimentazione di ciò che viene investito nelle strutture relazionali fra individui e
organizzazioni. Stiamo parlando di beni collettivi di tipo relazionale tra attori che consentono
la diffusione di conoscenze e informazioni riducendo i costi di diffusione e favorendo la
capacità di coordinamento.

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
GASTALDI propone di estendere il concetto di capitale sociale legando fra loro
caratteristiche sociali, economiche, e culturali di un luogo e le specificità territoriali in una
logica dinamica. Sviluppa quindi il concetto di Capitale Sociale Territoriale (CST) inteso come
“il luogo delle interrelazioni tra risorse territoriali e risorse socio-culturali, funzionale alla loro
reciproca valorizzazione, alla crescita dell’identità e allo sviluppo locale”.
La visione più statica legata alle componenti storiche e culturali del capitale sociale è
stata riconsiderata infine in maniera dinamica in grado di adattarsi secondo le risorse anche
potenziali del territorio.
Il capitale sociale territoriale è quindi una caratteristica specifica di ogni territorio che
può essere più o meno “attiva” o “attivabile” in base al senso dell’imprenditorialità, alla
capacità di sviluppare una visione creativa del futuro, alla capacità di anticipare e prevedere
scenari, di programmare azioni, di tutelare risorse scarse, alla capacità di saper cogliere e
reinterpretare segnali esterni ed innovazioni.
Pertanto se i territori ai margini dello sviluppo urbano e industriale erano stati
considerati come aree avverse all’innovazione anche a causa della scarsità delle risorse e
dell’arretratezza culturale dei suoi attori politici, economici e sociali, nella nuove visione
post-fordista, in cui le nuove tecnologie della comunicazione svolgono un ruolo trainante, i
territori considerati ai margini, ostili alla innovazione, finiscono per divenire protagonisti di
uno sviluppo alternativo e possibile.
L’applicazione del concetto di capitale sociale al turismo e al territorio è, anche questa,
abbastanza recente e sono ancora limitati gli studi legati al ruolo giocato dal capitale sociale
per lo sviluppo locale delle destinazioni turistiche. La visione che accomuna tali studi è
tuttavia la capacità del capitale sociale di influenzare la partecipazione della comunità nello
sviluppo turistico dell’area.
4. Identità locali e comportamenti turistici
Nei territori c.d. minori, portatori quindi di una visione innovativa del territorio come
valore, in cui è presente in maniera più marcata la divergenza tra qualità della vita e crescita
del PIL, l’identità locale, come anche il capitale sociale, costituisce una componente

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
importante del sistema turistico del territorio. Un territorio infatti si definisce oggi anche per
la sua identità, ossia per l’insieme di tutte quelle componenti costruite attorno ad un progetto
di trasformazione continua e si rinnova attraverso processi di modernizzazione.
Nella più recente letteratura un territorio si definisce infatti attraverso il coordinamento
di componenti geografiche, naturalistiche, paesaggistiche, antropiche e storiche. Tuttavia per
essere definito e/o definibile come tale ha bisogno di una sua coerenza: quale appunto
l'identità locale. Il territorio è quindi formato anche da aspetti riconducibili all’identità
territoriali e alle popolazioni che lo abitano e grazie ai quali si struttura ciò che è stata definita
“soggettività locale” 5.
In questo quadro il territorio, in quanto composto da fattori storici, culturali e sociali
nonché di organizzazione della produzione e dei processi di cambiamento economico, non
può non svolgere che un ruolo attivo nello sviluppo dell’area stessa. Il territorio diviene luogo
dove hanno origine relazioni e competenze e dove si scambiano informazioni e conoscenze.
L’identità locale quindi è intesa in una duplice accezione: come percezione e
rappresentazione di sé da parte degli attori del territorio e come un luogo viene percepito
dall’esterno. La prima concorre alla costruzione della vision di un intero territorio mentre la
seconda assume un ruolo fondamentale nella valorizzazione e promozione turistica di un
territorio6.
I dati più recenti sui comportamenti turistici degli europei confermano, inoltre, come
l’identità delle località visitate risulti un elemento determinante nella scelta delle destinazioni
turistiche, attuata dalla maggioranza dei casi (32%) sulla base dell’ambiente locale inteso
nell’accezione di attrattività globale dei luoghi (Commissione UE, 2010).
Le più recenti indagini di mercato, d’altro canto, indicano chiaramente quanto ormai il
turista-viaggiatore intenda sempre più la “vacanza” come un’esperienza personale che deve
essere il più possibile autentica, quanto ormai sia stuzzicato da nuove motivazioni culturali e
tentato dalla riscoperta delle tradizioni locali, con una forte propensione a forme alternative di
ricettività quali bed & breakfast, agriturismi, soggiorni in castelli e residenze storiche.
5 SAVELLI, Turismo, territorio e identità, Milano, 2004. 6 CALZATI, Il ruolo dell’identità, capitale sociale e certificazione territoriali, Perugia, 2012.

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
In Italia la domanda legata all’ospitalità nei territori e centri urbani “minori”, al di fuori
dei tradizionali percorsi turistici, e legata ai prodotti dell’enogastronomia e alla scoperta del
patrimonio artistico ed architettonico, degli usi e dei costumi delle comunità locali, è in
costante aumento. Il turismo culturale, che si muove alla scoperta del nostro ampio
patrimonio, fatto di città d’arte, di eventi, di manifestazioni, e di tradizioni enogastronomiche
e religiose, fa registrare, meglio delle altre tipologie di turismo, un andamento positivo, con
tassi di crescita medi, negli ultimi anni, del 5-8%. La valenza peculiare del sistema della
tipicità italiana, fondata su paesaggio, valori ambientali, patrimonio artistico e monumentale,
cultura, varietà gastronomiche, consente sempre più di parlare di una risorsa strategica per
l’economia italiana e soprattutto per quella dei territori in ritardo di sviluppo.
In tutto ciò acquista importanza il legame tra la percezione del turista da una parte e
l’identità e l’immagine del territorio dall’altra. E’ necessario allora, prima di parlare di
politiche per il turismo, sia a livello comunitario che nazionale e territoriale, individuare
l’identità che un dato territorio possiede (o è in grado di esprimere), per poi svilupparne
un’immagine turistica e monitorare quanto entrambe confluiscano nella percezione dei turisti.
È’ questa identità territoriale, adeguatamente delineata, che può porsi come premessa
fondamentale di quello sviluppo che metterebbe in grado gli attori territoriali di presentare al
mercato offerte turistiche che non sfruttano il territorio ma, anzi, lo potenziano.
Il turismo si trasforma quindi in un elemento innovativo, potenzialmente in grado di
rafforzare la ricchezza immateriale e il senso di appartenenza di una comunità al suo
territorio. Per raggiungere lo scopo è però necessaria un’interazione stretta con la comunità,
per rafforzarne il suo senso d’appartenenza al territorio, accelerando nel contempo
l’interazione anche con gli altri settori dell’economia locale. In una parola c’è bisogno di un
quadro istituzionale e politico adeguato a questo scopo.
5. Politiche di sviluppo turistico dei territori minori in Europa
Il turismo, ed in particolare il turismo nelle aree di ritardo di sviluppo dell’Unione
Europea, soffre di una difficile dicotomia: preservare e conservare le risorse che un territorio
può offrire, da un lato; valorizzarle e “sfruttarle”, dall’altro.

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
Sono ormai anni che l’Unione Europea considera il turismo una risorsa economica
rilevante: lo sviluppo economico e competitivo degli Stati membri passa anche attraverso la
valorizzazione e la promozione turistica del territorio; per questo motivo sono numerosi i
pareri e i programmi europei che dettano disposizioni e prevedono interventi per questo
settore, mettendo le risorse culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche al centro degli
interventi. Non a caso, il Comitato economico e sociale europeo, ha approvato un parere sul
tema “Turismo e cultura: due forze al servizio della crescita” (2006), nel quale sottolinea
come questi due settori possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi della crescita e
dell’occupazione definiti dalla Strategia di Lisbona. Valorizzare e sviluppare questo settore
significa creare nuove opportunità di sviluppo e di crescita degli Stati membri in generale e
delle realtà di minore dimensione demografica in particolare. Il parere individua inoltre
quattro segmenti di turismo culturale, legati a: patrimonio artistico; eventi, mostre e
manifestazioni; enogastronomia e turismo rurale; parchi tematici e culturali e sottolinea come
la presenza di questi fattori indirizzi sempre più spesso le scelte dei turisti.
In linea con gli indirizzi contenuti del parere del Comitato economico e sociale anche
l’ultimo Quadro Comunitario di Sostegno 2007 – 2013 ha riconosciuto la valenza strategica
del turismo per le regioni in ritardo di competitività. L’obiettivo dichiarato della
valorizzazione delle risorse naturali e culturali è necessario per aumentare l’attrattività anche
turistica dei territori minori attraverso una strategia che tenga conto di tutte le risorse presenti
sul territorio.
In coerenza con quanto detto, sia a livello comunitario che anche in ambito nazionale
attraverso i recenti documenti strategici in materia di turismo7, nei territori minori si evidenzia
quindi, in termini di policy, la necessità di “fare sistema” al fine di superare la connotazione
settoriale del turismo e di restituirlo ad un vocazione multidimensionale in grado di
coinvolgere l’intero territorio e la popolazione che lo compone. Si deve stabilire quindi la
necessità di costituire un “patto sociale territoriale” nel promuovere l’accoglienza e la
permanenza del turista consumatore viaggiatore. I territori devono individuare un capitale
7 Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del Turismo “Italia 2020” – Ministero del turismo e dello Sport –
2012.

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
www.koreuropa.eu
sociale disponibile in grado di: definire una offerta turistica differenziata ed integrata nei
contenuti e nei valori, rispondendo all’attuale domanda di consumo turistico e di vacanza che
si traduce in un nuovo “stile di consumo” orientato alle relazioni, all’incontro, allo scambio,
all’esperienza. Necessitano quindi politiche di gestione integrata delle risorse naturali e
culturali (con forme sinergiche pubblico-privato), dell’attivazioni di politiche bottom-up, di
cooperazione e concertazione, di nuovi strumenti di certificazione e identificazione (brand
turistico), di organizzazione dell’accoglienza in modo diffuso e con basso impatto (B&B,
agriturismi, ostelli, ect...), di formazione delle risorse umane e professionali ma soprattutto dei
servizi di accoglienza e accompagnamento.
Si tratta in definitiva di immaginare uno sviluppo sostenibile dei territori c.d. “minori” o
“lenti” che sappiamo proporre al turista viaggiatore una esperienza unica e speciale in forte
contatto con la comunità locale e con la sua identità.
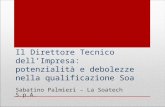
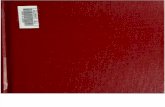
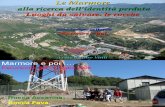

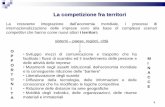
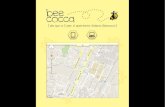
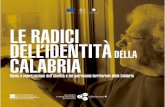




![[Progetto TAG] L'evoluzione dell'Identità Online, il Personal Branding](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/54632e25b4af9f671c8b4af9/progetto-tag-levoluzione-dellidentita-online-il-personal-branding.jpg)