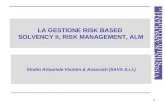RISK Numero 6
-
Upload
risk-rivista -
Category
Documents
-
view
231 -
download
0
description
Transcript of RISK Numero 6



riskriskQUADERNI DI GEOSTRATEGIA


• COMMENTARI •Il lugubre link
(tra crisi economica e guerre)Oscar Giannino
pagina 4
• DOSSIER •
Una coabitazione difficileStefano Silvestri
Il ritorno di TsahalAndrea Nativi
Il nuovo volto di HamasAndrea Margelletti
Ai Qassam si risponde cosìPietro Batacchi
Obama al fianco di GerusalemmeWalter Russel Mead
pagine 10/49
• Editoriali •
Michele NonesStranamorepagine 50/51
• SCENARI •
Chi sostiene il fanatismo di Ahmadinejad?Gennaro Malgieri
Perché non bisogna mollare KarzaiAhmad Majidyar
La politica industriale non è più un tabùFabrizio Braghini
pagine 52/75
• SCACCHIERE •Unione EuropeaGiovanni Gasparini
BalcaniFabrizio EdomarchiAmerica Latina
Riccardo Gefter Wondrich
RussiaDavid J. Smith
AfricaEgizia Gattamorta
pagine 76/87
• LA STORIA •
Virgilio Ilaripagine 88/93
• LIBRERIA •
Mario ArpinoLudovico Incisa di Camerana
Andrea TaniMauro Canalipagine 94/107
• RUBRICHE •
Beniamino Irdi Pierre Chiartanopagine 108/111
quaderni di geostrategiaS O M M A R I O
riskrisk
Editore Filadelfia, società cooperativa di giornalisti, via della Panetteria, 12 - 00187 Roma.Redazione via della Panetteria, 12 - 00187 Roma.
Tel 06/6796559 Fax 06/6991529 email [email protected]
Amministrazione: Cinzia RotondiAbbonamenti: 40 euro l’anno Stampa Gruppo Colacresi s.r.l.
via Dorando Petri, 20 - 00011 - Bagni di Tivoli Distribuzione Parrini s.p.a. - via Vitorchiano, 81 00189 Roma
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA N. 283 DEL 23 GIUGNO 2000
50
DIRETTOREAndrea Nativi
CAPOREDATTORELuisa Arezzo
COMITATO SCIENTIFICOMichele Nones
(Presidente)Ferdinando Adornato
Mario ArpinoEnzo Benigni
Vincenzo CamporiniAmedeo Caporaletti
Carlo FinizioRenzo Foa
Giovanni GaspariniPier Francesco Guarguaglini
Virgilio IlariCarlo Jean
Alessandro Minuto RizzoRemo Pertica
Luigi RamponiStefano Silvestri
Guido VenturoniGiorgio Zappa
RUBRICHEArpino, Incisa di Camerana,
Chiartano, Ilari, Irdi, J. Smith, Gasparini, Gattamorta, GefterWondrich, Ottolenghi, Tani

4
IL LUGUBRE LINK(TRA CRISI ECONOMICA E GUERRE)
DI OSCAR GIANNINO
CommentariC
iamo nel pieno di una crisifinanziaria di quelle che - seriestoriche alla mano - si vedonouna volta nell’arco della pro-pria vita. Era trascorso giàoltre un anno e mezzo dai suoiprimi evidenti segnali quando,
il 15 settembre 2008 - con la decisione dei regolato-ri Usa di lasciar fallire Lehman Brothers - la crisi siè a quel punto diffusa in tempi strettissimi sull’inte-ra catena d’intermediazione bancaria e finanziariamondiale, per immediatamente riverberare i suoiaspri effetti restrittivi sull’economia reale. È la finedi un paradigma finanziario: quello che ha fattotesto per un ventennio, basato sull’intermediazionead alta leva, bassa congruità patrimoniale, tecnichedi diluizione e annullamento della responsabilitàpatrimoniale degli intermediari stessi per i rischi dicontroparte assunti attraverso classi intere di prodot-ti e servizi finanziari, impacchettati in pooling eceduti a terzi. È la fine di un paradigma geopolitico,basato sull’alto consumo degli Usa finanziato adebito privato, dai Paesi del Far East che così si assi-curavano mercati ad alto assorbimento delle propriemerci a basso costo, e in cambio sostenendo i defi-cit di bilancia commerciale e dei pagamenti Usainvestendovi l’eccesso di risorse così ottenuto, con
alti rendimenti garantiti dall’elevata remunerativitàdel capitale finanziario grazie al primo paradigma. Ed è insieme la fine di un paradigma monetario,quello che ha spinto per anni la Fed americana a pra-ticare una politica “lasca” in anni di forte crescita,con indifferenza agli effetti di instabilità teorizzatiinvece dall’offertismo monetarista: la Fed ha opera-to sulla base della convinzione che la superiore pro-duttività Usa si basava assai più sugli effetti degliinvestimenti in Itc - un dato di economia “reale” -che sull’elevata, e sempre più rischiosa, alta redditi-vità del capitale finanziario “in bolla”. Le cancelle-rie e le elite politico-finanziarie si interrogano orasui tempi della recessione mondiale, sugli strumen-ti per affrontarla e sulle migliori modalità, se condi-vise a livello internazionale o praticate in merocoordinamento ma secondo priorità e possibilitànazionali dai diversi Paesi. Ognuno dei tre paradig-mi saltati indica in realtà rimedi e modalità diverse. Il primo - quello finanziario - richiede una revisioneprofonda degli standard e delle regole seguite innan-zitutto dai regolatori finanziari americani, e consi-glia che le prassi e le revisioni normative siano il piùpossibile condivise dai regolatori di tutti i sistemifinanziari avanzati. Si tratta di stabilire nuovi requi-siti per i coefficienti patrimoniali per unità di capita-le intermediata e relativo rischio di controparte da
•
•SS

commentari
55
parte degli intermediari finanziari, di modalità divalutazione degli attivi patrimoniali, di profondeinnovazioni per quanto riguarda le agenzie deirating, il loro ruolo e le loro modalità operative. IlFinancial Stability Forum coordinato dal governato-re della Banca d’Italia Mario Draghi è al lavoro conbuona lena da mesi, ma innanzitutto occorre capireche cosa davvero vorrà fare il nuovo “dream team”dei superconsiglieri economici di Obama, nei primimesi dopo l’insediamento della nuova amministra-zione. Il secondo - quello geoconomico - sospinge inevita-bilmente il grande malato da cui l’epidemia ha ori-gine, gli Usa, a riavviare al più presto su nuove basiil meccanismo di reciproca convenienza con il FarEast, in modo da riattivare la crescita del commer-
cio mondiale e assicurarsi l’eccesso di risparmiocolà maturato, al fine di rendere meno “duro” l’at-terraggio di milioni di consumatori e lavoratori Usa,chiamati ad allineare la propria capacità di consumoalle proprie capacità di risparmio, negative da alcu-ni anni. Il tallone monetario di tali accordi commer-ciali resta saldamente il dollaro, al quale sono lega-ti da accordi di cambio semi-fissi le valute di unaventina di Paesi emergenti la cui crescita ha sospin-to il mondo negli anni precedenti l’attuale crisi. Il terzo - quello monetario - è purtroppo sostanzial-mente un problema americano, ma come detto eser-citerà riflessi immediati, attraverso il dollaro, sulleragioni di scambio in tutto il mondo. La breve premessa è obbligata per limitarsi a inqua-drare il problema. Nella consapevolezza che i quat-tro cantoni del mondo sviluppato nutrono interessi aparole convergenti - riavviare commercio e consumi- ma in realtà divergenti. Stati Uniti, Unione euro-
pea, Paesi detentori di risorse finanziarie e Nazionidepositarie di risorse energetiche sono i quattro can-toni di un “grande gioco” in cui ogni vertice del qua-drilatero persegue un interesse proprio preminente.Per gli Usa, non scalfire di troppo la precedente ege-monia finanziaria e politica - stante che la leadershipmilitare è intaccata, ma ben assicurata dal bilanciodel Pentagono. Per Cina e Far East, si tratta divedersi confermato il drive di crescita triplo e qua-druplo rispetto ai Paesi Ocse, come premessa perrecuperare il gap storico accumulato nelle propriearcaiche strutture sociali e produttive. Per i Paesi“energetici”, come Russia e blocco Opec, si tratta dinon vedersi brutalmente ridotte royalties e tassi dicrescita, come sta avvenendo in questi ultimi mesicon il precipizio dove è caduto il prezzo del barile.
Ma una volta fatta la premessa, occorre com-piere un passo indietro. C’è un legame diretto e con-creto tra crisi economiche e conflitti militari? Leprime segnano lo spartiacque tra fasi in cui accele-razioni tecnologiche, innovazioni finanziarie, ege-monie commerciali e di materie prime declinano,per trapassare nel tempo a nuovi detentori. I conflit-ti sono direttamente connessi alle crisi, con ciclicitàe legami causali che continuano ad alimentare unappassionante dibattito tra gli studiosi.Nell’informazione quotidiana offerta dai mediageneralisti si tende a credere che nel mondo odiernole fasi belliche siano per così dire “bandite” dall’or-dinarietà, ridotte a meri episodi di traumatica, maeccezionale occorrenza, rispetto a un ordine mon-diale sempre più evolutosi verso l’eliminazione deiconfronti militari, con questi sempre più ridotti a“tensioni d’area” sfuggite di mano ad attori incapa-ci o falliti.In realtà non è affatto così. Si tratta di una
Da Gray a Goldstein, da Chase Dunn a Modelski: ben prima del crollodella Leheman & Brothers era stato previsto il tracollo della supremazia
statunitense. Perché le egemonie mondiali che caratterizzano le fasi del capitalismo sono destinate ad affermarsi e poi a decadere

Risk
6
visione falsata, in cui l’irenismo tendenziale asso-ciato al progresso di pretesi o presunti “governi delmondo” prevale su una spassionata considerazionedei fatti di medio e lungo periodo. Le tensioni diordine globale, economico-politico, trovano ancoraoggi nel ricorso alle armi la soluzione per certi versipiù “classica”, sotto molti punti di vista della scien-za come della prassi statuale e metastatuale. Stannoa comprovarlo molti studi, in questi ultimi anni esoprattutto dal cruciale 2001 in avanti. Per esempioGeorge Modelski, dell’Università di Washington, el’italiano professor Fulvio Attinà hanno messo inevidenza come molti segnali mostrino quanto siadifficile sottrarsi al ciclo fatale delle trasformazionidelle leadership globali e dell’aumento delle tensio-ni - anche e necessariamente militari - tra competi-tori globali. Sin da metà degli anni Sessanta è indeclino l’indice di aggregazione nei patti di difesa,che misura la percentuale di Paesi che aderiscono adalleanze militari sul totale dei membri Onu. E ciòsuggerisce che la leadership globale degli Usa,affermatasi nel 1945, sia entrata in contrazione inmaniera analoga a quanto tra il 1850 e il 1878 avve-niva con l’avvio della delegittimazione della leader-ship imperiale britannica, seguita poi da una decon-centrazione delle alleanze nel sistema internaziona-le tra il 1878 e il 1914, fenomeno che culminò nelprimo conflitto mondiale.
L’ipotesi di studio consegnataci dalla crisifinanziaria globale e dalla recessione assai estesache ne deriva, dunque, è che la belle époque dellaglobalizzazione 1970-2007 non ci lasci certo in ere-dità un mondo più stabile, né pacifico perché piùequilibrato ed egualitario.Gli approcci moralisti alle diverse fasi del succeder-si dei sistemi di equilibrio non si lasciano affascina-re da tesi sociologico-giornalistiche alla “fine dellastoria” di Francis Fukuyama. Dai tempi di NikolajKondratiev in avanti, è di concreti indicatori econo-mici che si nutre la teoria dei cicli lunghi della con-giuntura, secondo la quale l’economia procede a
grandi ondate successive, che generano inevitabil-mente grandi conflitti. Kondratiev era direttore aMosca dell’Istituto per lo Studio della Congiuntura,e cadde vittima della prima “purga” staliniana nel1928, per morire in un gulag dieci anni dopo. Hadovuto attendere la riabilitazione sino al 1987. Mala sua metodologia di studio comparato di serie sto-riche di una pluralità di variabili economiche didiverse nazioni che, statisticamente trattate, indica-vano un andamento in crescendo per una fase e poiun calo a seguire, continua a offrire un’utile piatta-forma di strumenti per comprendere la relazione traeconomia e conflitti. Non è affatto detto che i ciclisiano cinquantennali come Kondratiev inferiva, per-ché le innovazioni tecnologiche e finanziarie sonoaccelerate, nel mondo contemporaneo. Ma continuaad avere fondamento il suo presupposto, per il qualelo sviluppo è catalizzato nel lungo periodo da gran-di investimenti in “beni capitali fondamentali” cherichiedono ingenti disponibilità finanziarie per esse-re realizzati, e un lungo periodo di logoramentoprima di essere rinnovati. Joseph Schumpeter lavo-rò su questa stessa falsariga, nell’approfondire il cri-terio delle innovazioni strategiche o epocali cheintervengono periodicamente a trasformare radical-mente la maniera capitalistica del produrre. Neglianni più recenti, molti lavori teorici come quelli delgrande Joshua Goldstein, Andre Gunder Frank,Immanuel Wallerstein e Arno Tausch hanno pun-tualmente rielaborato l’ipotesi dei cicli di Kon-dratiev, e l’analisi del declinare di egemonie econo-miche sfociate nei tre più devastanti conflitti mon-diali, la guerra dei Trent’anni 1618-1648, le guerrenapoleoniche 1793-1815, i due conflitti mondiali1914-1945. Molti di questi autori hanno applicatoallo schema interpretativo kondratieviano dati e sta-tistiche economico-commerciali relativi agli annidal 1945 a oggi, aggiungendovi anche la stima dellevittime di conflitti armati. La conclusione è che lamaggioranza degli studiosi che si dedicano a questistudi esita oggi ad abbracciare in tutto e per tutto lascuola degli andamenti cinquantennali di

7
Kondratiev, identificati in letteratura come “cicli”associati al suo nome. Ma la maggioranza di essicontinua ad essere convintz della validità ricorrentedi onde lunghe.
Ad esempio George Modelski “riorganizza”in fasi egemoniche più o meno comprendenti alme-no tre cicli cinquantennali di Kondratiev la correla-zione tra predominio economico e potenze leader.Dal 1120 al 1190 la potenza leader è Genova e il set-tore dominante di controllo il decollo di fiere comequella di Champagne. Dal 1250 al 1360 la potenzaegemone è Venezia, grazie alle spezie. Dal 1430 al1492 il Portogallo, con l’oro della Guinea Dal 1492al 1580 l’Olanda, unendo i commerci baltici conquelli asiatici. Poi la lunga egemonia britannica, dal1688 al 1850. Quando iniziano a porsi le basi del-l’egemonia americana. Ognuno di queste periodiz-zazioni ruota incentrandosi sul passaggio da unagrande guerra globale all’egemonia di una potenza
dominante, poi alla graduale e via via più spiccatadelegittimazione dell’ordine internazionale prece-dente, infine alla de-concentrazione del sistema glo-bale, e infine a una nuova guerra globale. Moltiautori che si sono confrontati con questi spunti dianalisi hanno ritenuto che fosse del tutto improbabi-le, che analoghi scenari di confrontation potesserointeressare i protagonisti del capitalismo globale delXXI secolo, e che altri soggetti - in parte o del tuttoextrastatuali - potessero candidarsi a fenomeni didestabilizzazione di caratteristiche profondamentediverse che in passato. Buona parte del filone di stu-dio dedicato al jihadismo e alla minaccia del terro-rismo fondamentalista post 11 settembre 2001 haseguito tale filone. Ma c’è anche chi ha propostoscenari del tutto diversi, assai più vicini agli spunti
di Kondratiev. Cristopher Chase-Dunn e BrucePobodnik, per esempio, ben prima della crisi attua-le, hanno avanzato l’ipotesi documentale di un’U-nione Europea ridotta a leadership germanica e che,a seguito di una crisi mondiale che spezzasse lacompartecipazione al commercio mondiale sin quicondivisa tra le due rive dell’Atlantico, divengapronta a un confronto militare contro gli Stati Uniti,non più tardi del 2020. Uno scenario che, negli ulti-mi mesi, si legge con un interesse del tutto diversoda quello di quando fu avanzato, anni fa. Quanto aImmanuel Wallerstein, risale al 2000 il suo studiosull’ipotesi di grande conflitto tra Europa e Asia,alla fine del XXI secolo, dopo decenni di crescenteinstabilità finanziaria da una parte ed energetica dal-l’altra. Al di là di ipotesi così estreme, GiovanniArrighi ritiene che il XXI secolo come oggi ci sipresenta indichi una prospettiva assai più problema-tica e instabile del previsto di empowerement del FarEast asiatico, con Stati Uniti tentati dal decoupling
ai danni dell’Europa, e di conseguenza il compitoper la Ue di rinforzare la propria capacità ed effi-cienza tecnologica e la propria influenza democrati-ca, al fine di evitare che l’equilibrio incerto tra due“costellazioni di terra ferma” possa sfociare in unosquilibrio geopolitico tale da ricalcare quello del1340, del 1560, del 1750 e del 1930, tutti associati agrandi conflitti successivi. Se seguiamo l’imposta-zione di George Modelski, gli sfidanti globali di unoscenario alla Arrighi devono essere sempre caratte-rizzati dall’interazione tra notevoli potenzialità mili-trari, estese aree d’influenza economica, societàchiuse o molto controllate, bassa libertà d’informa-zione e forti tensioni etniche risolte in chiave nazio-nalista. Le egemonie mondiali che caratterizzano lefasi del capitalismo sono destinate ad affermarsi e
Abbiamo pensato a lungo che fossero i kamikaze suicidi del jihadismo.Non abbiamo capito che erano le obbligazioni-salsiccia che avevamo
in portafoglio, il vero mezzo per mettere a rischio oggi, e forse in ginocchio domani, l’egemonia americana nel mondo
commentari

Risk
8
poi a decadere. La difficoltà è distinguere, natural-mente, i segnali di crisi delle diverse onde capitali-stiche, le crisi che ne identificano la de-concentra-zione graduale dei sistemi egemonici, rispetto poialle crisi finali. Le transizioni pacifiche da un’ege-monia all’altra rappresentano eccezioni, non regola:ricordiamocelo bene. Le grandi depressioni mon-diali hanno condotto assai più spesso ad esiti belliciper nuove egemonie, che a transizioni pacifiche econcordate. È successo così nel 1340, nel 1560 chesegna l’apogeo olandese, nella grande crisi del1750-60 che conduce all’imperialismo britannico, einfine nel 1030 che segna il suo esito definitivo.
E oggi, a quale punto della de-concentrazio-ne mondiale dell’egemonia statunitense ci trovia-mo, rispetto a precedenti analoghi che possanoessere richiamati? Siamo all’equivalente del 1870?Del 1913? Del 1938? Limitiamoci a richiamarealcune delle tesi sin qui più recentemente avanzate.Goldstein ha previsto che intorno al 2020 le attualitensioni possano sfociare in conflitti generalizzati.Chase-Dunn e Pobodnik considerano anch’essi nel-l’elevata percentuale del 50% l’ipotesi di un vastoconflitto intorno a quel cleavage temporale, e indi-cano chiaramente gli Stati Uniti in difficoltà comepotenza pronta a difendere l’egemonia declinantecon azioni armate, contrapposte a Europa e/oGiappone. Boswel ha articolato sin dal 1999 - diecianni fa - ben dieci fasi successive di declino del-l’egemonia americana, identificando tra il 2020 e il2030 l’ipotesi un conflitto neoimperiale. Attinà eModelski ritengono che l’egemonia americanaattraversi oggi un declino paragonabile a quellodella delegittimazione britannica negli anni 1850-78, e di conseguenza prevedono che seguirà solodopo una fase di deconcentrazione mondiale chepossa sfociare in vasti conflitti, ma solo entro finesecolo. Uno degli aspetti più stupefacenti di questistudi - tutti precedenti al 15 settembre 2008 in cuiLehman Brothers fallisce e la crisi economica mon-diale a lungo incubata infine esplode - è che essi
indicavano con larga convergenza il restringersidell’influenza mondiale che avrebbe interessatopilastri ideologici dell’egemonia americana nelmondo, come “libertà” e “diritti umani”. Avviene inAsia, dalla Russia alla Cina, ma avviene anchenell’Africa in generale a cominciare dal SudAfricae non solo dai failed States come Somalia, Congo eDarfur. Ma avviene anche nei Paesi occidentali, siapure in maniera assai più strisciante, per le misureadottate su terreni come la guerra al terrorismo equella all’immigrazione clandestina. Tutti gli stu-diosi convergono e sottolineano che la forza milita-re della superpotenza americana è ancora attual-mente priva di veri credibili sfidanti globali. Maidopo Roma e l’Impero, la superiorità militare diuna potenza egemone è stata così nettamente a suofavore. Ma deficit della bilancia dei pagamenti ecommerciali nell’ordine di 5 e 6 punti percentualidi Pil annuo, come quelli statunitensi, pesano assaipiù del bilancio militare assicurato al Pentagono,nel levare punti di forza all’America. Come scriveColin S. Gray, forse il più influente tra gli analististrategici nella politica americana dei più recentianni, tornato in auge dopo l’ubriacatura Netcentricadi Rumsfeld, «gli affinamenti tecnologici dellasuperiorità militare americana non possono e nondevono essere sopravvalutati, perché l’esperienzadi questi anni insegna che la sfida all’America saràasimmetrica. Paesi e forze che mirano alla decon-centrazione dell’egemonia americana lo farannoevitando accuratamente di mettere alla prova lanostra più immediata e temibile capacità di rispo-sta. La trasformazione dello scenario mondiale aseguito di una crisi finanziaria ed economica globa-le, nata nel nostro sistema americano, chiama allasbarra assai più che le nostre capacità e potenziali-tà militari: mette in crisi i nostri stessi valori, crite-ri e prassi che dalla finanza americana esercitavanoegemonia sui mercati di tutto il mondo, determi-nando le forme stesse dell’investimento e dei suoiritorni stimabili». Scriveva Kondratiev che le guerre «non cadono dal

9
cielo e non derivano dall’arbitrio di singole perso-nalità. Nascono dal sostrato dei rapporti reali, spe-cialmente economici… e si succedono con regola-re periodicità e soltanto durante la fase di ascesadelle onde lunghe, perché trovano ragione nell’ac-celerazione del ritmo e nella tensione della vitaeconomica, nella intensificata lotta per i mercati eper le fonti di materie prime». Nel 1932 l’economi-sta americano Alvin Hansen, riflettendo sugli effet-ti della Grande Depressione allora in pieno corso,condivideva appieno, e profeticamente scriveva:«non è la guerra che causa la fase di crescita dilungo periodo. Piuttosto è la lunga fase di crescita che produce lecondizioni per l’irrompere della guerra». Ma anco-ra nel 1938, pur con Hitler che annetteva Paesedopo Paese, c’era chi dissentiva. L’economista bri-tannico A. L. Macfie obiettava che «quando la fidu-cia è commista al nervosismo, quando le vertenzedel lavoro scuotono i nervi, quando i tassi d’inte-
resse sono a crescere e la prospettiva di conservareil livello dell’investimento vacilla», allora «gliumori e le sensibilità che prevalgono nelle depres-sioni non sono bellicosi: nell’affrontare le difficol-tà, si diventa autocentrici e si preferisce mettereordine al disordine esistente piuttosto che crearnedell’altro». Si è visto, purtroppo, chi aveva ragionee chi torto. Le due Grandi Guerre del ‘900 si sonoscatenate proprio quando il ritmo degli affari era alribasso, i prezzi calavano, la disoccupazioneaumentava e gli “spiriti animali” dei capitalisti lan-guivano.Si dirà che basterebbe dare retta a JohnMaynard Keynes, per evitare i conflitti dalle crisieconomiche. Non sono d’accordo. Keynes stessoscrisse che «le guerre possono servire ad accresce-re la ricchezza, se l’educazione dei nostri gover-
nanti secondo i principi dell’economia classicaimpedisce che si compia qualcosa di meglio».Venuto meno il grande confronto planetario tra Usae Urss, la ripresa della spesa militare “keynesiana”è puntualmente riavvenuta dopo ciò che nel settem-bre 2000 il Project for the New American Centuryprofeticamente quasi auspicava: «un qualche even-to catastrofico catalizzatore, una nuova PearlHarbor». Un anno dopo, era l’11 settembre.
E tuttavia, hanno ragione i due TenentiColonnelli dell’Armata Popolare cinese, Qiao Lange Wang Xiangsui, a scrivere che nel conflitto perl’egemonia postamericana «il volto del dio dellaguerra è diventato indistinto». In un mondo integra-to dalla globalizzazione, il conflitto si può ottenereanche con strumenti ed azioni non di guerra adopera di soggetti anche non militari che minaccia-no la stessa esistenza quotidiana con armi non con-venzionali capaci di attentare alla sicurezza, alla
salute, al benessere, all’opinione pubblica. Questonuovo combattimento - osservavano i due strateghicinesi - finirà per “provocare nella gente comune,come anche nei militari, grande stupore nel consta-tare che le cose ordinarie, quelle a loro vicine, pos-sono anche diventare armi con le quali ingaggiareuna guerra. Siamo persuasi che alcune persone si sveglierannodi buon’ora, scoprendo con stupore che diversecose apparentemente innocue e comuni hanno ini-ziato ad assumere caratteristiche offensive e letali».Abbiamo pensato a lungo che fossero i kamikazesuicidi del jihadismo. Non abbiamo capito cheerano le obbligazioni-salsiccia che avevamo in por-tafoglio, il vero mezzo per mettere a rischio oggi, eforse in ginocchio domani, l’egemonia americana.
La leadership globale Usa, affermatasi nel 1945, è entrata in contrazionein maniera analoga a quanto, tra il 1850 e il 1878, avveniva
con quella imperiale britannica. Ne seguì una deconcentrazione delle alleanze internazionali che culminarono nel primo conflitto mondiale
commentari

ALLA RICERCA DI ISRAELELe elezioni in Israele sono andate così, edè ora inutile stracciarsi le vesti se l’estremadestra è avanti e la sinistra continua a per-dere. È una realtà che trova riscontroanche altrove. La parità dei numeri tra Livnie Nethanyau era qualcosa di prevedibile, epreoccupa solo nella misura in cui reste-ranno ferme le rigidità personali, piuttostoche ideologiche, tra i due leader. Israele haperò un vantaggio, che consiste nella suaconsapevolezza di vulnerabilità. Quando ilpericolo è esistenziale, e periodicamentesuccede, diventa granitica. Questo onero-so collante è la sua salvezza.Il Presidente degli Stati Uniti - la cui manotesa all’Iran e al mondo islamico almomento non agevola il dialogo conIsraele, ha detto: «Mi auguro di lavorarepresto con il nuovo premier per cercareuna durevole e forte pace nella regione».Non sono parole da poco, e hanno il signi-ficato di un impegno già sottoscritto.Saggio atteggiamento, perché in fondoIsraele da sola può gestire assai poco glieventi del mondo che la circonda.Imbrigliata com’è, può solo esprimesi inmodo tattico, ma difficilmente lo può farein termini strategici. In altre parole, daIsraele può dipendere la condizione di tre-gua o di guerra, ma non la “pace”, quellavera e duratura. Quella dipende da altri, enon certo dal mondo islamico, nonostantela proposta saudita del 2002, dai più igno-rata, resti ancora l’unico atteggiamentostrategico concreto e costruttivo sinoraemerso dai credenti in Allah. Il resto, com-preso l’attivismo egiziano ed il silenzio gior-dano, rientra nelle categorie della tattica, etocca gli interessi di Israele solo di riflesso.Ciò significa che la pace dipende dal cir-cuito virtuoso che è necessario si crei reci-procamente tra Israele e il resto dell’Oc-cidente, e tra questo e il mondo musulma-no, e più segnatamente arabo. È da quiche il nuovo governo partirà. L’Americasarà di nuovo il grande regista dell’opera,mentre l’Europa, possibilmente con laTurchia, dovrà svolgere un ruolo di garantetra Stati Uniti, mondo arabo-musulmano eIsraele. Il primo nodo da sciogliere e quel-lo “Fatah contro Hamas” e da qui sipotrebbe cominciare, sempre che il logo“due popoli, due stati” resti di attualità. Ilsecondo passo potrebbe essere un inten-so lavoro sulla Siria per rescindere il cordo-ne ombelicale iraniano, stabilizzando così ilLibano e neutralizzando Hezbollah attra-verso un suo riassorbimento nella politica.A questo punto resterebbero ancora leincognite del problema dei rapporti conl’Iran, dove, nel frattempo, le elezionipotrebbero far riemergere personaggiassai diversi da Ahmedinejad. In ognicaso, se non lascerà cadere la mano tesa,il dialogo diretto ci sarà, e potrebbe daredei frutti. Se così fosse, l’Europa potrebbeentrare in campo con efficacia, esercitan-do un ruolo di garante sia per l’Iran che pergli Israeliani e i Palestinesi.A questo punto il piano arabo del sovranosaudita, prematuro nel 2002 e per questoaccantonato da tutti - ma non dimenticato- potrebbe ritornare attuale.

11
fatto la scelta meno contestabile: ha nominato uninviato speciale e lo ha inviato a parlare un po’ contutti. Poi si vedrà. Nel frattempo si sono svolte leelezioni in Israele e forse questo permetterà se nonaltro di uscire dal difficile clima della campagnaelettorale e di trattare con un governo nella pienez-za dei suoi poteri.Anche quest’ultima speranza potrebbe alla finerivelarsi illusoria. Il nuovo governo israelianodipenderà comunque da una difficile coalizione trapartiti con impostazioni e priorità molto diverse.Per di più, l’affermazione elettorale della destrapiù antiaraba e nazionalista di Avigdor Lieberman(nella foto) con il partito Israel Beitanu, rischia direndere sempre più difficile un confronto pacatosui problemi reali. Una situazione ancora più diff-cile è quella palestinese, dove continuano asopravvivere due governi separati e rivali, uno inCisgiordania ed uno a Gaza, con l’aggravante chequest’ultimo è largamente eterodiretto da una diri-genza residente a Damasco e rifiuta di fare i conticon la sua fazione terrorista. Per sperare in unasoluzione di questo dilemma bisognerebbe aspet-
tare almeno le nuove elezioni presidenziali palesti-nesi del 2010 (anche se non è affatto detto che esseandranno meglio delle precedenti). In altri termini,sia da parte israeliana che da parte palestinesemancherà un interlocutore forte ed univoco, ingrado non solo di fare la guerra (la strada più sem-plice per tutti) ma anche di concepire ed imporreuna pace, con tutto il corollario di difficili compro-messi che essa dovrebbe necessariamente compor-tare, da una parte come dall’altra.
È quindi difficile pensare che la pace possadiscendere semplicemente da un accordo tra leparti, in Palestina ed in Israele. In passato, l’alloraPrimo ministro israeliano Sharon aveva contrap-posto a questa situazione il suo piano di arrivaread una fine del conflitto attraverso una serie dimosse unilaterali, cominciando con la distruzionedegli insediamenti israeliani a Gaza e la restituzio-ne dell’intero territorio all’Autorità palestinese,ma proseguendo poi con la costruzione del “muro”per la protezione fisica di Israele e di molti inse-diamenti in Cisgiordania da attentati e rivendica-
CON IL NUOVO GOVERNO IL PROCESSO DI PACE DEVE DECOLLARE. E OBAMA LO SA
UNA COABITAZIONE DIFFICILEDI STEFANO SILVESTRI
difficile inventare qualcosa di nuovo. Lo scontro tra israeliani e palesti-nesi a Gaza, la cui fase acuta è durata sino a poche ore prima dell’in-sediamento del nuovo Presidente americano, Barack Obama, il 20 gen-naio, non fa che confermare le difficoltà di una matassa sempre piùingarbugliata da veti e ricatti reciproci. In questa situazione Obama ha
•
DossierD
•èè

Risk
12
zioni palestinesi. Tuttavia questa mescolanza dicarota e di bastone non ha raggiunto gli obiettiviche forse Sharon si proponeva, sia perché è conti-nuata la spinta colonizzatrice e annessionistaisraeliana in Cisgiordania, sia perché Hamas havinto le elezioni a Gaza, prendendone il controllo.Ora è molto dubbio che qualcuno possa seriamen-te pensare di ripercorrere quella strada. Un tentati-vo diverso e più tradizionale è stato quello com-piuto dal governo Olmert che prima ha condottouna campagna militare nel Libano meridionale,per bloccare gli attacchi missilistici degliHezbollah, e poi si è impegnato in un negoziatoindiretto con la Siria, attraverso la Turchia.
Se quest’ultimo avesse avuto successo, essoavrebbe evidentemente aperto un nuovo capitolopolitico nella regione. Ma il negoziato è improvvisa-mente fallito. Il duro scontro verbale, a Davos, tra ilpremier turco Erdogan e il presidente israelianoPeres, scandito dalle reciproche accuse di aver volu-to far fallire il negoziato e di non capire nulla delMedio Oriente, non sono certo un buon segnale peril futuro. Solo l’analisi storica, se e quando saranno
pienamente disponibili materiali oggisegreti, ci dirà come si sono realmentesvolte le cose. Nel frattempo è semprepiù probabile che, se si vorrà far ripren-dere forza ai negoziati di pace, l’inizia-tiva dovrà provenire dal di fuori edimporsi ad interlocutori molto riluttan-ti e sospettosi. Il dilemma è duplice. Da un lato nes-sun accordo sarà possibile senza lapartecipazione e il consenso dei diret-ti interessati. D’altro lato però il cre-scere di importanza di fazioni armatecome Hezbollah e e Hamas, con forticollegamenti internazionali, ha difatto accresciuto il peso degli attoriesterni, inclusi alcuni interlocutoriparticolarmente “difficili” come
L’Iran e la Siria.Non sembra in realtà credibile l’dea di convocareuna sorta di conferenza regionale di pace, con tuttigli attori interessati: troppi interessi divergenti esoprattutto troppe diverse fonti di conflittualitàreciproca ostacolerebbero il raggiungimento di unconsenso purchessia. Più credibile, anche se diffi-cile, potrebbe essere l’ipotesi di un nuovo incontro“alla Camp David”, tra israeliani e palestinesi,preparata però da negoziati e colloqui a livelloregionale con alcuni dei principali interlocutori.Per Washington ciò significa che l’iniziativa sullaPalestina dovrebbe essere preceduta da un proces-so molto delicato di ripresa di contatti con l’Iran econ la Siria (in particolare con questa seconda),per evitare improvvisi ricatti e iniziative di sbarra-mento. Ciò a sua volta potrebbe risultare tanto piùdifficile se non avesse anche il consenso, o quantomeno l’acquiescenza del governo diGerusalemme. Essa d’altro canto potrebbe essereresa più complicata dall’ulteriore necessità, daparte dell’amministrazione americana, di dimo-strare agli altri interlocutori regionali in MedioOriente la serietà del suo “nuovo corso” politico,
Alcuni pensano che sia opportunotentare un approccio diretto, cercando di negoziare con Hamasla sua legittimazione in cambio di una reale rinuncia al terrorismo e di un superamento della sua posizione ideologica sulla necessaria distruzione di Israele.Altri ritengono che un tale obiettivo sarà del tutto impossibileda raggiungere senza la piena collaborazione di Damasco

dossier
probabilmente anche esercitando forti pressioni suIsraele sulle questioni umanitarie, sul problemadegli insediamenti in Cisgiordania, eccetera.Un vero nodo gordiano, che non potrà certamenteessere sciolto alla maniera di Alessandro Magno,con un taglio netto, ma che richiederà un approc-cio graduale e prolungato nel tempo. Il problemaè che anche questa strategia ha le sue controindi-cazioni, che discendono soprattutto dalla propen-sione più volte dimostrata sia da Israele che dalleforze palestinesi di puntare a creare dei nuovi“fatti compiuti” che poi, a loro volta, cambiano ilclima politico e complicano la ripresa del proces-so di pace.Per questo, malgrado tutte le considerazioni fattein precedenza, è anche possibile che il PresidenteObama possa essere tentato dalla scelta di unapproccio più rischioso, che però avrebbe il van-taggio di fargli mantenere l’iniziativa nei confron-ti di tutti i suoi riluttanti interlocutori, accorciandoi tempi delle consultazioni e delle esplorazioni chestanno conducendo i suoi vari inviati per il MedioOriente e proponendo bruscamente una sua solu-zioni complessiva ai principali protagonisti delconflitto, tentando di imporla con la forza del suocarisma politico, con i molti strumenti di pressio-ne a sua disposizione e con la collaborazione dellacomunità internazionale. Un approccio di questo genere fu tentato dalPresidente Clinton al termine del suo mandato eraggiunse l’obiettivo di accordi di pace moltoavanzati, che tuttavia vennero poi completamentedisattesi al momento della loro applicazione,soprattutto perché era nel frattempo cambiata lamaggioranza governativa in Israele ed era cambia-to il presidente a Washington. Alcuni analistiritengono che quegli accordi furono in realtà pos-sibili anche perché nessuno credeva che sarebberostati poi applicati. Obama avrebbe il vantaggio diagire dopo le elezioni politiche in Israele, quandoha ancora davanti a sé almeno quattro e forse ottoanni di presidenza, e mentre può ancora sfruttare
un forte consenso internazionale a suo favore. Lasua maggiore credibilità renderebbe probabilmen-te più difficile l’accettazione dei necessari com-promessi da parte dei vari interlocutori, ma incompenso renderebbe anche più probabile la loroeffettiva applicazione.Sarà però comunque molto difficile raggiungererisultati significativi, se nel frattempo non saràstato trovato il modo per inserire Hamas nella trat-tativa o per neutralizzarla. Quest’ultima sembre-rebbe essere l’opzione preferita di Israele, ma ilsolo uso della forza a Gaza non sembra, almenoper ora, aver raggiunto il risultato sperato. Nésembra ancora funzionare l’ipotesi, tentata da AbuMazen con l’appoggio della Lega Araba, di rico-stituire una sorta di governo di unità nazionale,che diluisca la presenza di Hamas nel negoziato eallo stesso tempo lo renda possibile.
Siamo qui in presenza di un ostacolo chebisognerà sormontare. Alcuni pensano che siaopportuno tentare un approccio diretto, cercandodi negoziare con Hamas la sua legittimazione incambio di una reale rinuncia al terrorismo e di unsuperamento della sua posizione ideologica sullanecessaria distruzione di Israele. Altri ritengonoche un tale obiettivo sarà del tutto impossibile daraggiungere senza la piena collaborazione diDamasco, riproponendo quindi la questione del-l’allargarsi a macchia d’olio dei negoziati. Altriancora sono convinti della strutturale impossibili-tà di ottenere simili risultati da un movimento che,a differenza di Fatah, non ha radici e natura laiche,ma è essenzialmente religioso e fondamentalista.È probabile che sia necessario esplorare in profon-dità tutte queste diverse ipotesi, nella speranza chepossa delinearsi un reale spiraglio. Ove questo sirivelasse impossibile, potrebbe rivelarsi inevitabi-le un nuovo tentativo di imposizione unilateraledella pace che, tuttavia, non sia solo concepito daIsraele, ma trovi il consenso e l’appoggio dell’in-sieme della comunità internazionale.
13

Risk
14
l’esito fosse stato negativo. Tutt’altro. Lo dimostra ilfatto che Hezbollah se ne stia buono e quieto da oltredue anni e mezzo, mentre a sorvegliare la zona cheva dal Litani al confine c’è Unifil II che Tel Aviv cri-tica ufficialmente per la scarsa efficacia, ma che inrealtà ha sgravato Israele dalla necessità di occupareuna fascia di territorio libanese o di mantenere forzeconsistenti al confine settentrionale, esposte a scontrio imboscate contro gli agguerriti combattenti sciiti. Equesta soluzione permette anche di risparmiare tanti,ma tanti soldi. Che Hezbollah non abbia alcuna voglia di cercarerogne, almeno per ora, è confermato dal fatto che siarimasto a guardare mentre Gaza veniva, sia pur par-zialmente e temporaneamente, occupata e che si siaaffrettato a distanziarsi da chi, durante gli scontri, halanciato dal Libano un pugno di razzi verso Israele.Lo stesso Libano si è affrettato a rinforzare lo schie-ramento di unità dell’Esercito e forze di sicurezza asud, perché nessuno vuole che Israele sia costretta acolpire di nuovo. Certo, nel 2006 le operazioni furo-no condotte davvero malamente, soprattutto la cam-pagna terrestre e gli errori commessi portarono adimbarazzanti passi falsi e provocarono innumerevoli
vittime, tuttavia l’epilogo non fu certo quella “vitto-ria” celebrata, per ben poco tempo, da Nasrallah ecompagni. Ad Hamas è andata quindi ancora peggio.
Situazione iniziale e obiettivi israelianiBisogna guardarsi dal fare troppi paralleli tra Libanoed Hezbollah e Gaza ed Hamas, perché la situazioneper Hamas era ed è decisamente più sfavorevole.Innanzitutto dal punto di vista geografico e orografi-co la Striscia mal si presta a qualunque tentativo didifesa. Mentre in Libano Hezbollah può giocare sulladifesa in profondità, sulla cessione ragionata di terre-no, perché le forze israeliane non possono che attac-care ed avanzare da sud verso nord, la Striscia è unrettangolo irregolare, con una superficie complessivache non supera i 360 kmq ed ha una profondità mas-sima di una quindicina di chilometri ed una lunghez-za di una quarantina di chilometri. Israele ha confinidiretti su due lati, il terzo confine è con l’Egitto e die-tro le spalle…c’è solo il mare. In secondo luogo nonci sono rilievi significativi o ostacoli naturali chepossano davvero rallentare l’avanzata delle forzecorazzate e meccanizzate, mentre le rotabili sonopoche e con andamento nord-sud, ma non est-ovest.
CON L’OPERAZIONE “PIOMBO FUSO” RINASCE UNA VERA FORZA MILITARE
IL RITORNO DI TSAHALDI ANDREA NATIVI
sraele ha un a capacità straordinaria: riesce a metabolizzare appieno e con ecce-zionale rapidità le lezioni apprese in conseguenza di ogni prova militare. Ed èstato così anche nel caso delle operazioni condotte a Gaza, dove Tsahal hamostrato di aver corretto le deficienze emerse nel corso del conflitto dell’esta-te 2006 in Libano contro Hezbollah. Intendiamoci, non che in quella occasioneII• •

dossier
15
L’elevata densità di popolazione, 1,5 milioni di abi-tanti, rappresenta si un problema per Israele, ma se ladensità media è di 4.100 abitanti kmq questo datonon è significativo, perché in ampie zone della stri-scia non c’è niente e nessuno, mentre la densità neigrandi agglomerati urbani (Gaza City con 400milapersone, per non parlare dei campi profughi) consen-te una “cinturazione” abbastanza agevole di questezone critiche.Le forze di Israele sono entrate più volte a Gaza inpassato ed hanno dimostrato di potersi muovere infretta ed a piacimento a dispetto della resistenzadelle milizie palestinesi. Milizie che sono poconumerose, potendo contare su 16mila uomini, inclu-dendo nel totale le unità scelte di Hamas (Brigate Izzad-Din al Qassam), ma anche i membri della forza dipolizia e sicurezza interna. Israele parla di una forzapermanente di 6-10mila uomini e di forse altrettantimiliziani armati disponibili part-time. Hamas non èHezbollah: non ha la consistenza, l’addestramento,la capacità militare, l’armamento di Hezbollah.Hamas ha solo armi leggere, pochissimi e poco effi-caci missili antiaerei leggeri, pochi missili controcar-ro e lanciarazzi anticarro moderni e il tanto strom-bazzato arsenale di razzi d’artiglieria e di mortai,oltre a non aver alcun valore militare, non può esse-re impiegato in modo realmente massiccio ed effica-ce contro i centri abitati israeliani. E non sono i pochirazzi a lunga gittata di produzione cinese e iraniana(che comunque non vanno oltre i 40 km) a mutare irapporti di forza. Razzi che per arrivare a Gaza devo-no essere trasportati laboriosamente, smontati in piùparti.Fattore ancora più importante, Hezbollah èmonolitico e può contare su un vasto seguito popo-lare, almeno in parte del Libano. Lo stesso non acca-de certo per Hamas, che ha si vinto le elezioni, leprime democratiche nella storia dell’Anp/Olp, chel’occidente stupidamente ha tanto insistito avesseroluogo (e quindi ora, ci piaccia o meno, con Hamasnon si può non parlare o non riconoscerlo) però poiper consolidare il suo potere ha dovuto combattereuna guerra fratricida contro Fatah. Anche durante il
conflitto con Israele i regolamenti di conti non sonomancati, forse non tanto per evitare che gli uomini diFatah collaborassero con Israele, quanto per evitareuna “rivincita” a ostilità concluse. I superstiti diFatah in effetti non vedono l’ora di poter avere unaseconda opportunità di contestare con le armi il ver-detto delle urne e questo spiega perché i soldatiisraeliani sono stati attenti a cosa colpire, mentre gliuomini di Fatah qualche segnalazione la hanno fatta.Hamas ha sbagliato a non giocare la carta dell’unitàpalestinese contro il nemico comune. E ne ha paga-to lo scotto. Aggiungiamo che neanche all’Egitto,così come a quasi tutti i Paesi arabi moderati, Hamasproprio non va giù e non è un mistero che i serviziegiziani sottobanco abbiano passato informazioniagli israeliani, ad esempio sulla disposizione e sugliaccessi ai famosi tunnel di Rafah che attraversano gli11 km del corridoio Philadelphia. Non sappiamo e forse non sapremo mai quali fosse-ro gli obiettivi israeliani. Posto che nessuno aveva,ha o avrà intenzione di tornare ad occupare laStriscia, mentre è altrettanto chiaro che è impossibi-le “disarmare” Hamas dei suoi razzi o impedirne illancio, gli scopi dell’operazione non potevano cheessere limitati: infliggere una “legnata” ad Hamas,eliminando quanto più possibile della sua organizza-zione militare e di sicurezza, dei suoi arsenali, maga-ri con la speranza che le perdite sarebbero state cosìsignificative da consentire a Fatah di rientrare ingioco, se non di riprendere il controllo di Gaza.Convincere una parte della popolazione che Hamasal potere non porta benessere…ma bombe e distru-zione (e in questo Hamas ha dato una mano, nonmantenendo le promesse elettorali e mostrandosipoco meglio di Fatah). Distruggere, almeno tempo-raneamente i tunnel verso l’Egitto che consentono ilcontrabbando di tutto, comprese armi, munizioni erazzi e stabilire un nuovo regime di gestione e con-trollo della fascia di confine tra Egitto e Gaza,ampliando da 60-70 metri a 1.000 metri o più la zona“di nessuno” più facile da controllare, rendendomolto più complicato se non impossibile scavare


dossier
17
tunnel, che dovrebbero avere una lunghezza… diecivolte superiore a quella attuale (sui 250 metri) perrisultare utilizzabili. Gli ingegneri palestinesi sonobravi, ma non possono compiere miracoli utilizzan-do strumenti e macchinari limitati. CostringereHamas a sottoscrivere un accordo di tregua nei ter-mini dettati da Tel Aviv era un altro obiettivo rag-giungibile. E magari ripetere a Gaza quanto ottenutoin Libano: una “internazionalizzazione” del proble-ma Gaza, con schieramento di una forza internazio-nale al confine con l’Egitto che si assuma gli oneri diun controllo effettivo, nonché di forze navali interna-zionali che si occupino di monitorare i traffici marit-timi e di impedire il contrabbando.Il tutto doveva avvenire senza subire troppe perditeo provocare vere stragi tra i palestinesi. E così èstato. Chi si ostina a pensare che Israele abbia fallitoperché non ha “risolto” il problema Hamas non hacognizione della situazione e dei constraints checondizionano l’uso della forza da parte di Israele.
Sorpresa e guerra mediatica Israele è riuscita ancora una volta ad assicurarsi unvantaggio fondamentale in ogni vicenda bellica:quello della sorpresa. E lo ha fatto a livello strategi-co, operativo e tattico. Vi sono pochi dubbi cheIsraele abbia accuratamente preparato il conflittocontro Hamas, ricorrendo poi ad alcune mirate pro-vocazioni per ottenere la reazione desiderata dall’av-versario. Hamas è caduto nel tranello. Israele ha“provocato” quando, il 4 novembre, ha colpito aGaza 6 miliziani di Hamas. Hamas ha risposto con irazzi, 193 solo a novembre, Israele con attacchiaerei. Poteva finire lì, ma Hamas ha commesso unerrore di valutazione, riprendendo i lanci di razzi (70solo il 21 dicembre, 200 nell’intero mese fino all’ini-zio guerra) e poi lasciando scadere, senza rinnovar-lo, il cessate il fuoco che per diversi mesi aveva evi-tato scontri significativi. Ed in questo modo ha offer-to un meraviglioso casus belli all’avversario. Tanto èvero che l’opinione comune attribuisce ad Hamas laresponsabilità di aver cancellato il cessate il fuoco,
provocando e legittimando poi la risposta militareIsraeliana.Come Hezbollah nel 2006, Hamas non pensava cheIsraele fosse pronta ad alzare in modo così dramma-tico il livello di confronto e ad arrivare all’invasionedel suo territorio. Israele invece era prontissima,anche per ragioni di opportunità politica (fine presi-denza Bush ed elezioni politiche domestiche alleporte), le serviva solo un pretesto. Quando ha colpi-to, lo ha fatto in modo estremamente violento ericorrendo all’arma che più garantisce la sorpresa,quella aerea. Chi avrebbe potuto informare Hamas diquanto si andava preparando…non lo ha fatto. Ed Israele non ha ripetuto alcuni degli errori del2006, quando perdette clamorosamente la guerradelle informazioni/mediatica con Hezbollah. Hamasdi per sé non è sofisticata come Hezbollah, non ha néle capacità né la forma mentis per comprenderequanto sia importante “presentare” in modo credibi-le, puntuale e sfruttando tutti i media (compresi quel-li occidentali) la propria visione di quanto sta avve-nendo. E Israele ne ha approfittato. Intanto, durantei primi giorni del conflitto, la guerra era esclusiva-mente aerea e navale e le uniche informazioni suquanto stesse accadendo erano quelle ufficiali israe-liane. Informazioni fornite in modo continuativo,utilizzando lo strumento delle conferenze stampa,con gli addetti militari affiancati da quelli politici(interessante novità), mentre l’uso delle riprese effet-tuato dai velivoli senza pilota è stato molto intensoed ha permesso di chiarire come molti degli asseriti“crimini” israeliani fossero in realtà provocati dallascelta di Hamas di trasformare molte moschee, scuo-le, edifici pubblici in depositi di armi, rifugi, basimilitari se non direttamente come postazioni di lan-cio per razzi o armi anche “pesanti” (si fa per dire).C’è stato un “buco” solo nel caso delle famose gra-nate sulla scuola Onu, che invece finirono su edificineanche troppo vicini. Ma non si riuscì a documen-tarlo in modo credibile. Israele ha anche usato ognitipo di media: radio, Tv e internet (ormai l’uso diYou Tube è un caso di studio da parte degli addetti ai

Risk
18
lavori). Parallelamente è stato deciso di non concede-re alla stampa internazionale di accedere al teatrooperativo, né durante la fase “aerea” delle operazio-ni, né successivamente. Un esercito di inviati diguerra e corrispondenti è rimasto bloccato fuori Gazae poteva vedere e raccontare poco o niente delle ope-razioni belliche. Hamas a differenza di Hezbollahnon fornisce notizie sulle vicende belliche (peraltronon era in grado di avere un vero quadro della situa-zione). A Gaza c’era Al Jazeera, Bbc, Reuters, ma aranghi ridotti nonché qualche collaboratore localefreelance. Altro che guerra in diretta! Tsahal haanche aggirato la intimazione della corte israelianache imponeva di portare a Gaza almeno un pool digiornalisti internazionali a causa della impossibilitàdi garantirne la sicurezza. Considerato l’atteggia-mento dei media internazionali verso Israele è unascelta abbastanza comprensibile. Naturalmente si èanche provveduto a confiscare i cellulari ai soldatiisraeliani, specie i videofonini, chiarendo poi qualeconseguenze disciplinari e penali ci sarebbero stateper chi avesse tentato di trasformarsi in soldato/gior-nalista. Non solo, sono stati impiegati essenzialmen-te soldati professionisti e volontari, limitando il ricor-so a riservisti meno affidabili. Senza contare che lefrequenze utilizzate dai telefonini possono esseredisturbate, le “celle” dei cellulari eliminate distrug-
gendo i ripetitori etc. E così quella di Gaza passeràalla storia come una delle vicende belliche menodocumentate e raccontate degli ultimi anni. Conbuona pace di chi crede davvero alle fole sul villag-gio globale. Gaza anzi potrebbe fare scuola…
La guerra aerea e la risposta di Hamas Utilizzando l’aeronautica per l’attacco iniziale del 27dicembre Israele ha scatenato l’offensiva senzalasciare che alcun segnale potesse consentire all’av-versario di immaginare quanto si andava preparando.Anche perché la massima segretezza ha avvolto lapreparazione della offensiva, anche a livello politico-militare di vertice. Gli aerei del resto erano pochiminuti, poche decine di secondi in qualche caso,dagli obiettivi. Obiettivi già sorvolati dai velivolisenza pilota (Uav). Per di più si è deciso di dare il viaalle operazioni durante una festività ebraica, con ivelivoli che sono arrivati dal mare. E la sorpresa èstata totale, anche se “dopo” Hamas ha detto di esse-re a conoscenza dell’imminenza dell’attacco. Se cosìè stato…beh, la dirigenza del partito è colpevole dinon avere preso le più elementari misure di sicurez-za. La guerra aerea è stata orchestrata in modo asso-lutamente efficace, colpendo bersagli fissi predeter-minati e studiati con cura in modo da ottenerne ladistruzione senza provocare troppi danni collaterali.Sempre a questo fine sono state scelti i punti diimpatto delle armi, sono state scelte le traiettorie e laprogrammazione delle spolette. Da un punto di vistatecnico è stato mirabile il modo in cui Israele hacoordinato l’impiego di velivoli senza pilota (finoad una dozzina in volo contemporaneamente aquote diverse per ottenere una copertura completa ecostante, giorno e notte, dell’intera Striscia), deglielicotteri da combattimento e dei cacciabombardie-ri. Un esercizio delicato, risolto senza che si verifi-cassero incidenti. Il vantaggio di operare pratica-mente all’interno del territorio israeliano si è tradot-to in elevati tempi di persistenza dei velivoli nellazona operativa nonché in possibilità di effettuarequasi immediatamente interventi su “chiamata”.
L’intelligence israeliana si aspettava fino a 200razzi/bombe al giorno e questo anche con offensiva di terra in corso e con la massima pressioneaerea. Ma così non è stato:Hamas non è riuscita a sostenere un ritmo di 100 colpi/giorno

dossier
19
Hamas poteva rispondere con attentati, con il lanciodi razzi e tentando di scatenare la terza intifada.L’intifada non c’è stata, gli attacchi dei kamikazeneanche ed Hamas si è affidata ai razzi ed ai mortai.L’intelligence israeliana si aspettava fino a 200razzi/bombe al giorno e questo anche con offensivadi terra in corso e con la massima pressione aerea.Ma così non è stato: Hamas non è riuscita a raggiun-gere ed a sostenere un ritmo di 100 colpi/giorno edanzi con il protrarsi delle operazioni si è scesi a 20-30. Dall’inizio delle ostilità fino all’avvio delle ope-razioni terrestri non aveva lanciato più di 400 trarazzi e bombe. Questo non significa naturalmenteche Hamas non avesse riserve di razzi o che abbiarinunciato ad impiegarli, tutt’altro. Le stime indica-vano in 3mila i razzi disponibili. Circa 1.200 sonostati distrutti da Israele. Ma non è riuscita a farlo equando vi è riuscita…ha raccolto ben pochi risultati.Questo è dovuto al fatto che molte postazioni di lan-cio semi-permanenti sono state subito eliminate, irazzi più grandi, pesanti e…letali solo con grandedifficoltà potevano essere prelevati dai depositi eportati in batteria, mentre l’aeronautica israeliana haridotto a minuti, quando non a poche decine disecondi, il ciclo sensor to shooter, il tempo intercor-rente tra la scoperta della postazione di lancio e l’in-tervento di aerei, elicotteri o artiglieria.Parallelamente il sistema di difesa anti-razzo ha fun-zionato: i razzi e le bombe di mortaio non possono(per ora) essere intercettati, ma possono essere sco-perti in volo già subito dopo il lancio (e le coordina-te sono passate ai velivoli da attacco) ed è possibiledeterminare la traiettoria e stabilire il probabile puntodi impatto con una buona approssimazione, dandoquindi alla popolazione (ma solo a quella davverominacciata) un avviso che è tanto più tempestivoquanto è maggiore la gittata dell’ordigno. E opportu-ne procedure di difesa civile hanno fatto il resto. Aquesto si aggiunga che i razzi di Hamas sono comun-que rudimentali, decisamente imprecisi, con ridottocarico bellico. Militarmente non hanno significato.Funzionerebbero come arma del terrore se cadessero
sulle città e i villaggi israeliani al ritmo di centinaiaal giorno Ma questo non è accaduto. Ed Hamas allafine del conflitto difficilmente aveva più di 1.200razzi nei suoi arsenali. L’Aeronautica israeliana hadistrutto decine e decine di obiettivi con efficacia(come non era accaduto in Libano), oltre 600 solo gliobiettivi principali, ed in particolare il “flow” di aereiiniziale è risultato micidiale, con un centinaio diobiettivi colpiti nel giro di una manciata di minuti.
Le operazioni aero-terrestri L’Aeronautica aveva compiuto il grosso del suolavoro già nei primi 4 giorni di guerra (anche se allafine del conflitto avrà volato forse 2.700 sortite).Quando Israele ha lanciato la cosiddetta “Fase 2” delpiano operativo, il 3 gennaio, ha lanciato entro laStriscia elementi di 3 brigate di fanteria e di almeno1 divisione corazzata, appoggiati da reparti delgenio, dell’artiglieria, con una forte componente diforze speciali e di team di collegamento con le forzeaeree. In tutto circa 10mila soldati. Anche l’attaccoterrestre ha avuto successo, Hamas si aspettava, gli èstato fatto pensare, che il fulcro delle operazionisarebbe stato il nord della Striscia. Ed è li che avevaconcentrato le forze. Invece Tsahal ha “tagliato” laStriscia in tre tronconi, con decisi e veloci affondi dicolonne blindate e corazzate che hanno raggiunto nelgiro di poche ore il mare, assunto il controllo e bloc-cato tutte le rotabili principali, orientate nord-sud,circondato i campi profughi e le aree urbane princi-pali, a partire da Gaza City. Poi i soldati sono andatia caccia dei bersagli segnalati dall’intelligence, evi-tando accuratamente di penetrare in profondità nellecittà, pur essendo in grado di farlo (quanto applicatoa suo tempo con successo a Jenin è stato ancor piùperfezionato). Non è vero che Hamas sia sempre“scappata” e non si sia battuta, preferendo sopravvi-vere per combattere la prossima guerra. No, in qual-che caso ci sono stati scontri a terra, anche moltoaccesi, però Israele non è entrata in forze nei centriabitati (lo ha fatto, ma solo con reparti speciali edazioni mirate), Hamas ha impiegato largamente trap-


dossier
21
pole esplosive, anche ingegnose, ha usato i pochimissili anticarro, i lanciarazzi, gli ordigni esplosi-vi…insomma, il poco di cui dispone. Ma non hainflitto perdite veramente significative, perché i sol-dati israeliani non hanno seguito gli assi di penetra-zione più evidenti, hanno sfruttato la copertura delletenebre, hanno continuato a muoversi e ad utilizza-re un fuoco di soppressione costante, sfruttandoappieno l’appoggio aereo guidato in modo mirabi-le, con le bombe e i missili che colpivano ad appe-na una trentina di metri di distanza dalle proprietruppe. Ogni comandante di brigata aveva a propriadisposizione un certo numero di aerei, elicotteri,artiglieria, che poteva utilizzare senza dover passa-re dai comandi centrali. Israele ha usato ampiamen-te la fanteria, i buldozer corazzati per sfondare eabbattere case ed edifici e creare nuove vie di acces-so. Hamas aveva naturalmente piazzato ordigniovunque, ma molti non hanno funzionato, sono statiaggirati e disinnescati.Inoltre il sistema israeliano per il soccorso immedia-to dei feriti, la loro stabilizzazione, evacuazione etrattamento negli ospedali civili e militari ha funzio-nato perfettamente, non come accadde in Libano.Anche perché…si giocava in casa. In ogni caso ilnumero di feriti subito da Tsahal non è stato proprioinsignificante, come hanno ammesso gli stessicomandi militari. Hamas ha visto le sue formazioniisolate, impossibilitate a muoversi, mentre far arriva-re i rifornimenti era estremamente difficile e il siste-ma di comando e controllo è andato rapidamente alcollasso, rendendo scoordinate le operazioni. Adiffe-renza di Hezbollah, Hamas non aveva sistema dicomunicazioni sicuri e ha parlato troppo. Non di meno, anche se qualche comandante diTsahal avrebbe voluto proseguire le operazioni sulterreno ed avanzare in forze nel cuore dei centri abi-tati per costringere Hamas a dare battaglia, la sceltadi sospendere le operazioni appare sensata. Andareavanti avrebbe significato alzare in misura significa-tiva le vittime tra i civili e accettare scontri ravvici-nati nei quali la superiorità tattica e tecnologica dei
soldati Israeliani sarebbe risultata sempre meno deci-siva, anche perché Hamas si è dimostrato a sua abba-stanza rapido nel capire cosa non doveva fare.L’esito sarebbe stato vittorioso per i soldati israelia-ni, ma molti ufficiali erano convinti che i costi sareb-bero stati superiori ai benefici.Quando, il 17/18 gennaio, Israele ha deciso un cessa-te il fuoco unilaterale ed ha avviato il ritiro delle suetruppe l’operazione è stata condotta rapidamente e inmodo esemplare. Hamas non è riuscita ad interferirein modo efficace neanche in questa fase molto deli-cata: le truppe e i mezzi israeliani sono rientrati nelleloro posizioni iniziali quasi indisturbati. Il 21 il ritiroera completato. Chi si aspettava una “Fase 3”, coningresso in massa delle truppe israeliane nei quartie-ri di Gaza City e magari una “Fase 4”, il “cambio diregime” a Gaza è stato deluso. Personalmente credoche tutto questo parlare di Fase 3-4 rientri nel gene-rale concetto di “deception” messo in atto da Israelee subito fatto proprio dalla stampa internazionale(come del resto si voleva accadesse), rinforzato poidalla decisione di mobilitare decine di migliaia diriservisti, presa e comunicata al momento giusto.Non dubitiamo che lo Stato maggiore avesse preso inconsiderazione anche l’ipotesi di doversi spingere eimpegnare a fondo, ma questo solo perché gli Statimaggiori che funzionano predispongono piani perfronteggiare qualsiasi evenienza. Ma sperano di nondoverli utilizzare. Discutere quanto di reale ci sia poistato nella asserita dialettica tra i tre personaggi fortidel governo israeliano esula dagli scopi di questadisamina.
Armi “illegali” e perditeÈ sempre difficile discutere in termini asettici di unconflitto che ha provocato centinaia di morti emigliaia di feriti. Tuttavia Israele è riuscita, più diquanto non avesse fatto in passato, a minimizzare ilnumero delle perdite civili. Persino Al Jazeerastima che almeno il 50% delle vittime appartengaalle forze militari e paramilitari di Hamas. Gliisraeliani sostengono che la percentuale sia più

Risk
22
vicina al 65%. Non ci sono ancora verifiche indi-pendenti. Naturalmente Hamas ha giocato la solitacarta delle accuse di stragi di civili. Indubbiamentea Gaza ci sono state tante, troppe, perdite civili. Èinevitabile in guerra, spesso quando si combatte inaree urbane, ancorché periferiche, densamentepopolate e soprattutto considerando che Hamasapplica sistematicamente il ricorso a “scudi umani”civili per proteggere la sua leadership, così comeinfrastrutture chiave. Ad esempio una pratica effi-cace in passato è stata quella di mandare sui tetti
degli edifici dove si rifugiavano quadri e dirigentidel partito i familiari o altri civili, legando così lemani ai piloti israeliani. Così non è stato in questocaso, perché Israele ha “innovato”, telefonando acasa degli inquilini delle case sotto tiro, avvisandodell’imminente attacco. In diverse occasioni la tele-fonata, che precedeva il missile o la bomba di pochiminuti…è stata efficace. In altri casi i tetti si sonopopolati, ma i piloti israeliani hanno regolarmentesparato un missile leggero a testata inerte, da eser-citazione, contro l’angolo di un edificio limitrofo. Ilmessaggio è stato quasi sempre recepito.Naturalmente in questi casi il bersaglio “umano”sfuggiva, ma la sua casa no, così come il deposito,il comando, la sede ufficiale. Israele ha anche fatto
ricorso a munizioni con un più ridotto potenzialedistruttivo per evitare di causare troppe vittimecivili: è questo il caso delle bombe Sdb a guidasatellitare, integrate a tempo di record sui caccia-bombardieri F-15, che pesano “solo” 250 libbre ecolpiscono con una precisione metrica. Precisione eridotta carica esplosiva, nonché attacco verticalediminuiscono l’ampiezza dell’area letale. Altrearmi “umanitarie” sono le bombe FocusedLethality (Flm) che sostituiscono il normale“corpo” in metallo pesante che si frammenta in
schegge letali con un involucro inmateriali compositi, che racchiudeuna carica di esplosivo speciale. Ilmeccanismo letale è basato sullaesplosione, sulla sovrapressione,non sulle schegge. Questo vuol direridurre enormemente il raggio letale(e spiega le vittime il cui corpo nonpresentava ferite esterne, ma eradisarticolato), specie se la traiettoriafinale dell’arma è poco angolata.Israele ha probabilmente sbagliato anon fornire e pubblicizzare, perragioni di sicurezza mal intese, ilmotivo per il quale sono state impie-gate simili munizioni “nuove”, matutt’altro che illegali. Ha anche sba-
gliato a non spiegare che il ricorso a muniziona-mento d’artiglieria al fosforo è avvenuto per sten-dere cortine fumogene per coprire il movimentodelle proprie truppe o per illuminare l’area operati-va. Il che è perfettamente legale. Anche in ambien-te urbano, se si combatte in ambiente urbano.Peraltro non più di una ventina di granate al fosfo-ro è stata sparata in tali aree. Purtroppo la guerra“umanitaria” non esiste e tragici errori vengonosempre commessi, lo conferma il fatto che la mag-gior parte delle vittime tra i militari israeliani siaconseguenza di ingaggi fratricidi blue-on-blue. In ogni caso, anche se la struttura demografica aGaza è molto particolare, con il 45% della popola-zione sotto i 14 anni, non ci sono state affatto le
“Piombo fuso” oltre agli indiscutibili risultati tattici ha dimostrato chiaramente che Tsahal è tornata quella di un tempo, che è in grado di condurre con efficacia operazioni militari convenzionalicosì come combattimenti in areeurbane ed operazioni di “polizia”. Hezbollah e Teheran lo hanno capito

stragi di civili, di bambini, raccontate dalle fontipalestinesi. È presto per analisi accurate, ma alcu-ne fonti riportano che il numero dei morti potrebbeessere ampiamente inferiore a mille. E l’esperienzadei “massacri” di Jenin è illuminante in questosenso. Va anche precisato che Israele si è preoccu-pata di far si che a Gaza non si verificasse alcunacrisi umanitaria ed infatti la distribuzione di acqua,energia, viveri, medicinali è stata assicurata, siapure a ritmi e volumi ridotti, anche grazie alle “tre-gue” giornaliere e nonostante Hamas approfittassedi questi break, ad esempio utilizzando le ambulan-ze per muovere i propri combattenti o comunqueper raggrupparsi, riorganizzarsi e tirare il fiato gra-zie all’interruzione della pressione militare israelia-na, che altrimenti sarebbe stata costante, giorno enotte. Non ci sono norme che impongano ad unbelligerante di concedere tanto al suo avversario edalla popolazione civile. Israele lo ha comunquefatto per contenere le strampalate accuse che le pio-vono regolarmente addosso ogni volta che ricorrealle armi.
Quali prospettive?Nel momento in cui scriviamo Israele ha ritirato lesue forze da Gaza, lo ha fatto rapidamente, effica-cemente e senza subire attacchi significativi. Ed havotato. Hamas conduce una attività offensiva abasso livello, con sporadici tiri di razzi e mortai equalche imboscata contro le forze israeliane in pat-tugliamento, ai quali Israele ha risposto moltopesantemente, una soluzione negoziata sembraessere finalmente a portata di mano ed è anche unodei primi campi di prova per la diplomazia dellanuova amministrazione statunitense. In cambio delcessate il fuoco (che non sarà certo la “Hudna” cuipensa Hamas) Israele è anche disposta a levare ilblocco ai valichi, mentre già consente il transito aiconvogli umanitari. I pessimisti osservano che laricostruzione dei tunnel distrutti (200 sui 300 sti-mati ad inizio ostilità) è già iniziata, che le armipresto ritorneranno a Gaza, che Hamas è ancora al
potere, che i miliziani uccisi o feriti saranno sosti-tuiti. Forse e davvero così. Forse la desideratainternazionalizzazione dei confini non ci sarà(peraltro l’Egitto si è già impegnato a fare meglio epuò contare sulla collaborazione e gli strumentitecnologici e gli istruttori forniti dal corpo delgenio dello US Army). Magari l’Anp non riuscirà arientrare in gioco, neanche con un governo di unitànazionale. Però Cast Lead rimane a mio avviso un grande suc-cesso. Oltre agli indiscutibili risultati tattici hadimostrato chiaramente che Tsahal è tornata quelladi un tempo, che è in grado di condurre con straor-dinaria efficacia operazioni militari convenzionalicosì come combattimenti in aree urbane ed opera-zioni di “polizia”. Chi, dopo il 2006, aveva nutritoqualche speranza deve ricredersi: non c’è alcunacrepa nella superiorità militare di Israele. In parolepovere, Israele ha ricostituito una deterrenza basa-ta sullo strumento militare convenzionale. E siamoconvinti che anche Hezbollah e Teheran ne avran-no preso nota. Per non parlare di Hamas il quale,una volta ripresosi, valuterà con maggiore attenzio-ne fino a che punto sia conveniente spingersi nelconfronto militare con Israele. Hamas sta cercandodi “vendere” il ritiro israeliano come un grandesuccesso, ma non ci crede nessuno. E se mostreràin futuro la stessa moderazione adottata daHezbollah…Israele avrà ottenuto quando desidera-to. Ancora, è importante per Tsahal aver recupera-to fiducia in se stesso, senza alcun rischio di cade-re nel peccato di arroganza e sopravvalutazione incui è caduto più volte nella sua storia. Dal punto divista tecnico, infine, Tsahal si è mostrato capace dicondurre operazioni joint e networkcentriche ad unlivello che nessuno è in grado di emulare. E questoè importante anche per la popolazione israeliana,che si è riconciliata con le sue forze armate, le qualisono riuscite a colpire senza che il nemico potessemettere a ferro e fuoco neanche le cittadine piùesposte. A qualche commentatore politico tuttoquesto sembrerà poco. Per Israele non lo è.
dossier
23


dossier
25
bilisce un budget per i mesi a venire. Le tre settimanedi “Piombo fuso” - l’operazione militare con la qualeIsraele ha cercato di decapitare la leadership operativae politica di Hamas - hanno messo a dura prova ilmovimento, ma non hanno minacciato la sua sopravvi-venza politica nel complesso panorama palestinese.Penetrando con i Merkava e la fanteria nella Striscia diGaza, Tzahal intendeva distruggere le postazioni dilancio e gli arsenali di razzi lì presenti. Ma questoobiettivo è stato raggiunto solo parzialmente. Il fattoche, dopo la fine delle ostilità, il lancio di razzi versoAshkelon e Sderot sia proseguito - seppure ad un livel-lo inferiore, se confrontato con gli oltre 600 razzi lan-ciati e i colpi di mortaio sparati durante la guerra - ciporta a dire che la santabarbara di Hamas non è stataannientata e che le perdite subite si stanno progressiva-mente colmando. Anche per quanto riguarda l’articola-ta rete di tunnel che collegano la Striscia con l’Egitto èstata indebolita sono temporaneamente, ma non com-promessa al punto da bloccare il continuo rifornimen-to di beni che, dal Sinai, giungono a Gaza per via sot-terranea. Certo, il confronto militare è apparso fin dasubito impari. Era assolutamente prevedibile che unamilizia addestrata alla guerriglia com’è quella palesti-
nese - peraltro dalle dimensioni significativamenteridotte rispetto a quelle, per esempio, di Hezbollah -non potesse che piegarsi di fronte all’esercito più tec-nologico di tutto il Medio Oriente. Tuttavia, al di làdelle perdite subite sul campo, possiamo immaginare icapi di Hamas che, seduti a tavolino e ancora rintanatinei loro bunker, siano giunti alla conclusione che glielementi per parlare di una mezza vittoria ci sono. Per prima cosa, la tregua in sé. Il fatto che Israele l’ab-bia voluta sottolineandone l’unilateralità sta a significa-re che, in questo modo, non ha alcuna intenzione diriconoscere o legittimare l’esistenza del movimentoislamico. Un atteggiamento quasi scontato. Israele èuno Stato sovrano - qualifica di cui è carente Hamas -che si sente attaccato da una realtà classificata, nell’am-bito del suo contesto di sicurezza, come terroristica.Questo gli concede la possibilità di confrontarsi con ilmovimento islamico da un livello superiore in ambitodi diritto internazionale. D’altra parte, oltre questa lineadura di facciata, si può intravedere un’implicita dimo-strazione di spossatezza da parte di Tzahal. Le tre set-timane di guerra non gli hanno permesso di centrarel’obiettivo. Di conseguenza, con il Paese in piena cam-pagna elettorale e per evitare ulteriori perdite, ha prefe-
MILITARMENTE È DISTRUTTO, MA POLITICAMENTE NO. E VUOLE GIOCARE LE SUE CARTE
IL NUOVO VOLTO DI HAMASDI ANDREA MARGELLETTI
artiamo dalla tregua. A prescindere dalla sua fragilità, bisognachiedersi come potrebbe tornare utile ad Hamas un anno di cessa-te il fuoco. In questo senso, il movimento islamico dovrebbe fareuna valutazione di se stesso. Come un’impresa che, alla fine del suoanno commerciale, traccia un bilancio e, sulla base di questo, sta-
•PP•

Risk
26
rito chiedere un break nello scontro. Merito di Hamas,questo, e della sua capacità di resistenza di fronte aforze maggiori. L’insufficienza delle sue doti operativeè stata colmata dalla forza ideologica dei suoi militantie dalla loro tenacia nell’affrontare il nemico.Ma è nel contesto politico che la leadership del movi-mento è riuscita a mantenere le posizioni. Certo, la per-dita di uomini del calibro di Saiyed Siam, l’ex ministrodell’Interno del governo Haniyeh, si farà sentire nellungo periodo. Tuttavia, l’Hamas di oggi non è piùquello di Sheikh Yassin o di Abdel Aziz al-Rantisi,quando era un’unica grande guida a dettare il passo.Oggi la struttura orizzontale permette che il contraccol-po per la scomparsa di uno dei suoi dirigenti vengaincassato e immediatamente metabolizzato. Nel perio-do che ha anticipato il conflitto, i giorni durante que-st’ultimo e la quotidianità post-bellica ci stannomostrando un movimento per molti aspetti iperattivo.L’atteggiamento battagliero, che aveva anticipato“Piombo fuso” - in coincidenza con le celebrazioni peril 21esimo anniversario della fondazione del movimen-to - la conduzione politica di guerra e soprattutto inegoziati in corso per ottenere un accordo di tregua ilpiù soddisfacente e duraturo possibile ci stannomostrando un Hamas convinto che sia il momento dipassare dalla fase operativa a quella eminentementepolitica.
In questo senso, permangono le tre grandicorrenti interne alla dirigenza del movimento. KhaledMeshal si ritiene essere ancora il Segretario generaleche da Damasco detta la linea, seguendo una concerta-zione di ampio respiro di cui fanno parte il governosiriano, Hezbollah e l’Iran. Tuttavia, né questa collegia-lità decisionale né l’indiscutibilità sulla leadership diMeshal possono essere prese come oro colato. Il cosid-detto “Asse del Male”, soprattutto adesso che alla CasaBianca non c’è più Bush potrebbe essere rivisto.Inoltre, con la Siria che sta rientrando nel club diploma-tico internazionale, Hezbollah concentrato nella corsaelettorale libanese del maggio prossimo e l’Iran altret-tanto impegnato a gestire le elezioni presidenziali coin-
cidenti con la peggiore crisi economica mai vissuta dal-l’avvento di Khomeini, si potrebbe dire che il bloccoantioccidentale è sempre meno monolitico. Di conse-guenza, proprio dall’estero potrebbero ripercuotersi suGaza le maggiori difficoltà in questo momento di rico-struzione. Peraltro, sempre restando concentrati suMeshal, quello che è emerso durante il conflitto è unasorta di scollamento operativo tra la testa di Hamas,protetta dalla campana di vetro messa a disposizionedall’efficiente apparato di sicurezza siriano, e il restodella dirigenza, che ha condiviso con la popolazione diGaza le tre settimane di guerra. In un certo senso, si staripetendo quanto accaduto nell’Iraq post-Saddam,quando gli esuli - rimasti lontani dal Paese per almenovent’anni - pretesero di instaurare un regime democra-tico in un contesto di cui avevano perso la cognizione.Parallelamente, tra Meshal da un lato e Haniyeh e al-Zahar dall’altro, corre la quotidianità della vita nellaStriscia. Perchè una cosa è dettare gli ordini e attende-re che questi vengano eseguiti a trecento chilometri didistanza, un’altra è impartirli brevi manu a esecutoricon cui si mantiene un rapporto e un dialogo assoluta-mente costante. Nella fattispecie, Ismail Hanieyh eMahmoud al-Zahar - rappresentanti rispettivamentel’ala moderata e quella più oltranzista del movimento -occupano una posizione di evidente vantaggio. Il fattodi essere rimasti rinchiusi nei bunker di Gaza durantegli attacchi israeliani ha permesso loro di vivere il con-flitto in prima persona, rendendosi così conto dei puntidi forza come pure delle debolezze di Hamas. Inoltre,fattore ancora più importante, la loro presenza nellaStriscia ha consacrato la loro immagine di fronte allapopolazione. Aonor del vero, condividere con i palesti-nesi le restrizioni nate con il blocco dei valichi è sem-pre stata una prerogativa di Hamas. È dai tempi dellosceicco Yassin, infatti, che la dirigenza del movimentoha scelto di non seguire l’esempio controproducente diFatah, i cui leader ostentano un tenore di vita manife-stamente superiore a quello medio della popolazionenel West Bank e a Gaza. Oggi il fatto di vivere la guer-ra in “presa diretta” attribuisce alla leadership di Hamasun’aura di valore che nemmeno la dirigenza di

dossier
27
Damasco può avere. Resta il fatto che tra Haniyeh e al-Zahar intercorrono le stesse differenze di impostazioneche hanno portato all’acutizzarsi della crisi. Non si puòdimenticare, infatti, che fu proprio l’oltranzismo del-l’ultimo tra i due a portare l’esecutivo di Hamas a pren-dere Gaza con la forza nel giugno 2007e, in tempiancora più attuali, a far saltare l’ultimo banco delle trat-tative per il rinnovo della tregua semestrale, pocoprima dello scoppio del conflitto.Ora, sulla base di questo quadro, Hamas deve affronta-re il 2009 all’insegna della ricostruzione, sia dellaStriscia sia del suo apparato interno. Questo obiettivonon può che essere il minimo comunedenominatore fra le tre sfere del movi-mento. Si tratta di un impegno cherichiede ingenti sforzi. Questi potrannovenire dall’estero, ma non è nemmenoscontato che l’origine sia quella chemolti pensano in Occidente, vale a direda Teheran. Tuttavia, sarà un terno allotto che, se riuscirà, potrà portareHamas a una nuova vittoria elettoralealle legislative e alle presidenziali del2010. Una ricostruzione su due binariche, per forza di cose, dovranno svilup-parsi contemporaneamente. Da una parte, bisogneràintervenire sulla popolazione della Striscia, dall’altra suun rafforzamento della dirigenza politica del movi-mento. Per molti aspetti, possiamo parlare di “Gazaanno zero”. Secondo una stima approssimativa - pur-troppo in un conflitto la precisione è dettata da altri fat-tori - “Piombo fuso” ha provocato una serie di danniper un ammontare complessivo di 2-3 miliardi di dol-lari. Il dato, però, è riferito unicamente agli edifici, pub-blici e privati, colpiti dai bombardamenti e non tieneconto delle ripercussioni anche economiche che posso-no generare dalla morte di oltre 1.200 persone e dalferimento di 5mila. A guerra appena finita, Hamas hafatto sapere che verserà mille euro alla famiglia di cia-scun “martire” e 500 per ogni ferito. Lecito chiedersidove potrà trovare risorse così ingenti per una politicadi Welfare tanto impegnativa. Peraltro i conti non pre-
vedono ancora la ricostruzione degli edifici, delle infra-strutture colpite e il riavvio di un sistema economicolocale già vessato dalla politica israeliana dei blocchi.Dall’Iran, il sostegno che gli Ayatollah hanno finoramantenuto per avere dalla loro parte una forza destabi-lizzante sulle coste del Mediterraneo potrà subire unacontrazione. ATeheran la corsa alle presidenziali insie-me alla crisi economica dovuta al crollo del prezzo delpetrolio possono rivelarsi una bomba a orologeria peril regime. Il Paese, infatti, vive una situazione in cui larepressione non ha né annientato il potere dell’opinio-ne pubblica né quello ancora più pericoloso di una sol-
levazione delle masse. In questo quadro, un aiuto adHamas - fratello comunque minore nella rivoluzioneislamica, per giunta sunnita e che persegue una lotta fintroppo territoriale - potrebbe apparire impopolare esoprattutto inopportuno. Uno spazio, questo, lasciatovuoto e che potrebbe essere colmato dall’ArabiaSaudita. Non è giunta a caso la mossa di Riyadh dioffrire un miliardo di dollari per la ricostruzione diGaza.
Un gesto che ha contemporaneamente spacca-to il fronte della Lega Araba, ma anche un tentativoopportunistico di contenere finalmente l’influenzadi Teheran su Hamas. È anche vero che simili sup-posizioni diventano molto meno realistiche seinquadrate nel contesto mediorientale. Le ipotesiche si possono formulare in un quadro di pace euro-
A guerra appena finita, Hamas ha fatto sapere che verserà mille euro alla famiglia di ciascun “martire” e 500 per ogniferito. Lecito chiedersi dove potrà trovare risorse così ingentiper una politica di Welfare tanto impegnativa

Risk
28
peo rischiano sempre di scontrarsi con gli attriti, gliimprevisti e le logiche di fazione che compongono ilcomplesso mondo palestinese.Più chiaro - per quanto anch’esso di difficile concretiz-zazione - è il processo di ricostruzione politica cheHamas dovrà affrontare. Qui non si tratta di ripartire dazero, bensì di saper mostrare all’opinione pubblicainterna e alla comunità internazionale che il movimen-to è tutt’altro che vinto. È probabile che la guerra abbiaaccelerato i tempi nell’evoluzione del movimento e gliabbia imposto quel passaggio dalla fase prevalente-mente operativa a quella politica, necessario per assu-mere saldamente il controllo dell’Anp. Le elezioni del2006 sono state un banco di prova che Hamas non hasaputo sfruttare. Di fronte all’ostracismo politico e allesanzioni economiche imposti dalla comunità interna-zionale, la reazione fu quella di un movimento nonancora pronto a reagire con strumenti altrettanto politi-ci. Il colpo di mano a Gaza e, per alcuni aspetti, ilsequestro di Gilad Shalit ne sono la dimostrazione piùevidente. “Piombo fuso”, infine, è servita da ulterioreribalta per l’ala intransigente di Hamas. Tuttavia, dopoquesta sequenza di estremismi, alla dirigenza del movi-mento resta l’opzione politica, se effettivamente vuoleraggiungere l’obiettivo prefissato di guidare l’Autoritàpalestinese.
In questo senso, Hamas non può più permet-tersi di confrontarsi con Fatah adottando strumenti chesono propri di una lotta armata fra clan e fazioni. Il rag-giungimento del potere e soprattutto l’acquisizionedella leadership implicano - al fine di realizzare il veroprogetto di Hamas, vale a dire l’affermazione di unoStato palestinese con un’impronta islamica - sia il rico-noscimento degli organi di governo dell’Anp sia quel-lo delle istituzioni con le quali aprire il confronto.Certo, anche in questo caso si tratta di una prospettivarealizzabile sulla carta e molto difficile da vedere inchiave mediorientale, tuttavia la realtà non offre alter-native. Governare uno Stato significa assumersi even-tualmente l’onere di riformarlo, ma non distruggerlo.Per forza di cose, quindi, Hamas sarà prima o poi
costretta a rivedere il suo concetto di resistenza, le sueinterpretazioni del contesto internazionale in cui que-st’ultima è inserita e perfino un possibile riconoscimen-to di Israele. Se politica significa, anche in MedioOriente, compromesso, allora il movimento dovràaccettare questa regola. Se vuole essere legittimato aRamallah e in seno alla comunità internazionale, alloradeve altrettanto legittimare le istituzioni dell’Anp equelle mondiali.Non basta, di conseguenza, recarsi in visita a Teheran,come ha fatto Meshal subito dopo la guerra, oppureinviare al Cairo i suoi rappresentanti più moderati per inegoziati su una tregua duratura. E non è nemmenosufficiente attendere la formazione di un governo israe-liano disposto a cedere alle proprie istanze. Se Hamasvuole davvero essere riconosciuta come una forza digoverno deve effettuare un’evoluzione strutturale eideologica al suo interno. Strutturale perché volta acontenere l’autonomia delle sue milizie. In quest’ambi-to Hamas potrebbe incorrere nelle maggiori difficoltà.Molti dei comandanti delle sue milizie sono infatti con-vinti che l’affermazione di uno Stato confessionaledella Palestina sia possibile unicamente seguendo la viadella resistenza armata. La leadership politica, invece,deve assumere il controllo anche della linea tattica,affinché la forza esecutiva agisca unicamente sulla basedel vertice decisionale. In un certo senso, suo malgrado il movimento islamicosarà costretto a seguire l’esempio di Fatah, le cui mili-zie sono state integrate nell’apparato di sicurezzadell’Anp. Ideologica invece perché, lo si voglia omeno, Israele è uno Stato sovrano e indipendente, rico-nosciuto dalla comunità internazionale. Per questo, ilsuo annientamento resta un progetto dai contenutimeramente propagandistici, ma irrealizzabile da unpunto di vista lucidamente politico. L’accettazione delconcetto di “due popoli due Stati” è, anche per Hamas,un passaggio imprescindibile. Si tratta di uno sforzoche molti dei suoi dirigenti potrebbero non cogliere.Tuttavia, questa è l’unica strada. Per la sopravvivenzadel movimento e, come Hamas stessa sottolinea, per ilbene del popolo palestinese.

dossier
29
to, provoca vittime civili. Per questa ragione Israele stasviluppando, ormai da diversi anni, un sistema di dife-sa capace di intercettare il razzo, o il missile, durantela sua traiettoria. Un sistema aperto e flessibile ingrado di adattarsi ad una minaccia multiforme - dalrazzo artigianale Qassam al missile a medio raggioiraniano Shahab 3 - e basato su più strati: uno strato“alto”, uno “intermedio” ed uno strato “basso”. Perciascuno di questi strati è già operativo, o è in corso disviluppo, un sistema: Arrow, Magic Wand e IronDomee.
La difesa contro i missili a medio raggio: l’ArrowIl sistema Arrow costituisce lo strato più alto delladifesa Abm israeliana ed è pensato per la protezionecontro missili balistici a medio raggio. L’Arrowaffianca il Patriot - utilizzato con scarsi risultati controgli Scud iracheni nel 1991 - al quale resta come ruoloprincipale la difesa aerea. Lo sviluppo del sistemaaffonda le sue radici sin nella seconda metà degli anniOttanta, quando il governo israeliano e gli Stati Unitifirmarono un protocollo d’intesa per condividere icosti di un programma rivolto alla realizzazione di unsistema in grado di proteggere il territorio israeliano daattacchi con missili balistici. In cambio della parteci-pazione finanziaria, che copre l’80% del programma,
gli Usa avrebbero avuto accesso a tutti i dati e le infor-mazioni e partecipato ai test (alcuni dei quali condottinegli Usa). Un’esperienza da travasare poi nei loroprogrammi antimissile, a cominciare dal Thaad, ed ungrande esempio di cooperazione. Al programma,infatti, oltre alla Mda, Missile Defense Agency, parte-cipano più di 100 aziende americane coordinate daBoeing, mentre quest’ultima fabbrica nei propri stabi-limenti il 50% delle componenti del missile Arrow 2,in base ad un accordo del 2003 con la Iai (l’aziendaisraeliana prime contractor del programma).Originariamente il sistema nacque per neutralizzare imissili Scud, ma nel corso degli anni ha subito unaggiornamento che ne ha via via incrementato le pre-stazioni per intercettare anche missili con caratteristi-che e portate differenti, come lo Shahab 3 iraniano(Arrow System Improvement Program, Asip). Il sistema è operativo dal Duemila e sul territorioisraeliano sono schierate già due batterie, una dispie-gata nella base di Palmachin, tra Ashdod e Tel Aviv, el’altra ad Ein Shemera, nei pressi di Hadera, a sud diHaifa. Israele prevede di schierare una terza batterianel sud del Paese, probabilmente contestualmente aldispiegamento del nuovo intercettore Arrow 3.Secondo gli israeliani queste due batterie di Arrowoffrirebbero già un’eccellente copertura per il territo-rio israeliano, sufficiente a fronteggiare un attacco
ARROW, MAGIC WAND E IRON DOME: COME DIFENDERSI DA RAZZI E MISSILI
AI QASSAM SI RISPONDE COSÌDI PIETRO BATACCHI
•II•
l recente conflitto di Gaza ha confermato una volta di più la necessità perIsraele di dotarsi di una difesa anti-razzo e anti-missile. Finora, le opzioni inmano israeliana per affrontare tale minaccia si sono limitate ai raid aerei - pre-ventivi o come rappresaglia deterrente - contro le aree di lancio. Una strate-gia che molte volte non ha portato ai risultati militari sperati e che, soprattut-

Risk
30
condotto con un numero limitato di missili balistici. L’Arrow intercetta i missili nella parte alta della strato-sfera (la stratosfera inizia intorno ai 12 km di distanzadalla Terra, 8 km ai poli e 20 km all’equatore, e termi-na ad un’altitudine di circa 50 km) ed al momento èl’unico sistema antimissile terrestre in grado di farlo(in attesa del Thaad americano). Il sistema si componeessenzialmente dell’intercettore Arrow 2, di un centrodi controllo del lancio, per operare e gestire i lanciato-ri, di un sistema di controllo del tiro Citron Tree e delradar di scoperta e tracking EL/M-2090 Green Pine.
Tutte componenti basate su piattaforme shelterizzatetrasportabili. L’Arrow 2 è un intercettore bistadio com-prendente un booster a propellente solido, che garanti-sce al missile l’uscita dal tubo del lanciatore e la spin-ta iniziale, ed un motore a razzo (sustainer), per man-tenere la velocità di 9 Mach. (2,5 km/s) durante le suc-cessive fasi della traiettoria, ed è dotato di un sistemadi controllo vettoriale della spinta che assicura un’al-tissima manovrabilità, in particolare nella fase termi-nale e di approccio al bersaglio. La sezione anterioredel missile - il cosiddetto kill vehicle - è equipaggiatacon quattro alette a controllo aerodinamico, per garan-tire un profilo migliore anche contro bersagli a bassequote, all’interno dell’atmosfera, ed ospita la testata a
frammentazione, in grado di distruggere il missileentro un raggio di 50 metri, la spoletta ed il sistema diguida terminale duale IR/radar. Ciascun lanciatoredispone di sei missili ed una batteria generalmentecomprende quattro o otto lanciatori, a seconda dellaconfigurazione. Il cuore dell’Arrow è costituito dalsistema di controllo del tiro Citron Tree. Un vero e pro-prio gioiello dell’elettronica in grado di analizzare letracce, valutare la minaccia, ottimizzare l’intercetta-zione e sovraintedere a tutta la missione fino all’ingag-gio. Il sistema può controllare fino a 14 intercettazionisimultaneamente e, oltre ai dati provenienti dal radar,può ricevere informazioni anche da altri apparatiesterni o dai satelliti. Infine, il sistema può operare inmodalità automatica o manuale (quest’ultima per darmodo all’operatore di controllare tutte le fasi dellamissione e nel caso di farla abortire). L’ultimo ele-mento dell’Arrow è il radar Green Pine EL/M-2090.Il Green Pine è un apparato molto potente a stato soli-do in banda L (1-2 GHz, per una lunghezza d’onda di30-15 cm) capace di assolvere la funzione di scopertae inseguimento del bersaglio. È accreditato di una por-tata di 500 km ed è in grado di inseguire un bersaglioin volo ad una velocità di 3.000 m/s. Nel corso deglianni l’Arrow è stato sottoposto ad un’estesa campa-gna di test. In totale, 14 prove di lancio e ingaggio, dicui 10 come sistema completo. Nel luglio 2004 è statoprovato per la prima volta contro un bersaglio reale:un missile Scud lanciato da una piattaforma marittimanel poligono californiano di Point Mugu dove per l’oc-casione erano state trasferite tutte le componenti delsistema. L’Arrow 2 ha intercettato e distrutto il bersa-glio ad un’altezza di 40 km. Un ulteriore passo inavanti è stato compiuto nell’aprile 2008 quando, in unnuovo test, il sistema ha simulato con successo l’inter-cetto di un bersaglio surrogato di un missile Shaahab3, denominato Blue Sparrow, lanciato da un caccia F-15 in volo ad oltre 12mila metri di quota. Il test aveval’obiettivo di valutare le capacità del sistema contro unbersaglio con testata separata ad alta velocità di rien-tro. Nonostante questi elementi di complicazione, ilradar è riuscito ad acquisire il bersaglio e il sistema di
Il Magic Wand/Stunner sipresenta come un sistemaflessibile ed economico perrispondere nel più brevetempo possibile al requisitodella difesa contro razzipesanti o missili a breveraggio. Per questo il sistemasi basa su tecnologie mature e riutilizza componenti già esistenti

dossier
31
controllo del tiro a calcolare in modo corretto la geo-metria di intercettazione. A breve dovrebbe tenersi untest in cui verrà provato un ingaggio reale.Nel complesso, l’Arrow è un Abm unico al mondonella sua categoria che, oltretutto, ha il vantaggio diessere integrato con il sistema di allarme lancio, l’ear-ly warning satellitare americano. Un fatto di enormerilevanza che in uno scenario reale gli consentirebbe diricevere immediatamente i dati sull’approntamento eil lancio di un eventuale Shahab 3 iraniano, predispo-nendosi così all’azione con notevole anticipo. A bene-ficio della copertura e dei tempi di reazione. Inoltre, unulteriore passo in avanti verrà compiuto quando saràattivato il collegamento con il radar Fbx-T che gliamericani hanno dislocato nella base di Nevatim, asud di Bersheedba, nel cuore del Negev, pochi mesi fa.Il radar, fa parte della Bmd (Ballistic Missile Defense)americana ed è gestito da personale americanodell’European Command. In tal senso il sensore non èun assetto israeliano - infatti personale israeliano nonha accesso al suo sito - ma può lo stesso passare i datiall’Arrow, estendendone le capacità di scoperta radarben oltre quelle garantite finora dal Green Pine. Ilcompletamento del link tra Fbx-T e Arrow dovrebbeavvenire entro quest’anno. Infine, il salto di qualitàdefinitiva avverrà quando sarà pronto il nuovo inter-cettore Arrow 3 con capacità d’ingaggio esoatmosfe-rica di missili balistici a raggio intermedio. Lo svilup-po è già iniziato e si stima che questo possa costare neiprossimi tre anni 7/800 milioni di dollari. Il Congressoamericano ha inserito tali fondi nel budget annualerelativo al programma Arrow rinnovato, fino al 2013,nel novembre 2007.
L’ombrello intermedio: il Magic Wand/StunnerIl sistema Magic Wand costituisce un ideale comple-mento per l’Arrow ed estende le capacità dell’IronDome anche al contrasto di razzi più pesanti deiQassam e dei Grad come i Fajr - con calibri superiori,tra i 240 ed i 333 mm, e gittate superiori, comprese trai 45 ed i 70 km - oppure di missili tattici a breve rag-
gio quali gli Zelzal 2 - in grado di colpire ad oltre 100km di distanza. Tutte armi da tempo in mano adHezbollah. Come l’Arrow, anche il Magic Wand è svi-luppato in modo congiunto tra Israele e Stati Uniti, madiversamente dall’Arrow, che è gestito dagli israelianied è una componente esclusiva della difesa dello Satoebraico, si tratta di un sistema cogestito. Gli Usa, chenon hanno nel loro arsenale un sistema in grado diaffrontare un tale tipo di minacce, hanno infattimostrato da subito molto interesse per il sistema epotrebbero anche acquisirlo. Il sistema è sviluppato inpartnership tra l’azienda israeliana Rafael ed il colos-so missilistico americano Raytheon. Il Congressoamericano ne ha approvato i finanziamenti nel settem-bre 2006 con un primo importo di 20,6 milioni di dol-lari. Nel complesso si stima che il completamentodello sviluppo del sistema, e la produzione dei primimissili, possa venire a costare attorno ai 400 milioni didollari. Il Magic Wand/Stunner si presenta come un sistemaflessibile ed economico per rispondere nel più brevetempo possibile al requisito della difesa contro razzipesanti o missili a breve raggio. Per questa ragione ilsistema si basa su tecnologie mature e riutilizza moltecomponenti già esistenti, da tempo realizzate dalle dueaziende nell’ambito di altri programmi. È previsto cheil sistema raggiunga una capacità operativa iniziale nel2012 o al massimo l’anno successivo. Nella sua con-figurazione base, il Magic Wand comprende un siste-ma di controllo del tiro, un radar multifunzionale equattro lanciatori, ciascuno contenente 16 intercettoriStunner. Per il momento si sa che il radar potrebbeessere lo stesso dell’Iron Dome e l’intercettore adattar-si anche ai lanciatori dei Patriot. Lo Stunner è un inter-cettore bi-stadio comprendente un booster, sviluppatodall’azienda americana Atk, ed un motore a razzomulti-impulso, sviluppato dalla Rafael, ed è caratteriz-zato da un’altissima manovrabilità e da un sistema diguida a doppia banda, Ir e radar, che gli conferisce lanecessaria precisione nella fase terminale ed un’eccel-lente resistenza alle contromisure (dal momento che ilseeker Ir è basato su un detettore di nuova generazio-


dossier
33
ne che riduce la radiazione di fondo infrarossa in mododa minimizzare l’efficacia degli inganni pirotecnici). Ilmissile intercetta il bersaglio con il cosiddetto mecca-nismo “hit-to-kill”, ovvero per impatto diretto, e lodistrugge con la sola forza dell’energia cinetica. Aquanto se ne sa, il sistema dovrebbe essere rischiaratoall’inizio nella parte settentrionale di Israele, al confi-ne con Siria e Libano.
Il livello più basso: l’Iron DomePer neutralizzare le minacce al più basso livello tatti-co, per intendersi razzi con una gittata inferiore ai 70km, leggi soprattutto Qassam e Grad, la Difesa israe-liana sta sviluppando il sistema Iron Dome. Adifferen-za dell’Arrow e del Magic Wand, l’Iron Dome è unsistema interamente israeliano e, almeno per ilmomento, non si ha notizia di finanziamenti da parteamericana. Il sistema è stato selezionato nel 2006 dopoche tutte le alternative prese in considerazione fino adallora si erano dimostrate troppo costose e tecnologi-camente immature. Per anni Israele, assieme agli Stati Uniti, ha cercato disviluppare sistemi con laser ad alta energia per contra-stare la minaccia dei razzi. Uno per tutti, il programmaNautilus, condotto in cooperazione con l’azienda ame-ricana Northrop Grumman, che però alla fine dei gio-chi si è rivelato semplicemente un enorme macchina“mangia soldi” e “mangia tempo”. Ed Israele non puòinvestire centinaia di milioni di dollari - alla fine pareche il Governo israeliano abbia investito nel Nautilus400 milioni di dollari - senza avere la certezza di unrisultato in tempi ragionevoli. È così che Israele si èdecisa ad uscire dal programma Nautilus e a prenderein considerazione alternative più economiche e fattibi-li. Il conflitto con Hezbollah nel 2006 ha spinto poi allascelta definitiva per l’Iron Dome: un sistema moltosemplice, altamente mobile, basato su tecnologiemature, e, soprattutto, un sistema pronto già nel 2010. L’Iron Dome si basa su un sistema di controllo del tiro,un radar per la scoperta e il tracking ed un intercettoredenominato Tamir. Quest’ultimo è lungo tre metri,pesa 90 kg, ha un diametro di 160 mm ed è dotato di
una testata a frammentazione con spoletta di prossimi-tà. Il Tamir è inoltre caratterizzato da un’altissimamanovrabilità, conferita dal sistema di controllo aero-dinamico ad alette, ed utilizza un seeker radar per l’ac-quisizione del bersaglio. Il radar è l’Elta EL/M-2084,basato sulle stesse tecnologie del Green Pine, in gradodi scoprire il bersaglio fino ad una distanza di 200 kme mantenerlo in tracking fino all’impatto. Una batteriaIron Dome comprende un sistema di controllo del tiro,un radar e tre lanciatori con 20 missili ciascuno.Secondo la Rafael, il sistema garantirebbe la copertu-ra di un’area di 100 Kmq, ma ciò che lo rende vera-mente all’avanguardia, in grado di adattarsi al meglioal requisito della difesa anti-razzo, è la sua capacità dianalizzare i dati forniti dal radar e determinare in basea questi l’esatta localizzazione del punto di ricadutadel razzo. Se questo è situato in un centro abitato o inuna qualunque area sensibile, viene lanciato l’intercet-tore, altrimenti no. In tal senso il sistema è esattamen-te in grado di discriminare tra traiettorie “buone” e“cattive” e ciò consente di dare una realistica applica-zione alla difesa anti-razzo, proteggendo davveroquello che di importante c’è in un territorio ed evitan-do di lanciare missili, che costano 100 volte tanto, con-tro Qassam che andrebbero altrimenti a colpire ildeserto o l’aperta campagna. Resta un grande punto interrogativo sui tempi di rea-zione del sistema. Un problema che sta agitando isonni della stampa israeliana e … dei cittadini diSderot, imbufaliti con il ministro Barak, accusato diaverli lasciati privi di difese, per via della presunteincapacità del sistema di intercettare i razzi lanciaticontro la cittadina che dista solo un chilometro dalconfine, e soli due chilometri dalle aree di lancio neipressi di Beit Hanoun. Un Qassam lanciato da quiimpiega dieci secondi per raggiungere Sderot.Troppo pochi per dar tempo all’Iron Dome di scopri-re il razzo, analizzare la traiettoria e poi lanciare ilTamir. Un bel problema, anche perché la stessaRafael ha più volte dichiarato in passato che l’IronDome ha una capacità di ingaggio minima di 4 km.E la polemica continua.

conoscimento dello Stato ebraico avrebbe costituito unatto di umanità in linea con i valori americani tradizio-nali. Per provare la fondatezza delle rivendicazioni ter-ritoriali degli Ebrei, Clifford citò il Libro delDeuteronomio: «Ecco, io vi ho posto il Paese dinanzi;entrate, prendete in possesso il Paese che il Signore hagiurato di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco eGiacobbe e alla loro stirpe dopo di essi». Ma non riuscìa convincere Marshall, il quale disse a Truman che nonavrebbe votato per lui alle elezioni ormai prossime sequella fosse stata la linea politica che intendeva seguire.Alla fine, Marshall accettò di non rendere noto il suodissenso. Due giorni dopo, passati 11 minuti dall’auto-procalamazione dello Stato di Israele, gli Stati Uniti loriconoscevano. Diversi osservatori interni e stranieriattribuirono la decisione di Truman al potere dellacomunità ebraica americana. Ritenevano determinanti ivoti degli ebrei, l’influenza dei media da questi control-lati ed i loro contributi economici alla campagna eletto-rale per le elezioni del 1948. Da allora, questo meccani-smo si è più volte riprodotto. Famosi esperti statuniten-si in materia di politica estera chiedono a Washington diadottare un atteggiamento prudente in Medio Oriente edammoniscono i Presidenti americani sull’elevato prez-zo da pagare a livello internazionale se gli Stati Uniti
offrono eccessivo sostegno ad Israele. Quando iPresidenti non danno ascolto ai loro consiglieri e assu-mono posizioni pro-israeliane, gli osservatori le attribui-scono alla “lobby israeliana”, che riconoscono (o accu-sano) di influenzare il Capo del Governo. Ma va consi-derato un altro fattore. Come ha scritto DavidMcCullough, biografo di Truman, l’iniziativa volta asostenere lo Stato ebraico godeva all’epoca di “notevo-le consenso” negli Stati Uniti. Secondo un sondaggioeffettuato nel 1948 dalla Gallup, il numero di americanisimpatizzanti per gli israeliani era almeno tre voltesuperiore a quello dei simpatizzanti per gli arabi. E quelsostegno non fu un fuoco di paglia. Il sostegno diffusoad Israele costituisce, infatti, uno dei principali pilastridella politica estera americana e, nel corso degli ultimi60 anni, nessun sondaggio Gallup ha mai mostrato unnumero maggiore di consensi per gli arabi o i palestine-si rispetto agli israeliani.Nel corso del tempo, inoltre, è andato rafforzandosi ilsentimento pro-israeliano della popolazione statuniten-se, soprattutto tra i non ebrei. Durante la presidenza diGeorge W. Bush il consenso dell’opinione pubblicaamericana nei confronti di Israele ha raggiunto i livellipiù alti e li ha mantenuti nel corso di entrambi i suoimandati. L’incremento si è registrato nonostante la
Risk
34
PERCHÉ WASHINGTON RESTA IL MIGLIORE ALLEATO DELL’UNICA DEMOCRAZIA IN MEDIORIENTE
OBAMA AL FIANCO DI GERUSALEMMEDI WALTER RUSSELL MEAD
l 12 maggio 1948 Clark Clifford, “chief counsel” della Casa Bianca, esponevale argomentazioni a favore del riconoscimento di Israele al gabinetto delPresidente Harry Truman, i cui componenti avevano opinioni divergenti.Dinanzi ad un accigliato George Marshall, allora Segretario di Stato ed uno scet-tico Robert Lovett, Sottosegraterio di Marshall, Clifford argomentava che il ri-II• •

dossier
35
diminuzione della rilevanza demografica della popola-zione di religione ebraica. Nel 1948, gli ebrei costituiva-no il 3,8% circa della popolazione statunitense.Supponendo che quell’anno quasi tutti gli ebrei ameri-cani vedessero con favore una politica estera pro-israe-liana, poco più del 10% dei sostenitori americani diIsraele aveva origini ebraiche. Nel 2007, gli ebrei costi-tuivano soltanto l’1,8% della popolazione degli StatiUniti e rappresentavano il 3% circa dei sostenitori ame-ricani di Israele. I dati summenzionati, alquanto elo-quenti, probabilmente sottostimano il fenomeno. Nel2006, il Pew Research Center ha condotto un sondaggioin cui chiedeva se la politica americana in MedioOriente fosse equidistante, favorisse gli israeliani, oppu-re favorisse i palestinesi. Il 47% degli americani harisposto che la riteneva equa, il 6% che favoriva i pale-stinesi e soltanto il 27% che favorisse Israele. Il sondag-gio è stato condotto nel periodo in cui era in corso lacampagna armata israeliana contro Hezbollah nelLibano meridionale, un momento in cui il sostegno sta-tunitense ad Israele era più che mai oggetto di aspre con-troversie in tutto il mondo. Se ne deve quindi dedurreche quelli che rispondono ai sondaggi asserendo che lapolitica statunitense è equidistante ed equa, in realtàsono favorevoli ad una politica che la maggior partedegli osservatori non americani considererebbe forte-mente ed irresponsabilmente pro-israeliana. L’opinionepubblica americana si mostra favorevole ad iniziative dipolitica estera marcatamente, profondamente, durevol-mente e notevolmente in contrasto con quanto invecepropugnato dall’opinione pubblica degli altri Paesi.Negli Stati Uniti, una politica estera pro-israeliana nonrappresenta il trionfo di una lobby minoritaria sullavolontà della cittadinanza, bensì la capacità dell’opinio-ne pubblica di influenzare la politica estera nonostante itimori degli esperti stranieri. Così come la guerra al nar-cotraffico e la barriera lungo il confine con il Messico, ilsostegno ad Israele costituisce una linea di politica este-ra che turba esperti e specialisti, ma gode del consensodell’opinione pubblica. Ciò non significa che la “lobbyisraeliana” non esista o non contribuisca a delineare lapolitica mediorientale degli Stati Uniti. E non significa
neppure che gli americani facciano bene a pensarlacome la pensano. (Resto convinto che tutti, compresi gliamericani e gli israeliani, trarrebbero giovamento da unamaggiore comprensione da parte statunitense dellerichieste e delle necessità dei palestinesi). Ma significache il motore primario della politica estera americana sisitua al di là del Beltway e al di fuori della comunitàebraica. Per capire perché la politica estera americanasia pro israeliana anziché essere neutra o favorire i pale-stinesi, è necessario studiare le ragioni dell’atteggiamen-to pro-israeliano di alcuni gruppi sociali non apparte-nenti ad alcuna élite e non ebrei.
I figli di DavideLa storia del sostegno americano ad uno Stato ebraico inMedio Oriente ha origini antiche. John Adams nonavrebbe potuto essere più esplicito. Infatti, dopo la con-clusione della sua presidenza, espresse l’auspicio «divedere gli ebrei ancora in Giudea, nazione indipenden-te». Dall’inizio del XIX secolo, i sionisti statunitensi sisono divisi in due gruppi. I sionisti profetici, che vede-vano il ritorno degli ebrei nella Terra Promessa come larealizzazione dell’interpretazione letterale della profeziabiblica, spesso correlata al ritorno di Cristo e alla fine delmondo. Sulla base di tale interpretazione del capitolo 18delle Profezie di Isaia, ad esempio, il PastorePresbiteriano di Albany John McDonald predisse, nel1814, che gli americani avrebbero assistito alla restaura-zione da parte degli ebrei del loro antico Stato. IMormoni condividevano tale visione; il ritorno degliebrei nella Terra Promessa era in atto, come sottolinea-va nel 1841 Elder Orson Hyde: «La grande ruota è inne-gabilmente in movimento e la parola dell’Onnipotenteha dichiarato che girerà». Altri, cristiani meno letterali eprofetici, hanno sviluppato un sionismo progressista,che avrebbe avuto eco per decenni tra laici e religiosi.Nel XIX secolo, i cristiani liberali ritenevano spesso cheDio stesse costruendo un mondo migliore attraverso ilprogresso dell’umanità. Questi consideravano gli StatiUniti, Paese democratico e (relativamente) egualitario,un esempio del nuovo mondo che Dio stava costruendoe un potente strumento per il compimento di quel gran-


dossier
37
dioso disegno. Alcuni protestanti americani credevanoche Dio si stesse adoperando per riportare gli ebrei, cheloro ritenevano umiliati ed oppressi, nella TerraPromessa, così come Dio stava migliorando il livello divita di altre popolazioni ignoranti e miscredenti attraver-so l’affermarsi dei principi protestanti e liberali.Desideravano che gli ebrei creassero un loro Stato per-ché credevano che ciò li avrebbe posti al riparo dallepersecuzioni e, grazie al potere di redenzione della liber-tà e del lavoro agricolo onesto, avrebbe consentito lorodi migliorare ed elevare i costumi e l’igiene, che ritene-vano squallidi e riprovevoli, degli ebrei ottomani ed est-europei contemporanei. Per dirla con Adams, «Unavolta che avranno un governo indipendente e che nonsaranno perseguitati, cancelleranno alcune delle asperi-tà e delle peculiarità del loro carattere e forse potrannodiventare cristiani unitari liberali». Per questi cristiani, ilsionismo americano faceva parte di un programma piùampio di trasformazione del mondo attraverso la pro-mozione degli ideali degli Stati Uniti. Non tutti i sioni-sti progressisti hanno basato le loro argomentazioni supresupposti religiosi. Già nel 1816, il Weekly Registerdi Niles, il principale periodico americano d’opinioni enotizie della prima metà del XIX secolo, prediceva esalutava con favore l’imminente ritorno degli ebrei inuno Stato indipendente con Gerusalemme capitale.
Secondo il giornale, la restaurazione degli ebrei avreb-be promosso i lumi ed il progresso e di ciò, naturalmen-te, avrebbero beneficiato sia gli Stati Uniti che gli stes-si ebrei. I sionisti profetici divennero più numerosidopo la Guerra civile americana e andò affermandosi laloro visione in ordine al ruolo che uno Stato ebraicorestaurato avrebbe potuto svolgere negli eventi cheavrebbero portato all’apocalisse. I libri e le pubblica-zioni sulla prevista restaurazione degli ebrei e sul-l’identità ed il ritorno delle “tribù perdute” degli antichiebrei erano sempre tra i più venduti ed il connubio traDwight Moody, il più eminente evangelista del Paese eCyrus Scofield, illustre studioso della Bibbia, pose lastoria futura di Israele al centro dell’immaginario delprotestantesimo conservatore americano. Tali gruppi disionisti non ebrei trovarono nuovi sebbene talvolta
sgradevoli alleati dopo il 1880, periodo in cui ebbe ini-zio una forte ondata migratoria di ebrei russi verso gliStati Uniti. Alcuni di loro ed alcuni ebrei americano-tedeschi integrati speravano che la Palestina diventassela nuova dimora di quello che era un gruppo non benvisto di immigranti, al posto degli Stati Uniti. Per gliantisemiti, la creazione di uno Stato ebraico avrebbepotuto, oppure no, “curare” gli ebrei eliminando quellecaratteristiche che venivano attribuite loro da molti nonebrei, ma ad ogni modo la creazione di uno Stato avreb-be ridotto i flussi migratori verso gli Stati Uniti. Nel1891, questi filoni di Sionisti non ebrei si unificarono. Illeader laico metodista William Blackstone presentò unapetizione al presidente Benjamin Harrison chiedendoagli Stati Uniti di adoperarsi per organizzare un verticedelle potenze europee volto ad indurre l’ImperoOttomano a consegnare la Palestina agli ebrei. La stra-grande maggioranza dei 400 firmatari era composta danon ebrei e tra loro figuravano il primo giudice dellaCorte Suprema, il presidente della Camera deiRappresentanti, i presidenti delle Commissioni Waysand Means ed Affari Esteri della Camera, il futuro pre-sidente William McKinley, i sindaci di Baltimora,Boston, Chicago, New York, Filadelfia e Washington,gli editori o proprietari delle principali testate dellaCosta Orientale e di Chicago, nonché un’impressionan-
Negli Stati Uniti, una politica estera pro-israeliana non rappresenta il trionfo di una lobby minoritariasulla volontà della cittadinanza, bensì la capacità dell’opinione pubblica di influenzare la politica estera nonostantei timori degli esperti

Risk
38
te numero di religiosi appartenenti alle Chiese episcopa-le, metodista, presbiteriana e cattolica romana. Tra gliesponenti del mondo economico che firmarono la peti-zione figurano Cyrus McCormick, John Rockefeller e J.P. Morgan. In un’epoca in cui la comunità ebraica ame-ricana non era né potente né cospicua e non esistevanulla di paragonabile ad una lobby israeliana, i pilastrinon ebrei dello Stato americano continuavano a soste-nere un’iniziativa diplomatica statunitense volta a crea-re uno Stato ebraico nei territori della Bibbia.
Comandamenti comuniQualsiasi riflessione riguardante l’atteggiamento degliStati Uniti nei confronti d’Israele deve partire dallaBibbia. Per secoli, l’immaginario americano è statoimpregnato delle scritture ebraiche. Tale influsso haavuto origine dalla riscoperta del Vecchio Testamentodurante la Riforma, si è accentuato con lo svilupparsidella teologia calvinista (che evidenziava gli elementi dicontinuità tra le leggi antiche e moderne della graziadivina) ed è stato reso più vitale dalle similitudini stori-che tra le esperienze ebraiche moderne ed antiche.Quindi, la lingua, gli eroi e le idee del VecchioTestamento permeano la psiche degli americani.Un’istruzione in ebraico biblico era obbligatoria nelleuniversità di Columbia, Dartmouth, Harvard, Princetone Yale. James Madison concluse i suoi studi a Princetonin due anni, ma vi restò un altro anno per studiare la lin-gua ebraica. I predicatori ed i liberalisti coloniali conti-nuavano a descrivere gli Stati Uniti come una nuovaCanaan, «una terra inondata da latte e miele» e a ricor-dare al loro pubblico che così come gli ebrei avevanoperso i loro doni del cielo per aver offeso Dio, allo stes-so modo gli americani avrebbero sofferto se avesserodisobbedito al Dio che li aveva condotti alla loro terrapromessa. Oggi, i riferimenti al Vecchio Testamentocontinuano a permeare gli scritti politici, l’oratoria epersino la geografia americani: più di mille città e pesidegli Stati Uniti hanno nomi tratti dalle Sacre Scritture.La più evidente espressione religiosa dell’importanzadel Vecchio Testamento per la cultura Usa di oggi ècostituita dall’affermarsi del “dispensalismo” pre-mille-
narista, un’interpretazione delle profezie bibliche cheannette particolare rilevanza ai concetti religiosi espres-si nel Vecchio Testamento quale la “teologia del patto”(o covenant theology) ed attribuisce un ruolo decisivoallo Stato ebraico restaurato (con Gerusalemme comecapitale) nella storia futura. Si calcola che il 7% circadegli americani sostenga tale posizione teologica (ungruppo di persone numericamente quattro volte supe-riore alla comunità ebraica americana), mentre unnumero notevolmente superiore di individui ne sono piùo meno influenzati. I propugnatori di tali teorie condivi-dono spesso (ma non sempre) l’idea sostenuta da alcu-ni ebrei ortodossi, secondo cui gli ebrei devono insiste-re per avere uno Stato che ricomprenda tutti i territoripromessi agli ebrei. Si oppongono a qualsiasi compro-messo con i palestinesi e sono favorevoli agli insedia-menti israeliani in Cisgiordania. Ma si tratta di unaminoranza, anche tra i sostenitori statunitensi di Israele.D’altro canto, il sionismo cristiano progressista è corre-lato all’etica cristiana anziché alla profezia. Si fondaessenzialmente sul senso di colpa e sull’idea che i mal-trattamenti subiti dagli ebrei da parte dei cristiani impe-disca loro oggi di accettare il cristianesimo. Per moltopiù di un millennio, gli ebrei d’Europa hanno subitocrudeltà terribili ed a volte inenarrabili per mano dei cri-stiani europei. Sebbene alcuni protestanti americaniabbiano perpetuato questa storia di intolleranza ed anti-semitismo, molti protestanti americani liberali dal XIXsecolo in poi hanno considerato il rifiuto di tale passatocome uno dei compiti caratterizzanti la Chiesa america-na riformata ed illuminata. Tali protestanti potevano (elo fecero senza problemi) deprecare l’antisemitismocattolico considerato una conseguenza della deplorabilecorruzione della Chiesa sotto il papato, ma le parole egli atti antisemiti di riformatori quali Martin Lutero nonpotevano essere negati tanto facilmente. Molti apparte-nenti alle chiese protestanti liberali americane conside-ravano un sacro dovere completare il lavoro iniziatodalla Riforma liberando il cristianesimo da ciò che di“medievale” rimaneva in esso, come ad esempio lasuperstizione, il fanatismo e l’antisemitismo. Fareammenda per i peccati commessi in passato proteggen-

dossier
39
do gli Ebrei ha costituito per molto tempo una provareligiosa importante per molti (sebbene assolutamentenon per tutti) protestanti americani. Per converso, lamaggior parte dei cristiani americani ha nutrito pochi onessun senso di colpa per le relazioni storiche che leloro comunità hanno avuto con il mondo musulmano.Molti musulmani considerano i conflitti cristiano-musulmani dell’ultimo millennio un fenomeno costan-te e relativamente omogeneo, ma i protestanti america-ni non la vedono allo stesso modo. Solitamente questideplorano le crudeltà delle Crociate ed il concetto diguerra santa, ma li considerano errori dei cattolici anzi-ché dei cristiani in senso più ampio e, ad ogni modo,ritengono le crociate qualcosa di ormai passato che,comunque, ha avuto luogo in risposta ad un’aggressio-ne da parte musulmana. Inoltre, solitamente disappro-vano le campagne predatorie condotte dalle potenzeeuropee negli ultimi secoli, ma le considerano un pro-dotto dell’imperialismo del Vecchio Mondo piuttostoche del cristianesimo e, per questo, non se ne ritengonoresponsabili. (Va ricordata una importante eccezione:molti missionari statunitensi che operano inMedioriente hanno stabilito forti legami con le popola-zioni arabe di quell’area ed hanno espresso profondosostegno al nazionalismo arabo, sia come condanna delcolonialismo europeo, sia nella speranza che un movi-mento nazionalista laico possa migliorare le condizio-ni dei Cristiani arabi. Tale comunità di missionari ha contribuito all’affer-marsi della fazione arabista presso il dipartimento diStato ed alla reazione delle Chiese Protestanti domi-nanti contro la politica israeliana nei territori occupatidopo la guerra del 1967). Nel 1948, molti cristiani negliStati Uniti si sentivano carichi di un pesante fardello.Un debito storico e degli obblighi nei confronti degliebrei, ma non dei musulmani. Semmai, ritenevano cheil mondo islamico fosse in debito con i missionari cri-stiani americani per molte delle importanti università eper i numerosi ospedali e che il sostegno dei cristianiamericani prima e dopo la Seconda Guerra Mondialeavesse contribuito all’affermarsi, in quel periodo, diStati Arabi e musulmani sovrani.
I cugini presceltiIl senso identitario e missionario degli Stati Uniti è statoforgiato dalle letture della storia e del pensiero ebraici.Lo scrittore Hermann Melville espresse tale visione:«Noi americani siamo il popolo peculiare, il popolo pre-scelto - l’Israele dei nostri tempi; noi portiamo l’arcadella libertà del mondo». Dall’epoca dei puritani adoggi predicatori, pensatori e politici degli Stati Uniti -tanto laici quanto religiosi, tanto liberali quanto conser-vatori - hanno intravisto negli statunitensi il popolo elet-to, legato non da vincoli di sangue, bensì da un comunesostrato di principi e da un comune destino. Gli ameri-cani hanno creduto che Dio (o la storia) li avesse con-dotti in una nuova terra, li avesse resi grandi e facoltosi,hanno creduto che la propria prolungata prosperitàdipendesse dall’adempiere compiutamente agli obbli-ghi verso Dio o verso i principi che hanno finora con-sentito che il destino arridesse loro. Ignorate tali princi-pi - rivolgetevi verso il vitello d’oro - ed il flagello siabbatterà su di voi.Tanto gli americani credenti quanto quelli non credentihanno visto nelle Sacre Scritture ebraiche un esempio dipopolo depositario di una missione e perciò chiamato acompiere il proprio destino, quello cioè di plasmare il
In un’epoca in cui la comunità ebraica americana non era né potente né cospicua e non esisteva nulla di paragonabile ad una lobbyisraeliana, i pilastri nonebrei dello Stato americanocontinuavano a sostenereun’iniziativa diplomaticastatunitense volta a creareuno Stato ebraico


dossier
41
mondo. La terra in cui gli americani risiedono apparte-neva un tempo ad altri? Si, ma allo stesso modo anchegli ebrei conquistarono la terra dei canaaniti. Le piccolecolonie statunitensi armate solo della propria giustacausa sconfissero i grandi imperi mondiali? Altrettantofece Davide, l’umile pastore, nell’abbattere Golia. Nelsecolo XIX gli americani erano isolati e derisi in ragio-ne dei propri ideali democratici? La stessa sorte toccòagli ebrei, circondati da idolatri. Gli americani hannosconfitto i propri nemici interni ed esterni? Ugualetrionfo, secondo le Scritture, arrise al popolo ebraico. Equando gli americani assoggettarono alla schiavitùmilioni di persone in violazione dei propri principi,furono essi puniti e flagellati? Sì, e nella misura in cui ilpopolo ebraico patì le sofferenze derivanti dai peccaticommessi di fronte a Dio.Tale mitica concezione della natura e del destino degliStati Uniti costituisce uno dei più potenti e durevoli ele-menti della cultura e del pensiero americani. Come gliantichi ebrei, molti americani contemporanei ritengonodi essere depositari di una rivelazione, non solo per lorostessi ma per il mondo intero; essi hanno sempre consi-derato sé stessi come una Nuova Israele voluta da Dio.Una delle tante conseguenze che discendono da talesupposta parentela è che molti americani giudichinotanto giusto quanto appropriato il supporto di un popo-lo prescelto ad un altro popolo. Essi non si sentono tur-bati quando l’appoggio statunitense ad Israele, un popo-lo ed uno stato sovente isolato ed ostracizzato, rende gliStati Uniti impopolari o genera nuove tensioni.L’adozione, da parte statunitense, del ruolo di protettoridello Stato di Israele e di amici del popolo ebraico rap-presenta una via di legittimazione del proprio status dipaese scelto da Dio come portatore di un destino unico.Per di più, dal XIX secolo gli Stati Uniti hanno conside-rato sé stessi come gli emissari scelti da Dio per porta-re a compimento l’opera di protezione e redenzionedegli ebrei. Gli americani ritenevano che gli ebrei sisarebbero risollevati dalla propria degradata condizionemigrando dai sobborghi cittadini alle campagne - cosìcome gli immigrati provenienti da tutta Europa si eranocostruiti vite migliori ed una reputazione di forti conta-
dini jeffersoniani. I cristiano-liberali come Adams rite-nevano che ciò avrebbe condotto gli ebrei in tempo nel-l’alveo del protestantesimo liberale come parte di ungenerale miglioramento dell’umanità. E i sionisti profe-tici auspicavano che una conversione in massa degliebrei ad una cristianità revivalista avrebbe favoritol’apocalisse e la discesa di Cristo in terra. In un modo onell’altro, il ruolo speciale ricoperto dagli Stati Unitinella redenzione degli ebrei informava le aspettativedelle classi agiate americane circa un percorso insitonella storia e confermava le convinzioni di queste rela-tivamente all’identità ed alla missione degli Stati Uniti.
Gli Stati coloniGli Stati Uniti ed Israele godono inoltre dello status con-diviso di “stati coloni” - nazioni create da popolazioni lequali giunsero ad ottenere il controllo dei propri attualiterritori dopo aver allontanato le popolazioni originarie.Entrambi sono stati potentemente modellati da una sto-ria di conflitti e scontri contro coloro che hanno sop-piantato, ed entrambi hanno addotto similari giustifica-zioni per la propria condotta. Sia gli americani che gliisraeliani si sono innanzitutto rivolti al VecchioTestamento, le cui pagine consacrate narrano la storiadel conflitto tra gli antichi ebrei ed i canaaniti, i prece-denti abitanti di quella che il popolo ebraico considera-va la propria Terra Promessa. Gli americani trovaronol’idea di essere il nuovo Israele di Dio così allettanteanche poiché essa aiutava a giustificare lo spostamentodei nativi americani. Come Theodore Roosevelt ebbe adire nella sua fortunata storia dell’ovest americano«Molti tra i migliori zoticoni leggevano la Bibbia, maessi furono cresciuti all’insegna di un credo che attinge-va in buona parte dal Vecchio Testamento, e ponevapoco risalto sui concetti di pietà, verità, o misericordia.Essi guardavano ai propri nemici così come i profetiebrei guardavano ai nemici di Israele. Quali furono leefferatezze a causa delle quali i Canaaniti furono distrut-ti da Giosuè, in confronto alle efferatezze perpetrate daiselvaggi pellerossa le cui terre quegli uomini, parte di unaltro popolo prescelto, avrebbero dovuto ereditare?»(Roosevelt stesso, come il cugino Franklin ed Eleanor,

Risk
42
era un sionista cristiano. «Mi sembra assolutamenteappropriato creare uno stato sionista attorno aGerusalemme», scrisse nel 1918.)Al di là di una diretta promessa divina, due altre impor-tanti giustificazioni addotte dagli americani nel corsodella loro lotta contro i nativi furono il principio secon-do cui essi si stessero espandendo verso “terre vuote” ela connessa dottrina delle “libere utilizzazioni” di JohnLocke, che sosteneva che una proprietà inutilizzatacostituisse uno spreco ed un’offesa alla natura. I colonistatunitensi ritenevano che solo chi avesse apportatomigliorie alla terra mediante la creazione di aziendeagricole imperniate sulle colture estensive e mediante lacostruzione di nuovi insediamenti urbani godesse deldiritto di possederla. John Quincy Adams addusse a ciòvalidi argomenti nel 1802: «Condanneranno (i nativi)un’immensa regione del globo alla desolazione perpe-tua…?». E Thomas Jefferson avvertì che i nativi ameri-cani che non si sarebbero rivelati in grado di apprende-re dai bianchi e di impegnarsi in un’agricoltura produt-tiva sarebbero andati incontro ad uno spiacevole desti-no. Essi «ripiomberanno nella barbarie e nella miseria,ridurranno la propria consistenza a fronte delle guerre edei conflitti, e noi ci vedremo obbligati a condurli tra leMontagne Rocciose, assieme alle bestie della foresta».Lungo buona parte del corso della storia americana, talivisioni riecheggiavano non solo tra gli zoticoni maanche tra i cittadini liberali e raffinati. Tali argomenta-zioni conservavano un significato speciale in riferimen-to alla Terra Santa. Poiché negli americani devoti alber-gava il pensiero delle glorie dell’antica Gerusalemme edel Tempio di Salomone, essi descrissero una terramagnifica e fertile - «una terra dove sgorgano latte emiele», come narra la Bibbia. Ma a partire dal secoloXIX, quando prima decine, poi centinaia, infine miglia-ia di americani visitarono la Terra Santa - ed altri milio-ni assistevano a lezioni e simposi che fornivano reso-conti di tali viaggi - rimanevano poco latte e poco miele;la Palestina era una delle province più povere, arretrateed instabili dell’Impero Ottomano. Agli occhi degliamericani, i pendii collinari e le distese rocciose dellaGiudea apparivano desolati e vuoti - molti ritenevano
che Dio avesse scagliato una maledizione contro quellaterra quando costrinse gli ebrei ad un secondo esilio,visto come la punizione inferta al popolo ebraico pernon aver riconosciuto in Cristo il Messia. E così, credet-tero gli americani, gli ebrei appartenevano alla TerraSanta, e la Terra Santa apparteneva agli ebrei. Essi nonavrebbero mai potuto prosperare fintanto che non fosse-ro stati liberi in casa propria, e la terra sarebbe fioritasolo con il ritorno dei suoi legittimi proprietari. Il profeta Isaia aveva descritto il futuro ritorno del popo-lo ebraico alla terra d’origine come la grazia di Dio cheporta acqua ad una terra deserta. E gli americani guarda-vano con occhi stupiti alla ritrovata fertilità del suolograzie alle coltivazioni dei primi coloni sionisti come alcompimento della profezia biblica. «Le primavere dellavigorosa colonizzazione ebraica, ampiamente foraggia-ta dal denaro dell’ebraismo mondiale, scorre fino aldeserto» scriveva Time Magazine nel 1946, riecheg-giando il linguaggio di Isaia. Due anni dopo, a seguitodel successo ebraico nel conflitto del 1948, descrivevagli arabi con una terminologia che oggi susciterebbescalpore, ma che al tempo rappresentava il comune sen-tire degli americani: «Il mondo occidentale tende avedere l’arabo come un guerriero dagli occhi di falco suun bianco destriero. Quell’arabo è ancora presente, main quantità meno cospicua degli sventurati perseguitatidalle malattie che giacciono nelle strade arroventate,troppo deboli, malfermi e senza alcun fine per trascinar-si all’ombra». Gli americani intravidero una lotta tra unpopolo arretrato ed incapace ed uno in grado di piegareil deserto ai propri scopi facendolo rifiorire, portandomiracolosamente a compimento le antiche profezie diuno stato ebraico. Gli ebrei sono stati generalmente con-siderati come il popolo più deplorevole dell’Europaorientale: ignoranti, depravati, superstiziosi, divisi trafazioni, irascibili ed inguaribilmente arretrati. Il fatto chetale popolo, dopo essere stato soggetto alla barbariesenza precedenti della persecuzione nazista, erigesse laprima stabile democrazia del Medio Oriente, sviluppas-se una fiorente economia nel cuore del deserto e scon-figgesse ripetutamente i propri nemici grazie ad esercitidi gran lunga più grandi e forti costituì per molti ameri-

dossier
43
cani un’impressionante riprova storica degli ideali a loropiù cari.
La svolta a destraSebbene il supporto ad Israele da parte delle classi piùagiate degli Stati Uniti sia rimasto forte e si sia persinoaccresciuto a partire dal secondo conflitto mondiale, isuoi connotati sono cambiati. Fino alla guerra dei SeiGiorni, l’appoggio ad Israele proveniva principalmentedalla sinistra e riscuoteva maggiori simpatie tra i demo-cratici che tra i repubblicani. Icone liberali comeEleanor Roosevelt, Paul Tillich, Reinhold Niebuhr eMartin Luther King Jr. rappresentavano delle eminentivoci a sostegno del supporto statunitense ad Israele. Madal 1967 il sostegno liberale è gradualmente diminuito,sostituito da un sempre maggiore appoggio da parte deiconservatori. Vari fattori hanno fatto sì che il sionismoprogressista diventasse un potente ago della bilancianella politica statunitense, in particolar modo a sinistra.Innanzitutto, l’impatto provocato nel mondo protestan-te dall’Olocausto fu enorme. La Germania aveva untempo costituito il principale fulcro dottrinario per lachiesa protestante americana, e l’acquiescenza passivacon la quale buona parte delle chiese protestanti tede-sche salutarono l’avvento del Nazismo provocò unani-me sdegno all’interno del protestantesimo americano. Iprotestanti tedeschi antinazisti furono elevati al ruolo dieroi teologici negli Stati Uniti del dopoguerra, e l’oppo-sizione all’antisemitismo divenne una fondamentalecartina tornasole attraverso cui i protestanti americanitradizionali iniziarono a giudicare sé stessi ed propri lea-der. Tale profondo shock intensificò la risposta umanita-ria a fronte delle rivelazioni sui campi di sterminio esugli omicidi di massa. Le sofferenze degli sfollati, affa-mati ed impoveriti rifugiati ebrei nella caotica Europapostbellica ebbe come ovvia conseguenza il fatto che iprotestanti americani, sostenitori da secoli dei diritti delpopolo ebraico, appoggiassero entusiasticamente lemisure volte a porre in condizioni di sicurezza gli ebreid’Europa. Un secondo fattore fu il considerevole supporto fornitodagli afroamericani agli ebrei in un periodo in cui la
popolazione di colore iniziava a svolgere un ruolo disempre maggior influenza nelle campagne elettorali sta-tunitensi. Durante gli anni ’30, la stampa afroamericanain tutti gli Stati Uniti aveva seguito da vicino l’imposi-zione di politiche razziali da parte di Hitler. I leader
afroamericani non persero occasione di denunciare lesomiglianze tra il trattamento inferto da Hitler agli ebreied i provvedimenti di segregazione emanati da JimCrow negli stati del Sud degli Stati Uniti. Per gli afroa-mericani la persecuzione degli ebrei si palesava attraver-so l’esperienza quotidiana. Inoltre, essa forniva loroimportanti basi argomentative al fine di persuadere ibianchi che la discriminazione razziale violasse i princi-pi fondamentali americani, fornendo così un solido ter-reno d’incontro tra gli ebrei americani ed il movimentoper i diritti civili nato nel 1945 e sopravissuto alla mortedi King. Anche durante il corso del secondo conflittomondiale, gli attivisti di colore Du Bois, Zora NealeHurston, Langston Hughes e Philip Randolph sostenne-ro il precursore del partito israeliano Likud nei suoi sfor-
Il fatto che il popolo di Israele, dopo essere statosoggetto alla barbarie della persecuzione nazista, erigesse la prima stabiledemocrazia del MedioOriente e sviluppasse una fiorente economia nel cuore del deserto sconfiggendo eserciti più grandi e forti costituì per molti americani un’impressionante riprovastorica degli ideali a loro più cari


dossier
45
zi volti a creare un esercito ebraico. Il leader dei diritticivili Adam Clayton Powell Jr. si spinse oltre, racco-gliendo 150mila dollari per il gruppo militante sionistaIrgun Zvai Leumi - da lui definito «un’organizzazioneterrorista clandestina in Palestina» - durante una mani-festazione a New York City.Un’ulteriore impulso alla creazione di uno stato israelia-no indipendente venne dall’Unione Sovietica. A Yalta,Josip Stalin disse a Franklin Delano Roosevelt che eglistesso era un sionista, e nel maggio 1947 il ministrodegli esteri sovietico Andrei Gromyko annunciò dall’as-sise delle Nazioni Unite che l’Unione Sovietica avrebbeappoggiato la creazione di uno stato ebraico. Tale soste-gno, comunque di breve durata, rafforzò la convinzionedi buona parte della sinistra americana che la definizio-ne di una patria per il popolo ebraico fosse parte di unapiù generale lotta per il progresso nel mondo. In effetti,nei decenni successivi al conflitto, molti americani inter-pretarono il proprio appoggio ad Israele come parte delloro impegno a favore della libertà, contro il coloniali-smo (gli ebrei della Palestina stavano tentando di affran-carsi dal dominio britannico), contro le discriminazionirazziali e religiose, per la laicità, per l’umanitarismo enel solco della tradizione progressista statunitense. Altempo Israele appariva come un idealistico esperimentolaico di democrazia sociale; gli ebrei americani ed anchegli alti strati della società statunitense si recarono inIsraele per sperimentare la vita di lavoro in comunitàtipica dei kibbutz. Pertanto nel 1948, quando Trumandecise di sostenere la creazione di Israele, egli non stavasemplicemente pensando ad accaparrarsi il voto degliebrei d’America. L’appoggio ad Israele riscuoteva con-sensi tra i neri del Nord, che si erano avvicinati al PartitoDemocratico sulla scia del New Deal e della sempremaggiore tutela dei diritti civili da parte di Truman. Il farpropria la causa d’Israele suscitò simpatie tra la sinistra,altrimenti orientata verso i Progressisti di HenryWallace. E consentì inoltre a Truman di riscuotere suc-cesso tra quel gruppo di elettori Dixiecrats del Sud con-servatori, praticanti, avidi lettori della Bibbia facenticapo a Strom Thurmond. Il sostegno ad Israele fu infat-ti una delle poche questioni che consentì ad un Partito
Democratico diviso di serrare i ranghi.In ogni caso, a partire dalla guerra del 1967 la base disostegno statunitense ad Israele si è spostata: l’appoggioad Israele ha connotato in misura sempre maggiore ladestra rispetto alla sinistra. A sinistra, infatti, una diffusaavversione alle politiche messe in atto da Israele neiterritori occupati ed un minore interesse circa la suasicurezza all’indomani del trionfo bellico portaronomolti afroamericani, molti protestanti tradizionalisti emolti intellettuali liberali, un tempo tra i più fervidisostenitori statunitensi di Israele, a fraternizzare con lacausa palestinese. L’accresciuta identificazione daparte dei cittadini di colore con i movimenti anticolo-niali di tutto il mondo, l’erosione dell’alleanza afro-ebraica relativamente alla politica interna statunitensee la crescente attrazione esercitata da figure comeMalcom X ed i leader della Nation of Islam ridusserogradualmente il sostegno afroamericano ad Israele. Daparte loro, le chiese protestanti liberali si dimostraronomaggiormente aperte nei confronti delle prospettive diquei missionari solidali con il nazionalismo arabo, equando le principali chiese iniziarono a muovere criti-che alla tradizionale visione americana circa l’identitànazionale ed il destino degli Stati Uniti, essi si distan-ziarono ancora di più dalle tradizionali interpretazionidel Vecchio Testamento. (D’altro canto, i rapporti tra icattolici americani e gli ebrei iniziarono a migliorare aseguito del conflitto del 1967, soprattutto in virtù delnuovo approccio teologico delineato dalla chiesa catto-lica nei confronti del popolo ebraico a seguito delConcilio Vaticano II.)A destra, il cambiamento più significativo dal 1967 ècostituito dall’enorme intensificazione dell’appoggio adIsraele tra i cristiani evangelici e, più in generale, traquanti ho definito gli elettori “jacksoniani” nel cuoredegli Stati Uniti. I jacksoniani sono elettori populisti-nazionalisti propugnatori di un forte esercito statuniten-se, generalmente scettici nei confronti delle organizza-zioni internazionali e dell’assistenza umanitaria globale.Non tutti gli evangelici sono jacksoniani, e non tutti ijacksoniani sono evangelici, ma esiste una certa commi-stione tra le due componenti. Molti bianchi del Sud sono

Risk
46
Jacksoniani; così come molti degli elettori incerti delNord, noti come i democratici di Reagan. Molti jackso-niani si fecero un’immagine negativa degli arabi duran-te la Guerra Fredda. Essi facevano notare come i pale-stinesi e gli Stati arabi tendevano a prendere le partidell’Unione Sovietica e del movimento dei NonAllineati contro gli Stati Uniti. Durante la crisi di Suezdel 1956, gli egiziani declinarono l’offerta di aiuto sta-tunitense e si rivolsero all’Unione Sovietica per riceve-re armamenti e sostegno; le forniture belliche e gli
esperti sovietici consentirono agli eserciti arabi di prepa-rarsi per la guerra contro Israele. I jacksoniani tendono ad giudicare gli eventi internazio-nali attraverso il loro unico prisma e, a partire dallevicende mediorientali del 1967, essi hanno dimostratouna sempre maggior vicinanza ad Israele anche se moltiosservatori non-Jacksoniani statunitensi - e molti altrinel resto del mondo - se ne siano sempre più distaccati.La Guerra dei Sei Giorni ha ridato slancio all’interessedei sionisti profetici per Israele e, agli occhi di moltiJacksoniani, ha rafforzato il legame percepito tra Israelee gli Stati Uniti. Conclusa la Guerra Fredda, i jacksonia-ni intravidero che i maggiori oppositori degli Stati Uniti
nella regione, come ad esempio Iraq ed Iran, lo eranoanche di Israele.I jacksoniani ammirano la vittoria, e la vittoria totale èciò che più amano. Lo schiacciante, travolgente trionfodell’esercito israeliano nel 1967 contro nemici numeri-camente superiori provenienti da tre diversi paesi cattu-rò l’immaginazione dei jacksoniani - specialmente in unperiodo in cui gli scarsi risultati dell’impegno statuniten-se in Vietnam avevano reso molti di loro pessimisti circail futuro del proprio Paese. Da allora, alcune delle azio-ni che hanno scalfito l’immagine di Israele nel mondo -come le risposte palesemente sproporzionate agli attac-chi del terrorismo palestinese - hanno al contrario fattoaccrescere il sostegno da parte dei jacksoniani.Quando dei razzi lanciati da Gaza colpiscono Israele,gli israeliani rispondono a volte con una maggiorepotenza di fuoco, con maggiori distruzioni, con unmaggior numero di vittime. In buona parte del mondo,simili atti sono considerati come un’eccessiva ritorsio-ne, un’offesa pari o persino superiore all’attacco subito.Al contrario, i jacksoniani giudicano il lancio di razzipalestinesi su obiettivi israeliani come un atto di terro-rismo e ritengono pertanto che gli israeliani godano diun diritto illimitato, forse quasi un dovere, di reagirecon tutte le forze a propria disposizione. Sin dagli anni’50, quando cioè le milizie palestinesi iniziarono a vio-lare furtivamente la linea del cessate-il-fuoco al fine diattaccare gli insediamenti israeliani, molti palestinesi edarabi hanno visto, con qualche ragione, queste incursio-ni come atti di grande coraggio di fronte ad un sover-chiante potere. Ma tali attacchi a tradimento controobiettivi civili, ed in special modo gli attentati suicidi,violano i basilari principi jacksoniani sul modo civile dicondurre la guerra. I jacksoniani ritengono che solo unaschiacciante e totale reazione a tali tattiche possa funge-re da deterrente contro altri eventuali attacchi. Tale è ilmodo in cui gli uomini della frontiera trattarono i nativiamericani, il modo in cui il generale unionista WilliamSherman “educò” i confederati, il modo in cui il gene-rale Douglas MacArthur e Truman ricompensarono igiapponesi per Pearl Harbor. I Jacksoniani non riesconoeffettivamente a comprendere perché il mondo muova
La Guerra dei Sei Giorni fu un catalizzatore sia del movimento di rinascitaevangelica che della ripresadel sionismo profetico. La rapidità e la risolutezzadella vittoria israelianaaveva del miracoloso, e la conquista della CittàVecchia implicava che i luoghi del Tempio erano nuovamente in mani ebraiche

dossier
47
critiche ad Israele relativamente all’esercizio di ciò cheessi ritengono il suo inalienabile diritto all’autodifesa -esattamente ciò che essi farebbero se fossero al posto diIsraele. Agli occhi dei palestinesi e dei loro sostenitori, ipalestinesi - esiliati, emarginati, occupati, divisi - rap-presentano un eroico popolo oppresso dal potere di unasuperpotenza regionale sostenuta dalle nazioni piùpotenti del pianeta. Ma per i jacksoniani Israele, malgra-do tutto il suo potere e le sue vittorie, rimane un paesein pericolo circondato da nemici. Il fatto che gli arabi ela più ampia comunità di un miliardo di musulmaniappoggi, almeno sul piano della retorica, la causa pale-stinese rafforza la convinzione di molti jacksoniani cheIsraele sia un piccolo e vulnerabile Paese meritevoled’aiuto. Ironicamente, alcuni tra i più grandi successipolitici e militari del movimento palestinese - lo svilup-po di un’attiva resistenza armata, la garanzia (in buonaparte retorica) del sostegno da parte di organizzazioniquali la Lega Araba ed anche l’Assemblea Generaledelle Nazioni Unite, lo spostamento della resistenzapalestinese dal nazionalismo laico alla religione, l’ap-poggio da parte di alcuni potenti stati della regionecome l’Iraq di Saddam ed oggi dell’Iran - hanno finitoper rafforzare ed aumentare il supporto dell’élite ameri-cana nei confronti di Israele.
Fratellanza cristianaUn altro importante fattore alla base dell’accresciutosostegno statunitense ad Israele trova giustificazione nelfatto che dal 1967 una serie di risvegli religiosi ha carat-terizzato gli Stati Uniti, con effetti considerevoli sulleprese di posizione pubbliche relative al Medio Oriente.Una conseguenza è ravvisabile nel fatto che anche ovele tradizionali chiese protestanti di orientamento libera-le muovano critiche ad Israele, esse dimostrano di averormai perso influenza sulla società e sulla politica.Un’altra conseguenza è rappresentata da un significati-vo aumento del sionismo profetico, da un maggior inte-resse, mai prima d’ora così forte, da parte dei cristianievangelici e fondamentalisti americani alla profeziabiblica ed al ruolo di Israele nell’avvicinamento all’apo-calisse. Molti cristiani evangelici e fondamentalisti
hanno dimostrato un interesse relativamente scarsoverso Israele nel periodo immediatamente successivoalla sua indipendenza. Nella loro visione, la profeziabiblica affermava chiaramente che gli ebrei avrebberoricostruito il Tempio nel suo luogo originario, ed altret-tanto avrebbero fatto con gli altri luoghi sacri dellaGerusalemme in mani arabe; il conto alla rovescia perla fine dei tempi pareva pertanto essersi rallentato. Nelfrattempo, il laico e quasi-socialista Stato d’Israele deglianni ’50 appariva meno allettante ai conservatori che ailiberali. Con gli occhi fissi sulla minaccia comunistadurante gli anni di più acuta tensione della GuerraFredda, i cristiani evangelici e fondamentalisti si impe-gnavano molto meno nella politica mediorientale degliStati Uniti di quanto avessero fatto nel XIX secolo. LaGuerra dei Sei Giorni cambiò tutto; essa fu un cataliz-zatore sia del movimento di rinascita evangelica chedella ripresa del sionismo profetico. La rapidità e la riso-lutezza della vittoria israeliana aveva per molti america-ni del miracoloso, e la conquista della Città Vecchiaimplicava che i luoghi del Tempio erano nuovamente inmani ebraiche. La sensazione che la fine dei tempi sistesse avvicinando costituì un potente impulso al risve-glio religioso americano iniziato durante questo perio-do. Da allora, una serie di best-seller, non solo di narra-tiva, hanno soddisfatto l’interesse di milioni di america-ni circa la possibilità che la fine dei tempi, così comeannunciata nel Vecchio e Nuovo Testamento, stesseprendendo forma nel Medio Oriente.Sin dalla fine della Guerra Fredda, una nuova forza haulteriormente irrobustito i legami tra lo Stato d’Israele emolti cristiano-conservatori d’America. Mentre il risve-glio religioso conferiva nuovo potere e nuove energiealle chiese evangeliche e fondamentaliste, la loro atten-zione si rivolgeva sempre più all’esterno. I precedentirisvegli religiosi avevano avuto come conseguenza unaumento dell’interesse e dell’attività di stampo missio-nario; l’attuale non è diverso. E mentre i cristiani ame-ricani hanno sviluppato un più ampio interesse per lesorti dei cristiani nel mondo, essi hanno fatto la cono-scenza del più importante rivale mondiale del cristiane-simo, l’Islam, e hanno appreso come le condizioni dei


dossier
49
cristiani in una serie di paesi a maggioranza musulma-na non siano buone. La preoccupazione per la sorte ditutti i cristiani perseguitati è un connotato di lunga datadella cristianità, e non solo negli Stati Uniti. Gli stessicapi religiosi che si prodigarono nella difesa degli ebreiin Europa e nell’Impero Ottomano si impegnaronospesso in simili iniziative per proteggere i cristiani inCina, Corea, Giappone e nell’Impero Ottomano, soloper citarne alcuni. L’ascesa del comunismo in quantopiù brutale nemico della religione del XX secolo indus-se molti cristiani d’America a fondare organizzazioni ilcui scopo era di fornire aiuto ai fedeli al di là della
Cortina di Ferro. Dal 1989 la persecuzione a danno deicristiani da parte dei comunisti era diminuita (sebbeneancora presente), e così il centro delle preoccupazioni èdiventato il mondo musulmano, dove molti cristiani edindividui di altre fedi o senza fede sono vittime delladiscriminazione legale e sociale - e dove, a volte, i cri-stiani vengono picchiati ed assassinati per ciò in cui cre-dono. Per di più, le leggi di molti paesi islamici proibi-scono il proselitismo e la conversione - questioni di vita-le importanza per i cristiani evangelici, che credono nelfatto che chiunque muoia senza accettare Cristo soffriràall’inferno e che la diffusione della fede cristiana costi-
tuisca uno dei loro principali doveri morali. I mezzid’informazione tradizionali non dedicano particolarespazio nei notiziari alle persecuzioni patite dai cristiani,ma ciò non impedisce che il problema informi la visio-ne dell’Islam e, di riflesso, del conflitto tra Israele edalcuni suoi vicini da parte di molti americani.L’opinione pubblica statunitense non è monoliticariguardo al Medio Oriente, né tantomeno immobile neltempo. Dal 1967 ha subito significativi mutamenti, conalcuni gruppi più favorevoli ad Israele e altri meno.Oggi un minor numero di afroamericani appoggiano ilPartito Likud rispetto a quanti erano sostenitori del-l’esercito ebraico durante la seconda guerra mondiale.Nuovi cambiamenti potrebbero subentrare. Delle lea-dership palestinesi ed arabe più sensibili ai valori ed allepriorità politiche della cultura politica americanapotrebbero sviluppare nuove e più efficaci tattiche alfine di indebolire, piuttosto che rafforzare, il sostegnoamericano allo Stato d’Israele. Ad esempio, la fine degliattacchi terroristici, assieme ad una ben organizzata edisciplinata resistenza civile nonviolenta, potrebbemodificare la percezione Jacksoniana della lotta palesti-nese. È altresì possibile che con il passare del tempo glievangelici ed i fondamentalisti americani possanoripercorrere le orme di Jimmy Carter, da un sionismo digioventù a ciò che egli definirebbe come una posizionepiù equilibrata. Ma se Israele dovesse affrontare unaqualsiasi seria crisi, sembra più probabile che l’opinio-ne pubblica si attesti su posizioni opposte. Molti degliamericani che oggi invocano una politica più neutralenei confronti dei palestinesi la chiedono poiché ritengo-no Israele fondamentalmente sicuro. Qualora tale valu-tazione dovesse modificarsi, i sondaggi d’opinionepotrebbero rivelare livelli persino più alti di gradimentoper il sostegno statunitense a Israele.Almeno una cosa sembra chiara. In futuro, così comenel passato, la politica mediorientale degli Stati Uniticontinuerà, nel bene o nel male, ad essere plasmata dallavolontà della maggioranza dei cittadini, e non dallemacchinazioni di una qualsiasi minoranza, quantunquericchi o coinvolti nel processi politici alcuni dei suoimembri possano essere.
Una cosa sembra chiara. In futuro, così come nel passato, la politica mediorientale degli Usacontinuerà ad essere plasmata dalla volontà della maggioranza dei cittadini, e non dalle macchinazioni di una minoranza, quantunque ricca o coinvoltanel processi politici

Risk
50
GLI EDITORIALI/MICHELE NONES
Un mercato europeo della difesa sempre più integrato
Fra metà dicembre e metà gennaio l’Unione europea hasistemato tre importanti tasselli del mercato europeo delladifesa: la Direttiva sugli acquisti pubblici di prodotti per ladifesa e la sicurezza, la Direttiva sui trasferimenti intra-comunitari e la Posizione Comune che rende obbligatorioil Codice di condotta dell’Ue sulle esportazioni militariverso Paesi terzi. Tutte queste decisioni sono il risultatodella consapevolezza Ue che la frammentazione nazionaledel mercato europeo non è più compatibile con lo scenarioeuropeo e internazionale. I soggetti interessati si sono arre-si di fronte al cambiamento: la Commissione europea hariconosciuto che la specificità del mercato della difesarichiede regole particolari; i governi europei, che l’effi-cienza delle Forze Armate richiede equipaggiamenti piùavanzati al minor prezzo possibile e, quindi, un’industriapiù efficiente e competitiva; le imprese europee, che ènecessario avere un mercato di riferimento continentale,anche se devono accettare una maggiore competizione suimercati domestici. La Direttiva sugli acquisti pubblici militari offre una detta-gliata regolamentazione di come dovranno essere fatti ifuturi acquisti nel campo della difesa e della sicurezza. Ilsuo campo di applicazione comprende anche i prodotti“sensibili”, cioè quelli che coinvolgono informazioni nonliberamente divulgabili, e riguarda, quindi, anche le forzedi polizia. Le nuove minacce non sono più solo militari e ilconfine fra sicurezza e difesa sta diventando sempre piùlabile. Anche l’acquisizione degli equipaggiamenti neces-sari per contrastare terrorismo e criminalità organizzatapotrà utilizzare la stessa regolamentazione “speciale”destinata ai prodotti militari. La procedura preferenzialesarà quella della trattativa privata in un quadro di compe-tizione controllata, salvaguardando le esigenze delle ForzeArmate in termini di affidabilità del fornitore. In alcunicasi, però, il ricorso ad una competizione non è possibile:la nuova Direttiva prevede, quindi, alcune esclusioni, come
nel caso dei programmi gestiti da Agenzie Nato odall’Agenzia europea Occar, dei programmi di collabora-zione intergovernativa europea che contengano attività diR&S, dei progetti di R&S (fino allo stadio dei dimostrato-ri tecnologici). La Direttiva sui trasferimenti intra-comuni-tari di prodotti militari abolisce, di fatto, le barriere nazio-nali e consentirà di muovere i prodotti all’internodell’Europa con il minimo controllo richiesto dalla sensi-bilità dei prodotti militari. Vi saranno tre forme di autorizzazione: licenza generale,globale e individuale. La prima consentirà il trasferimentodi tutti i prodotti selezionati da ciascun Paese (soprattuttoquelli meno “sensibili”) negli altri Paesi europei a condi-zione che siano utilizzati dalle Forze Armate o che sianoricevuti da imprese “certificate” dal proprio governo. Laseconda permetterà il trasferimento di uno specifico elen-co di prodotti fra specifiche società (ad esempio, apparte-nenti ad uno stesso gruppo industriale o partecipanti ad unprogramma di collaborazione). La terza (l’unica utilizzataoggi in quasi tutti i Paesi europei) resterà limitata ad ope-razioni singole (soprattutto quelle che coinvolgono prodot-ti “sensibili”). Ogni Paese sarà libero di fissare limitazio-ni alle esportazioni verso Paesi non-europei, ma la logicadel nuovo sistema è quella di delegarne la responsabilità alPaese in cui l’equipaggiamento viene integrato. LaPosizione Comune, infine, rende vincolante il Codice dicondotta per le esportazioni militari verso Paesi terzi,adottato nel 1998. In questi 10 anni i suoi criteri guida perl’autorizzazione delle esportazioni sono stati così assimila-ti che il numero delle divergenze di valutazione è limitatis-simo, prefigurando una sostanziale politica esportativaeuropea. A partire dal 2011-12 (termine per il recepimento delleDirettive) il mercato europeo della difesa cesserà di esseresolo un’obiettivo e si avvierò a diventare una realtà concre-ta. La strada è stata tracciata.

editoriali
51
Mentre proseguono i negoziati indiretti tra Hamas edIsraele per addivenire ad un effettivo accordo di cessate ilfuoco e mentre continuano le schermaglie tra le parti,sembra essere calato un imbarazzato silenzio sulle propo-ste ed offerte che l’Italia aveva formulato quando ancorala guerra era in pieno svolgimento. Il premier aveva par-lato di un intervento di Carabinieri per pattugliare il con-fine tra Egitto e la Striscia di Gaza, nonché di forze nava-li per sorvegliare le frontiere marittime e dichiarazionianaloghe erano arrivate anche dal ministro della Difesa,mentre già si parlava di ridistribuire gli sforzi delle ForzeArmate tra i diversi teatri e missioni, in modo da racimo-lare personale da poter eventualmente impiegare a Gaza. Poi, un passo alla volta, c’è stata l’abituale retromarcia,fino a quando il ministro degli Esteri, Frattini, non èintervenuto dichiarando che le forze italiane non sarannoimpegnate fino a quando a Gaza governerà Hamas, il chevuol dire…mai!È una grande fortuna per l’Italia che Hamas non vogliasoldati stranieri, specie se non musulmani, sul “proprio”terreno. Le forze internazionali saranno eventualmenterappresentate da truppe turche, mentre la maggiorresponsabilità continuerà a ricadere sull’Egitto. Una mis-sione internazionale a Rafah e a largo delle coste di Gazanon potrebbe che avvenire sotto l’egida dell’Onu ed ècurioso constatare che un governo che non ha lesinato lecritiche alla Unifil II in Libano, salvo poi (molto opportu-namente) evitare di chiudere o di ridimensionare la nostrapresenza nel Paese dei Cedri, abbia espresso tanto entu-siasmo per una possibile missione analoga a Gaza.Missione dai contorni estremamente vaghi, mentre si puòessere certi che si tratterebbe/sarebbe trattato di una mis-sione a lungo, lunghissimo termine, piuttosto costosa epericolosa. Per avere successo, impedire il contrabbandodi armi e materiali verso Gaza e violazioni dei confini unaforza internazionale dovrebbe essere abbastanza robusta,
consistente e dotata anche di assetti aerei di sorveglian-za/collegamento/supporto, quali elicotteri e velivoli senzapilota. Insomma qualcosa di molto diverso rispetto al pic-colissimo contingente dei Carabinieri schierato prima delconflitto. Si sarebbe dovuto trattare di un contingente ben piùnumeroso, dotato di “muscoli” per difendersi e pergarantire l’esecuzione del mandato, nonché di significati-ve capacità tecniche per riuscire a individuare e, sperabil-mente, a chiudere i tunnel sotterranei. Non si capisce poi perché a svolgere funzioni “dogana-li”/confinarie estese avrebbero dovuto provvedere iCarabinieri, che non hanno particolare esperienza o com-petenze in materia e non piuttosto la Guardia di Finanza,insieme all’Esercito. Dopo tutto si tratta di un Corpo a ordinamento militareche ha tra i compiti di istituto proprio la sorveglianza deiconfini e la repressione del contrabbando e di altri traffi-ci illeciti. In terra e in mare. Ed infatti considerando cheGaza ha ben pochi porti e coste lunghe una quarantina dikm ben avrebbe potuto occuparsene la Finanza, che hauna “flotta” di tutto rispetto, per consistenza, tonnellag-gio, esperienza ed equipaggiamento. Senza bisogno discomodare la Marina Militare. Insomma se si fosse dato seguito ai proclami iniziali sisarebbe combinato un costoso e dispendioso papocchio.Inutile sperare che questa esperienza suggerisca unamaggiore prudenza per il futuro, ma quantomenodovrebbe portare ad una più attenta considerazionedelle capacità e know-how disponibili, per poi sceglie-re le forze più indicate per rispondere alle esigenze spe-cifiche. Posto che se eviteremo di farci impelagare inuna eventuale missione Onu a Gaza….avremo compiu-to una scelta saggia. Possiamo sicuramente lasciarequesto onore-onere alla Francia. Il Libano all’Italiapuò bastare.
GLI EDITORIALI/STRANAMORE
A Gaza, a Gaza! Ma chi e perché?

52
Il “sogno” asiatico di GeorgeW. Bush non si è realizzato.L’ex-presidente americano
immaginava che dalle guerre inAfghanistan e in Iraq sarebbevenuta fuori una sorta di rivolu-zione geopolitica nell’area cheavrebbe innescato un meccani-smo di dissoluzione dell’Iran. Èandata esattamente al contrario. Ilregime degli ayatollah si è raffor-zato, mentre nei due Paesi confi-nanti il terrorismo, le bande assassi-ne, i clan, le tribù hanno ripreso aspadroneggiare. Tanto a Baghdadquanto a Kabul si teme il peggio.Se i fedeli di Saddam Hussein sonostati sgominati, non significa che lapacificazione dell’Iraq sia a portatadi mano. In Afghanistan non regnal’ordine americano ed i talebani diventano ognigiorno più minacciosi, mentre la vecchia cultura tri-bale mostra insofferenza verso una sia pur timidamodernizzazione. L’Iran non si limita a guardare e adifendere le proprie frontiere, ma si erge a protetto-re del mondo musulmano con l’aggressività di unsistema ideologico, economico, militare e politicotenuto insieme con il collante dello sciismo. A tren-t’anni dalla rivoluzione khomeinista è questo ilbilancio che il presidente Mahmoud Ahmadinejadpresenta al Paese ricandidandosi alle elezioni di giu-
gno contro il moderato e “dialo-gante” Mohammad Khatami, giàal vertice dello Stato dal 1997 al2005, che ha annunciato la suaintenzione di ripresentarsi, dopo“l’esilio” di Qom, per dareall’Iran stabilità e riprendere lavia dell’avvicinamento all’Occi-dente sbarratagli dall’ala piùintransigente del regime ed inparticolare dalla guida spirituale
Alì Khamenei, successore diKhomeini e padrone assoluto delPaese.È difficile dire se Khatami riusci-rà nell’intento. Non dimentichia-mo che i Guardiani della Rivo-luzione hanno decimato i cosid-detti riformisti riducendoli adun’irrilevante pattuglia al Majlis,
il parlamento di Teheran. Chi appoggerà quello cheè stato il loro capo, debole peraltro e senza moltoseguito nel Paese dopo la delusione cocente che lesue timidezze hanno provocato nella borghesia ira-niana che lo appoggiava? Dalla sua Khatami hal’antipatia di Ahmadinejad. Il quale, a parte basiji,pasdaran e consistenti nuclei delle forze armate,non può contare neppure sulla totalità del clero cheha visto le sue posizioni estremiste pericolose perl’Iran, lo sciismo e la Umma, vale a dire la comuni-tà universale musulmana. Neppure i bazarì, potenti
IRAN
CHI SOSTIENE IL FANATISMO DI AHMADINEJAD?DI GENNARO MALGIERI
SCENARI
Un politico modesto, detestato dai giovanissimi(che costituiscono la parte
più consistente della societàiraniana), guardato male dalclero, ma con una solida basenegli apparati più estremistidel regime. Contro di lui, alleprossime elezioni, Khatami

scenari
53
commercianti, devoti a Khamenei, al quale elargi-scono oboli considerevoli, lo hanno in simpatia.Per non parlare di tutti coloro i quali temono riper-cussioni dalle sue furenti intemerate contro Israele,gli Stati Uniti e l’Occidente. Sicuramente non avràil voto dei giovani molti dei quali, i meno ideolo-gizzati, restarono scioccati dal suo discorso pro-nunciato il 26 ottobre 2005 a Teheran, a conclusio-ne della conferenza “Un mondo senza sionismo”, epoi ripetuto ossessivamente. Fu allora, per la primavolta, che il neo-presidente annunciò il propositodi “cancellare il regime di occupazione - cioèIsraele - dalle carte geografiche, assicurando che lalotta dei palestinesi e di tutti i musulmani «elimi-nerà questa macchina disgraziata dal mondo isla-mico». Chiarendo, a chi non l’avesse capito, che«un mondo senza gli Stati Uniti e il sionismo èpossibile».Per di più l’Iran nelle sue componenti più dinamicheed “aperte” comincia a sentirsi accerchiato ed è unasensazione cha anche molti esponenti politici diprimo piano avvertono senza manifestare il disagioper timore di rappresaglie. Il fronte esterno scric-chiola. Chi ha avuto modo, come il sottoscritto, diincontrare governanti e parlamentari siriani direcente ha avuto la sensazione che Ahmadinejad stiadiventando un problema del quale farebbero ameno. Gli sono rimasti Hezbollah in Libano edHamas nella Striscia di Gaza. Un po’poco per ambi-re a una leadership nell’area e pretendere di assume-re la guida del mondo musulmano. Gli resta laminaccia nucleare per catalizzare attorno al regime i«nemici del sionismo e dell’Occidente». Ma anchequesta potrebbe rivelarsi un bluff e oltre gli StatiUniti, direttamente interessati a smantellare l’arse-nale iraniano sono lo stesso Iraq, il Pakistan,l’Arabia Saudita e in misura minore la Turchia. Suchi può contare, oltre ai fanatici, il fanaticissimoAhmadinejad?Egli, invenzione di Khamenei per togliersi dai piedii riformisti, non è un religioso e neppure un intellet-tuale; non fa parte della casta degli sciiti, ma non ha
saputo in quattro anni neppure prendere le distanzeda loro sostenendo, come qualcuno ingenuamente siattendeva, la difesa della laicità dello Stato. Ha vintole elezioni grazie ai delusi da Khatami e ad una bor-ghesia che non ha creduto nella sua vittoria al puntoda non votare e lasciare solo Rafsanjani. Agli ayatol-lah deve tutto, ma cinici come sono, quando capi-ranno che può essere più un ingombro che una risor-sa, non esiteranno a mollarlo. Insomma, un politicomodesto, detestato dai giovanissimi che costituisco-no la parte più consistente della società iraniana,guardato male dal clero, con una sia pur solida basenegli apparati più estremisti del regime,Ahmadinejad ha mostrato tutti i suoi limiti, queglistessi riconosciutigli come sindaco di Teheran. Einoltre poco si confà alle ambizioni di un mondocomunque in crescita che sogna impossibili (perora) aperture, ma che guarda all’Occidente con inte-resse maledicendo coloro che trent’anni fa bloccaro-no lo sviluppo di un Paese che aveva tutto per poterprimeggiare non soltanto nell’area. Infatti, la socie-tà iraniana è sostanzialmente laica, soprattutto nellegrandi città; il mondo imprenditoriale è piuttostoavanzato considerando le condizioni in cui opera;nonostante i rapporti tesi con il resto del mondo leesportazioni iraniane di petrolio, manufatti e fruttagarantiscono un fatturato considerevole. Tuttavial’economia ristagna, domina un forte malcontentopopolare accompagnato da un pessimismo che sitocca con mano se soltanto si ha la possibilità discambiare qualche parola con i giovani che affolla-no gli internet cafè, guardati male dai pasdaran,oppure con imprenditori e “donne di compagnia”nei grandi alberghi di Teheran Nord.
Ahmadinejad ha comunque raccolto un’e-conomia stagnante, nonostante le risorse che potreb-be sfruttare. Nel 2007 il tasso medio di inflazione èstato del 17%, il Pil ha rallentato costantemente lasua crescita e il debito pubblico è aumentato vertigi-nosamente. Non ha aiutato la ripresa la crescentestatalizzazione dell’economia (proprio ciò contro


scenari
cui si erano battuti studenti ed intellettuali nellarivoluzione del 1979) sottolineata da un dato assaieloquente: l’85% delle entrate statali viene dalpetrolio.Soprattutto negli anni Novanta il regime iraniano haavuto la capacità di sopravvivere ai mutamenti efronteggiare il balzo demografico, utilizzando stru-mentalmente (come aveva fatto a suo tempoKhomeini con Bani Sadr ed i mujaheddin del popo-lo) i vari politici di turno che di volta in volta repu-tava più utili ai suoi fini: prima il laico-religiosoRafsanjani, poi il riformista Khatami (nella foto), etra i due sempre e comunque Khamenei, non a casoscelto come suo successore per tenere a bada rifor-misti e conservatori a seconda dei momenti. Agli ayatollah va comunque riconosciuta l’abilità digarantirsi la sopravvivenza manovrando laici e reli-giosi a seconda della bisogna. Inflessibili nellostroncare i movimenti di rinnovamento; duttili nel-l’assecondare le esigenze e le richieste di queglistrati prevalenti della società che gli assicuravano lacontinuità.La stesso khomeinismo nacque e si sviluppò nelsegno dell’opportunismo mascherato da intransi-genza. La rivoluzione, infatti, che culminò nel ritor-no in patria, dopo il lungo esilio parigino diKhomeini, politico scaltro, ma teologo irrilevantenel mondo religioso sciita, fu animata non soltantoda movimenti radicali musulmani, ma anche daorganizzazioni laiche, intellettuali, studenti, catego-rie, insomma, che volevano riprendersila loro libertà e facevano coincidere taleistanza con la “reislamizzazione” delPaese che Reza Phalavi aveva sostan-zialmente avversato. Fu, dunque, unarivoluzione antioccidentale, identitaria,libertaria al punto che Bani Sadr, esule aParigi come Khomeini, dopo esserestato per soli quattro mesi presidentedell’Iran, fantoccio nelle mani di buratti-nai sinistri, sconsolato ammise di avercreduto che il nuovo leader, pur essendo
un esponente del clero, non era un fanatico sprov-veduto.Cacciato Bani Sadr, affidato formalmente per unbrevissimo periodo il potere a Mohammad AlìRajai, assassinato in circostanze oscure, Khomeinimise l’Iran nelle mani del presidente Alì Khameneiil quale per quasi trent’anni, scanditi dallo sprofon-damento dell’Iran nelle tenebre dell’oscurantismo,delle guerre sanguinosissime (quella con l’Iraq fu unvero martirio per oltre un milione di giovani che vipersero inutilmente la vita e durò dieci anni), dellarepressione sistematica del dissenso, dell’influenzacrescente nel mondo islamico al punto di sostenereterroristi come Hamas e puntare alla creazione di unmini Stato islamico nella Striscia di Gaza qualeminaccia permanente a tutto il Medio Oriente edall’Europa.
In verità tanto il successore di Khamenei,Rafsanjani (due volte presidente: dal 1989 al 1997)che Khatami, hanno fatto ben sperare sull’avvenirese non proprio democratico del Paese, quanto menosulla ritrovata ragionevolezza del regime. In realtàsono state illusorie le aspettative suscitate. Nessuno,tuttavia, dentro e fuori i confini dell’Iran, immagina-va, nel giugno del 2005, l’ascesa al potere diMahmud Ahmadinejad, di cui s’è detto, incarnazio-ne del khomeinismo più brutale.La sua elezione alla presidenza della Repubblicaislamica iraniana terremotò la geopolitica dell’area e
Agli ayatollah va riconosciuta l’abilità di sopravviveremanovrando laici e religiosi a seconda della bisogna.Inflessibili nello stroncare i movimenti di rinnovamento; duttili nell’assecondare le esigenzee le richieste della società
55

Risk
56
la strategia dell’Occidente che si apprestava agestire la pacificazione dell’Iraq e la soluzione delconflitto israelo-palestinese dopo le “aperture” diAriel Sharon. Ahmadinejad ha mandato a monte leillusioni di quanti speravano in un processo diaccettabile democratizzazione ed ha riaperto feriteantiche.
Ahmadinejad, al momento dell’elezione erasindaco della capitale. Personaggio inquietante finnell’aspetto, accusato apertamente di essere stato unsicario durante la rivoluzione, secondo qualcuno(ma le voci sono tante e le verifiche impossibili)responsabile dell’eliminazione di esponenti monar-chici e liberali, affrontò la campagna elettorale, cosìcome aveva svolto le sue funzioni di primo cittadi-no di Teheran, in chiave apertamente populista,
spalleggiato dai pasdaran e dai basiji - i custodiarmati e violenti dello “spirito” rivoluzionario edella moralità pubblica - rispolverando il più logo-ro bagaglio anticapitalista di Khomeini, scagliando-si contro le promesse egalitarie “tradite”, a suo dire,dai riformatori come l’ex-presidente Khatami efacendo leva sui temi sociali che gli “illuminati”progressisti hanno nascosto come polvere sotto itappeti facendo crescere, nel corso negli ultimi anni,un malessere diffuso riversatosi, al momento delvoto, su un personaggio impresentabile, ma chegarantiva, evidentemente, la discontinuità con un
recente passato fatto di illusioni. Sei mesi primadelle elezioni ero a Teheran con una delegazione delParlamento italiano. Incontrai anche Ahmadinejadnel suo ruolo di sindaco. Sapevo già chi era, mal’impressione che ne riportai superò ogni più foscaaspettativa. Il suo eloquio da invasato, gli occhifiammeggianti attraversati da una luce sinistra, lefacce poco rassicuranti dei collaboratori che glifacevano corona, gli argomenti datati e polverosiche spiattellava compiaciuto a testimonianza dellasua purezza rivoluzionaria, la certezza della vitto-ria sull’odiato Israele e gli accenni, tutt’altro chediplomatici, alle presunte responsabilità dell’Occi-dente riguardo alla situazione in Medio Oriente, gliaccenni alla necessità per l’Iran di continuare lacorsa all’arricchimento dell’uranio, mi fecerointendere che questo “figlio” della rivoluzione,
orgoglioso di aver preso parte all’occu-pazione dell’ambasciata americana chemise definitivamente in crisi i rapporticon gli Stati Uniti, avrebbe avuto unnefasto ruolo sul futuro del suo Paese. Ecosì è stato. Ebbi, in quell’occasione, la percezione,purtroppo poi confermata dai fatti, chese Ahmadinejad fosse diventato presi-dente, circostanza che tutti negavano,ma tutti sapevano che ci avrebbe quanto-meno provato, l’Iran sarebbe tornatoirrimediabilmente indietro, non tanto
sotto il profilo dei costumi (su questo tema bisogne-rebbe intrattenersi a lungo ed in un’altra occasione),quanto nella direzione di un deprecabile dirigismoeconomico, in un’accentuazione delle politichepopuliste, in una ripresa dell’aggressività esterna.L’attivismo rivoluzionario di Ahmadinejad si spie-ga anche con l’esigenza di offrire ai suoi sponsor ilmassimo dell’affidabilità. Sarà bene ricordare checoloro i quali facevano e fanno riferimento allaGuida spirituale e ai pasdaran, alla vigilia delle ele-zioni, al fine di contrastare Rafsanjani o, come sidiceva, l’ex-ministro degli esteri Velayati che aveva
A differenza di un rozzo comeAhmadinejad, Khatami ha avuto il coraggio, nonostante i risentimenti dell’establishment,di scrivere saggi con “perle”di questo genere: «L’arbitro definitivo per l’instaurazionedello Stato è il popolo»

scenari
57
mostrato interesse a ridiscendere in campo, avreb-bero voluto candidare personalità più “presentabili”politicamente. Non trovarono però un accordo e sidivisero su quattro nomi tutti afferenti, in un modoo nell’altro, all’universo chiuso e violento deipasdaran: Qalibaf, ex-capo della polizia, Larjani,espressione del potere giudiziario e già direttoredella Tv di Stato, Rezai, ex-capo dei pasdaran ed,infine, il sindaco della capitale. Per motivi cheresteranno chissà per quanto misteriosi, Khameneidecise, convincendo pasdaran, basiji e gli esponen-ti più influenti del bazar e delle associazioni carita-tevoli (che sono una vera potenza in Iran) a soste-nere il “docile” e ambizioso Ahmadinejad.Ma c’è un altro livello di analisi sul quale puntareper comprendere l’ascesa del Signor Nessuno diTeheran e spiegare la sua insensata politica diaggressione. Ed è un livello che tiene conto delleesigenze economiche e sociali che dominano le pre-occupazioni degli iraniani.Rafsanjani, uno degli uomini più ricchi e potenti delPaese, prometteva riforme economiche in chiave diliberalizzazione più o meno “selvaggia”, dimenti-cando che il liberismo, i cui effetti negativi si sonofatti sentire in tanta parte del Terzo Mondo, contra-stava perfino con i dettami della dottrina khomeini-sta fondata su un pauperismo di facciata (la nomen-klatura, il clero, i “padroni” del bazar godono di unaprosperità notevole) e su un rigore morale anch’es-so ipocrita. Il regime, comunque, distribuisce ai piùindigenti ogni anno miliardi di dollari in prodotti diprima necessità, dal pane agli alloggi, dal latte allabenzina, che non potrebbe più permettersi in unsistema di libera concorrenza. Non è stato propostodai riformatori alcun tipo di “terza via” per scardi-nare il regime e così il ceto umile che non è dispo-sto a perdere piccoli privilegi ha accompagnatol’ascesa di chi gli garantiva un ragionevole stato dimiseria sostenuto dal soddisfacimento dei bisognielementari. Lo sviluppo non interessa al regimeteocratico: basta che le gerarchie vivano e domini-no sull’indigenza per garantire l’ordine a Teheran.
E quando questo non dovesse bastare, vi sono sem-pre i pasdaran pronti ad entrare in azione. Un siste-ma, insomma, chiuso la cui manifestazione“migliore” è proprio Ahmadinejad.Di questa “chiusura” è espressione la struttura dellasocietà iraniana fondata, oltre che sulla rigida ripar-tizione di funzioni nell’ambito del potere (Guidaspirituale, Consiglio dei Guardiani della Rivo-luzione, Majilis - che ha soltanto un potere legisla-tivo-consultivo - forze armate, pasdaran e magistra-tura, controllate direttamente dalla Guida), sul clerosciita, sul bazar e sui bonyad. Il primo, come si sa,ha avuto un ruolo centrale nel nuovo Iran prenden-do su di sé il ruolo di indirizzo e di controllo dellapopolazione. Dal tempo della rivoluzione quasitutte le cariche di rilievo sono state ricoperte damembri influenti del clero. Il bazar comprende laclasse mercantile che ha beneficiato di appalti econtratti, munificamente elargitigli dal clero incambio del suo asservimento e della costruzione dimoschee oltre che del sostegno agli ambienti piùortodossi del regime. I bonyad si sono affermaticome organizzazione caritatevole di aiuto ai piùdisagiati, ma anche loro hanno avuto in cambioenormi benefici soprattutto nell’ambito del com-mercio petrolifero. Negli ultimi anni la nomenkla-tura ha cercato di arginare il loro potere, ma senzariuscirci.
Queste strutture sono state determinanti perl’affermazione di Ahmadinejad il quale ha mostra-to quasi di volersi emancipare dai suoi tutori. Nonc’è riuscito finora e difficilmente ci riuscirà, anchese non è da escludere un conflitto interno al regime,qualora Ahmadinejad sopravvalutasse la suainfluenza nell’Iran impaurito ed incerto.I riformisti, dunque, che fine hanno fatto? Sonostati semplicemente cancellati. Per incapacità ecodardia. L’abbraccio, presumibilmente istituziona-le e convenzionale, tra Ahmadinejad e Khatami,avvenuto due anni fa, alla vigilia del ritiro provvi-sorio, come s’è visto, del secondo dalla scena poli-

Risk
58
tica, ha fatto capire come l’opportunismo degli aya-tollah sia imprevedibile. Adesso che l’ex-presidenteridiscende in campo è immaginabile un’inversionedi tendenza a Teheran? Nessuno pensava, al tempodi Khatami, che il Paese si sarebbe dovuto occiden-talizzare per poter rientrare a pieno titolo a far partedella comunità internazionale. Anzi, al contrario,alcune idee dell’allora presidente vennero conside-rate come le basi per una cooperazione più stretta tramondi ritenuti fino a poco prima incomunicabili. Inun suo acuto saggio sulla libertà nell’Islam ed inOccidente, Khatami scrisse: «Come la civiltà occi-dentale ha usufruito in larga misura della civiltà isla-mica, la civiltà islamica dei “tempi d’oro” ha usu-fruito in larga misura delle civiltà iranica e greca. Midomando dunque: in questo tempo in cui la civiltàdominante è l’occidentale, e noi musulmani abbia-mo perso la nostra civiltà antica, che cosa dobbiamofare? Se vogliamo essere presenti e attivi nel nostrotempo, vorrà dire che dobbiamo tornare alla civiltàche ha preceduto la civiltà occidentale? Si tratta diuna concezione regressiva. Oppure vogliamo giun-gere ad una fase successiva alla civiltà occidentale,oppure ancora dissolverci nella civiltà occidentale?I tradizionalisti affermano: «dobbiamo tornare alpassato». I seguaci dell’Occidente replicano: “dob-biamo dissolverci nell’Occidente”. Ma a mio pare-re, i pensatori che davvero si preoccupano della pro-pria religione, del proprio popolo, della propria cul-tura nazionale, insegnano: “dobbiamo spingerci allafase successiva all’Occidente, e questo impegnonecessita di un nuovo modo di guardare alle nostrerisorse religiose”. Nel tempo in cui viviamo dobbia-mo scegliere un modo di guardare di questo tipo,cioè dobbiamo conoscere i problemi e i bisogni delnostro tempo. Quando affermiamo che dobbiamoraggiungere il “dopo-Occidente”, oltrepassarel’Occidente, intendiamo che dobbiamo fare nostritutti i prodotti umani e positivi della civiltà occiden-tale e guardare la situazione dal punto di vista dellanostra fede e in base ai valori del nostro pensiero.Ciò che manca all’Occidente, lo aggiungiamo noi.
In questo senso intendo il concetto di “utilizzarel’Occidente”: perché io penso a ciò che verrà dopol’Occidente, non a ciò che è accaduto primadell’Occidente». Accenti lontani. Quasi impercetti-bili. La siderale distanza tra le minacciose parole diun residuo del peggior khomeinismo comeAhmadinejad e di un “illuminato” come Khataminon potrebbe essere rappresentata meglio.Disgraziatamente il primo domina con ambizionifolli un Paese fragile, il secondo non ha neppure ten-tato di realizzare la sua rivoluzione, immaginando,forse, che il popolo si sarebbe spontaneamente sol-levato. Strabismo da mullah. L’Iran, intanto, affon-da nelle contraddizioni che da decenni non riesce arisolvere.
La ricandidatura di Khatami, nonostantetutto, accende nuovamente le speranze. Ma lo scet-ticismo è d’obbligo. Su chi può contare? E soprat-tutto perché dovrebbe essere votato dopo aver delu-so? A dire la verità un’attenuante ce l’ha:l’Occidente ha fatto male a non credere in lui. Il piùdelle volte è stato considerato un visionario o la fac-cia presentabile dell’impresentabile regime degliayatollah. Dopo le esperienze recenti bisogna fargli creditonecessariamente. E, soprattutto ricordare che il 23maggio 1997 divenne presidente della RepubblicaIslamica dell’Iran con il 70% dei consensi, promet-tendo equità sociale e democratizzazione. Non glihanno permesso di attuare il suo programma. Nonglielo ha permesso neppure l’Occidente che,miope, non si è fidato di lui avendone avuto la pos-sibilità. Eppure, a differenza di un rozzo semianal-fabeta come Ahmadinejad, Khatami ha avuto ilcoraggio, nonostante i risentimenti che provocavanell’establishment più ottuso, di scrivere saggi checontenevano perle di questo genere: «L’arbitrodefinitivo, per l’instaurazione dello Stato, è il popo-lo. In ciò consiste la democrazia». Era l’estate1996. L’Iran viveva un’altra rivoluzione. Nove annidopo sarebbe precipitato nell’abisso.

scenari
59
Hamid Karzai è stato un par-tner affidabile perWashington, ma negli ulti-
mi due anni il suo potere è andatoscemando. Attualmente il governoafghano controlla solo il 30% delterritorio nazionale, e le organizza-zioni umanitarie considerano qual-si la metà del Paese come troppopericolosa per i propri operatori. Il2008 è stato l’anno che ha visto ilmaggior numero di morti, tra leforze della coalizione, dalla cadutadei talebani nel 2001. Nei primi ottomesi dell’anno, oltre 1.445 civilisono rimasti vittime delle azioni deitalebani, del fuoco incrociato delletruppe alleate e di attentati terroristi-ci. Per far sì che il presidente afgha-no possa acquisire la legittimitàpopolare necessaria per guidareefficacemente questo Paese multiet-nico, il tempestivo svolgimento delle elezioni presi-denziali nei termini previstoi dalla Costituzione sisarebbe rivelato essenziale. Così non sarà, visto chesono state programmate per il 20 agosto prossimo.Comunque: nell’ottobre del 2004, Karzai fu eletto perun mandato quinquennale nella prima elezione direttadel presidente della storia dell’Afghanistan, e le ele-zioni di quest’anno dovranno dimostrare l’intenzionedegli afghani di contrastare gli estremisti che si oppon-gono al processo democratico in atto nel Paese. Stabilita la data delle elezioni, la sicurezza rappresen-
ta il successivo problema daaffrontare. Secondo il rappresen-tante speciale dell’Onu perl’Afghanistan, Kai Eide, la sicu-rezza è ai minimi storici dai tempidella caduata dei talebani. Larivolta, che prima era circoscrittaalle province meridionali - comeHelmand e Kandahar - adesso haraggiunto anche regioni più tran-quillle nell’Afghanistan centrale eoccidentale, tra cui le province diFarah, Badghis, Logar e Wardak. Italebani hanno conquistato il con-trollo di alcuni distretti di provin-ce vicine a Kabul, minacciando lacapitale del Paese, anche con unrecente attentato. Pare che quattrodistretti su sette, nella provincia diLogar, siano sotto il controllo deitalebani. Vi è stato anche unaumento degli attentati kamikaze,
di attacchi con uso di razzi e omicidi politici. Lo stes-so Karzai è sfuggito a quattro attentati, il più recentedei quail è avvenuto il 28 aprile 2008, giorno in cui aKabul si festeggia l’indipendenza. Il 7 luglio 2008, unattentato kamikaze contro l’ambasciata indiana aKabul ha provocato la morte di 41 persone ed il feri-mento di oltre 140. Incoraggiato dal successo di taliazioni, nell’agosto del 2008 un talebano ha ucciso treoperatori umanitari a Logar, a meno di 100 chilometria sud di Kabul. Il mese successivo, i talebani hannoucciso il governatore di Logar, Abdullah Wardak.
AFGHANISTAN
PERCHÉ NON BISOGNA MOLLARE KARZAIDI AHMAD MAJIDYAR
Il posticipo delle elezioni al 20 agosto rischia
di consegnare il Paese nelle mani dei talebani
e di trasformarsi nel principale autogol
di Obama, mentre l’attivitàdei ribelli è ai massimi livelli
dai tempi dell’invasione guidata dagli Usa nel 2001.
Ecco cosa può accadere e chi contende
la poltrona a Karzai

Risk
60
Mentre il 14 novembre 2008, dei sicari hanno assassi-nato a colpi di arma da fuoco Maulvi Shamsuddin,capo di un consiglio religioso nella provincia occiden-tale di Farah, al confine con l’Iran, come risposta aisermoni in cui il religioso si scagliava contro agliattentati kamikaze e la violenza. Infine l’11 febbraiodi quest’anno un dublice attentato suicida ai Danni diedifici governativi ha provocato innumerevoli vitti-me. Nonostante la crescente insicurezza, il 6 ottobre2008 la Commissione Elettorale Indipendente (Cei)ha avviato la prima delle quattro fasi previste perl’iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, durante laquale si sono iscritti 1 milione di aventi diritto in 14province dell’Afghanistan settentrionale, nordorienta-le e centrale. Un mese dopo, è partita la seconda fasedi iscrizioni in dieci province, prevalentemente nelleregioni del nord. La terza e quarta fase, avviate nelleprovince meno stabili nel sud e sudest del Paese,dovrebbero concludersi prima della fine di febbraio2009. Il coinvolgimento dei talebani, i quail hannorespinto i tentativi compiuti dalla Cei per convincerli apartecipare alle elezioni, non eviterà la violenza. Adicembre il Mullah Omar, leader dei talebani, ha lan-ciato un appello agli afghani dalla clandestinità in cuivive, alla vigilia della festa musulmana dell’Eid, esor-tandoli a boicottare le elezioni e promettendo rinnova-ti attacchi da parte dei ribelli se le truppe straniere nondovessero lasciare il Paese. «Non fatevi ingannare daquesto falso annuncio di elezioni. In realtà la sceltaverrà fatta a Washington». Il 14 ottobre, il capo dellaCei della provincia di Logar ha dichiarato che le iscri-zioni elettorali si erano ridotte del 30% nella provinciadopo la distibuzione nei villaggi, da parte dei talebani,di lettere in cui si avvertiva la popolazione a non iscri-versi. Il 20 ottobre, i talebani hanno distrutto un ufficioelettorale a Ghazni e poi ucciso un funzionario eletto-rale il 9 novembre.
L’intimidazione non è appannaggio esclusi-vo dei talebani: anche i comandanti locali vi ricorrono.Il 7 novembre, miliziani fedeli al leader di Hezb-eIslami, il latitante Gulbuddin Hekmatyar hanno rapito
due dipendenti dell’ufficio elettorale di Wardak, unaprovincia vicina a Kabul in cui regna l’instabilità. I funzionari statunitensi hanno descritto lo svolgimen-to delle iscrizioni elettorali in Afghanistan come tran-quillo e riuscito. Un tale ottimismo è prematuro,soprattutto perché questo processo è solo all’inizionelle zone più calde della rivolta. Contrariamente alleelezioni precedenti, la Polizia di Stato afghana dovreb-be occuparsi dell’aspetto sicurezza. Ma un rapportoscritto da Grant Kippen, ex capo della Commissioneafghana sui reclaim elettorali, avverte come l’impossi-bilità da parte della polizia di raggiungere alcune zonedell’Afghanistan meridionale possa privare moltipashtun del diritto di esprimere il proprio voto. Il 12novembre 2008 Ronald Neumann, l’ambasciatoreamericano in Afghanistan dal 2005 al 2007, ha dichia-rato in un’intervista quanto segue: «Nonostante i rischilegati alla sicurezza, le elezioni possono svolgersisenza intoppi anche all’interno del quadro attuale, se cisi prepara in modo adeguato sulla base di una valuta-zione approfondita, volta a stabilire le priorità ed iden-tificare le carenze», un modo un po’vago per afferma-re che un po’di insicurezza non basterà ad impedire leelezioni. In realtà, il fatto che due tornate elettorali inAfghanistan - le elezioni presidenziali del 2004 e lepolitiche nel 2005 - si siano svolte con successo in unclima di violenza diffusa, suffraga l’affermazione diNeumann. a questo punto, quali preparativi sarebbero necessari?L’annunciato invio di altre 17mila truppe stastunitensida parte del Segretario alla Difesa Robert Gates, il 21novembre 2008, dovrebbe contribuire in qualche
L’esito delle elezioni è incerto. Karzai rappresentail volto dell’Afghanistan in Occidente, ma internamente la sua eredità è ridotta a brandelli

scenari
61
ABDULLAH ABDULLAH. Uno dei consiglieri del defunto leaderdell’Alleanza del Nord, Ahmad Shah Masoud, e ministro degli Esteri delgoverno Karzai dal 2002 al 2006. Non ha ancora rivelato se si presenterào meno alle elezioni presidenziali ma, secondo indiscrezioni, sarà il candi-dato designato dal Fnu. Sebbene il padre sia di etnia pashtun originario diKandahar, Abdullah viene considerato dai più un tagico, a causa dei suoirapporti con l’Alleanza del Nord.
HEDAYAT AMIN ARSALA. Con un dottorato in economia conseguito pres-so la George Washington University, Arsala fu vice presidente del Paesedurante il governo di transizione per essere poi nominato ministro per ilCommercio e, successivamente, vice primo ministro del governo Karzai.Non ha ancora annunciato la propria candidatura, ma secondo alcune vocisarebbe già pronto a scendere in campo nelle prossime elezioni.
RAMAZAN BARSHADOT. Con un dottorato in giurisprudenza conseguitopresso l’Università francese di Tolosa, Bashardost è stato ministro per laPianificazione nell’amministrazione Karzai dal 2004 al 2005. Attualmenteè deputato nel parlamento afghano ed è apprezzato a Kabul per la sua atti-vità di contrasto alla corruzione. Ma la sua base elettorale è circoscritta agliHazara e agli abtianti di Kabul. Ha già annunciato la propria candidatura.
EHSAN BAYAT. Dopo essersi laureato in ingegneria presso il New JerseyInstitute of Technology, Bayat ha fondato la Wireless CommunicationCompany, la Fondazione Bayat e l’emittente televisiva Ariana inAfghanistan. Tagico di Kabul, l’imprenditore è apprezzato per le sue attivi-tà filantropiche in tutto il Paese. Si dice che voglia correre contro Karzai,ma la sua popolarità presso i pashtun è piuttosto scarsa.
ABDUL RASHID DOSTUM. Karzai ha nominato Dostum, già comandantemiliziano uzbeco filo-sovietico, Capo di Stato Maggiore dell’EsercitoNazionale Afgano, un incarico più che altro di rappresentanza. All’inizio del2008 è stato deposto dal suo incarico perché implicato in un caso di rapi-mento. Nelle precedenti elezioni presidenziali è arrivato quarto, assicuran-dosi il 10% dei voti.
ASHRAF GHANI. Economista di fama mondiale, Ghani è stato un perso-naggio chiave nella formazione del governo afghano dopo la caduta deitalebani. Attualmente Presidente dell’Istituto per l’efficacia dello Stato, èstato consulente dell’Onu per l’elaborazione degli accordi di Bonn, nonchéministro delle Finanze afghano dal 2002 al 2004. Le aspre critiche da luimosse di recente nei confronti di Karzai, fanno ipotizzare che possa pre-sentarsi alle prossime elezioni presidenziali. Di etnia pashtun.
MASSOUDA JALAL. Jalal è stata l’unica candidata donna nelle elezionipresidenziali del 2004, raggiungendo il settimo posto su diciassette candi-dati.Venne poi nominata ministro per gli Affari Femminili. Ha dichiarato chesi presenterà alle prossime elezioni.
ALI AHMAD JALALI. Professore presso il Centro di Studi Strategici per ilVicino Oriente Meridionale dell’Università Nazionale per la Difesa. Ha par-tecipato alla resistenza anti-sovietica come capo della pianificazione mili-tare ed è stato a capo dei servizi pashto e persiani per Voice of America.Nel 2003 è diventato ministro degli Interni del governo Karzai. Jalali si èdimesso due anni dopo a causa di presunti contrasti con Karzai circa lanomina dei governatori provinciali ed il comportamento da tenere nei con-fronti dei funzionari coinvolti nel traffico di stupefacenti. La sua inflessibili-tà nei confronti dei signori della guerra e dei narcotrafficanti è stata elogia-ta da più parti.
HAJI MOHAMMAD MOHOQIQ. Presidente di Hezb-e Wahdat, ha svolto unruolo attivo nella jihad islamica contro i sovietici e si è unito alla Alleanzadel Nord per combattere contro i talebani. È stato ministro per laPianificazione del governo Karzai ed il suo partito recentemente è entratoa far parte del Fnu. Si è candidato alle elezioni presidenziali del 2004, giun-gendo terzo con l’11,7% dei voti. Pare che abbia intenzione di candidarsicome indipendente alle prossime elezioni.
GHULAM FAROUQ NAJRABI. Capo del Partito afghano indipendente, unpicolo partito poco consociuto di tenedenze nazionaliste ed islamiche. Dietnia tagica, ha partecipato alle elezioni del 2004 raccogliendo solo lo0,3% dei voti. Correrà anche quest’anno.
ABDOL LATIF PEDRAM. Di origine tagica, Pedram è il capo del PartitoNazionale del Congresso afghano. Arduo sostenitore del federalismo edel laicismo, è contrario alla presenza di truppe straniere inAfghanistan. È stato al centro di polemiche dopo aver offeso il defuntoRe Muhammad Zaher Shah ed aver proposto di cambiare nome alPaese. Quinto alle ultime elezioni elezioni del 2004 (con l’1,4% dei con-sensi), si è già candidato.
ABDUL JABAR SADET. Nel 2006 Karzai ha nominato Sabet ministro dellaGiustizia. È stato acclamato come il più energico rappresentante del gover-no Karzai nel contrasto alla corruzione, ma la sua popolarità si è appanna-ta quando non è riuscito ad incriminare alcuni importanti funzionari digoverno, tra cui Abdul Rashim Dostum. Anche l’aver ordinato la perquisi-zione della rete televisiva privata Tolo ha contribuito a screditare Sadet agliocchi degli afghani. Karzai ha licenziato Sabet nel momento in cui questiha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali. Sadet è diorigine pashtun ma gli manca un’ampia base elettorale nel Paese. Si mor-mora che in passato sia stato uno stretto collaboratore del latitante leadermujaheddin Gulbuddin Hekmatyar.
GUL AGHA SHIRZAI. Attuale governatore della provincia orientale diNangarhar è originario di Kandahar e noto per gli sforzi compiuti per elimi-nare i papaveri da oppio dalla provincia. Non ha annunciato la propria can-didatura, ma sembra intenzionato a presentarsi.
HALIM TANWIR. Vice ministro per l’informazione e la cultura, ha già uffi-cializzato la propria candidatura. Di origine pashtun, è poco conosciuto intutto il Paese.
FNU. Fondato nel 2007, il Fnu è una variegata alleanza di ex fazioni jiha-diste, ex leader comunisti ed un certo numero di tecnocrati.Tra i personag-gi di spicco vi sono Barhanuddin Rabbani, ex presidente e leaderdell’Alleanza del Nord; Mohammad Qasim Fahim, ex Ministro della Difesa;Yunus Qanuni, presidente della camera bassa del parlamento; Ahmad ZiaMasoud, vice presidente di Karzai; il leader uzbeco Abdul Rashid Dostum;ex leader comunisti come Sayed Mohammed Golabzoy e Nor-ul-Haq Ulomie comandanti dell’Hezb-e Islami come Qazi Mohammad Amin Waqad. IlFnu sostiene di godere del sostegno del 40% del parlamento afghano.Rabbani e Qanuni hanno già espresso la propria intenzione di non presen-tarsi alle elezioni.
MOSTAFA ZAHER. Nipote del defunto re Muhammad Zaher Shah, è attual-mente a capo dell’agenzia nazionale per l’ambiente e membro del Fnu.Secondo alcune indiscrezioni, l’Fnu intenderebbe nominare Zaher comeproprio candidato alle prossime elezioni. Nonostante il fatto che sia unerede della famiglia reale, non gode di un vasto appoggio.
I POSSIBILI CANDIDATI ALLE PROSSIME ELEZIONI

Risk
62
modo. Il 20 dicembre 2008, l’Ammiraglio MichaelMullen, capo di stato maggiore della difesa, ha affer-mato che il numero potrebbe salire fino a 30mila. Trale 3.500 e le 4.000 unità sono già in partenza da FortDrum, nello Stato di New York. Durante una vistat asorpresa in Afghanistan l’11 dicembre, Gates si è dettointenzonato ad inviare altre due brigate in Afghanistanentro la primavera. Anche i Paesi della Nato dovrebbe-ro contribuire a questo incremento di truppe, almenoin via provvisoria, fino alla fine della elezioni. Ma glialleati europei non hanno mostrato un’eccessiva soler-zia al riguardo fino a questo momento.
Dopo un incontro con il Generale DavidPetraeus, il 10 dicembe il ministro della difesa italianoIgnazio La Russa ha affermato che,quest’anno l’Italiaavrebbe provvisoriamente inviato altri cinquecentomilitari per sei mesi, ma altre dichiarazioni precedentida parte del ministro lasciano pensare che si tratti dipersonale preposto all’addesttramento militare delleforze di sicurezza afghane e non di truppe combatten-ti. Notizie riportate dalla stampa indicano come il riti-ro delle truppe britanniche dall’Iraq consentirà allaGran Bretagna di inviare tra i 2.000 e i 5.000 militariin più in Afghanistan. Ma, da programma, il ritiro delletruppe dall’Iraq dovrebbe svolgersi tra marzo e giugnoed il loro ridispiegamento può richiedere altro tempo.La Germania si è rifiutata di inviare truppe nelle regio-ni più instabili, nel sud e nell’est del paese. IlCancelliere Angela Merkel forse non vuole rischiare diperdere consensi inviando altri uomini in zone di guer-ra a ridosso delle elezioni tedesche, previste per il set-tembre 2009. Anche la colaborazione da parte delPakistan sarà fondamentale per garantire lo svolgi-mento in sicurezza delle elezioni. Nel periodo prece-dente le elezioni politche afghane del settembre 2005,il governo pakistano ha aumentato il numero delletruppe ed intensificato I pattugliamenti lungo i confiniper evitare il passaggio transfrontaliero di ribelli.Anche i gruppi di miliziani afghani hanno svolto unruolo attivo nel garantire la sicurezza in elezioni pas-sate. Ma con tanti miliziani che attualmente si stanno
unendo ai ribelli, non sarebbe saggio coinvolgerli inquesta circostanza.Consentire agli afgani di esprimere il prorpio voto saràdifficile. Ma altrettanto difficile sarà fare in modo chei loro voti contino. Brogli e irregolarità hanno già fune-stato le elezioni afghane in passato. Nel voto presiden-ziale del 2004, tutti i candidati, ad eccezione di Karzai,hanno denunciato irregolarità minacciando di invali-darne gli esiti. La Cei è sottoposta a critiche semprepiù insistenti circa la propria indipendenza ed impar-zialità. Mohammad Daud Soltanzoi, un parlamentaredella provinica di Ghazni, ha accusato la Cei di briga-re a favore di Karzai, il quale ha nominato tutti e novei membri della commissione, inclusi il presidente ed ilvicepresidente, il 19 gennaio 2005. In precedenti ele-zioni, il coinvolgimento di organizzazioni ed osserva-tori internazionali può aver mitigato i problemi legatialla Cei, ma da allora la commissione ha assunto ilruolo di autorità primaria per quanto riguarda le elezio-ni. Il rapporto di Kippen sottolinea anche come alcunedella affermazioni del presidente della Cei mostrinocome la commissione non sia imparziale. La carenzadi fondi rappresenta un altro fattore che ha ostacolatoI preparativi. Il costo totale delle due precedenti elezio-ni è stato di $359 milioni. Tuttavia la Cei non è stata ingrado di erogare i $102 milioni stanziati dai donatoriper le quattro fasi dell’attuale processo di iscrizioneelettorale. Rispetto alle elezioni precedenti, gli attualiproblemi di finanziamento hanno portato alla mancan-za di seggi ed uffici elettorli nei Paesi confinanti,negando l’accesso al voto a 2 milioni di aventi dirittoafghani residenti in Iran e Pakistan. Secondo l’AltoCommissario Onu per i Rifugiati, oltre 4 milioni diAfghani, iscritti o meno nelle liste elettorali, vivono inPakistan ed Iran: oltre il 15% della popolazione afgha-na. La scarsità di fondi può determinare dei ritardi nel-l’affluenza alle urne. Un’indagine della AsiaFoundation ha rivelato che solo il 53% degli intervista-ti era a conoscenza delle prossime elezioni e pocomeno del 48% ha dichiarato di sapere cosa fare periscriversi nelle liste elettorali. L’esito delle elezioni è incerto. Karzai può rappresen-

scenari
63
tare il volto dell’Afghanistan in occidente, ma interna-mente la sua eredità è ridotta a brandelli. Il suo gradi-mento presso la popolazione afghana, che in passatoraggiungeva l’83%, si è ridotto a causa della sua inca-pacità di rendere il Paese più sicuro e porre un frenoalla corruzione. Può vantare alcuni successi al suo atti-vo. Nonostante alcune battute d’arresto, i media liberie independenti godono di ottima salute. Nel 2008, ilnumero di studenti che ha conseguito un diploma discuola media superiore è stato superiore rispetto a tuttigli anni precedenti e il 40% sono ragazze. Impos-sibilitate a lavorare sotto il regime dei talebani, ora ledonne si sono riaffacciate sulla scena sociopolitica delPaese, assicurandosi 68 seggi parlamentari su 249 nelparlamento afghano a maggioranza conservatrice.Mentre gli sforzi compiuti da Karzai per creare istitu-zioni politiche e democratiche in Afghanistan hannoavuto in larga parte successo, lo stesso non vale perquanto riguarda il loro effettivo funzionamento.Nonostante i miliardi di dollari spesi negli ultimi setteanni dagli Usa, dai partner della Nato e da altri Paesidonatori per lo sviluppo, circa 20 dei 25 milioni diafghani che vivono nel Paese rimangono al di sottodella soglia di povertà. Inoltre il Paese si colloca al176, posto su 180 nazioni, nel Corruption PerceptionIndex 2008 di Transparency International (indice dipercezione della corruzione), seguito solo da Haiti,Iraq, Myanmar e Somalia. Il New York Times ha sco-perto l’esistenza di collegamenti tra il fratello diKarzai, Ahmad Wali Karzai, ed il traffico di eroina,confermando ciò che tanti afghani già sospettavano.La recente offerta, da parte di Karzai, di un’amnistiaper i leader talibani, incluso il Mullah Omar - che italebani hanno respinto con fermezza - ha lo scopo dirallentare o invertire il calo di popolarità di cui è vitti-ma. Le tribù pashtun, che costituiscono il 40% dellapopolazione afghana, auspicano una riconciliazionecon I talebani. Tuttavia la mossa di Karzai si è rivela-ta controproducente presso il resto degli afghani. Ilquotidiano indipendente Eqtedar-e Melli, schierato afavore del Fronte Nazionale Unito, ha descritto l’offer-ta di amnistia di Karzai come «uno stratagemma per
essere rieletto»; Il settimanale Payam-e Mojahed, vici-no a Jamiat-e Islami, ha osservato come l’azione diKarzai fosse «un tentativo per garantire la propriasopravvivenza»; mentre il quotidiano indipendenteCheragh ha sentenziato che si tratta di «un gesto com-piuto unicamente a fini elettorali»; ed il quotidianolaico indipendente Hasht-e Sobh ha definito il tutto«una scommessa politica».Karzai può farcela ad essere eletto per un secondomandato? Sì. Rimane comunque il candidato più forte,grazie alle divisioni che spaccano l’opposizione eall’assenza di un rivale pashtun di una certa caratura.Un recente rapporto del Congressional ResearchService ha mostrato come Karzai possa contare sulsostegno del 60% della popolazione, percentuale cheindica come il suo seguito vada oltre la comunitàpashtun a cui appartiene. L’indagine della AsiaFoundation è giunta a conclusioni analoghe. Anche sei sondaggi esagerano la popolarità di Karzai, l’attualepresidente può sfruttare la propria esperienza e le pro-fonde spaccature etniche e politiche all’interno del-l’opposizione. Vi sono 84 partiti politici registrati inAfghanistan. Ma una vera opposizione esiste. Il prin-cipale blocco d’opposizione è l’Fnu (Jabha-eMottahid-e Melli), un’alleanza ad ampio spettro di exfazioni jihadiste, ex leader comunisti e vari gruppisociali ed etnici.
Composta soprattutto da gruppi etnici di mino-ranza non pashtun - come Hezb-e Wahdat-e Eslami-yiMardom-e Afghanistan (Partito Popolare Afghano diUnità Islamica), attualmente presieduto dal leader diHazara, Haji Mohammad Mohaqiq, e da Jonbesh-eMelli-e Eslami-yi Afghanistan (Movimento Islamicoafghano), guidato dal Generale Abdul Rashid Dostum-l’alleanza avrebbe delle difficoltà a raccogliere abba-stanza consensi per scalzare Karzai senza rivolgersi aipashtun. La coalizione non ha ancora raggiunto unaccordo riguardo ad un candidato (vedi tabella per unalista di possibili candidati). Il leader dell’alleanzaBorhanuddin Rabbani, il quale sostenne Karzai nelleelezioni del 2004, ha escluso un proprio appoggio a

Risk
64
Karzai nelle prossime elezioni. Dostum e Mohaqiqpotrebbero proporsi come candidati indipendentemen-te l’uno dall’altro. I leader del Fnu non sono stati nean-che in grado di superare la scarsa reputazione di cuigodono in virtù del loro comportamento passato.Abdorrab Rasul Sayyaf, ex leader dell’Alleanza delNord e attuale parlamentare di Kabul, è accusato daHuman Rights Watch di crimini di guerra durante gliscontri tra opposte fazioni a Kabul tra il 1992 ed il1994 ed è famoso per i continui espropri di terre nellasua roccaforte, il distretto di Paghman a Kabul.Dostum è stato sospeso dal governo a febbraio a segui-to del rapimento di un suo oppositore poiitico. Si diceche stia cercando di ottenere asilo politico in Turchiacome parte di un accordo con Karzai per essere pro-sciolto da ogni accusa a suo carico. Anche l’ex mini-stro dell’interno Ali Ahmad Jalali e l’ex ministro dellefinanze Ashraf Ghani rappresentano degli avversaritemibili per Karzai. Gli afghani sono soddisfatti del-l’operato di ambedue gli ex ministri. Mentre Ghaninon ha ancora annunciato ufficialmente la propria can-didatura, è stato designato come candidato da Ejma-eMelli-e Afghanistan (Associazione nazionale afgha-na), un’alleanza cher racchiude 32 partiti politici e 342consigli popolari. Anche Jalali sta valutando le propriepossibilità: «Mi sto consultando con il popolo afghanoe con gli anziani delle tribù e annuncerò la mia deci-sione se candidarmi o meno alla presidenza nel giro diqualche mese» ha dichiarato a novembre in un’intervi-sta. Jalali è contrario alle alleanze e correrà proponen-do un “programma nazionale” per la vittoria.
Eppure, nonostante i suoi successi, Jalalinon è troppo conosciuto dalle masse afghane, soprat-tutto perché ha trascorso quasi vent’anni lontano dalPaese. Solo grazie ad un’ampia campagna ben finan-ziata sarà in grado di proporsi come un concorrentecredibile. Una pletora di altri candidati si muove aimargini. Nonosante la data delle elezioni sia stata fissata per il20 agosto, non bisogna dimenticare che l’articolo 61della costituzione afghana sancisce che il mandato
presidenziale scade il primo giorno del mese afghanodi Jawza (il 22 maggio) e che le elezioni debbano averluogo tra i trenta e sessanta giorni prima di quella data,quindi nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 22aprile 2009. Questo, dunque, non sarà. Perché DaudAli Najafi, capo della Cei, l’organo a cui spetta l’auto-rità e la responsabilità di indire le elezioni secondol’articolo 156 della costituzione, ha evidenziato lanacessità di un posticipo di almeno tre mesi per potersvolgere le elezioni «pienamente preparati ed in pienatrasparenza», avvertendo come molte persone nonsarebbero state in grado di votare a maggio, un impas-se che “potrebbe mettere in discussione la legittimitàdel voto». Zekria Barakzai, vice presidente della Cei,ha spiegato che se le elezioni si fossero tenute nelladata indicata dalla costituzione a causa di pressionipolitiche, i risultati sarebbero stati “illegittimi”, citan-do i rigori del clima e la sicurezza come i due princi-pali ostacoli al voto. Ma visto che un’intesa (formale)è stata raggiunta, si apre un altro problema: di naturacostituzionale. Chi guiderà il Paese dal 22 maggio finoall’elezione del nuovo presidente? Il raggiungimentodi un accordo su questo punto appare difficile. I rap-presentanti del governo Usa non devono presumereche gli afghani acconsentano ad un’estensione delmandato di Karzai. Alcuni attivisti ritengono che que-st’ultimo debba cedere il potere alla Camera Alta delParlamento il 22 maggio. Altri propongono che il pre-sidente, secondo l’articolo 67, trasferisca la propriaautorità al vice presidente alla scadenza del mandato.La Cei sostiene che la presidenza Karzai può continua-re, ma molti funzionari afghani hanno definito l’ipote-si incostituzionale. «Se Karzai rimane al potere ancheper un solo giorno oltre il suo mandato ufficiale, cioèil primo giorno di Jawza, il governo dovrà affrontareuna resistenza accanita da parte di tutti i partiti politicie i gruppi di opposizione e l’Afghanistan scivolerà inuna crisi ancora più profonda», ha affermato AbdulKabir Ranjbar, capo della Commissione parlamentaredi vigilanza costituzionale.Durante la sua campagna, Barack Obama ha espressodei giudizi negativi nei confronti di Karzai. Il 19 luglio

scenari
65
scorso, durante una visita in Afghanistan, Obama hacriticato Karzai per non aver fatto abbastanza per pro-muovere il buon governo nel suo Paese. «Ho detto alPresidente Karzai che ritengo debba concentrarsi mag-giormente sui problemi legati alla corruzione e al nar-cotraffico, contrastando il traffico di stupefacenti inmaniera molto più aggressiva di quanto non abbiafatto finora». In un’intervista precedente ha dichiaratoalla Cnn: «Penso che il governo Karzai non sia anco-ra emerso dal bunker per aiutare ad organizzarel’Afghanistan, il governo, la magistratura e le forzedell’ordine, in modo da far sentire la gente sicura». Il7 ottobre, durante il secondo dibattito presidenziale,Obama ha affermato: «Dobbiamo avere un governoche risponda alle esigenze del popolo afghano, e one-stamente, in questo momento non è così». Pare che ilclima durante l’ultimo incontro tra il vice presidenteJoe Biden e Karzai fosse così teso che Biden, ad uncerto punto, si sia alzato e se ne sia andato.IlSegretario di Stato Hillary Clinton ha inferto l’ultimocolpo all’amministrazione Karzai. Pochi giorni primadi assumere l’incarico, ha bollato l’Afghanistan comeun “narco-stato”, il cui governo ‘e «afflitto da capaci-tà limitate e corruzione».Critiche di questo tenore non sono passate inosserva-te presso la popolazione afghana e hanno alimentatospeculazioni secondo cui Obama abbia intenzione diattuare anche qui il suo mantra di cambiamento. Untitolo sulla prima pagina del quotidiano indipendenteArman-e Melli citava, «Obama avvierà la sua politicadi cambiamento in Afghanistan sbarazzandosi diKarzai». Mentre il Daily Afghanistan scriveva, «Labuona stella del Presidente Karzai tramonterà con lavittoria di Obama». Anche i media iraniani hanno ali-mentato tali ipotesi. «Gli americani stanno cercando dimettere in discussione la popolarità del presidente edanneggiare la sua reputazione per sostituirlo con unaltro personaggio alle prossime elezioni presienziali»,ha affermato la Voce della Repubblica Islamicadell’Iran in un servizio speciale dedicato all’A-fghanistan.Il quotidiano iraniano Sarmayeh hadescritto la poltica estera di Obama definendola un
“incubo” per Karzai. I timori di Karzai di non poterepiu’ contare sul sostegno incondizionato degli Usa sisono manifestati in un cambiamento radicale del suoatteggiamento. Oltre alla recente apertura nei confron-ti dei talebani, il suo tono è diventato più polemico daquando Obama ha vinto le elezioni. Offrendo prote-zione al latitante leader dei talebani, il Mullah Omar, il16 novembre Karzai ha dichiarato alla stampa aKabul: «Se dico di voler offrire protezione ad Omar,allora la comunità internazionale ha due possibilità:destituirmi dal mio incarico o andarsene se non sono
d’accordo. E tutte e due vanno bene». ln passato il pre-sidente non si era mai riferito alla partenza delle trup-pe straniere come “un bene” per il Paese.L’atteggiamento poco conciliante di Karzai dovrebbepreoccupare Obama - il quale, nonostante le enormisfide che deve affrontare sia sul fronte interno che suquello internazionale, si è comunque impegnato arisolvere la questione afghana come assolutamenteprioritaria - soprattutto considerando il fatto che larichiesta di Karzai di definire i temp del ritiro delleforze straniere avviene nell’esatto momento in cu ilPentagono sta inviando altri 17mila miitari in quel tea-tro bellico.Come dovrebbe comportarsi Obama? La neonataamministrazione dovrebbe appuntare le proprie spe-
Chi guiderà il Paese dal 22maggio fino all’elezione del nuovo presidente? Il raggiungimento di unaccordo su questo punto è difficile. Il governo Usanon deve presumere che gli afghani acconsentiranno ad un’estensione del mandato di Karzai

Risk
66
ranze non sui singoli individui, ma sul rafforza-mento delle istituzioni democratiche nel Paese.Schierarsi a favore di un candidato nelle elezioniafghane avrebbe molte implicazioni negative. Inprimo luogo, se gli Usa appoggiassero Karzai(nella foto) per la conquista di un secondo manda-to, questo farebbe nascere dei dubbi circa l’indi-pendenza dell’Afghanistan. «Qualora il ruolo dell’America nelle elezioniafghane risultasse esplicito», ha osservatoNeumann, «questo non farebbe che confermare lapropaganda talebana secondo cui sono gli ameri-cani a governare il Paese, e non gli afghani». Percontro, se gli Stati Uniti sostenessero un altro can-didato, il governo attuale si sentirebbe minacciatoe potrebbe iniziare ad epurare i funzionari legatiagli Usa e cercare alleati stranieri ostili agli StatiUniti, come l’Iran e la Russia.
L’obiettivo principale dell’America inAfghanistan è quello di aiutare il Paese ad instau-rare un governo che sia democraticamente eletto,stabile, autosufficiente, un amico affidabile per gliUsa nonché alleato nella lotta contro il terrorismo.Tutto questo non si può realizzare se il presidenteafghano è ostile agli Stati Uniti ed amico dei suoinemici. Karzai, nonostante il calo di popolarità, ècomunque il candidato più forte nella corsa allapresidenza e ha la possibilità di essere eletto per unsecondo mandato. Anche se dovesse perdere leprossime elezioni, rimarrà in carica per i prossimiquattro se non otto mesi. L’amministrazioneObama dovrebbe collaborare a stretto contatto conKarzai per affrontare i crescenti problemi relativialla sicurezza e alla governance in questo periodoprima delle elezioni, anche se decidesse di nonmanifestare il proprio appoggio nei suoi confronti.Questo dimostrerebbe che una buona governancerichiede la trasformazione di un sistema e non l’in-vestimento in unico personaggio, per quanto possafar comodo il fatto che il personaggio in questionesia il presidente attualmente in carica.

scenari
67
Ora che il semestre europeoa guida francese è arrivatoalla sua scadenza, nei suoi
termini formali, perché nelle inten-zioni e nei fatti gli sforzi di Parigi digiocare la carta europea nella pro-spettiva di svolgere un ruolo guida edi primo piano nella Ue continuanosotto la presidenza ceca, meritaforse rileggere con attenzione lemeticolose modalità con cui è statapreparata l’agenda della presidenzafrancese, e le conseguenze che ilsuo imprinting, supportato da unsolido impianto di pensiero, staavendo o potrà avere sull’imposta-zione del futuro assetto dell’U-nione, tenendo sempre ben presentigli interessi francesi. Obiettivo chela Francia aveva già iniziato a giocare in anticipo nel 2007(anche per far dimenticare il “no” alla Costituzione euro-pea), anche se non sempre nella consapevolezza che nonè poi così semplice gestire le differenti istanze di 27 Paesispesso in antitesi tra loro, al momento dell’approvazionedel Trattato di Lisbona e nelle critiche all’operato diTrichet in particolare sulla questione del cambio euro-dol-laro. La Francia ha perseguito tenacemente alcune ideeportanti, un’Europa più protetta, un’Europa attore mon-diale nella globalizzazione ed esportatrice di valori,un’Europa della difesa, l’identificazione dell’interesseeuropeo rappresentativo dell’identità francese. Dietro que-sto filo conduttore vi sono certamente esigenze condivisedall’opinione pubblica, ad esempio come affrontare ildumping asiatico e i fondi sovrani, ma insieme a queste
anche le esigenze di superare diffi-coltà legate alla competitività eco-nomica interna e di perduta leader-ship francese in Europa. È quindipartito con grandi ambizioni e cla-mori (e molta preparazione) unsofisticato e senza dubbio efficaceprogramma per il semestre euro-peo, progettato sulla condivisionein Europa degli interessi francesi.Per realizzarlo sono state sollevatecritiche sulla debolezza diun’Europa refrattaria e indolente, equindi scarsamente efficace e reat-tiva a pensare in termini più attualial di là dei suoi confini, e ad affron-tare le nuove sfide della globaliz-zazione. Un’Europa che, nella pro-spettiva di Parigi, bisogna aggiu-
stare - vedasi la concorrenza - con misure protettive eregole di reciprocità, un’Europa che bisogna pensare nellasua dimensione esterna estendendola in modo strumenta-le anche alla politica di difesa e alla politica estera - e quin-di creando barriere intorno al mercato interno europeo adesclusivo vantaggio dell’economia francese e a discapitodelle economie degli altri Paesi che sono più aperti allacompetizione e alla cooperazione transatlantica. In questisei mesi è stata messa molta carne al fuoco e diversi risul-tati, ottenuti sul filo di lana, sono di rilievo, anche se nontutto è passato. Sei mesi però sono indubbiamente pochi,occorreva più tempo per perseguire un disegno così com-plesso ed ambizioso. Parigi forse aspetta la ratifica delTrattato di Lisbona, che dà spazio a più flessibili formuleistituzionali, per continuare a cercare di svolgere un ruolo
EUROPA
LA POLITICA INDUSTRIALE NON È PIÙ UN TABÙDI FABRIZIO BRAGHINI
Per poter svolgere un ruolo di attore politico
internazionale, l’Unione euro-pea deve disporre
di armi pari a quelle dei concorrenti, esigendo
misure di protezione comparabili e l’apertura
dei mercati esteri

Risk
68
di primo piano in Europa. La strada è stata avviata, ma èarrivata la crisi. Grandi sono state le attese da parte del-l’opinione pubblica europea per le ambizioni dellaPresidenza francese della Ue, che hanno portato a un pro-ficuo dibattito sulle sorti dell’Europa. Molti sono stati icommenti anche critici nella stessa Francia, che hannoanalizzato l’iperattivismo e gli entusiasmi di Sarkozy connumerosi vertici straordinari (anche se non sempre leaspettative dell’Hexagone sono rimaste intatte come èstato il caso dell’Unione Mediterranea, ridimensionatarispetto al suo progetto originale dagli altri governi perreticenze e sospetti di egemonia), e le promesse mantenu-te sulle priorità dei dossier clima, difesa, immigrazione easilo, agricoltura. La pressione per portare a compimentoi dossier è stata continua, con risultati sicuramente utili perla politica interna. Il dinamismo sulla scena mondiale durante le due grandicrisi internazionali della Georgia e dei subprime ha datoslancio all’Unione Europea, portando all’affermarsi sullascena internazionale e dell’economia un’Europa piùintergovernativa che comunitaria, che se non era propriocoordinata e univoca è stata però più presente e proposi-trice, vedasi la crisi del Caucaso e i tentativi di adombra-re una qualche forma embrionale di coordinamento ogovernance economica europea nel mezzo della recessio-ne economica globale. Ma, citando La Tribune, dai bril-lanti successi diplomatici ai risultati concreti resta ancoramolto da fare.
Certo, la Francia si è trovata al centro di unasituazione mondiale di continue crisi, che ha saputo gesti-re in modo pragmatico, ma pur sempre nel quadro di unalibertà d’azione frenata suo malgrado dai limiti di un man-dato sottoposto al “metodo comunitario”, soddisfacendoad ogni buon conto le proprie ambizioni politiche di primodella classe in Europa.Già, Parigi si accorgeva che il motore del continente eradiventata la Germania con cui i rapporti hanno raggiuntoun minimo storico, e non volendo più essere vista un frenoall’Europa come in precedenti occasioni, l’Europa diven-tava la sua priorità politica, la sua “missione universale”anche se è capitato di vedere un po’ di schizofrenia come
si è visto nella giravolta sulla direttiva dei trasferimentiintracomunitari della difesa. La politica che Parigi ha perseguito a Brussels ha rispostoampiamente alle aspettative e alle esigenze di una politicacasalinga plasmata da forme di patriottismo economico,sovranità appropriata, protezionismo - compatibili con isuoi interessi - da allargare su scala continentale comemodello dirigistico valido per tutti, anche se l’economia ela strategia francese non sempre gli stessi di quelli deglialtri Paesi europei. Infatti, se la struttura industriale france-se è molto concentrata e la presenza pubblica è diffusa,risultano diversi i modelli di business delle grandi impre-se europee che si sono diversificate e adattate alla globa-lizzazione con flessibilità e anticipo rispetto a quelle fran-cesi, tra l’altro facendo shopping negli Usa utilizzando laleva del cambio e aprendo maggiormente ad investitoriesteri. Parigi ha dunque avuto la possibilità di inserirsi inuna fase di debolezza strutturale di un’Europa debole eincerta sulla sua stessa identità, lenta a reagire e rigida inuna sua ortodossia e in un dogmatismo che spesso nonvede al di là della regolamentazione del suo mercato inter-no, risultando inadeguata ad affrontare pienamente le sfidedella globalizzazione. Si imponeva pertanto un urgenteadeguamento delle politiche comunitarie che, se certa-mente fondate su argomentazioni realistiche e condivise,vengono elaborate in modo compatibile e funzionale ageneralizzare la politica francese in un piano europeo,tutelando quindi gli interessi nazionali, colmando una dif-ficoltà culturale francese sul tema di come affrontare laglobalizzazione. Quello che ha impressionato favorevolmente, è stata l’ef-ficienza e il rullo compressore con cui si è mossa Pariginel gestire un’agenda più volte aggiornata per affrontare leimpreviste emergenze che hanno caratterizzato il 2008.Questo processo non avrebbe potuto dispiegarsi con tantodinamismo, se non vi fosse stato un intenso, laborioso eapprofondito dibattito preparatorio interno tra la puissan-ce publique delle Amministrazioni (come i rapporti delSenato e dell’Assemblée Nationale), Università, GrandiScuole ed Enarques, Centri studi e Grandi Imprese, che haconsolidato nell’opinione pubblica francese i valori chia-ve da esportare nella dimensione europea. In due parole,

scenari
69
Parigi ha ampiamente sfruttato la sua presidenza della Uecome una finestra di opportunità per creare le condizionidi un nuovo consenso in suo favore. Il metodo di elabora-zione delle idee centrato su assi portanti, sviluppatodall’Institut Montaigne, alla Fondation Schuman, allaFondation pour la Recherche Strategique, e se vogliamoanche il blog coulisses di Liberation - contribuendo allaformazione di un pensiero forte e condiviso - si è dimo-strato strumentale per tentare di imporre, o meglio per farcondividere agli altri Paesi e alle rispettive opinioni pub-bliche, con sofisticate argomentazioni tipiche della pervi-cace “supremazia culturale francese”, un pensiero organi-co di idee e principi forti. Questi hanno informato i lavoridel Semestre nel quadro di un disegno strategico comples-sivo volto a modificare l’attuale impostazione della Ue, inquanto giudicata da molti inadeguata ad affrontare le sfidedi un mondo in grande trasformazione.Nel costruirne il substrato ideologico, un contributo allaPresidenza francese è venuto dal Rapporto di LaurentCohen-Tanugi Une strategie européenne pour la mondia-lisation di aprile 2008 (consultabile su www.euromon-de2015.eu) che ha disegnato le grandi linee di una strate-gia globale europea coerente nella mondializzazione, tra-mite una “rivoluzione copernicana” cha conduca a un rio-rientamento sulla dimensione esterna della costruzioneeuropea. Dai grandi principi si passa rapidamente alleazioni concrete. Viene proposta una analitica modificastrutturale delle condizioni finanziarie per il budget comu-nitario 2014-2019, che accanto a un aumento quasi ovviodelle dotazioni per conoscenza e infrastrutture, prevede unforte crescita (10 volte) ad es. del Fondo europeo di aggiu-stamento alla mondializzazione e della Pesc che passereb-be dall’attuale 0,2% all’1,7% del budget, rappresentandoun cambiamento sostanziale del ruolo della Ue in politicaestera e di difesa, sicuramente foriero di grandi divergen-ze tra le Nazioni.Hanno completato e arricchito il dibattito gli EntretiensFriedland organizzati dal giornale economico Les Echose dalla Ccip (Chambre de commerce et d’industrie deParis), sul tema “Entre concurrence et compétitivité: quelavenir pour l’industrie française en Europe?”, focalizzatisull’idea di adeguare le politiche industriali per «preparar-
si a battersi ad armi eguali in una prospettiva di concorren-za internazionale». Il primo e più eclatante passo delgoverno francese è quello, ben noto, della modifica notte-tempo del Trattato di Lisbona, durante il summit del 20giugno 2007, quando venne modificata la dizione di con-correnza. Se si riprendono i commenti di Sarkozy di queigiorni, è evidente la precisa ratio che caratterizzerà il man-dato della Presidenza francese a Brussels: «La concurren-ce n’est plus un “objectif en soi” de l’Union européenneet le document final du Conseil européen de Bruxellesreconnaît la place des services publics en Europe». «Nousavons obtenu une réorientation majeure des objectifs del’Union». «La concurrence n’est plus un objectif en soi,c’est un moyen au service du marché intérieur mais cen’est plus un objectif de l’Union». «Un protocole confir-me que les questions de concurrence relèvent de l’organi-sation du marché intérieur, c’est un point majeur. La con-currence est un moyen, ce n’est pas une fin en soi».
Secondo Sarkozy sarebbe possibile arrivare“peut-être une jurisprudence différente” da parte dellaCommissione Europea, che potrebbe considerare la con-correnza come un mezzo per «favoriser l’émergence dechampions européens», «porter une véritable politique in-dustrielle et non comme un dogme». «Par ailleurs, dansses relations avec le reste du monde, il est désormais affir-mé pour la première fois que l’Union doit contribuer àassurer la protection des citoyens». «Le mot protectionn’est plus tabou». Molte furono le polemiche sollevate da molti esperti tracui Barroso su questa iniziativa notturna che sembròestemporanea, a cui partecipò anche il responsabile delservizio legale della Commissione, come rappresentato inun seminario dal significativo titolo “The place of compe-tition law in the future community legal order”, organiz-zato l’8 novembre 2007 a Brussels dalla Revue de droit dela concurrence (vedasi il sito www.concurrences.comweb) su questa tematica attuale e controversa. Per l’occa-sione il Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Jean-Pierre Jouyet fu molto chiaro e deciso con un suo cahierde doléances in presenza di un Commissario allaConcorrenza visibilmente irritato, che ribadì come non vi

Risk
70
fosse la necessità di creare una nuova politica di concor-renza, quanto di apportare modifiche in modo da accre-scerne la stabilità e la prevedibilità e quindi la crescita.Con toni accesi si è dibattuto delle divergenti interpreta-zioni derivanti dall’esclusione della concorrenza dalnuovo Trattato di riforma Ue: è stato soppresso il riferi-mento alla “concorrenza libera e non falsata” dagli obiet-tivi fondamentali dell’Ue, e come compromesso è statoinserito un Protocollo che definisce la concorrenza comeuno strumento politico a servizio degli obiettivi Ue.
Secondo il rappresentante del governo francese,la concorrenza doveva essere adattata efficacemente alservizio della competitività europea. Il che significa saper-si adattare alle nuove tecnologie (es. attribuzione delle fre-quenze, economia dei servizi intangibili) e rafforzare idiritti delle imprese e il funzionamento dei mercati, comela necessità di concentrazioni a livello europeo. La politi-ca industriale in Europa non è più un tabù; ha una rinno-vata importanza, ma deve essere considerata non soloall’interno del mercato europeo ma a livello mondiale.Occorre pertanto un dibattito sugli strumenti della concor-renza che deve essere rinforzata tramite cooperazioni piùintegrate e strutturate. Di pari passo occorre rafforzarealcune politiche europee, nei settori dell’energia, coordi-namento fiscale, aiuti di Stato, commercio multilaterale,rendendo la politica di concorrenza più coerente con i fat-tori produttivi.Puntualmente sono stati elencati i punti di disaccordo traGoverno francese e Ce: caso Alstom (divieto di concen-trazione); servizi pubblici (si riconosce che il nuovoTrattato non scalfisce in nessun modo la dimensione inter-na delle Nazioni, costituita dall’organizzazione del territo-rio); integrazione dei servizi postali e delle telecomunica-zioni (la cui liberalizzazione deve essere equilibrata con lefinalità sociali); energia (la strategia europea di liberalizza-zione deve tenere in considerazione le specificità del mer-cato e le modalità di attuazione - unbundling delle reti epatrimoniali).Un ulteriore passo concettuale è stato elaborato in Franciacon il briefing paper Entre stratégie industrielle et politi-que de concurrence, quelle voie pour l’Europe?
dell’’Institut Montaigne nella serie Amicus Curiae (vediwww.institut.montaigne.org), che riassume in modo deci-samente efficace e indicativo l’opinione di Parigi sul rap-porto industria-concorrenza. La tesi espressa si muovedalla necessità di superare pregiudizi e malintesi sulle pro-poste francesi di politica industriale, sospettate (comeaffermano gli autori) di mettere in pericolo l’integrazioneeuropea a tutto vantaggio delle filiere tecnologiche inchiave francese. Viene raccomandato di cessare la sterilecontrapposizione tra strategia industriale e regole del mer-cato interno, in favore di una politica di competitività glo-bale che favorisca maitrise e savoir-faire locali di specifi-che aree tecnologiche. Il riferimento è esplicito: “le indu-strie della sovranità e della sicurezza, l’aerospazio, l’ener-gia”. Un freno alla competitività dell’Europa viene identi-ficato nelle regole della concorrenza, il cui controllo daparte della giurisprudenza dovrebbe vedere la coesistenzatra preminenza del diritto e adattamento a esplicite sceltepolitiche - da parte del Consiglio e del Parlamento - sudossiers essenziali per l’Europa, quale il mantenimentodel controllo di specifici settori industriali, e l’adozione dimisure commerciali difensive anche di ritorsione.Interessante infine la citazione che «la Francia non devedimenticare, circa l’adattamento della sorveglianza sugliaiuti di stato, di averne beneficiato in occasione di dossiersdifferenti, dalla ricapitalizzazione di Air France al salva-taggio di Alstom, allo sviluppo di progetti tecnologicifinanziati dall’Agenzia per l’Innovazione Industriale, pernon citarne che alcuni particolarmente mediatici».Rientra in quest’ampia prospettiva della difesa degli inte-ressi comuni la questione, per ora accademica, di comedefinire l’interesse europeo. Finora si è discusso in conses-si ad alto livello il tema di quale sia o potrebbe essere l’in-teresse nazionale. Il dibattito si è spostato gradualmente inun’ottica continentale, ed è stato affrontato al seminarioorganizzato nell’ottobre 2008 al Parlamento Europeo dal“think tank” Confrontations Européennes (www.confron-tations.org). Si è assistito all’unisono a forti critiche daparte di rappresentanti di importanti settori manifatturierifrancesi e polacchi nei confronti delle politiche commer-ciali adottate dalla Commissione Europea (legate anche alnegoziato sul futuro del Wto), che a loro parere disinteres-

scenari
71
sandosi dell’offerta europea in nome di principi teorici,ostacola la competitività di settori industriali chiave comel’automobile, l’aerospazio e difesa, il tessile, il ferroviario,la cantieristica. L’eccesso di regolamentazioni unilateralinel mercato interno, non trovando corrispondenza fuoridell’Ue, nei fatti creano uno svantaggio competitivo perl’Europa, unitamente a difficoltà di accesso su mercati diPaesi terzi protezionisti che adottano politiche di dumpingsleale. Questo ampio tema, peraltro già affrontato in pas-sato dall’Aspen nella sua dimensione nazionale, potrebbeavere una certa rilevanza se la Commissione Europea o gliStati Membri intenderanno promuovere e tutelare i propriinteressi nazionali all’interno di un quadro europeoarmonizzato. Una volta definiti i settori o le aree di “inte-resse europeo”, va da sé che prima o poi si arriverà a for-mulare regole specifiche o preferenziali. E quindi diven-terebbe di importanza essenziale definire le proprie areedi eccellenza da valorizzare in una dimensione comuni-taria, dove la combinazione di strumenti di sostegnonazionali ed europei fornirebbero un effetto di leveragerilevante. L’incontro Confrontations (ma era intenzional-mente propedeutico agli sviluppi successivi?) ha prece-duto di poche settimane il lancio di piani nazionali di sal-vataggio per l’economia con l’aggravarsi della crisi deisub-primes, che in Francia (a mero titolo esemplificativo)sono mirati proprio a sostenere i settori sopra descritti. Eseguendo la stessa logica il 2 gennaio 2009 il presidentedi Alstom Transports ha rilanciato un pubblico appello aboicottare i treni cinesi in quanto Pechino attuerebbe unapolitica protezionista nei confronti dei fornitori esteri (danotare che la stessa denuncia era stata fatta contro ilGiappone durante il seminario in questione).
Un comune filo logicoha legato la riflessione sullanecessità di cambiamenti profondi in Europa intorno allacomprensione degli interessi comuni, nell’ambito di unanuova concezione delle relazioni con il mondo e di cam-biamento di governance tra gli Stati e l’Unione Europea.La traduzione in parole povere mostra la volontà di con-durre specifiche opzioni politiche, identificabili in unnuovo approccio in tema di politica della concorrenza,politica commerciale esterna, industria della difesa, inte-
resse europeo, sullo sfondo della ricerca di un ruolodell’Europa nella globalizzazione. Teniamo conto chenelle dichiarazioni programmatiche del Governo francesesono emersi tre aspetti prioritari della sua politica europea:la reciprocità, la politica dei cambi monetari per modifica-re la politica monetaria della Bce, la politica di concorren-za come strumento e non come finalità. Circa la specificariforma della politica commerciale esterna e dei suoi stru-menti, un utile contributo è venuto dal CommissarioMandelson, che nel suo intervento “the Alcuin lecture” aCambridge l’8 febbraio 2008, intitolato “Europe’s open-ness and the politics of globalisation” (vedi il sito
http://ec.europe.eu/trade), delineò i limiti di misure di dife-sa commerciale lanciando il concetto di “projectionism”europeo, da intendersi come modello di governance per il21° secolo. Questi concetti hanno influenzato le riflessio-ni circa la prospettiva di esportare valori e regole europeeper influenzare i partners commerciali della Ue in ambitomultilaterale, anche se al momento il Wto registra unostallo prolungato.L’insieme delle argomentazioni sopra riportate sostengo-no che per poter svolgere un ruolo di attore politico inter-nazionale, l’Unione Europea deve disporre di armi pari aquelle dei concorrenti, esigendo misure di protezionecomparabili e l’apertura dei mercati esteri. Questo approc-cio, stile “vogliamo un’Europa protetta”, è stato un filoconduttore continuo. Un aspetto critico che ha permeato il
Occorre un dibattito suglistrumenti della concorrenzache deve essere rinforzatatramite cooperazioni piùintegrate e strutturate. Dipari passo serve rafforzarealcune politiche europee,nei settori dell’energia,coordinamento fiscale, aiuti di Stato e commercio

Risk
72
semestre riconduce le difficoltà dell’economia europea inuna fase di grandi squilibri nel commercio internazionale,alla concorrenza sleale dei Paesi asiatici ma anche, qui stail nocciolo della questione, della Commissione Europeaper il suo immobilismo di fronte della concorrenza cine-se, e alla mancanza di una politica industriale avendo pre-ferito un approccio di mercato corretto da regole di con-correnza. In pratica, la mancanza di una dimensione ester-na rende incapace l’Ue di operare come “soft power” ingrado di far valere i propri valori. Occorreva subito modi-ficare l’impasse della ideologica dell’Europa con riformesignificative, come la creazione di un level playing fieldcon strumenti di difesa commerciale equivalenti a quelledei paesi Terzi, il superamento della separazione tra agen-da interna ed esterna dell’Unione, nuove regolamentazio-ni in materia di investimenti esteri, … anche perché l’eco-nomia francese stava perdendo colpi (meno competitivi-tà, meno esportazioni, grande deficit commerciale), ed èminacciata dalle delocalizzazioni.
L’ordine di scuderia veniva illustrato con “laricerca dell’interesse europeo per l’industria e la sua pro-mozione nella competizione mondiale”. Sembra chiaroche questa sofisticata costruzione accademica porterà ungiorno i suoi frutti, e sembra opportuno ricordare che inquesto filone di analisi critica sulle insufficienze dell’at-tuale visione dell’Europa e sulle cause della crisi globalesi possono richiamare le valide argomentazioni sollevate
in Italia sulle conseguenze di un’Europa che sopravvivesul primato del mercato, ed è rinunciataria e struttural-mente debole (il noto saggio politico “La paura e la spe-ranza” di Giulio Tremonti), o anche, relativamenteall’energia, l’analisi sugli effetti perversi e disincentivan-ti di certe scelte comunitarie - poco pragmatiche mamolto ideologiche - nell’ambiente e nella sicurezza ener-getica, che non può trovare nei soli meccanismi di mer-cato piena e adeguata risposta” (“Il rebus energetico” diAlberto Clò).Un’interessante argomentazione a sostegno delle tesifrancesi è quella della Fondation Robert Schuman, che èservita a sostenere l’idea dalla reciprocità nella difesa.Ma qui la Francia è rimasta isolata in quanto l’idea, priva
di validità giuridica e mai discussa all’interno della stessaUnione, è stata rigettata dagli altri Paesi. L’idea parte dalTrattato di Lisbona che include alcune innovazioni istitu-zionali nel campo della politica di difesa e sicurezzacomune. Viene fatta un’estensione per analogia del con-cetto di dimensione esterna dell’Europa (che si limita allapolitica estera e commerciale) alla difesa. La conclusioneè che il Trattato di Lisbona estende l’area di competenzadell’Unione agli aspetti industriali e commerciali del set-tore armamenti. Con questa forzatura, ecco creata dalnulla la base giuridica per la reciprocità. Peccato che innessuna sede europea se ne sia mai parlato! (Vedi i fichierssul Trattato di Lisbona di dicembre 2007, nel sitowww.robert -schuman.eu). Questo tema della reciprocità,sbandierato a ripetizione, è diventato un leit motiv quoti-diano, suscitando anche un dibattito tra i Paesi membri ela Francia, che si è trovata più volte in posizione solitaria.Vale la pena di accennare che la complessità della temati-ca è già stata affrontata dal Senato francese nel Rapportd’information n°112 (2005-2006) (vedasi il sitowww.senat.fr) nel quale si è concluso che la nozione direciprocità comunitaria ha una valenza unicamente politi-ca. Prendendo come analogia i settori dell’agricoltura edell’acqua, Parigi ha spinto per l’introduzione di una clau-sola di reciprocità vincolante per le importazioni di equi-paggiamenti per la difesa sul territorio europeo, con espli-cito riferimento agli Stati Uniti che hanno adottato datempo un Buy American Act che impone noti vincoli ai
Il Trattato di Lisbona estende l’area di competenza dell’Unioneagli aspetti industriali e commerciali del settorearmamenti. Con questa forzatura, si crea dal nulla la base giuridicaper la reciprocità

scenari

Risk
74
clienti esteri del Pentagono. La materia è senza dubbiocomplessa e politicamente rilevante per i rapporti transa-tlantici. Considerando però che i Paesi europei godono dieffetti sospensivi di tale regime, e che l’Exagone è tradi-zionalmente il mercato più ermetico nella Ue, la propostadi cui sopra è stata vista come un tentativo di chiusura prodomo sua di un mercato europeo della difesa, propriodurante la fase di approvazione di un pacchetto di normemiranti a una maggiore liberalizzazione (il PacchettoDifesa). Essendo alla fine prevalse le posizioni dei Paesipiù coinvolti nelle cooperazioni transatlantiche, insiemecon l’opposizione della Commissione Europea a sostene-re una clausola contraria alle regole del Wto, la reciproci-tà è alla fine rimasta nella direttiva difesa solo comedichiarazione politica di principi senza effetti giuridici. Inestrema sintesi, eventuali riferimenti alla “dimensionepolitica esterna della Ue” che portino ad interpretazioniestensive della nozione di “trade” al “mercato” della dife-sa non risultano essere oggetto di dibattito tra gli StatiMembri. Di conseguenza l’applicazione del principio direciprocità anche alla difesa è apparsa una forzatura non
richiesta e non appropriata.Altro argomento che rimane sempre di attualità è quellodella difesa europea, con un dibattito politico in primopiano che si sta progressivamente avviando dal dibattitoaccademico e concettuale a un approccio più realistico,come dimostrato da qualche tempo da diverse azioni dicoordinamento intergovernativo anche in ambito Pesd.Difesa europea e Pesd che comunque non hanno moltarilevanza nei periodi di crisi, essendo messi in secondopiano dal prevalere degli interessi sovrani delle Nazionipiù grandi ed influenti. Cosa poteva fare la Francia nel-l’ambito del suo mandato su questo tema controverso edelicato? Si è riparlato in dettaglio della futura Edtib,acronimo che identifica un insieme di iniziative diversemirate a rafforzare la competitività dell’industria delladifesa europea. Moltissimo è stato scritto al riguardo, al pari dell’ambi-zione politica francese di voler svolgere il ruolo di guidala difesa europea e di esserne il precursore. Tuttavia èsuccesso che la difesa europea è avanzata su un canaleparallelo al semestre Ue. Infatti diversi accordi di coope-
razione sono stati sottoscritti a fine anno dai Ministri dellaDifesa in sede di Agenzia Europea di Difesa; e quindi laPresidenza francese della Ue si è probabilmente trovata apercorre un sentiero stretto, limitandosi ad una serie diseminari, peraltro molto ben strutturati nel metodo di lavo-ro e nella scelta dei temi, svolti in prestigiosi palazzi pari-gini. Questi si proponevano di individuare nuove iniziati-ve europee da identificare con una serie di “roadmaps”,quali ripensare la strategia della ricerca, definire la sicurez-za degli approvvigionamenti nel lungo termine, migliora-re il ruolo delle piccole e media imprese, definire le siner-gie tra tecnologie duali e della sicurezza, federare gli sfor-zi governativi e industriali per l’identificazione di FutureAir Systems da mettere sul tavolo degli Stati entro l’anno.Ma dal momento che di questi temi attinenti la difesaeuropea se ne parla da decenni, con risultati decisamentemediocri per la verità, le questioni poste all’ordine delgiorno dalla Dga in base a propri criteri si sono dimostra-te troppe e molto delicate, vedasi la creazione di un dispo-sitivo europeo di controllo degli investimenti esteri (comei fondi sovrani) nella difesa europea sulla falsariga del
La tentazione di un’Europaa due velocità con unnucleo ristretto di Paesiguida “che si fanno le regole”, trova un terrenofertile ai disegni d’oltralpe,in questa fase confusa e senza un progetto dilungo periodo dell’Europa. Ma questo non potrà cheessere a vantaggio di queiPaesi che dimostreranno la volontà di attrezzarsi per andare avanti insieme

scenari
75
sistema statunitense Cfius. Ne è risultato un interessantequanto vivace dibattito tra esperti di diversi Paesi, senzache vi fosse alcun legame con la strategia dei governi, equindi di risultati concreti se ne è un po’ persa traccia el’insieme dei dibattiti è sembrato perdere quel livello dipriorità che gli era stato precedentemente assegnato. Jean-Pierre Maulny dell’Iris ha affermato su La Tribune che laPresidenza francese non ha mantenuto le promesse, comeci si poteva aspettare.
È evidente che l’obiettivo primario di Parigi èstato quello di cercare di portarsi a casa il maggior nume-ro di risultati entro dicembre, mese nel quale si sono suc-cedute con un ritmo impressionante i Coreper e le riunio-ni fiume nel palazzo Justus Lipsius. Un marginale quantopragmatico segnale per i funzionari è stata la richiesta diestendere ad libitum il funzionamento e l’apertura dellesedi europee, per consentire il susseguirsi notturno delleriunioni del Consiglio. Ad esempio, dopo 18 ore di discus-sione sul pacchetto Clima, i meeting si protraevano aoltranza fino quattro del mattino, continuando informal-mente nelle coulisse. La corsa al risultato ad ogni costo haportato a compromessi al ribasso dell’ultim’ora, cheaccontentano scontentando un po’ tutti (anche all’internodella Francia stessa nei confronti della propria Presidenza,come è successo a un certo punto per la direttiva difesa,prima oggetto di critiche da parte delle industrie d’oltralpeche avrebbero preferito nessuna direttiva a una ostile,risultando poi politicamente favorevoli), o con decisionied effetti posticipati per ottenere l’approvazione finale.Brussels diventa dunque sempre più il luogo dove la con-vergenza delle divergenze è possibile, con il duplice e con-traddittorio effetto che il treno della pressione comunitariaspinge gli Stati Membri, ma anche la Commissione stes-sa, a una maggiore flessibilità, creando d’altra parte uncomplesso di regole e principi evolutivi ma a volte ambi-gui, la cui interpretazione si fonda su grandi principi, men-tre la loro gestione può mettere alla prova il delicato bilan-ciamento di rapporti su cui è fondata la complessa costru-zione europeaSe si volessero trarre alcune considerazioni finali, di fron-te a un’Europa disorientata per gli effetti della crisi econo-
mica e per lo stallo istituzionale della Ue, il dinamismo diSarkozy - forte dell’efficacia di uno Stato-Nazione moltoben organizzato - ha avuto senza dubbio il merito di por-tare l’Europa, intesa come insieme di Paesi, agli stessitavoli negoziali internazionali insieme con i maggioriPaesi, provando a dare risposte in qualche modo coese alleinnumerevoli crisi occorse nel 2008. Grazie ad una elabo-razione analitica e sistematica probabilmente unica inEuropa sui principali dossier, funzionale a un ampio dise-gno politico di lungo termine pur se attuato con modalitàa volte impulsive o contraddittorie, Parigi ha saputo impri-mere all’Europa un impulso alla sua dimensione esternacome era nei suoi obiettivi. Allo stesso tempo questoimpulso, definito da alcuni “europeizzante”, ha fornito laprova e la consapevolezza che l’Europa ha anche la capa-cità di reagire velocemente alle nuove sfide, anche se inordine sparso e al di fuori del suo quadro istituzionale.Ne è emersa dunque una coscienza e una propensionecollettiva tra le Nazioni sul bisogno di pensare a formedi governance più efficaci, prefigurando una riflessioneistituzionale con una configurazione politica incentratasu Paesi forti, e finalizzata a dal sostegno agli interessicomuni europei nel mondo. Non a caso Sarkozy si è piùvolte soffermato sul ruolo dei grands pays che hannonon tanto dei diritti ma delle responsabilità in Europa,rilanciando l’idea di un Direttorio per “aiutare” il seme-stre della Cechia, ma con insita l’idea di un rilancio del-l’influenza di Parigi sulla gestione dell’Europa. Rimaneil fatto che la tentazione di un’Europa a due velocità conun nucleo ristretto di Paesi guida “che si fanno le rego-le”, può trovare un terreno fertile ai disegni d’oltralpe, inquesta fase confusa e senza un progetto o vision di lungoperiodo dell’Europa, con momenti di indifferenza inter-vallati da colpi di scena. Ma questo non potrà che esserea vantaggio di quei Paesi che dimostreranno la volontàdi attrezzarsi adeguatamente per andare avanti insieme(non solo con regole condivise e appropriate ma anchecon investimenti tecnologici mirati alla competitività deisettori strategici), evitando il rischio di essere scavalcatinella stessa casa comune, influenzando allo stesso tempodall’interno la formazione di quella che appare essere laprossima fase della costruzione europea.

76
lo scacchiereUE /dopo monaco riprende
il dialogo sulla sicurezza europea(ma i nostri leader continuano a fare orecchie da mercante)
Dopo un lungointermezzo lega-to all’avvio dellanuova Ammini-strazione Usa,finalmente euro-
pei americani e russi si trovanodavanti ad un tavolo per parlaree risolvere problemi, anzichéscambiarsi insulti e ripicche
come l’annoscorso. L’occasione perl’avvio di questolungo e difficileprocesso diriconciliazione èl’appuntamentoannuale alla con-ferenza di Mo-naco ad inizioFebbraio, checome di consue-tudine coinvolgei principali lea-der mondiali e“facilita” gliincontri formalisuccessivi nellesedi istituzional-mente proprie.Pertanto, nessu-
na decisione, ma l’avvio diincontri e dialoghi destinati inseguito a formalizzarsi. L’eventoprincipale è stato il discorso delvice presidente Usa Biden, sucui si sono catalizzati i commen-ti degli analisti, ma soprattutto lereazioni dei politici europei erussi. In un clima d’incertezzacaratterizzato dallo spettro sem-pre più concreto della crisi eco-nomica e delle sue conseguenzeanche di natura strategica, gliStati Uniti hanno voluto voltarpagina e mandare un segnaled’apertura e maggior coinvolgi-mento sia, come naturale, aglialleati europei, sia alla Russia. Ilrichiamo a lasciar da parte i“giochi a somma zero” e le“rigidità ideologiche”, oltre afare definitivamente piazza puli-ta dalla mentalità perdentedell’Amministrazione Bush,traccia il solco del dialogo entrocui aprire un confronto a volteduro con il Cremlino e con glialtri attori internazionali cheminacciano la stabilità.Questo rinato pragmatismo,unito al rifiuto dello “scontro diciviltà” e al rigetto della “falsa
DI GIOVANNI GASPARINI

scacchiere
77
alternativa fra sicurezza e valo-ri”, un altro cavallo di battagliadell’era Bush-Cheney che tantidanni ha fatto alla credibilitàamericana (alibi per pratiche illi-berali e antidemocratiche qualiGuantanamo, Abu Graib e ilPatriot Act, nefandezze che pertroppo tempo hanno macchiatola reputazione americana), sa-ranno i principi ordinativi dellanuova politica di sicurezza ame-ricana, riportata finalmente nell’alveo della continuità ideale emorale da cui era dipartita perotto lunghissimi anni. Gli StatiUniti chiedono una forte coope-razione agli alleati tradizionali,al fine di rendere efficaci le poli-tiche di stabilizzazione condivi-se nell’ambito della non-prolife-razione, il contrasto al radicali-smo fondamentalista e la stabili-tà globale. Il fine è di prevenire econtenere le crisi, risolvendolein maniera cooperativa quandoesse sono già manifeste, attra-verso l’impiego di ogni mezzoadatto, fra cui la forza militarequale ultima istanza. Uno deimezzi proposti è il rilancio dellaNato, di cui ad Aprile si festeg-geranno i sessanta anni. Lanuova presidenza pare favore-vole ad un ampliamento delleresponsabilità dell’Alleanza e alreintegro pieno della Francianella struttura militare dellaNato, cui si lega anche il suppor-to ad un maggior sviluppo dellecapacità dell’Unione europeaquale produttore autonomo di
sicurezza. Biden rilancia ancheiniziative problematiche come ladifesa antimissile, oggetto discontro con la Russia, ma miraad aprire un dialogo ampio conMosca su tutti i fronti, ad inizia-re dagli armamenti strategici,pur mantenendo fermo il princi-pio che non vi sia diritto in alcunmodo da parte russa a vederrispettata una qualche “sferad’influenza” di natura geopoliti-ca. Il discorso americano rifiutala logica “geopolitica a sommazero” finora imperante al Cre-mlino e ingaggia l’interlocutoresu un piano globale, cercando dimostrare soluzioni vincenti pertutti i giocatori; non sarà facile,ma è certo la strada giusta fuoridall’impasse generatadall’intervento in Ge-orgia la scorsa estate. Incomplesso, emerge l’av-vio di un dialogo strate-gico a tutto campo,molto articolato e in cuigli europei potrebberoritagliarsi ampi spazi dimanovra se non addirit-tura occasioni di leader-ship, se solo sapesseroagire unitariamente emettere a fattor comunele scarse risorse di cuisono dotati a livellonazionale.Il rischio però è che,davanti alla prova, ovve-ro alla richiesta di contri-buzione e di dialogo daparte americana, si solle-

Risk
78
La “success story” balcanica di nuovoalla prova della verità. Chi guarda aSkopje come al laboratorio della politi-ca europea nei Balcani (fondata su“principio di condizionalità” e “prospet-
tiva di adesione” attraverso una forma di regionalownership) rischia di veder nuovamente rinviato ilmomento delle celebrazioni. Prima nella sottoscrizio-ne dell’Accordo di Stabilizzazione ed Associazione il9 aprile 2001 (anche come riconoscimento dei meritiper la gestione dei 300mila profughi nel ’99 durantela crisi del Kosovo), fra le prime a veder riconosciutolo status di candiato (17 dicembre 2005), Skopje si staincagliando non tanto e non solo sull’attuazione dellemisure di decentramento previste dall’Accordo-qua-dro di Ohrid del 2001 quanto sulla ciclica questionedella denominazione. La prospettiva di allargamento(e, formalmente, quella di adesione alla Nato) hannoavuto, come noto un brusco stop in occasione del ver-tice dell’Alleanza Atlantica di Bucarest nello scorsoaprile. L’intransigenza di Atene dinanzi alla possibilenuova denominazione - con il governo del premier
Gruevski che in quella sede aveva accettato“Repubblica di Macedonia (Skopje)” - offrì la (atte-sa?) sponda a quanti dal vertice Nato chiedevano solo“combustibile” per la delicata campagna elettorale invista delle elezioni parlamentari macedoni del giugnoseguente. Così le settimane successive furono unescalation di dichiarazioni di fuoco, con Gruevskipronto a farsi paladino “offensivo” dei diritti deglislavi residenti nel Nord della Grecia, aggiungendorivendicazioni sui beni dei macedoni che lasciarono laGrecia dopo la guerra civile e reincendiando la con-troversa decisione di intitolare ad Alessandro Magnol’aereoporto della capitale. Gli strascichi di quellacampagna elettorale (conclusasi, come facilmenteimmaginabile, con un trionfo per Gruevski) hannocongelato i rapporti con Atene per mesi. E vanificatoquanto di buono si era creato, ad esempio, su dossierdelicati come il riconsocimento del Kosovo (su cuientrambi i Paesi avevano mostrato nelle prime setti-mane più d’una remora). Tradizionalmente, infatti,l’atteggiamento macedone sulla questione kosovara èstato di massima prudenza alla luce della consistente
vi un consenso amplissimo non suffragato da azioniconcrete, oppure l’avvio dell’ennesima corsa amostrarsi individualmente “buoni alleati” con il massi-mo dell’impegno retorico ed il minimo dello sforzoreale. I due banchi di prova imminenti, Afghanistan eIran, sono già al varco e le risposte sinora non sembra-no entusiasmanti; l’ostinazione a sviluppare sul pianobilaterale nazionale il rapporto di sicurezza transatlan-tico, è destinato a fallire per mancanza di forza politicae di risorse economiche.Ma l’Unione europea, minata dai litigi e dalle tentazio-ni protezionistiche degli stati membri e dalla mancanza
di una vera leadership, poiché la presidenza semestraledel Consiglio è risultata chiaramente fallimentare,mentre la mediocre Commissione attuale sembra averpaura della propria ombra, non sembra pronta ad assu-mersi quella responsabilità di guida che le spetterebbe.E così, in ordine sparso, i leader nazionali europei sipreparano a lodare la nuova politica estera americanama non a predisporre gli strumenti e le politiche neces-sarie per indirizzarla e accompagnarla, poiché ciòrichiederebbe il superamento dell’ultimo tabù su cui sipoggia il castello di carta del loro effimero potere ester-no: il mito dello stato nazionale.
BALCANI/skopje alla prova della verità fra le presidenziali di marzo e il summit Nato
Perché il caso macedone rischia di trasformarsi in un fallimento diplomaticoDI FABRIZIO EDOMARCHI

scacchiere
79
minoranza illirica residente che, benchè da semprerappresentata al governo da almeno un partito etno-nazionale, ha recentemente sviluppato nel suo senouna forte componente panalbanese facente capoall’Aksh, l’esercito nazionale albanese, forte di arti-colazioni in diversi paesi e di significativi finanzia-menti, anche di matrice islamica. Non è un caso che -cessato, nel post-Bucarest il clima di dialogo conAtene - Skopje abbia preso la decisione il 9 ottobre diriconoscere l’indipendenza di Pristina (ampliando defacto il solco con Atene sulla questione “denomina-zione”). Non è un caso che da parte macedone si siadeciso di far ricorso alla corte internazionale di giusti-zia in merito alla posizione greca, sulla scia della pre-visione (ad avviso di Skopje violata) dell’InterimAccord del ’95 secondo cui la Grecia non avrebbemai utilizzato la “leva denominazione” per bloccarel’ingresso macedonenelle organizzazioni internazio-nali. Da parte sua Atene, forte anche di un inaspetta-to, nella consistenza, sostegno da parte dellaPresidenza Francese dell’Unione Europea, non hainteso avvicinarsi a posizioni di mediazione ed orasono a rischio anche i tentativi esperiti dall’inviatodelle Nazioni Unite Matthew Nimetz. La cui propo-sta proposta, “Repubblica della Macedonia del Nord”nelle relazioni internazionali e “Republika Make-donija”, in cirillico per uso interno ha trovato ufficio-si riscontri positivi in entrambe le capitali ma non suf-ficienti da far pendere la bilancia verso l’ufficialità.Da parte macedone il rischio è duplice: da un lato uneventuale stallo può essere sfruttato - nuovamente -per finalità elettorali nella tesa campagna per le con-sultazioni presidenzali e locali in programma il 22marzo. La popolarità raggiunta da Gruevski lo scorsogiugno, nell’emozione post-Bucarest può indurre ilpremier a spendere parole e toni simili anche nellatornata odierna. Le presidenziali mettono infatti difronte il candidato del partito di maggioranza relativaVmro (Organizzazione rivoluzionaria interna mace-done), Gjorgi Ivanov, non solo all’esponente del par-tito tradizionalmente avverso Sdsm (partitoSocialdemocratico), Ljubomir Frckoski, ma, soprat-
tutto all’indipendente Ljube Boskovski, eroe deinazionalisti macedoni, uscito illeso dalla tribolatavicenda personale al tribunale de L’Aja. Questa can-didatura - autonoma - di stampo nazionalista rischiadi erodere il tradizionale elettorato della Vmro ecostringerà Ivanov, giocoforza, a spostare il baricen-tro della sua “proposta elettorale” su temi identitari, ascapito della possibile mediazione con Atene.Trasformando in un nuovo post-Bucarest l’attualecampagna elettorale. Trasformando, in ottica Nato, inPost-Bucarest il pre-Strasburgo/Kehl. Si perchè - equi viene il secondo rischio - la Nato ha in program-ma un ambizioso summit ad un anno di distanza dalprecedente che, oltre a celebrare i 60 anni dell’allean-za ed il possibile reingresso francese nel sistema inte-grato di comando dell’Alleanza, delineerà le adesioniprossime venture. Il rischio per Skopje è altissimo, tenuto conto dellaimpossibiltà - de facto - di ricreare condizioni di dia-logo nella angusta finestra fra il voto presidenziale edil summit transatlantico. Quindi un tema strettamenteformale si ripresenta in tutta la sua capacità di “deto-nazione” a far crollare le genuine aspettative di ade-sione presenti. ASkopje e a Bruxelles.Esistono, comenoto, in Europa diversi casi di omonimia fra regionied entità statuali contermini. Di tutta evidenza i casidi Lussemburgo e Moldavia, regioni di Belgio eRomania oltrechè stati sovrani. Il caso macedone,evidentemente insiste su un’identità fragile e molte-plice che lo rende unico, lo rende “Balcani deiBalcani” secondo la definizione di Susan Gal e JudithIrvine. E rimanda al grande interrogativo della Macedoniadi Rebecca West, un Paese che «si è trovato sotto-messo all’Impero Ottomano fino al 1913; è statofino ad allora imbalsamato dal malgoverno turcoesattamente in quelle condizioni medievali esisten-ti dai tempi dell’isolamento succesivo alla sconfittain Kosovo nel 1389. La Macedonia dovrebbe esse-re vista come una specie di museo...». La sfidaodierna è di riavviare questo Volksmuseum verso unfuturo di integrazione.

Risk
80
Due temi hanno dominato la scenamessicana nella seconda metà del2008: l’ondata di violenza generatadalla guerra tra i cartelli della drogae gli effetti della crisi economica
internazionale. In entrambi i casi, la relazione con lanuova amministrazione di Barack Obama rivesteun’importanza fondamentale. Il governo di centro-destra guidato dal presidente Felipe Calderón èimpegnato in una vasta operazione contro i cartellidel narcotraffico, con l’impiego di 30mila effettivimilitari e di polizia. I punti principali della“Campagna permanente contro il narcotraffico el’applicazione della legge federale sulle armi dafuoco e gli esplosivi” sono l’impiego delle ForzeArmate in azioni di contrasto alla criminalità e lalotta alla corruzione tra le forze di polizia.L’offensiva sta riducendo gli spazi a disposizionedei cartelli della droga, finendo per inasprire laguerra tra i clan per il controllo del traffico e del ter-ritorio. La disarticolazione dei cartelli è favoritaanche dall’estradizione negli Stati Uniti di diversicapi criminali, impedendo loro di continuare a man-tenere dal carcere contatti operativi con i narcotraf-ficanti. Il Messico è il primo fornitore di marijuanae cocaina e il secondo fornitore di eroina degli StatiUniti. Tra il 60 e il 70% delle metamfetamine con-sumate nel grande vicino settentrionale sono pro-dotte qui. Per l’Agenzia Antidroga degli Stati Uniti(Dea nella sigla in inglese) nel 2004 il 92% dellacocaina che entrava nel Paese era controllato daitrafficanti messicani, un business da 65 miliardi didollari l’anno (dati Dea). I cartelli messicani di oggi sono nati negli anniOttanta, quando si chiusero le rotte caraibiche del
traffico di cocaina verso gli Stati Uniti. Allora, i car-telli colombiani iniziarono a pagare le bande messi-cane di trafficanti con droga anziché denaro, perevitare problemi legati al riciclaggio dei narcodolla-ri. Ne è seguita la progressiva segmentazione delleattività di produzione in Colombia - e distribuzionedi cocaina - in Messico. I principali gruppi sonoquelli del Golfo, di Sinaloa-Pacifico, di Tijuana e diJuárez. Gli scontri iniziarono nel 1989, con losmembramento del cartello di Guadalajara. Dal2000 la violenza non ha cessato di crescere, e i car-telli sono passati dalla lotta per il controllo dellerotte del narcotraffico a quella per il dominio com-pleto di alcuni territori del Paese, specialmente negliStati nord-occidentali di Sinaloa e Chihuhua. Allafine del 2008 si sono registrate più di 5.700 vittime,la maggior parte narcotrafficanti brutalmente assas-sinati.Recentemente, il calo della domanda negli StatiUniti e le maggiori difficoltà di accesso al riccomercato settentrionale hanno portato i cartelli mes-sicani a concentrarsi sul mercato interno e su quellodi altri Paesi dove il consumo è in crescita, a partiredal continente latinoamericano. L’opinione pubbli-ca in generale sta appoggiando l’offensiva delgoverno e delle Forze Armate contro il narcotraffi-co, considerato dai messicani il secondo maggiorproblema dopo la corruzione. L’arresto di alcuni altifunzionari della Polizia dimostra l’efficacia dell’ini-ziativa, ciononostante il governo Calderón è accusa-to di non disporre di un piano integrale di preven-zione socio-economica del narcotraffico capace diaffrontare le cause profonde di tanta violenza. La lotta contro i cartelli della droga è un tema di altasensibilità anche per gli Stati Uniti. In un documen-
AMERICA LATINA /per colpa della crisi, i cartelli messicani si riorganizzano
Cala la domanda negli Usa e si aprono nuove rotte in Sudamerica DI RICCARDO GEFTER WONDRICH

81
to dello Stato Maggiore delle Forze Armate Usa suipossibili teatri mondiali in cui gli Stati Uniti potreb-bero dover intervenire militarmente per garantire lapropria sicurezza interna, il Messico è citato al fian-co del Pakistan quale nazione esposta alla possibili-tà di un “rapido collasso”. Nel documento si leggeche «il governo, i politici, la Polizia e il potere giu-diziario sono oggetto di un’aggressione da parte deigruppi criminali e dei cartelli della droga. La formache prenderà questo conflitto interno nei prossimianni avrà un impatto trascendentale sulla stabilitàdello Stato messicano».Per inquadrare la questione in un’ottica di sistema,bisogna considerare tanto la dimensione e naturadei cartelli quanto la debolezza strutturale dell’ap-parato poliziesco e del sistema giudiziario messica-no. Si sta gradualmente instaurando nel dibattitopubblico il tema della rafforzamento istituzionale,del rispetto della legge e del rifiuto di pratiche ille-gali comunemente tollerate. I problemi maggioririguardano il coordinamento tra i livelli federale estatale (ad esempio il narcotraffico e la delinquenzaorganizzata sono considerati crimini federali mentregli omicidi e i sequestri sono di responsabilità delleautorità statali) e tra le diverse forze di polizia. Ilcrimine organizzato ha costruito in questi anni unavasta rete di appoggi e di beneficiari nella societàcivile, contando sovente con alti tassi di corruzionee impunità. Per vincere la battaglia contro la delin-quenza organizzata c’è bisogno di uno sforzo con-giunto da parte del governo, dei partiti politici, deisindacati e della società civile.L’altro tema all’ordine del giorno è quello economi-co, con i drammatici riflessi che la crisi statunitensesta producendo sull’economia messicana. IlMessico è indicato come uno dei tre Paesi latinoa-mericani che maggiormente risentirà del difficilecontesto internazionale. Gli altri sono il Veneuzela el’Argentina, rispettivamente a causa della cadutadei prezzi del petrolio e degli alimenti, a cui nelcaso argentino si è andata sommando una dramma-tica mancanza di piogge durante l’estate australe.
La crescita del Pil messicano è passata dal 3,2% del2007 al 1,8% nel 2008, a causa di una minoredomanda interna e soprattutto della caduta delleesportazioni nel secondo semestre dell’anno. LaCommissione Economica delle Nazioni Unite perl’America Latina e i Caraibi stima che la crescitanel 2009 sarà inferiore a un punto percentuale acausa delle minori esportazioni manifatturiere(l’80% dell’export messicano va negli Stati Uniti),un mercato interno asfittico, meno credito, menorimesse e meno investimenti esteri. Il 2008 avrebbepotuto chiudersi assai peggio se il governo nonavesse assicurato le quotazioni del petrolio sul mer-cato finanziario durante il secondo semestre. Conun costo totale di circa 1,5 miliardi di dollari hainvece potuto garantire al greggio messicano unvalore di 70 dollari al barile, ciò che permette di sti-mare una compensazione di 9,5 miliardi di dollarinel 2009 calcolata su un prezzo di 40 dollari al bari-le. Per moderare l’impatto interno della decelerazio-ne mondiale, in ottobre è stato approvato un“Programma di Stimolo alla Crescita eall’Occupazione”, con un impegno finanziario pariall’1% del Pil. Sono previste maggiori spese ininfrastruttura, la costruzione di una nuova raffineria,un piano di appoggio alle Pmi, semplificazioni nelleoperazioni commerciali e migliori condizioni perattrarre investimenti esteri. La vittoria di Barack Obama presenta nuove oppor-tunità e alcuni rischi nei rapporti bilaterali tra StatiUniti e Messico. Le opportunità sono legate al ruolofondamentale che hanno avuto le comunità messi-cane nel trionfo democratico in Nevada, NewMexico, Flordia e Colorado. Esse possono trasfor-marsi in un prezioso strumento di lobby nei con-fronti del governo e del congresso americani. Al dilà degli aspetti commerciali, vi sono spazi perapprofondire l’integrazione specialmente nel setto-re dei servizi e della salute, che costituiscono enor-mi fonti potenziali di impiego. I rischi sono connes-si alla chiusura commerciale rispetto alle importa-zioni messicane, alla messa in discussione del Nafta
scacchiere


83
La 45esima Conferenza sulla Sicurezzache si è tenuta a Monaco ha offerto almondo un primo sguardo sull’emergen-te politica estera del presidente degliStati Uniti Barack Obama. Il pubblico
della conferenza, per lo più europeo, ha potuto sentireil nuovo tono costruttivo in cui aveva sperato. Ad ognimodo, l’effettiva politica diligentemente esposta datutti i rappresentati dell’Amministrazione a Monaco siè distinta per un’attenta continuità. Le aspettativeerano alte e Washington è stata all’altezza della situa-zione, mandando sul posto il vice presidente JoeBiden, il consulente per la Sicurezza Nazionale JamesJones, l’inviato speciale per l’Afghanistan RichardHolbrooke e il Generale in capo del ComandoCentrale degli Stati Uniti David Petraeus. Il pubblicoha accolto con entusiasmo l’arrivo di Biden sul palcoil 7 febbraio. Ed il vice presidente non ha perso temponel tendere la mano dell’America verso i suoi alleatieuropei.«Io vengo in Europa», ha detto Biden alle persone riu-nite nell’elegante Bayerischer Hof Hotel «per conto diuna nuova amministrazione, una amministrazione cheè determinata a stabilire un nuovo tono non solo aWashington, ma in tutti i rapporti dell’America nelmondo. Il nuovo tono ha origine da un forte spiritobipartisan per affrontare queste sfide comuni. E noiriconosciamo che queste sfide, l’esigenza di affrontar-
le, non rappresentano un’opportunità, ne’un lusso, maun’assoluta necessità». Una notevole dose di realtà èimmediatamente seguita: «Mentre ogni nuovo inizio èun momento di speranza, questo momento perl’America e per i Paesi rappresentati in questa sala ècarico di preoccupazione e considerevoli pericoli». Ilmessaggio era chiaro: là fuori ci sono pericoli e nonpossiamo più dare la colpa del fallimento ad un impo-polare presidente americano. «L’America farà di più.Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è chel’America chiederà anche di più ai suoi alleati». Unrinnovato spirito occidentale deve ora incontrarsi conquesto nuovo spirito americano. «Non esiste conflittotra la nostra sicurezza e i nostri ideali… l’esempio delnostro potere deve accordarsi con il potere del nostroesempio», ha detto Biden. «L’America non torturerà.Sosterremo i diritti di coloro che condurremo alla giu-stizia. Chiuderemo Guantanamo». Questo, ad ognimodo, è quello che volevano sentire anche la maggiorparte degli americani. Sulla Russia, ha detto Biden,«Negli ultimi anni si è assistito ad una pericolosa deri-va nei rapporti tra la Russia e i membri della nostraAlleanza. Per parafrasare il presidente Obama, è giun-to il momento per risistemare e rivisitare le numerosearee in cui possiamo e vogliamo collaborare con laRussia». Il numero due degli Stati Uniti ha suggerito di collabo-rare con la Russia nella lotta al terrorismo, in
Russia /obama vuole la georgia nella nato (e fermare la deriva dirigista di putin)Ecco perché la comunità internazionale adesso lo deve aiutare
DI DAVID J. SMITH
scacchiere
sotto la richiesta di un maggiore protezionismo e aulteriori rinvii sulla questione migratoria.L’efficacia delle azioni di contenimento della vio-lenza e la profondità della crisi economica si riper-cuoteranno sulle elezioni legislative previste perluglio prossimo. Il tradizionale Partito della
Rivoluzione Istituzionale sta riguadagnando terre-no, dopo aver passato due periodi presidenziali fuoridal governo: mantiene un buon seguito elettorale,numerosi deputati e governatori e si profila come ilprincipale beneficiario in caso di sconfitta delPartito di Azione Nazionale di Calderón.

Risk
84
Afghanistan, nella non proliferazione di armi nuclearie negli ulteriori tagli agli armamenti nucleari statuni-tensi e russi. Se il Cremlino intende frenare la suaaggressione, spegnere la sua retorica infiammatoria esmettere di giocare alla Guerra Fredda, Biden ha offer-to un gran numero di potenziali aree di cooperazione.Allo stesso modo, ha reso chiaro che l’Ammini-strazione Obama non si ritirerà di fronte alla bellige-ranza petulante di Mosca. Contrariamente a quanto siaspettavano in molti, non ha annunciato una revisionedel piano dell’America di dispiegare un sistema didifesa missilistica nella Repubblica Ceca e in Polonia.«Continuiamo a sviluppare - ha detto Biden - una dife-sa missilistica per contrastare la crescente capacità ira-niana, a patto che la tecnologia sia provata e vantag-giosa in termini economici. Agiremo in questo sensoin collaborazione con voi, i nostri alleati Nato e con laRussia». Non si può essere più imparziali di così.Ilvice presidente degli Stati Uniti inoltre ha mandato unsegnale inequivocabile che il Cremlino farebbe bene atenere in considerazione: «Gli Stati Uniti non ricono-sceranno l’Abkazia e l’Ossezia del Sud come statiindipendenti. Non riconosceremo alcun Paese cheabbia una sfera di influenza. Continueremo a ritenereche gli stati sovrani hanno il diritto di prendere le lorodecisioni e scegliere i propri alleati». Per la Georgianon è cosa da poco - rappresenta un passaggio fonda-mentale nell’orientamento della politica estera
dell’Amministrazione Obama! Il giorno successivo, inun incontro con il presidente della Georgia MikheilSaakashvili, un giornalista chiese a Biden se gli StatiUniti erano favorevoli all’inclusione della Georgianella Nato. «Sono favorevole a che la Georgia conti-nui ad essere indipendente e autonoma. Il resto sta allaGeorgia di deciderlo».Con tutte le offerte di cooperazione e consultazioneche Biden ha indirizzato alla Russia, i continui passidella Georgia verso la Nato non dovrebbero costituireun problema - a meno che il Cremilino non scelga difare in modo che lo siano. Da un punto di vista diver-so, molti cittadini dell’Europa occidentale devono rie-saminare la questione della Georgia nella Nato sotto lanuova luce gettata dall’Amministrazione Obama aMonaco. «Di fronte a nuove minacce, nuove realtà -ha detto Biden della Nato - abbiamo bisogno di nuovarisolutezza per gestirle e di nuove capacità per riuscir-ci. La nostra Alleanza deve essere meglio equipaggia-ta per fare in modo che si ponga fine alla diffusionedelle armi più pericolose del mondo, per fronteggiareil terrorismo e la cyber-security, per estendere il decre-to della sicurezza energetica e per agire più efficace-mente all’interno e all’esterno dell’area». In questocontesto, la Georgia nella Nato ha un senso. Il summitche si terrà a Stasburgo e Kehl il 3 e 4 aprile prossimiin occasione del sessantesimo anniversario dell’allean-za sarebbe l’occasione ideale per ribadirlo.
Africa /il potere logora chi non ce l’ha, ecco perché le dittature sono eterne
Mugabe, Bongo, Biya, dos Santos, Gheddafi, Mubarak: il futuro è più nero DI EGIZIA GATTAMORTA
In Africa, qual è la chiave del potere? Nellagestione della cosa pubblica, conta più la capaci-tà di ricatto o il carisma personale? È maggior-mente utile il controllo del dissenso o la sanagestione amministrativa? Di fronte alle vicende
del continente durante l’ultimo cinquantennio è quanto
mai plausibile porsi tali domande per comprendere lecause di alcune disfunzioni che si ripetono costantemen-te, seppur con modalità differenti, sia nella fascia setten-trionale che in quella sub-sahariana. Se l’elemento etni-co è stato e continua ad essere una determinante fonda-mentale per le vicende locali, vi sono a latere dei carat-

85
teri preponderanti che si perpetuano nelle cinque macro-regioni. Uno di questi è certamente la longevità del pote-re, l’attaccamento viscerale ai ruoli chiave delle istituzio-ni, il perpetuarsi del comando senza possibilità alcuna dialternanza. Omar Bongo, Hosni Mubarak, RobertMugabe, Zine el-Abidine Ben Ali, Muammar Gheddafi,Paul Biya, Josè Eduardo dos Santos sono visti da talunicome “padri della patria”, da altri come “dittatori” da eli-minare per iniziare un nuovo percorso verso l’alternanzademocratica e lo sviluppo reale dell’economia. Da verileader, essi hanno avuto la capacità di coagulare delleforze intorno a sé, di dare risposte a particolari segmentidella popolazione, pur macchiandosi di crimini efferati.Cosa lega questi uomini e cosa li differenzia? Il fattoretempo è il denominatore comune, vale a dire che ognu-no di loro gestisce il potere da circa trenta o quarant’an-ni, mentre la discriminante è la singola ricetta utilizzataper schiacciare l’opposizione all’interno, impedendo allostesso tempo l’ingerenza esterna negli affari nazionali. Idue prototipi possono essere considerati Mugabe eBongo. Quanto l’uno ha utilizzato ogni forma di coerci-zione contro il suo stesso popolo ed è stato reietto dallacomunità internazionale, tanto l’altro ha avuto la capaci-tà di mantenersi un interlocutore valido a livello regiona-le e internazionale, un peace-maker attendibile e un fat-tore di stabilità dell’area centro-occidentale, capace dirafforzare i legami con Francia e Stati Uniti, abile nell’in-sabbiare il controllo capillare dall’alto nonché alcunemanovre di restrizione delle libertà individuali dei pro-prio connazionali.Del presidente dello Zimbabwe si è detto e scritto moltonegli ultimi mesi. Le consultazioni elettorali dello scor-so anno sono un esemplare perfetto di come il potere siastato e continui ad essere gestito in modo personale edautoritario. Dopo essere venuto a conoscenza dei risul-tati del primo turno elettorale del marzo 2008 (risultatiche tra l’altro sono stati resi pubblici dopo circa cinquesettimane), solo per qualche ora Mugabe è stato tentatodi dichiarare la partita persa e di abbandonare il potere.Nel frangente è stato tuttavia sostenuto dalla rete clien-telare dei servizi segreti, dai vertici militari e da alcunidirigenti del partito. Quel baluardo lo ha fatto andare
avanti e gli ha permesso di riprendere saldamente leredini del potere nel secondo turno elettorale del succes-sivo 27 giugno, grazie all’uso di intimidazioni persona-li e alle violenze locali. Una stampa sotto controllo, l’ap-poggio dei veterani di guerra e delle regioni rurali, lademonizzazione dell’ingerenza imperialista occidentalesono le armi utilizzate per rimanere saldo alla guida delpartito (Zimbabwe African National Union-PatrioticFront, Zanu-Pf) e del Paese. La rete abilmente costruitanon permette nessuna forma di dissenso: gli attivisti dialcune organizzazioni per la tutela dei diritti umani sonostati messi in carcere e torturati solo per essere scesi instrada a fare volantinaggio, numerosi aderenti e simpa-tizzanti nelle città del Movement for DemocraticCh’ange (Mdc) sono stati arrestati e obbligati a rilascia-re confessioni false riguardanti presunti atti di sabotag-gio al potere centrale. All’età di 85 anni, Mugabe ha inmano le chiavi del sistema ed il network clientelare chesi è abilmente costruito lo garantisce dalle accuse diogni tribunale interno. A livello internazionale invece,gode dell’appoggio (o meglio dell’omertà) degli omolo-ghi capi di stato africani (solo i vertici di Kenya eBotswana hanno denunciato la sua gestione), nonchédella protezione dell’alleato cinese che in cambio dirame e avorio ha tentato di garantire il rifornimento diarmi in varie occasioni.Inconsistenti le voci per un possibile successore. Alcunihanno parlato di Joyce Mujuru, altri di Joseph Misika(entrambi esponenti di spicco e vicepresidenti del parti-to) ma quello che è certo è che non c’è un “delfino” pre-stabilito e preparato per il dopo-Mugabe. Il meccanismoè stato cristallizzato, ogni piccolo cambiamento è statobloccato sul nascere. Potrebbe sembrare paradossale maneanche il crollo del sistema economico e l’inflazionearrivata ormai a livelli impensabili (si parla addirittura diun tasso di 231.000.000%) potrebbero eliminare il “bigman”. Oggi come oggi, solamente il dilagare del colera(si sono registrate circa 2000 vittime nel giro degli ulti-mi mesi) potrebbe spingere ad un sovvertimento delpotere. Non altro. Come dimostra la recente nomina aPrimo ministro di Tsvangirai). Triste a dirsi, mentre la metà della popolazione è malnu-
scacchiere

Risk
86
trita, oltre 2 milioni di persone dipendono dagli aiutiinternazionali e l’80% della forza lavoratrice è disoccu-pata, il “vecchio combattente” si può permettere diaddossare la responsabilità di questa situazione a fanto-matiche armi chimiche che sarebbero state utilizzate daStati Uniti e Gran Bretagna per causare siccità e care-stia, può continuare a vivere nei suoi numerosi possedi-menti e può alimentare i lussi sfrenati della moglieGrace (soprannominata “Gucci Grace” e “The FirstShopper” per le spese sfrenate nelle boutique della gran-de moda) o del nipote Leo (già coinvolto in affari loschima sempre rilasciato dalle autorità giudiziarie).Apoco servono le sanzioni Ue, il divieto di viaggiare inPaesi europei o il congelamento di beni al di fuori delterritorio nazionale quando in un Paese di 13 milioni diabitanti solo una minima parte (forse un milione?)potrebbe vivere grazie ad un sistema costruito sulleminacce e le estorsioni. Che dire invece di OmarBongo, il più longevo al potere dopo la morte diEyadema in Togo? Anche in questo caso numerosesono le perplessità circa l’approvazione popolare del-l’operato dell’uomo al vertice dello stato gabonesedal 1967. Plebisciti dell’80% nascondono sempre votiobbligati, “simpatie artefatte”, supporti condizionati.Un lungo periodo di governo ha garantito una stabili-tà apparente, un bilanciamento delle esigenze dei varigruppi etnici ma ha anche permesso la creazione di unsistema clientelare intorno al presidente e al suo team,in particolare ai vertici del Parti DémocratiqueGabonais (Pdg). Le ricchezze accumulate in patria eal di fuori deriverebbero da particolari commissionielargite da compagnie petrolifere straniere (vd. Elffrancese) interessate alle risorse energetiche locali.Cosa dire delle lussuose proprietà di Parigi acquistatecon fondi pubblici? È palese in questo caso la conni-venza dell’Eliseo che ha preferito per tanti anni“guardare ma non vedere”. Sfortunatamente la stessacosa si può dire delle ultime tre amministrazioni ame-ricane che hanno scelto di eludere le denunce dinumerose associazioni dei diritti umani pur di crearsiun appoggio forte nel Golfo di Guinea. Cosa ne saràin questo caso della successione? Molte sono le voci
fumose alimentate dallo stesso Bongo, ad esempio siè parlato di una successione di tipo familiare (tentatain Togo e formalmente non riuscita) con l’inserimen-to extra-legem del figlio Ali Bongo, ma d’altra partepotrebbero anche essere selezionati dai quadri delpartito come Paul Tongui (attuale ministro dell’eco-nomia e delle finanze, nonché marito di una figlia diBongo) o Pierre Mamboundou (rappresentante deiPunu del sud ovest del Paese).Da nord a sud, da est a ovest, per mantenere il potere ileader africani non si pongono nessun limite: l’uso dellarevisione costituzionale è un classico, giustificato con larichiesta dal basso, o con la necessità di completare illavoro intrapreso (ab illo tempore) per le infrastrutture ela modernizzazione del Paese. Tipico esempio è quellodi Paul Biya (nella foto), l’uomo forte del Camerun dal1982, che dopo aver già modificato i tempi della presi-denza (passati da 5 a 7 anni), con qualche anno in anti-cipo, grazie al voto dell’Assemblea Nazionale del 10aprile 2008 scorso si è assicurato la possibilità di ripre-sentarsi alle elezioni del 2011. Non è la longevità alpotere - anomala di per se stessa - a lasciare perplessi.Quanto il contorno: l’ankylose sociale, è la stagnazionedell’autorità che fa nascere un senso di impotenza e fru-strazione. È chiaro che se non c’è un ricambio alla guidadel Paese, si sclerotizza la ricchezza, si alimenta unsistema malato, si garantisce il benessere di un migliaiodi persone o di categorie particolari a danno della mag-gioranza. Se questo è lo sconfortante panorama africa-no c’è da chiedersi se vi siano delle eccezioni. Sì, limi-tate ma altisonanti. I nomi di Nelson Mandela,Joacquim Chissano, John Koufur, Alpha OumarKonaré non sono andati nel dimenticatoio, anzi sarannosempre considerati simboli di una politica viva e dina-mica, indipendentemente dalle critiche sul loro operato.Possibile che questi leader siano una meteora nella real-tà continentale? Perché a loro sono stati sufficienti 7-8anni e agli altri non ne bastano 40?Un potere che si perpetua nel tempo inevitabilmentediventa patologico e s’incancrenisce…C’è da pensareche la prima malattia che colpisce l’Africa non è l’aids,né la malaria o il morbillo, bensì la sua classe politica!


88
LLaa ssttoorriiaaLLaa ssttoorriiaa
di Virgilio Ilari
QUANDO STAVAMO
DALLA PARTESBAGLIATA
QUANDO STAVAMO
DALLA PARTESBAGLIATA
L’immagine deimusulmani inpreghiera davantialle cattedrali diMilano e Bolognaè stata avvertitacome una provo-cazione, e pure la
sinistra laica e cattolica ha reagito coninquietudine e imbarazzo. All’epoca dellamia giovinezza, invece, vi avremmo certovisto “un segno dei tempi”; l’avremmoesaltata, per partito preso, progressista edecumenica. Allora l’Europa moderna eraterzomondista e anticolonialista: manife-stava contro i suoi governi paleo-imperia-listi e disprezzava i suoi soldati che sidisonoravano nell’assurdo tentativo difermare la storia. Oggi è fiera di aver tifa-to Obama e solidale con le ragazze e iragazzi in divisa che aiutano gli america-

storia
89
ni a portare pace e democrazia a casa degl’immigrati. Ilmestiere dello storico è spiegare i cambiamenti di men-talità. Ma prima di tutto occorre che se ne accorga e chein qualche modo li misuri. L’arte è il miglior orologiodella storia delle mentalità; e rivedere oggi un capola-voro come La Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvomi pare un buon sistema per misurare quanto siamodiversi da allora. Ricapitoliamo anzitutto il contesto. Laguerra d’indipendenza algerina, condotta dal Fronte diLiberazione Nazionale (Fln) e dal suo esercito (Aln),pose fine al tentativo della Francia di mantenere informe nuove il proprio impero coloniale, determinò ilcrollo della IV repubblica e aperse - per entrambi iPaesi - una nemesi storica non ancora conclusa.Combattuta esclusivamente colterrorismo e la guerriglia e senzabattaglie campali, provocò forsemezzo milione di morti algerini(300/460mila combattenti ecivili e 30/90mila collaborazio-nisti) e oltre trentamila francesi(di cui 28.500 militari e 4/6milacivili). Ripetutamente sconfittisul campo e infine respinti inMarocco e Tunisia da un podero-so esercito moderno di oltremezzo milione di uomini, gli8mila superstiti dell’Fln resistet-tero abbastanza a lungo da vince-re la battaglia per conquistare icuori e le menti, non solo deglialgerini, ma della stessa opinionepubblica francese, logorando lerisorse finanziarie e la determi-nazione del governo nemico.Salito al potere nel maggio 1958a seguito di un putsch militare capeggiato dal generaleSalan e col programma, inizialmente condiviso dallostesso Partito Comunista, di salvare l’Algeria francese,fu lo stesso generale de Gaulle a volere il referendumche l’8 gennaio 1961 approvò l’autodeterminazionedell’Algeria, a reprimere il secondo putsch dei genera-
li, ad aprire i negoziati segreti col Governo provvisoriodella Repubblica Algerina che condussero all’indipen-denza e infine a stroncare la resistenza dell’Oas(Organizzazione Armata Segreta), appoggiata da unaparte del milione di europei immigrati in Algeria (i“pieds noirs”). Amnistiati nel 1968, i generali golpistifurono riabilitati nel 1982, ma il ricordo della “saleguerre” non cessa d’inquietare il presente.
La Battaglia di Algeri nella storia e nel film (1965-66)Il film racconta l’inizio della rivoluzione algerina, inparticolare l’operazione militare condotta dalla 10aDivisione paracadutisti comandata dal generale Massu,per circoscrivere la ribellione e riprendere il controllo
della Casbah: un netto successomilitare, ma conseguito anchemediante la tortura e le esecuzio-ni, come ha ammesso e rivelato ilgenerale Paul Aussaresses in unlibro del 2001 (La battagliad’Algeri dei servizi speciali fran-cesi 1955-57, Libreria EditriceGoriziana, 2007). Pur apertamen-te schierato dalla parte algerina, ilfilm rappresenta con equilibrio eobiettività la strategia dei repres-sori e lo sdegno degli europei vit-time degli attentati terroristici, nétace il passato di delinquente eprosseneta dell’eroe algerino (AlìLapointe). Nel film non ci sono“buoni” e “cattivi”; eppure, pro-prio per questo, c’è un’alta tensio-ne morale di chiaro stampo mar-xista. Tortura, esecuzioni, terrori-smo sono raccontati come cruda
cronaca, sia dal punto di vista degli autori sia da quellodelle vittime, segnalando allo spettatore che la verità ela comprensione storica rappresentano un ampliamen-to di coscienza, e sono perciò eticamente superiori alpregiudizio ideologico o moralistico. Lo spettatorevede che il comandante dei parà (chiamato nel film
Nel 1966 “La Battaglia di Algeri” di Gillo
Pontecorvo era in piena sintonia col clima
ideologico europeo: benessere economico, egemonia culturale comunista, rifiuto
del passato coloniale e del militarismo, simpatia
per i movimenti di liberazione del TerzoMondo. Rivederlo oggi
consente di capire quantosiamo cambiati con la lotta
al terrorismo islamico

Risk
90
storia
“colonnello Mathieu”) e il capo dell’Fln (“Djafar”) siconfrontano senza odio, con reciproca stima; mentre igiornalisti (inclusi quelli comunisti) che contestano adentrambi i rispettivi metodi sporchi sono presentaticome ambigui o ipocriti. «Il punto non è se dobbiamoo no usare la tortura: il punto è se l’Algeria deve o norestare francese», ribatte il colonnello. «I vostri bom-bardieri uccidono la nostra gente. Dateci i vostri bom-bardieri e noi vi daremo i nostri cestini-bomba»,risponde il capo dell’Fln. Con suspense drammatica lospettatore vede le donne dell’Fln che si preparano perla loro missione di morte, stirandosi i capelli e truccan-dosi per confondersi con le europee; passano i posti diblocco con la bomba nascosta nella borsetta da spiag-gia o nel passeggino del figlio; scelgono le vittime albar o all’aeroporto con un misto di pena e fatalismo.Epica la scena del primo matrimonio celebrato da unrappresentante del Fln: un gesto rivoluzionario cheafferma la nuova legittimità nata dalla lotta e la speran-za di una nuova vita personale e comunitaria.
Scheda cinematograficaIl film nacque nel 1965 su proposta di Yacef Saadi, unodei capi militari dell’Fln ad Algeri, che ne fu anche pro-duttore e attore e che scelse il titolo (quello inizialmen-te pensato da Pontecorvo era, in alternativa, “Tu parto-rirai con dolore” oppure “Nascita di una nazione”). Fuperò il regista a imprimere al film l’effetto drammaticoe documentaristico di un cinegiornale, non solo giran-dolo in bianco e nero e con una cinepresa da 16mm, masgranando l’immagine, specialmente in alcune scene.Tranne Jean Martin (nel ruolo del Col. Mathieu), tuttigli altri sono attori non professionisti (tra cui BrahimHadjadj nel ruolo di Alì Lapointe; Yacef Saadi interpre-ta sé stesso col nome di “Djafar”). Il regista ha collabo-rato direttamente anche alla sceneggiatura, con FrancoSolinas, e alle musiche, con Ennio Moricone. La sce-nografia è di Sergio Canevari, la fotografia di MarcelloGatti. Il film è stato premiato col Nastro d’argento almiglior regista e col Leone d’Oro al Festival di Veneziae ha ottenuto 3 Nomination al premio Oscar (per Filmstraniero, regista e sceneggiatura originale).
Il contesto politico e ideologico Il film, prodotto nel 1966 da Saadi e distribuito dallaRizzoli, era in piena sintonia col clima ideologico allo-ra prevalente in Europa, incluse la Francia e la GranBretagna, caratterizzato dal benessere economico, dal-l’egemonia culturale comunista, dal rifiuto del passatocoloniale e del militarismo, dal progressismo, dal paci-fismo e dalla simpatia per i movimenti di liberazionedel Terzo Mondo. Questa espressione fu addiritturaconiata in Francia nei primi anni Cinquanta, ma laguerra d’Algeria provocò una profonda crisi nazionalee ciò spiega perché il film di Pontecorvo fu censuratofino al 1970 dal governo francese. Nel caso dell’Italia,il “terzomondismo” era però anche una precisa linea dipolitica estera, tesa a recuperare la piena “parità” diplo-matica con i minori vincitori della seconda guerramondiale (Francia e Gran Bretagna) e a ritagliarci unnostro spazio autonomo nei rapporti coi Paesi produt-tori di petrolio. Il punto di forza del terzomondismodiplomatico italiano era di poter contare su di una con-vergenza di interessi con gli Stati Uniti, impegnatianch’essi a subentrare in forme nuove nei due ultimiimperi coloniali europei. Benché la questione non siastata finora approfondita, sembra ormai certo chel’Italia - su pressione dell’Eni guidata da Enrico Mattei- abbia dato un forte sostegno militare al Fln algerino,e che il Centro Addestramento Guastatori (Cag) - la

storia
91
base segreta italo-americana creata nel 1954 a Nord diOristano - sia stato utilizzato addirittura per addestrarei combattenti algerini (“terroristi” per i francesi, ma“freedom fighter” per l’Italia e gli Stati Uniti, pur allea-ti della Francia, il cui territorio metropolitano, garanti-to dalla Nato, includeva allora anche l’Algeria). In ognicaso questa politica fu ufficializzata nel 1956 dal rifiu-to dell’Italia di partecipare all’ultima e fallimentareimpresa neocoloniale europea (l’intervento anglo-fran-cese nel Canale di Suez), e non fu fermata dalla miste-riosa morte di Enrico Mattei (avvenuta nel 1962 per unincidente aereo di cui furono sospettati l’Oas o gli stes-si servizi segreti francesi) e fu rafforzata dal ritiro delleforze armate britanniche da Malta (1967) e dal colpo distato in Libia (pianificato nel settembre 1969 nell’am-basciata libica a Roma), con conseguente espulsionedelle basi militari e delle compagnie petrolifere inglesidalla Cirenaica (Nonostante l’espulsione della comuni-tà ebraica e italiana dalla Libia, nel 1971 l’Italia sventòun tentativo dei servizi segreti inglesi di assassinareGheddafi, che fu riarmato dall’Italia, accolse 30milatecnici dell’Eni e nel 1974 salvò la Fiat). (v. V. Ilari,Storia Militare della Prima Repubblica, 1994).
Cosa possiamo imparare oggi dal film di PontecorvoRivedere questo film oggi, consente di cogliere il muta-mento del clima ideologico determinato in Europa enegli Stati Uniti dalla lotta contro il terrorismo islami-co e dalla difficile convivenza con le minoranze musul-mane. Ma consente anche di confrontare la diversaispirazione politica della lotta d’indipendenza algerina(che si richiamava comunque ai modelli laici ed euro-pei del nazionalismo e del socialismo) e dell’attualefondamentalismo islamico a base religiosa. Nondimentichiamo che la Francia fece appello proprio allatradizione religiosa musulmana per contrastare il prose-litismo del Fln nella popolazione algerina, e che fu poiil trasferimento del consenso popolare al FronteIslamico di Salvezza a far crollare il regime del Fln,accusato di corruzione ma sostenuto, per via del vitalegasdotto, dalle democrazie occidentali (le quali giusti-ficarono, nel 1991, l’annullamento del primo turno
elettorale vinto dal Fis, il colpo di stato militare e larepressione della sanguinaria rivolta terroristica con glistessi metodi usati quarant’anni prima dai francesi: v. leconfessioni del colonnello algerino Habib Souaidia (Lasale guerre, La Découverte, 2001). La battaglia diAlgeri è inoltre uno dei rarissimi film che fa compren-dere la “struttura” oggettiva della guerra (posta ingioco, calcolo e decisione strategica, incertezza). Èdunque prezioso per la storia militare e non a caso èstato proiettato e dibattuto nelle accademie militariamericane alla vigilia dell’invasione dell’Iraq (2003).
Le altre pellicole sulla guerra d’AlgeriaLa filmografia sulla guerra d’Algeria conta almeno 23film e 3 documentari (v. Films sur la guerre d’Algérie- Wikipédia, tratto da Guy Hennebelle, Mouny Berrahe Benjamin Stora, La Guerre d’Algérie à l’écran,Cinémaction, 1997. Cfr. pure A. Evans, Brassey’sGuide to War Films, 2000 e la tesi di laurea di YasminAbo-Loha, La guerra di Algeria nel cinema francese,Milano, Ucsc, 2002; entrambi consultabili nella nostrabiblioteca). I primi film, di intonazione fortemente anti-colonialista e perciò censurati dal governo francese,furono quelli di René Vautier (Une nation 1954;Algérie en flammes, 1958; Un peuple en marche,1963): un quarto film di questo regista controcorrente,del 1971 (Avoir 20 ans dans les Aurès), non fu distri-buito, benché premiato a Cannes. Il tema della guerraalgerina fu portato nelle sale cinematografiche solo nel1961, con due film e un documentario francesi. Le petitsoldat di Jean Luc Godard, censurato nel 1960 perchétrattava di diserzione e tortura (anche da parte del Fln),fu sdoganato nel 1963 e il tema della tortura ricorreanche in Muriel di Alain Resnais (1964), mentre laguerra compare sullo sfondo di Les parapluies deCherbourg (1964, di Jacques Demy, con CatherineDeneuve). Nel 1966, oltre al film di Pontecorvo, neuscirono altri due, uno algerino (Le Vent des Aurès diMohammed Lakhdar-Hamina), incentrato su unamadre alla ricerca del figlio arrestato dai francesi, e unoamericano (Né onore né gloria, 1966, di Mark Robson,tratto dal romanzo Les Centurions di Jean Lartéguy),


storia
93
un tipico film d’azione anni ‘60, condito di banalitàmoralistiche. La storia (di pura fantasia benché alcunipersonaggi siano ispirati a Yacef Saadi, Bigeard eAussaresses), è quella di un improbabile colonnellofrancese (Anthony Quinn) incaricato di arrestare unsuo ex-commilitone dell’Indocina (George Segal) chesi è ribellato contro l’abbandono dell’Algeria. La mora-le è rappresentata da un capitano (Alain Delon) cheaffianca il colonnello disapprovandone i metodi mache alla fine comprende il diritto dei popoli all’indipen-denza. In seguito il cinema francese ha affrontato laguerra d’Algeria solo come questione morale ed esclu-sivamente dal punto di vista soggettivo dei combatten-ti francesi. Se Le crabe-tambour (1977) e L’honneurd’un capitaine (1982), entrambi di Pierre Schoen-doeffer, La Trahison (2005, di Philippe Faucon) eL’ennemi intime (2007, di Florent Emilio Siri) rivaluta-no la memoria e le ragioni dei veterani, vi sono purstate nuove denunce della tortura e delle stragi. Ancoranel 1973 fu censurato R.A.S. (una coproduzione italo-franco-tunisina di Yves Boisset, che nel 1982 girò purel’analogo Allons z’enfants). Ma La Question di LaurentHeyenmann, basato su un’inchiesta del giornalistaHenri Alley, segnò una svolta nel 1977. Le testimo-nianze dei veterani sulla sale guerre abbondano in undocumentario televisivo del 2002 (L’ennemi intime, diPatrick Rotman); Escadrons de la mort, école françai-se (inchiesta giornalistica e poi film di Marie-MoniqueRobin) denuncia l’addestramento francese dei militariargentini; La nuit noire di Alain Tasma (2005) ricordala strage di manifestanti nordafricani uccisi a Parigidalla polizia il 17 ottobre 1961. La nemesi della tortu-ra è il tema di Mon colonel (Laurent Herbiet, 2006).
Gli altri film di Gillo Pontecorvo sulla guerra rivoluzionariaFratello del celebre fisico Bruno Pontecorvo, cresciutoin una famiglia benestante di Pisa, esule in Francia aseguito delle leggi razziali e formatosi nella culturadella Sinistra francese, comunista militante, GilloPontecorvo (1919-2006) trattò di guerra rivoluzionariaanche in altri due film, Queimada (1968, con Marlon
Brando) e Ogro (con Gian Maria Volonté). Il primo,pur essendo una storia di fantasia, traccia un quadropreciso e penetrante della storia dell’America Latina,con le vecchie potenze coloniali (Spagna e Portogallo)abilmente scalzate dall’Inghilterra in nome “dell’indi-pendenza” e della “libertà” (in realtà manovrandocome burattini la locale borghesia creola e usando glischiavi ribelli come carne da cannone). Ogro (“Orco”)racconta l’attentato all’ammiraglio spagnolo CarreroBlanco, designato da Franco come suo successore eucciso dai terroristi baschi dell’Eta nel 1973. La sce-neggiatura, basata su un libro che rivendicava ed esal-tava l’uccisione “dell’Orco” fascista, iniziò nel 1976,ma fu più volte rimaneggiata per le vicende politicheitaliane e le contraddizioni interne della Sinistra di fron-te alle Brigate Rosse. Pontecorvo ebbe anche un con-trasto con Ugo Pirro circa l’opportunità di discostarsidalle testimonianze dei terroristi per insinuare il sospet-to che fossero stati in realtà manovrati dai franchisti (lostesso argomento usato dal Pci per screditare le Br agliocchi delle proprie frange estremiste). Il rapimento el’uccisione di Aldo Moro da parte delle Br (1978) feceslittare al 1980 l’uscita del film. L’autrice del libro loaccusò di “moderatismo” per il pio sermone messo inbocca al capo terrorista (la violenza è giustificata con-tro la dittatura, mentre diventa fanatismo quando cisono gli strumenti democratici per realizzare i propriideali).
Bibliografia essenziale sulla guerra d’Algeria: AMIRI, Linda, La Bataillede France, la guerre d’Algérie en métropole, Robert Laffont, 2004. AUSSA-RESSES, Paul, La battaglia d’Algeri dei servizi speciali francesi 1955-57,Libreria Editrice Goriziana, 2007. BRANCHE, Raphaëlle, La Guerred’Algérie, une histoire apaisée ?, Points Seuil, 2005. DROZ, Bernard, Éve-lyne LEVER, Histoire de la guerre d’Algérie, Seuil, 1982 (2002). DUCHE-MIN, Jacques C., Histoire du FLN, La Table Ronde, 1962. HARBI,Mohammed, Les Archives de la Révolution algérienne, 1981. ID. etBenjamin STORA, La Guerre d’Algérie (1954-1994). La fin de l’amnésie,Robert Laffont, 2004. ID.et Gilbert MEYNIER, Le FLN, documents ethistoire 1954-1962, Paris, Fayard, 2004. HENISSART, Paul, OAS. L’ultimoanno dell’Algeria francese, Garzanti, 1970. HORNE, Alistair, Storia dellaguerra d’Algeria, Rizzoli, 1980*. MAUSS-COPEAUX, Claire, Appelés enAlgérie. La parole confisquée, Paris, Hachette-Littératures, 1999. ID., À tra-vers le viseur. Algérie 1955-1962, Lyon, éd. Aedelsa, 2003. MEYNIER,Gilbert, Histoire intérieure du FLN, Paris, Fayard, 2002. PERVILLE, Guy,Pour une histoire de la guerre d’Algérie, Picard, 2002. RIOUX, Jean-Pierre(dir), La Guerre d’Algérie et les Français, Fayard, 1990. STORA, Benjamin,Histoire de la guerre d’Algérie, 1954-1962, la Découverte, 1993. THE-NAULT, Sylvie, Histoire de la guerre d’indépendance algérienne,Flammarion, 2005. UBOLDI, Raffaello, Servizio proibito. Il primo librosulla guerra algerina, Einaudi, 1958.

la libreria

libreria
95
ANNIBALE,SCACCO MATTOAI ROMANI IN 45MILA MOSSE
Nessuno può negare di aver subìto, a scuola, il fascino diAnnibale, pur nella noia generale delle guerre puniche. Tutti ciricordiamo della traversata delle Alpi con gli elefanti, delle bat-taglie delle tre T (Ticino, Trebbia e Trasimeno), di Quinto FabioMassimo il Temporeggiatore, di Catone l’Uticense che insisteva
perché Cartagine dovesse essere distrutta e degli ozii di Capua. Ma i nostri ricor-di, in genere, si arenano lì, in superficie. Della sconfitta romana a Canne, unadelle più sanguinose tragedie della storia militare di tutti i tempi, in realtà ne sap-piamo poco o nulla. Dopo aver letto il libro di Bocchiola e Sartori non solo nesapremo molto di più, ma, attraverso l’analisi attenta degli Autori, avremo sco-perto un mondo che non immaginavamo e delle analogie con altri fatti della sto-ria che, senza questa guida, non ci saremmo mai azzardati ad affrontare.Sgombriamo subito il campo dagli accadimenti di quell’infausta giornata - era il2 agosto del 216 a.C - per concentrarci poi meglio sui commenti, le deduzioni,l’analisi e, a volte, anche le illazioni dei due ricercatori. Canne era all’epoca deifatti una città dell’Apulia, tra Canosa e il mare (a 12 km. da Barletta), sulla rivadestra dell’Ofanto e nei pressi dell’odierna Masseria di Canne. Il numero deicombattenti è, anche nel libro, oggetto di controverse supposizioni, basate sopratutto sulle testimonianze di testi antichi. Non è irrealistico pensare che Annibaleschierasse 40 - 45 mila uomini, in gran parte ispanici, galli, celti, liguri, numidie libici. Roma schierava otto legioni di cittadini romani e un buon numero diausiliarii italici, per un totale stimabile in 50 - 55 mila combattenti, agli ordinidei consoli Gaio Terenzio Marrone e Lucio Emilio Paolo, che assumevano il
di Mario Arpino
MASSIMO BOCCHIOLA MARCO SARTORI
Canne: descrizione di una battaglia
Mondadori pp 288 • euro 19
Il 2 agosto 216 a.C. è la data piùfunesta nella storia della Romarepubblicana. L’esercito romano,guidato dai consoli Emilio Paoloe Terenzio Varrone, si scontròcon quello cartaginese. Il libroparte dall’analisi delle condizio-ne economiche e politiche delbacino del mediterraneo. Dauna parte il melting pot di razzee commerci, dall’altra la deter-minazione politica di Roma.Bocchiola è traduttore di opereinglesi e ha pubblicato tre volu-mi di poesie. Sartori, studioso distoria romana, ha pubblicatodiversi saggi. Assieme aBocchiola nel 2005 ha pubblica-to il libro Teutoburgo.

Risk
96
comando a giorni alterni. Per quanto riguarda la stra-tegia degli schieramenti, Annibale schiera in avanti ilcentro, formato dai Galli e dalla fanteria celtica e ibe-rica, tenendo fermi alle due ali i fanti libici, mentrecon la cavalleria numida scompagina l’ala destranemica. Quando la fanteria romana, con gli uominimigliori in prima schiera, avanza e penetra con unacerta facilità nel centro dello schieramento cartagine-se, entra in azione la fanteria libica stringendo ai lati,con manovra a tenaglia, il cuneo dei romani, costrin-gendoli a combattere su due fronti. Inizia una carne-ficina che dura circa otto ore, con la cavalleria checompleta l’accerchiamento alle terga del cuneo.Muoiono in combattimento almeno 25 mila romani,tra i quali il console Emilio Paolo, e circa 10 milasono fatti prigionieri. Molti di questi, come si usava,vengono trucidati sul posto. Sui numeri, tuttavia, lecronache non concordano, né si fa cenno al numerodei caduti in campo cartaginese. Polibio parla di 4mila galli e 1.500 tra Ispani e Libi. Un km. a sud dellacittà antica una campagna di scavi ha messo in luceun sepolcreto esteso per 23 mila metri quadrati, conmucchi di scheletri fino a sei strati, e fosse rettango-lari di materiale non omogeneo. Manca qualsiasi cor-redo funebre e rare sono le armi, in quanto quelle deicaduti venivano riutilizzate dai nemici. Fin qui i fattie la dinamica dello scontro, di cui nel libro si ha unquadro organico solamente alla fine. D’altra parte, ilpregio di questa ricerca non sta tanto qui, quanto nelpaziente lavoro preparatorio attraverso il quale gliAutori, passo dopo passo, hanno la capacità di prepa-rare il lettore ad assaporare il film della battaglia fina-le, dopo aver compreso ambiente, abitudini, usanze,strategie, tattiche, motivazione e, infine, modo dicombattere dei contendenti. Il ricorso frequente, conampi brani, ai testi di Tito Livio e di Polibio ha ilmerito non solo di consentire confronti, ma soprattut-to di riportare gradevolmente indietro nel tempo colo-ro che hanno fatto studi classici. Molti lettori infattiricorderanno, spero con piacere, i tempi in cui eranoimpegnati sui banchi del liceo nelle versioni dal grecoe dal latino, con il vantaggio che qui le traduzioni
sono già belle e pronte per la consumazione. A volte,la vivacità del racconto e le precisione dei contorni ciricorda il film dei grandi eventi della prima guerramondiale, delle battagli di Verdun e della Marna, conquei feroci massacri davanti al filo spinato e allemitragliatrici che hanno decimato la popolazionemaschile di interi villaggi di ambo le parti. Solo che aCanne non c’erano carri, aerei, lanciafiamme e mitra-gliatrici. C’erano, come osservano gli Autori, sola-mente giavellotti, frecce, armi bianche e armi primiti-ve, zoccoli di cavalli e, nella ferocia della mischiacorpo a corpo, pietre, calci, morsi, polvere, sudore esangue. Eppure, sebbene con queste armi e per ladurata presunta di poche ore - la fatica fisica nonavrebbe potuto consentire tempi più lunghi - il contodelle vittime di questa battaglia è dello stesso ordinedi grandezza, e forse superiore, a quella dell’offensi-va britannica sulla Somme, al bombardamento diDresda o alla bomba su Hiroshima, e poi suNagasaki. C’è davvero da riflettere sulla ferocia delgenere umano e sulle sue attitudini.La struttura del libro è piuttosto complessa e articola-ta, dato l’ampio panorama storico e la profonditàdelle analisi che l’appassionata ricerca degli Autoripresenta al pubblico. In altre parole, per quanto la let-tura sia agevole e scorrevole, è un libro impegnativo,il cui contenuto non è apprezzabile nella sua interez-za con il semplice sfoglio delle pagine, come a voltesi fa. Bisogna leggerlo con metodo, dall’inizio allafine, e le sorprese non mancheranno. Magari sottoforma di cose, fatti, caratterizzazioni ed eventi che aitempi di scuola avevamo solo percepito, ma noncompreso, nè tanto meno assimilato. Questa è l’occa-sione buona. Il libro si compone di una bella introdu-zione e di un dotto prologo, dove si mettono a con-fronto le civiltà di Roma e Cartagine, e di cinqueparti, a loro volta suddivise i tre o quattro capitoli.Nella prima parte ci si sofferma sul lungo camminodel famiglia dei Barcidi - la prima guerra punica fucondotta da Amilcare Barca - prima di arrivare a uninevitabile confronto con Roma. È in questa parte chesi può comprendere il metodo di stima del numero dei

libreria
97
Cartaginesi, dei Romani e dei rispettivi alleati. È quiche si pone il quesito se contro Roma ci fosse tuttaCartagine, o solamente una famiglia accanita e nemi-ca giurata.Nella seconda parte si descrive, in modo ragionato, lacomposizione, le armi, le tattiche, il tipo di addestra-mento e lo spirito combattivo dei due eserciti. Mentrele legioni erano formate e comandate da veri cittadi-ni romani, con truppe ausiliarie italiche inquadrate aparte, ma comandate da ufficiali romani, l’esercitocartaginese era alquanto eterogeneo, con pochi vericartaginesi presenti nei ranghi. Nella terza parte sicerca di immedesimarsi nella battaglia antica, attra-verso l’immaginazione di quelli che dovevano esserei rumori, gli odori, l’ambiente, l’effetto degli agentiatmosferici e le tecniche di una battaglia a schiera-menti contrapposti in cui la massima distanza deicontendenti era quella del lancio del giavellotto. Solo
una trentina di metri, il seguito era corpo a corpo.Nella quarta parte c’è finalmente la descrizione dellabattaglia, con relative tecniche, tattiche, orrori e dina-mica sul terreno. La quinta parte è stand alone, a séstante, ma non è fuori dal libro. Riporta interessantivalutazioni sul “dopo Canne”, sui tre volti diAnnibale che gli antichi ci hanno tramandato, aseconda che sia visto dai Romani, dai Greci o daglistessi Punici. Completa la parte un capitolo sul miste-ro della morte di Annibale, cui i Romani non cesse-ranno mai di dare una caccia inesorabile. La biblio-grafia è molto ampia e un intelligente indice dei nomi- sono citate solo le persone, non i luoghi - agevolauna lettura che deve necessariamente essere attenta ededicata.Ma questo impegno che il libro richiede è un pregio,un segno della serietà dell’analisi e della ricerca. Nonè in alcun modo un difetto.
Ludovico Incisa di Camerana
Poche settimane fa la stampa spagnola annunciavala rimozione della statua del generale Franco, l’ul-
tima finora esposta nella piazza di un comune, tra l’al-tro governato dalla destra politica. Si confermavacosì, con questa decisione, il definitivo distacco dellaSpagna nel suo insieme da una storia del Novecentoche ha abbinato nel contempo la tragedia e la moder-nità, il volontarismo più generoso e l’eccidio più cru-dele. Si tratta forse di una delle poche iniziative pro-vinciali che ricordavano ancora l’immagine dei prota-gonisti di un secolo severo, del clima rovente e spie-tato dell’ultima guerra civile di Spagna, di una delleultime guerre globali europee, di un evento che hafortemente favorito la ripetizione, anche in Italia, diuno scontro interno nelle sue forme più aspre e crude-
li, ancora da registrare e discutere.L’eccellente bestseller dello storico inglese AntonyBeevor nella edizione 2006 del denso saggio TheBattle for Spain – The Spanish Civil War 1936-1939(Penguin Books - Londra), ha ricostruito una vicendastorica conflittuale ormai lontana, che si era infiam-mata con un’intensità tragica, imponendosi allaSpagna, ad un paese chiuso in sé stesso, rimasto fuoridalle correnti del mondo centrale europeo, ma capacein pieno secolo XIX di offrire una storia corredataancora oggi da reminiscenze spesso dimenticate,come, per esempio, quelle riguardanti il risvolto poli-tico e militare italiano della tragedia spagnola.Nell’insieme le immagini di allora non sono più vali-de, non esistono più collegamenti commemorativifrequenti, le bandiere stanno negli armadi, ma il pas-sato, per quanto allontanato, per quanto imbarazzante
L’ULTIMA STATUA DI FRANCISCO FRANCOLa strana alleanza italo-spagnola
degli anni ‘30 vista da uno storico inglese

Risk
98
e nebbioso, risponde alle tesi di Beevorche non nega l’efficacia sul campo del-l’intervento italiano, corretto dal predo-minante contesto spagnolo, ma nongiunge a rivelare una spaccatura difondo tra falangismo e fascismo, com-patibili anche se diversi, anche secomunque si insiste su un’esaltazionecostante del primo: “il falangismo sidistingue dal nazismo e dal fascismoper un profondo misticismo”, il falangi-sta ideale è “mezzo monaco, mezzosoldato”. I militari insorti si distingue-ranno dalla parte opposta strappando alnemico quasi ogni volta l’iniziativa.Ma al principio il movimento militaresembra fallito: quando scatta ufficial-mente l’allarme, il 18 luglio 1936,pochi comandanti ordinano immediata-mente lo stato di guerra. Le adesioni sidecideranno nelle giornate successive.A mano armata i colonnelli liquidano igenerali incerti in Marocco, a Sivigliain Andalusia, a Salamanca e Valladolidnel Centro, in Castiglia, a Saragozza inAragona, a Pamplona in Navarra, men-tre a furor di popolo la sinistra conqui-sta la capitale Madrid e la capitale del-l’industria Barcellona, capitale dellaCatalogna. I prescelti si mettono agliordini del capo, il generale Franco, arri-vato in Marocco in aereo dalle Canariee pronto ad eliminare oppositori edincerti. La stessa tragica scena si ripete-rà nella terra ferma con la liquidazionedei generali riluttanti, sostituiti da gio-vani colonnelli e capitani nazionalisti,quasi tutti con un’esperienza africana.L’avviamento di una guerra organicacomincia con l’intervento, su richiestadegli emissari nazionalisti spagnoli, deldittatore italiano, Mussolini, che di-
sporrà l’invio di una forza aerea italia-na, da impiegare per la protezione delpassaggio dello Stretto di Gibilterra,permettendo ai contingenti dell’eserci-to coloniale spagnolo, minacciati dauna flotta repubblicana potente, di var-care lo stretto di mare che separa le duesponde. Il passaggio già avviene sottola protezione degli aerei italiani (VediAldo Santamaria, Operazione Spagna,1936-1939, Volpe editore, Roma 1965,pp.10-11).All’intervento aereo italiano si aggiun-gerà altresì un analogo intervento tede-sco, con gli stessi obbiettivi e con rap-porti diretti con il comando spagnoloimpersonato dal generale Franco, cheassumerà di fatto il comando supremodelle forze nazionaliste e si servirà del-l’aiuto degli aerei italiani e tedeschi percostringere le navi repubblicane, privedegli ufficiali di carriera, eliminati daequipaggi ammutinati, a ritirarsi dallostretto con gravi perdite. Seguirà losbarco nella terraferma dell’esercito delSud, che si muoverà rapidamente nel-l’interno con le sue colonne e i suoi gio-vani comandanti, tra l’Andalusia eMadrid. Guidato dai giovani colonnelli,aiutato alle frontiere dai militari porto-ghesi l’esercito del Sud forma un bloc-co militarizzato, la cui capacità combat-tiva era stata approvata dall’addestra-mento clandestino in Italia di giovaniufficiali spagnoli, mentre un magnateJosé Luis Oriol si era procurato inBelgio gli armamenti necessari.I comandanti dell’esercito del Sud pro-seguiranno nell’occupazione di zone diantica povertà. In diverse di esse scop-pia una guerra sociale che include anchei presidi della Guardia civile, sotto la
ANTONY BEEVOR
The Battle for Spain The Spanish Civil War1936-1939
Penguin Bookspp. 64 • £ 12,99
La guerra civile spagnolaaveva attratto da tutto ilmondo sia liberali che socia-listi per sostenere la causacontro il governo diFrancisco Franco. Si trasfor-mò in un conflitto pienod’atrocità e caratterizzato dalgenocidio politico. L’autorene racconta la genesi dalcolpo di stato del giugno del1936 ai «selvaggi combatti-menti» dei tre anni successi-vi, compresa la distruzione diGuernica, da parte dellaLegione Condor.. Russi, ita-liani e tedeschi stavano met-tendo alla prova i loro appa-rati militari che avrebbero poiutilizzato durante il Secondoconflitto mondiale. Lo scon-tro si concluse con la disa-strosa sconfitta dei repubbli-cani filo-comunisti. Beevoranalizza e svela il complessointreccio politico tra le forzein campo, spesso anche ilegami e la natura di equilibrilocali che determinarono ladeflagrazioni del conflitto.

libreria
99
mira di una popolazione insorta contro il potere patro-nale. Saranno sterminate intere famiglie di proprieta-ri e amministratori. D’altra parte le colonne naziona-liste non perderanno tempo nella reazione ad unarivoluzione, quella dei contadini, isolata e senza appi-gli robusti. Comunque la lotta di classe verrà termina-ta a forza con il rapido sterminio degli elementi piùpericolosi o presunti tali. La resistenza del presidiodell’Alcazar di Toledo diventerà, una volta liberato,l’espressione di un’antica cavalleria. D’altra parte lavicinanza con Madrid non aiuterà la fine del conflitto.Le iniziative al Nord, abitato da un popolo relativa-mente prospero, faranno campo al generale EmilioMola che ha organizzato il movimento insurrezionalein concomitanza con Franco. Mola porrà subito difronte ai capi militari dipendenti ma esitanti un dilem-ma, «l’adesione o la morte». Il problema della sceltaverrà esposto a tutti i militari in servizio che in mag-gioranza aderiranno al Movimento e indosseranno ledivise tradizionali. Viceversa non tutti i generali, -come osserva Beevor - riescono a raggruppare le pro-prie truppe e a dar luogo a nuclei compatti.Riceveranno però un aiuto finanziario dalla burocra-zia pubblica dei grandi centri del Nord, spaventata daidisordini esterni, aggredita dalle masse in subbuglio,rifugiata all’estero in Francia e in Inghilterra. La pre-senza sempre maggiore in terraferma di forze militariterrestri ed aeree, italiane e tedesche, non influirà suipiani di Franco, che con una voluta lentezza adopere-rà i suoi eserciti, spagnoli od esteri, secondo le propriedecisioni e secondo una tecnica diretta essenzialmen-te a provocare lo sterminio degli avversari, mentre daparte italiana si mira a creare, per la via militare unlegame politico-economico permanente con unaSpagna, che invece, si preoccupa soprattutto di man-tenere la propria libertà d’azione.Si spiega così come il ritardo delle forze italo-spagno-le nella conquista del porto di Malaga, voluta con insi-stenza dagli italiani e soprattutto dai proprietari loca-li, dai rappresentanti della grande e media proprietà,vittima della spinta rivoluzionaria, rallenterà per vole-re di Franco la marcia delle forze italo-spagnole verso
il Nord. Accadrà così che il comando italiano quandocercherà di sfondare per le vie interne la meta dellacapitale repubblicana, Madrid, si troverà di fronte unesercito militarmente sostenuto da missioni sovieti-che. In verità, il tentativo delle divisioni italiane diaccelerare con tutte le forze la fine del conflitto non sisvilupperà per mancanza di un appoggio serio dei rin-forzi dell’esercito franchista. Ciò nonostante verrannoimpegnate quattro divisioni italiane, la Fiamme Nere,la Frecce nere, la Dio lo vuole, la Littorio, comanda-te dal Generale Roatta, con l’aggiunta di mezzi di tra-sporto e carri armati leggeri e la protezione di 32aerei, come descrive con accurata precisione Beevor.Parteciperanno alla battaglia i fuorusciti antifascistiche con altoparlanti inciteranno alla diserzione i sol-dati italiani dell’esercito e della milizia. Nel contem-po le condizioni degli aeroporti italo-spagnoli rendo-no impossibile, a favore delle divisioni italiane, l’in-tervento degli aerei italiani. Tuttavia i comandanti ita-liani non avrebbero dato il giusto peso al rafforzamen-to continuo dell’apparato avversario ne’ alla situazio-ne atmosferica.Il tentativo del corpo di spedizione italiano di accele-rare la fine del conflitto non riesce insomma per lamancanza di un appoggio consistente da parte spa-gnola, non richiesto, peraltro, da parte italiana. Daallora il Corpo militare italiano avanzerà al passo pru-dente di Franco. Come primo successo la crisi internadelle forze repubblicane del Nord Est porterà all’oc-cupazione della Spagna del Nord da parte delle fante-rie spagnole ed italiane, che si distingueranno nellapressa della capitale del Paese basco, Bilbao, e suc-cessivamente nello sfondamento del Passo delloScudo, la via del Mare Cantabrico, ricordo immemo-rabile di un criterio riservato, dopo la battaglia, ainumerosi caduti. Il ridimensionamento delle forze ita-liane si verificherà grazie, inoltre, all’incorporazionedegli ex prigionieri dell’esercito repubblicano nel-l’esercito di Franco, avvenuta senza complessi. Nonmancheranno risvolti comici: un futuro celebre poeta,capitano dell’esercito basco, costretto ad arruolarsicome sergente nell’esercito franchista, dopo la cattu-

Risk
100
ra si troverà nel reparto a lui assegnato tra gli stessisoldati, reduci delle sue stesse vicende, anche lorosotto la nuova bandiera. Nel contempo il Kremlinocerca di estendere alla Spagna repubblicana quellastessa mania politica epurativa, seguita ostinatamenteda Stalin applicandola anche ai capi politici spagnolicivili e militari, ma da essi dignitosamente respinta.Le truppe italiane, dopo la fine dei combattimentidecisivi, verranno impiegate nell’erosione di quantoancora rimaneva dell’esercito repubblicano, etnica-mente ancora consistente, ma portata verso l’autodi-struzione, con la generalizzazione degli eccidi, didestra e di sinistra, indignando la celebre intellettualefrancese Simone Weil, per la fucilazione di un ragaz-zo di 15 anni che rifiuta di passare con i rossi per aversalva la vita e verrà fucilato. Il comportamento finaledell’esercito volontario verrà lodato da Beevor: “Gliitaliani stanno combattendo molto meglio che in altrecircostanze” (p.325). Del resto soltanto a due italianie non agli stranieri verrà concessa da Franco la mas-sima decorazione spagnola, la Laureata: il sergentemaggiore Renato Zanardo, sopravvissuto (Santa-maria, p.104-105) il tenente di cavalleria principeGiuseppe Borghese, caduto (Santamaria, p.155). È daaggiungere il tenente colonnello di Stato Maggiore,
Giorgio Morpurgo, che affronta in assalto suicida lepostazioni nemiche (Santamaria, p.105).La presenza italiana durerà fino alla resa finale del-l’esercito repubblicano. Successivamente l’Italia inapparenza non riuscirà ad agganciare politicamente laSpagna. Economicamente sarà più fortunata. Comecompenso dell’aiuto italiano il governo spagnolooffrirà un forte appoggio alla penetrazione industrialeitaliana, in particolare alle grandi imprese, dalla Fiatalla Montecatini, all’Olivetti. Sul piano militare anchei personaggi più significativi della sinistra italianacome il socialista Pietro Nenni mantennero un rap-porto di convenienza con i governanti spagnoli dura-ne il regime franchista. La nostra sconfitta politica emilitare nella terza guerra mondiale non ostacolò laripresa di legami reciproci di collaborazione tra Italiae Spagna in campo militare. Nelle cerimonie di galagli ufficiali italiani ostentavano le decorazioni spa-gnole e viceversa. La marina italiana scambiavaperiodicamente visita con la marina spagnola.Quali i rapporti oggi con l’Italia? Con la Spagna dinotte quelli di veterani brontoloni, di giorno di invi-dia. Per le due parti un quadro comune di dispetto conFrancia e Germania e un forte senso di fraternità, dif-ficilmente intaccato anche sul piano militare.
Andrea Tani
La prima grande questione economica dei nostri gior-ni è se e come il mondo riuscirà a superare la crisi in
atto. La seconda è quale sarà il contributo che a questoprocesso daranno le tre grandi economie emerse ed emer-genti dell’Asia, Giappone, Cina e India. Oggi esse sonoimpegnate in una loro corsa verso la leadership planeta-ria e/o regionale che, come principale effetto socio-politi-co, dovrebbe far fuoriuscire miliardi di uomini dal sotto-
sviluppo, direttamente e come imitazione dei eventualisuccessi da parte di altri. Un altro importante effettoriguarda lo spostamento degli equilibri geopolitici delmondo dall’Occidente all’Oriente, e l’eventuale competi-zione che questo processo innescherà fra est e ovest,intendendo con quest’ultimo il mondo euroatlantico pro-priamente detto o quello allargato, comprendente cioè iPaesi dell’Asia-Pacifico occidentali e completamenteoccidentalizzati: il Giappone, in primis, parte dell’Aseane - da verificare quando e quanto - l’India.
TUTTE LE BATTAGLIE DELL’ORIENTEGiappone, Cina e India mirano
a una leadership planetaria (e tramano nell’ombra)

libreria
101
Innumerevoli discussioni, ricerche e ana-lisi sono stati prodotti su questi argomen-ti, che danno corpo ai i best seller più ven-duti e dibattuti della saggistica contempo-ranea, almeno fino alla comparsa diObama e della crisi globalizzata. Nessunoo quasi nessuno si è finora occupato di unargomento cruciale in queste nuove pro-spettive, ovvero della più o meno classicacompetizione di potenza che si sta deline-ando fra gli attori principali del risveglioasiatico, i citati Cina, Giappone e India.Essi non dovrebbero diventare solo i futu-ri numeri uno, tre e quattro dell’economiamondiale (il secondo essendo presumibil-mente gli Stati Uniti) ma anche i maggio-ri egemoni internazionali, in un ordine piùo meno corrispondente a quello economi-co (anche l’attuale leadership militare etecnologica degli Stati Uniti svanirà - sesvanirà - molto più lentamente di quellaeconomica). Asia contro Asia di Bill Em-mott, uno dei più famosi e autorevoli gior-nalisti contemporanei, caporedattoredell’Economist dal 1993 al 2006, comin-cia a colmare questa lacuna, e lo fa con ilmestiere di un grande professionista, chesa come presentare argomenti complessial grande pubblico tenendo avvinta l’at-tenzione come si trattasse di un thriller, econ l’autorità di un vero esperto di Asia.Soprattutto del Giappone, che Emmottconosce molto bene anche per avervi vis-suto a lungo. Suo è The sun also sets uncelebre e profetico saggio sulla crisi nip-ponica pubblicato nei primi anni Novanta,in anticipo sugli eventi. Con un tale curriculum occorre forse chia-rire il perché di quel “comincia a colmare”che può sembrare un po’ riduttivo, anchese non vuole esserlo. Il fatto è che Emmottè bravissimo nel tratteggiare i singoli casi
dei tre Paesi; meno - o meglio forse non inmodo completamente esauriente - neldelineare le interazioni strategiche possi-bili e il presumibile districarsi dei varisoggetti nella giungla risultante. Ma sitratta di un tema assai complesso sul qualeprobabilmente neanche i diretti interessatihanno le idee chiare, dato l’enorme nume-ro di variabili in gioco e la fluttuazionecontinua degli elementi al contorno. Ilfatto, comunque, che un personaggiodallo spessore di Emmott si cimenti conun esercizio che dovrà sempre più essereapprofondito, se si vorrà dare sostanzaagli scenari di riferimento che condizione-ranno sempre più quel divenire economi-co che pare sia diventato l’unica stellapolare del previsionismo internazionale,fa capire l’importanza e l’urgenza deltema.Lo scenario che scaturisce da Asia controAsia è quello di grandi opportunità e gran-di pericoli. Quelli economici sono più omeno noti: la Cina dovrà adattarsi ad unosviluppo più lento di quello - vertiginoso-conosciuto fino alla crisi che si è avviatal’estate scorsa, e la cosa potrebbe avereripercussioni socio-politiche tali da mette-re in pericolo la stabilità della RepubblicaPopolare. Si aggiunga a ciò il dazio chePechino pagherà inevitabilmente alla cor-rezione dei disastri ambientali che tale svi-luppo ha provocato, non più accettabili eaccettati in ambito interno e internaziona-le. Il Giappone affronta un futuro impe-gnativo, competitivo e turbolento con unapopolazione sempre più vecchia, e non viè esperienza nella storia di come si possagestire una situazione demograficamentetanto al limite (l’Italia non è troppo lonta-na dalla sua situazione, ma può usufruiredi una immigrazione regionale che il
BILL EMMOTT
Asia contro AsiaCina, India, Giappone e la nuova economia del potere
Rizzolipp. 393 • euro 19
Il vecchio caporedattoredell’Economist è tornato sull’ar-gomento di un’altro suo bestseller: “The Sun also Sets”.Oggi rinnova con nuove analisiil confronto tra Washington e letre potenze asiatiche più impor-tanti, Cina, India e Giappone.Una storia tutta asiatica chenon parla solo di economia, disviluppo emergente e di merca-ti, ma anche di potere. «Entrodieci anni l’india potrebbe avereun’economia due volte quelladel suo vecchio dominatorecoloniale. L’Inghilterra», hascritto “l’Indipendent” nellarecensione al libro. Se il XIXsecolo è stato europeo e il XX èstato americano, secondo letesi di Emmot il XXI sarà asiati-co. E la nuova amministrazioneObama ne ha preso atto col lavisita del suo segretario diStato, Hillary Clinton che l’hamessa in cima all’agenda delprimo tour estero. Rivalità è untermine che mescola duevalenze. La prima è quella dipericolo, mentre la secondarichiama alle opportunità. Ilpericolo, per l’autore risiede nelpassaggio storico che attraver-sa l’Asia, paragonata a quelloche l’Europa visse all’inizio delNovecento. La speranza è chela risposta sia diversa avendoimparato dagli errori altrui. Perl’Europa l’errore più grande fula Prima guerra mondiale.

Risk
102
Giappone non ha a disposizione e che forse non può sop-portare, data l’assoluta omogeneità etnica e culturale delpaese). L’India, dal canto suo, deve risolvere la sua fragi-lità nel campo delle infrastrutture, delle burocrazie e del-l’educazione primaria e secondaria - tutte inadeguate inmodo abissale alle dimensioni, dinamiche e necessità diun colosso in lievitazione di potenza - nonché gestire lasua estrema diversificazione culturale e confessionale, ilmotivo principale del suo fascino ma nel contempo ilmaggiore punto interrogativo sul suo futuro.Sono le incertezze geopolitiche e strategiche a dar tutta-via corpo alle nubi più minacciose che sovrastano i trePaesi Mentre le difficoltà e le competizioni portano ingenere all’ottimizzazione dei processi economici, e que-sto ha riverberazioni positive sulla vita degli stati - com-presi i tre in esame, che hanno fatto grandi progressiallorchè si sono esposti ai venti impetuosi della concor-renza - ciò non accade nei rapporti politici e strategici.Quando non funzionano essi tendono a complicare o arendere impossibili gli sviluppi favorevoli in altri ambiti. L’esempio storico più classico di tale maligna interferen-za è quello della Prima Guerra Mondiale, determinata damiopie e malgoverno di fenomeni politici che riuscironoa distruggere una crescente era di prosperità economicache aveva avuto in Europa il suo centro di gravità plane-tario, e con essa l’egemonia europea sul mondo.Commentando l’esempio, l’autore si augura chenell’Asia del 21° secolo non succeda la stessa cosa. Lepremesse sono, da un lato, fauste - nel senso che in gene-re dalla storia si impara qualcosa e se ne fa tesoro, anchese raramente la medesima si ripete negli stessi termini - edall’altro inquietanti: fra i tre Paesi esistono oggi tali etanti contenziosi da indurre forti motivi di preoccupazio-ne. Si va dall’instabilità nella penisola coreana, a Taiwan(antica colonia giapponese ancora infatuata dei suoi anti-chi padroni), ai contenziosi territoriali marittimi fra Cinae Giappone, a quelli fra India e Cina sul Trans Himalaiae sul Tibet, alla competizione di tutti e tre sulle fonti e lerotte dell’energia sia marittime (dal medio Oriente e daipossibili off shore nel Mar Cinese ) che continentali (dallaRussia), alla pericolosità oggettiva di uno degli alleatimaggiori di Pechino - nonché avversario di New Delhi -
come il Pakistan, semifallito, senza una vera guida, inparte fiancheggiatore del terrorismo e nel contemporobustamente nucleare.Emmott si sofferma e analizza particolarmente il proble-ma del Tibet che è molto più importante, serio, e gravidodi conseguenze di quanto sia comunemente percepito inOccidente, per una serie di motivi. Il primo è che per laCina si tratta di un argomento strategicamente primario.Il Tibet si identifica con quello che sono le Alpi per ilNord Italia e il Giordano per Israele: il crinale strategicodal quale si controlla l’accesso alla Repubblica Popolaree sul quale lo si interdice, e la fonte primaria di acquadella Cina, ovvero di un Paese che ne ha sempre di meno.Per il Tibet, la Cina sarebbe disposta a tutto, anche a unarepressione molto dura, ancora di più di quanto si è vistola scorsa estate. Persino ad una guerra. Il fatto è che i motidi agosto sono stati secondo l’autore solo un preludio diquello che verrà, perché se Pechino non può rinunciare alTibet, i tibetani detestano la dominazione cinese. Inaggiunta, il Dalai Lama ha 73 anni e quando morirà lasua successione prevede alcune procedure che i cinesihanno profondamente snaturato, contro la volontà degliinteressati. Come se non bastasse, lo stesso Dalai Lamaha dichiarato che non sarà possibile la sua reincarnazio-ne nel suo successore in una terra sotto controllo cinese.E quindi i suoi seguaci non accetteranno nessuna sceltaoperata in Tibet sotto il controllo cinese. Il libro analizzaaltre complicazioni ulteriori di cui facciamo grazia al let-tore. Si possono immaginare le prospettive complessivedi quello che succederà quando l’anagrafe farà il suocorso.Insomma il Tibet è una bomba a orologeria e non quelfenomeno un po’ incomprensibile e pittoresco che appa-re ai non specialisti, almeno in Europa. Quando scoppie-rà, le sue schegge coinvolgeranno con tutta probabilitàl’India, braccio secolare dell’intera tematica buddista. Sesi sentirà sufficientemente forte, Delhi potrebbe reagirein un modo ben più energico di quello che ha mostratodurante le passate Olimpiadi. Situazioni e problemi analoghi seppur qualitativamentediversi si trovano in larga parte delle questioni strategicheche interessano i tre Paesi, i quali stanno tutti più o meno

libreria
103
potenziando il loro strumento militare. Esplicitamente eassertivamente la Cina e l’India - la prima anche in fun-zione antiamericana - in modo molto discreto ma assolu-tamente efficace il Giappone, il quale, al di là delle suepruderie costituzionali, ha le più sofisticate e credibiliforze armate dell’Asia, soprattutto nel settore aeronavalee naturalmente convenzionale. Ci vuole molto menotempo ed energie a riscrivere qualche paragrafo di unaCarta Fondamentale di uno stato che a potenziale le sueforze armate. Emmott sostiene che non si tratta ancora diuna vera e propria corsa agli armamenti, ma della stipulamultipla di una polizza di assicurazione contro gli incertidel futuro, anche se la distinzione è piuttosto capziosa.Ogni corsa agli armamenti è volta a ottimizzare le poliz-ze di assicurazioni strategiche dei contraenti. Non c’èlimite ai premi da concordare. Se si parametrizzassero gliincrementi del procurement militare dei tre Paesi con-frontandoli con gli analoghi delle Grandi Potenze euro-
pee alla vigilia della Grande Guerra, o durante la GuerraFredda, si otterrebbero probabilmente curve analoghe.L’esempio della Guerra Fredda è forse il più aderente aquesto caso: Cina, India e Giappone avvertono chepotrebbero essere alla vigilia di una protratta fase di con-flittualità dalla temperatura ancora indefinibile, e si equi-paggiano di conseguenza. Non è l’unica prospettiva chepuò essere individuata e che lo stesso Autore avanza: selo sviluppo socio-economico dei tre Paesi andrà per ilverso giusto, conferendo alla Cina la co-leadership plane-taria alla quale aspira (assieme agli Usa), all’India laragionevole efficienza senza la quale non potrà sopravvi-vere in un mondo così competitivo come quello che siconfigura e al Giappone la sicurezza necessaria per com-pensare le sue ristrettezze e vulnerabilità, può darsi che itre collaboreranno in Asia-Pacifico e altrove per rendereil mondo un posto più ragionevole. Ma è tutt’altro chescontato ed è bene che l’Occidente prenda atto.
Mauro Canali
Kemal Mustafà, divenuto poi Kemal Pascia, einfine Kemal Ataturk, «il padre dei turchi», è
a tutti gli effetti il fondatore della Turchia moderna,il traghettatore che ha condotto il popolo turcofuori dal medioevo accompagnandone il passaggionella società contemporanea. Anche se si trattò diuna trasformazione brusca ma di breve durata - daun regime teocratico a uno stato laico in poco menodi un decennio - tuttavia lo spirito riformatore diAtaturk è ormai così radicato nella società turcache le forze politiche e sociali laiche e anti-tradi-zionaliste si appellano ancora a lui quando si trattadi opporsi alle ricorrenti spinte tradizionaliste eanti-moderniste della componente religiosa attual-
mente al governo del Paese. Una componente reli-giosa che tuttavia esercita con molta prudenza ilsuo primato politico, consapevole appunto di quan-to sia profondamente penetrata nella coscienza deiturchi la visione laicista di Ataturk. Più volte messealla prova, le forze tradizionaliste si sono guardatebene dallo sfidarla apertamente. Corre nella socie-tà turca un’invisibile linea di demarcazione travalori laici e teocratici, che è ancora quella vigoro-samente tracciata da Ataturk tra il 1924 e il 1929.Per i tradizionalisti essa rappresenta una vera e pro-pria barriera, valicata la quale essi sanno che ilPaese rischierebbe di frantumarsi. A guardia diquesta linea di confine vi è l’icona del “padre deiturchi”, e vi sono soprattutto le riforme da lui rea-lizzate negli anni Venti e Trenta. La storiografia
IL VOLTO AUTORITARIO DELLA LAICITÀCome un moderno “principe” edificò lo Stato nazionale unitario,
traghettando la Turchia dall’Asia all’Europa

Risk
104
anglo-sassone ha scritto sulla Turchiamoderna pagine interessanti e percerti versi definitive. Sono molti glistudiosi inglesi e americani che sisono impegnati a studiare le vicendeturche, a partire dalla rivoluzione dei“Giovani Turchi” del 1908, vero eproprio atto di nascita della modernaTurchia. Sono ormai considerati deipiccoli classici i lavori dei due Shaw,Stanford e Ezel Kural, quelli diSonyel sulla diplomazia kemalista, glistudi sulla storia economica turca diIssawi, i lavori sui “Giovani Turchi”di Hanioglu e Kansu, e, infine, l’im-portante biografia di Ataturk scritta daAndrew Mango, che seppure uscita direcente si è rapidamente impostacome un punto di riferimento indi-spensabile per gli studiosi del grandestatista turco. In Italia, gli studi sullaTurchia moderna e su Kemal si pre-sentano, fatta salva qualche eccezio-ne, sporadici e lacunosi. Un certointeresse per la Turchia moderna siebbe durante il ventennio fascista, magli studiosi fascisti osservarono ilfenomeno kemalista, - un regime chesi presentava autoritario e insiememodernizzatore - con una sorta dilente deformante, quasi a voler affer-mare nell’esperimento kemalista lapresenza d’una consapevole ispirazio-ne al regime mussoliniano. Spunti delgenere è possibile, ad esempio,coglierli negli studi di Cornelio DiMarzio, di Amedeo Giannini e diEttore Anchieri. Dopo la caduta delfascismo, nella seconda metà delnovecento, sembrò quasi che le vicen-de politiche di questo importantePaese mediterraneo cessassero d’inte-
ressare i nostri studiosi di storia, conl’unica eccezione, almeno per quantoriguarda l’ultimo ventennio, di FabioL. Grassi, che ha dedicato alla nascitae agli sviluppi politici della Turchiamoderna la sua intera produzionescientifica. In questo quasi vuoto sto-riografico non ci deve allora sorpren-dere il fiorire attorno alla Turchia dileggende e pregiudizi, ogni volta chele vicende politiche e diplomatichespingono Ankara sul proscenio dellapolitica internazionale. Il lavoro diFabio L. Grassi, (Ataturk, SalernoEditrice), che ora vede la luce, con-sente finalmente anche al lettore ita-liano di conoscere la vicenda politica,per molti versi straordinaria, diAtaturk. Di un lavoro così esaurientesi cominciava a sentire la mancanza,soprattutto in quest’ultimo periodoche la nazione turca è di nuovo salita,per molti e complessi motivi, non perultimo il suo futuro ingressonell’Unione Europea, agli onori dellacronaca politica e diplomatica. Lostudio di Grassi, punto d’arrivo di unlaborioso ventennio di studi di altoprofilo, offre uno spaccato chiaro edesaustivo del ruolo decisivo svolto dalgrande uomo politico turco nella for-mazione dello stato moderno turco;un lavoro che ha il pregio di basarsi sufonti bibliografiche e archivisticheturche. Grassi esamina la lenta ascesapolitica di Ataturk, che, sebbene risul-tasse sin dall’inizio tra i più autorevo-li leader del partito dei “GiovaniTurchi”, incontrò non poche resisten-ze per imporsi ai vertici di quella clas-se dirigente rivoluzionaria che nel1908 s’era impadronita del potere. A
FABIO L. GRASSI
Ataturk
Salerno Editricepp.448 • euro 29
Poco più di settant’anni fa, il10 novembre 1938, moriva aIstanbul Kemal Atatürk, ilfondatore della modernaTurchia. Da anni si discutesulla collocazione ideale,politica e culturale, di quelPaese, discussione intensifi-catasi dal momento in cui,non troppo tempo fa, sicominciò a valutare la possi-bilità d’ingresso nell’UnioneEuropea. Non furono pochiallora, e non sono pochissi-mi neppure oggi, coloro chesostennero il carattere asia-tico della Turchia, accam-pando anche la motivazione- che ha, peraltro, seri fon-damenti - di un non sempreadeguato standard di rispet-to dei diritti umani. A riper-correre la biografia di questostraordinario personaggio, cisi rende facilmente contoche non soltanto la Turchiaappartiene pienamente allastoria e alla cultura europea,ma altresì che, in fondo,l’autoritarismo, il militarismoe la persecuzione dei curdi,per esempio, rinviano diret-tamente ad Atatürk. Chedunque, nel bene e nelmale, è in larga parte ciòche la Turchia è oggi.

libreria
105
frenare le ambizioni di Kemal vi era l’ostilità deimassimi dirigenti politici raccolti attorno a HenverPascia, e fu solo grazie all’impresa di Gallipoli cheegli infine riuscì a emergere e a imporre la propriapersonalità. La difesa vittoriosa da lui condottacontro lo sbarco delle truppe inglesi a Gallipoli, ela cruenta battaglia con cui le inchiodò sulla picco-la striscia di terra che si estende nei Dardanelli, lagenialità strategica e anche la fortuna messe inmostra, resero il giovane ufficiale di Saloniccoimprovvisamente un eroe nazionale. Eppure dovet-tero passare ancora diversi anni prima di poterloveder trionfante a Istanbul. I massimi dirigenti delpartito dei Giovani Turchi ne temevano il carismanaturale, la grande capacità persuasiva, l’abilità nelmuoversi negli ambienti politici, e lo relegarono inSiria e poi in Iraq, dove tuttavia egli colse semprel’occasione buona per mettersi in luce, mostrandoin particolari situazioni anche notevoli doti diplo-matiche. Il suo momento giunse con la sconfittamilitare e la conseguente disgregazione del-l’Impero ottomano. In tali drammatiche circostan-ze, Kemal dimostrò di essere tra i pochi a posse-dere lungimiranza e doti politiche di grande stati-sta, cioè di comprendere l’inutilità di una battagliaa difesa di una ormai improbabile conservazionedell’integrità dei territori del vecchio impero,mostrandosi nel contempo deciso a battersi convigore e risolutezza per la conservazione dell’inte-grità dei territori abitati dalle popolazioni turche.Fu l’artefice di quel Patto Nazionale che già deli-neava le linee portanti del futuro stato nazionaleturco: sì al distacco e all’indipendenza dei territoriabitati dalle popolazioni arabe, ma difesa inflessi-bile dell’integrità dei territori a maggioranza turca,cioè Anatolia e Tracia europea. In realtà Kemal simuoveva secondo i dettami del dodicesimo deiquattordici punti di Woodrow Wilson, con cui siauspicava «la libertà e l’indipendenza delle nazio-ni soggette ai turchi ma anche la sopravvivenzadella sovranità turca in Turchia». Fu ancora lui,Kemal Pascia, dopo aver rianimato il movimento
nazionalista turco, molto depresso all’indomanidella sconfitta militare, a minacciare di volgeredecisamente le armi anche contro le potenze vitto-riose intente a progettare, in contrasto con lo spiri-to del wilsonismo che a parole garantivano di volerrispettare, la spartizione anche dei territori anatoli-ci, sotto l’ipocrita forma delle cosiddette sfered’influenza. Guidando le truppe raccolte sotto ilsuo comando egli rigetterà a mare le truppe grechesbarcate a Smirne, e stringerà in una morsa le trup-pe inglesi, francesi e italiane fatte nel frattemposbarcare a Istanbul a garanzia dell’attuazione deltrattato di Sevres, che rappresentava il pesantepedaggio che avrebbe dovuto pagare la Turchia perla sconfitta subita, e che avrebbe significato difatto la fine del sogno di una rinascita turca dallerovine dell’impero ottomano. In questi frangentiKemal Pascia si guadagnò la venerazione dellepopolazioni turche, poiché riuscì, alternandominacce di guerra e iniziative diplomatiche, a otte-nere, con l’armistizio di Mudanya, il riconosci-mento anglo-franco-italiano del diritto all’esisten-za della nuova nazione turca. Si apriva pertanto laconcreta prospettiva di giungere a un definitivotrattato di pace. Si trattò del primo grande trionfodiplomatico di Kemal, e del riconoscimento daparte occidentale del suo ruolo di leader indiscus-so della nuova Turchia. I passi successivi e quasiinevitabili furono l’abbattimento del potere del sul-tano, la sua cacciata in esilio, e la fondazione dellarepubblica turca, proclamata ufficialmente il 29ottobre 1923, a un mese circa dall’apertura dellaconferenza di Losanna, riunita per discutere con laTurchia le condizioni per la firma di un trattato dipace. A Losanna Kemal inviò in veste di negozia-tore uno dei suoi più abili e fidati amici, il genera-le Ismet Pascia, che aveva dato prova del suo valo-re durante il conflitto mondiale, quando, alla testadelle armate turche impegnate sul difficile frontesiriano, ne aveva impedito la disfatta riportandoleabbastanza integre in patria. Su questo nucleo disoldati aveva potuto far perno la successiva, gran-


libreria
107
de offensiva lanciata da Kemal per ottenere losgombero del territorio anatolico da parte delletruppe delle potenze occidentali. A Losanna trionfòla diplomazia kemalista, poiché le potenze uscitevittoriose dal conflitto mondiale dovettero rinun-ciare alle loro pretese di cancellare la Turchia dallecarte geografiche e riconoscere la legittimitàall’esistenza del nuovo stato turco. Quello diLosanna (novembre 1923-luglio 1924) fu la primaferita che le forze revisionistiche infersero all’as-setto geopolitico uscito dalla Grande Guerra.Rimase irrisolta la questione di Mossul, cioè a chiattribuire, tra Turchia e nuovo regno dell’Iraq, lavecchia provincia mesopotamica di Mossul, abita-ta prevalentemente da curdi. La questione si trasci-nò fino alla fine del 1925 quando la Società delleNazioni finì per consegnare il vilayet di Mossul alregno iracheno retto dal filo-inglese re Feisal. Ma ilgenio politico di Ataturk si espresse anche nellapolitica interna, nelle grandi riforme da lui attuatetra il 1923 e il 1929, che cambiarono letteralmenteil volto alla Turchia, avviando una profonda tra-sformazione della vecchia e immobile società otto-mana. Fu un processo riformatore di profonda econvinta adesione ai valori delle civiltà occidentaliquello che gli consentì di far nascere dalle ceneridel vecchio impero ottomano un organismo stataledel tutto nuovo e moderno. Iniziò col trasferire lacapitale ad Ankara, che trasformò in breve tempoin una moderna metropoli, declassando Istanbul,simbolo del potere del vecchio impero ottomano, alruolo di semplice capoluogo di provincia. Convintadella necessità di rendere la Turchia un Paese pro-fondamente permeato dei valori estetici e spiritua-li della civiltà occidentale, e di combattere gliavversati caratteri di quello che egli chiamava“l’Oriente pittoresco”, giunse al punto di proibirecon leggi ad hoc l’abbigliamento tipico arabo, alquale egli a più riprese riservò non poco del suoferoce sarcasmo. Il fez in particolare fu oggetto daparte sua di una campagna ostile che si conclusecon una legge che ne rendeva illegale l’uso. Per
l’illuminista Kemal il termine civiltà voleva signi-ficare civiltà occidentale. Giunse a vietare la barbaai pubblici ufficiali e persino i baffi ai militari.Adottò il calendario gregoriano e l’orario di tipooccidentale basato sulle 24 ore. Condusse infine unduro attacco alle condizioni privilegiate di cuigodeva la diffusione dell’Islam, combattendo nelcontempo tutte le manifestazioni pubbliche disuperstizione religiosa. Sciolse le logge dei dervi-sci, limitandone drasticamente il potere, e chiusetutti i mausolei dei santi e dei califfi. Continuò lasua rivoluzione introducendo nel 1926 un codicecivile che si ispirava a quello svizzero, e che forni-va “una prima sicura base giuridica per l’ingressodelle donne nella società e nel mondo del lavoro”.Ispirandosi sempre ai codici in vigore nei Paesioccidentali, passò alla riforma del codice di proce-dura civile, del codice di procedura penale e delcodice di commercio. Nel 1928 portò a termine la definitiva secolarizza-zione dello stato turco con l’abolizione del ruoloprivilegiato che la costituzione del 1924 ancoragarantiva alla religione islamica. Come scriveGrassi era “l’inizio della seconda ondata contro latradizione islamica”: la scrittura araba dei numerivenne sostituita da quella occidentale, venne aboli-to l’insegnamento nelle scuole dell’arabo e del per-siano, e venne avviata la riforma per la realizzazio-ne del passaggio dall’alfabeto in caratteri arabi aquello latino. Riguardo alla condizione femminileegli si batté con successo per l’eliminazione delvelo dal volto delle donne, una pratica che definìpiù volte “umiliante”. Adottò diverse bambinefavorendone la formazione di una cultura occiden-tale. Una di loro Sabiha, divenne pilota di aereimilitari, e a lei è tuttora intitolato il secondo aero-porto di Istanbul. La partecipazione delle donnealla vita politica della repubblica turca, nel ruolo dielettrìci ed elette, fu un processo che trovò unacompiuta realizzazione nel corso degli anni trenta.In Italia, per riconoscere alle donne tali diritti, sidovrà attendere il 1946.

Risk
108
• GEORGE FRIEDMANThe Next 100 Years: A Forecast for the 21st CenturyDoubleday 2009
«Sii pratico, aspettati l’impos-sibile». Questo è il motto del-l’autore, fondatore di Stratfor,l’agenzia di intelligence priva-te i cui clienti includono go-verni e le più importanti com-pagnie del mondo.In The Next 100 Years,Friedman si fa carico del-l’enorme sfida di prevedere glieventi che plasmeranno ilVentunesimo secolo, partendodal presupposto che «l’analisipolitica convenzionale soffredi una profonda mancanza diimmaginazione». Friedmantraccia una mappa di quelli cheritiene gli eventi più probabili,alcuni dei quali sorprendenti:più guerre, ma meno catastro-fiche; il riemergere dell’ag-gressività egemonica dellaRussia; il calo dell’influenzacinese dovuto a squilibrisocioeconomici; e l’alba di“un’età d’oro” americana nellaseconda metà del secolo. Purnella certezza di commetteredegli errori, Friedman si sbi-lancia in un “educated guess”coraggiosamente costruito suuna solida base logica.
• ALBERTO NEGRIIl turbante e la corona. Iran, trent’anni dopoCastelvecchi 2009
Il ritorno di Khomeini aTeheran dopo l’esilio fu saluta-to da quattro milioni di perso-ne, pronte a travolgere lamonarchia e instaurare una
aree d’influenza, e inaugurato-si con una Blitzkrieg, ossia unattacco fulmineo alla Poloniada parte dei tedeschi, il secon-do conflitto mondiale ebbe,nella sua prima fase, sviluppisingolari e contraddittori, chesuscitano interrogativi ancoraoggi senza risposta. Attraverso una cronaca detta-gliata, Arrigo Petacco raccon-ta gli eventi, i personaggi, e iretroscena del periodo fra il1939 e il 1940 in cui negliambienti politici e militarioccidentali il vero nemicosembrava essere più Stalin cheHitler, ed illumina il ruolodell’Italia di cui queste pagineripercorrono i nove mesi di“non belligeranza” descriven-do l’intensa attività diplomati-ca, palese e occulta, diMussolini.
• DEMETRIO VOLCICIl Piccolo ZarLaterza 2008
La Russia dello zar Putin èritornata con forza sulle primepagine di tutti i giornali con laGazprom, la crisi georgiana,l’assassinio della Politko-vskaya, l’avvelenamento diLitvinenko, e le dichiarazionidel neo-primo ministro circanuovi tipi di armi nuclearicome parte di un progetto“grandioso” per migliorare ladifesa del Paese. Afronte dellaflessione di quello americano,l’Impero russo rimane l’unicoaltro vero impero del pianeta,governato come tale, determi-nato a mantenere il controllodi nazioni e popoli etnicamen-te e culturalmente eterogeneima da sempre sotto la sua
Repubblica islamica. «La rivoluzione farà molto dipiù che liberare dall’oppres-sione e dall’imperialismo:creerà un nuovo tipo di essereumano». Era il 1979 quandoKhomeini pronunciò questeparole. In nome dell’islam la societàiraniana si sarebbe liberatadall’ingiustizia, dalla povertà,dalla corruzione. Dieci annidopo l’Iran, reduce da unadevastante guerra control’Iraq e da sanguinose lotteinterne piangeva la morte diKhomeini, in un’atmosfera diesaltazione mistica. Il pro-gramma nucleare di Ahma-dinejad, oggi, è una “secondarivoluzione”, che punta su unpopulismo millenarista perl’egemonia sciita in medio-riente. In questo libro AlbertoNegri ripercorre la storiadell’Iran per rintracciare leorigini della rivoluzione,esplorandone i luoghi, interro-gandone i protagonisti, esami-nando il ruolo del petrolio e“le colpe” dell’Occidente, edistricando la rete di alleanzefra le forze economiche e reli-giose del Paese che datrent’anni vanifica ogni spe-ranza di riforme.
• ARRIGO PETACCO La strana guerra. 1939-1940:quando Hitler e Stalin erano alleati e Mussolini stava a guardareMondadori 2008
Preparato da un patto di nonaggressione fra Germania eUnione Sovietica, che davacampo libero alle due potenzefirmatarie nelle reciproche
sfera d’influenza. Volcic rac-conta un Paese refrattario aqualunque intromissione oc-cidentale nei suoi affari espropositatamente ricco dirisorse minerarie e petrolife-re, concentrate nelle pochis-sime mani dell’oligarchia delCremlino.
• THOMAS E. RICKS The Gamble: General David Petraeus and the American MilitaryAdventure in Iraq, 2006-2008Penguin Press 2009
Una scommessa. È così cheRicks vede il “surge” che,deciso dal Generale Petraeus,sembra aver invertito l’anda-mento della Guerra in Irak. Eproprio Petraeus è al centrodel quadro tracciato dall’au-tore, un soldato intellettualeche si è circondato da ufficia-li con esperienza di combatti-mento e titoli accademici, fracui un antropologo australia-no, un’esperta di MedioOriente britannica antimilita-rista ed un pacifista palesti-nese.The Gamble offre una vistada dietro le quinte di coloroche hanno preso le decisioni,dei loro dubbi e dei lorodisaccordi, ed i relativi “con-gressional hearings” attra-verso gli occhi di Petraeusstesso e dell’AmbasciatoreRyan Crocker. Concludendoche la guerra si protrarrà peraltri 5-10 anni e che «glieventi per i quali la guerra inIraq sarà ricordata dalmondo non si sono ancoraverificati».
U S C I T I N E L M O N D O a cura di Beniamino Irdi

riviste
109
DOUG BANDOWKazakhstan turns uglyThe American Spectator December 2008
Scrollata di dosso la domina-zione sovietica molte delle exrepubbliche sembrano volerrientrare nell’alveo delle dit-tature. Il Kazakistan vorrebbefare marcia indietro riguardole libertà religiose, così comeper quelle politiche.Washington e Bruxelles stan-no decidendo se permettereal governo kazako di guidarel’Osce, mentre nella repubbli-ca del centro Asia si varanolegislazioni punitive nei con-fronti di organizzazioni reli-giose non iscritte agli elenchiufficiali. Prese di mira soprat-tutto le chiese cattoliche eortodosse, con diocesi acavallo di più confini rispettoa quelli nazionali di Astana.Viene, di fatto, impedito ilproselitismo e bandito ognitipo di materiale divulgativo acarattere religioso. Si preten-de addirittura che i ragazzi,per partecipare alle funzionireligiose, ottengano un per-messo dai genitori. LaMajilis, Camera bassa kaza-ka, si è mossa velocementeappena dopo la partenza deirappresentanti dell’Osce, che
erano andati ad Astana perdiscutere in merito. Ma nonsembra essere l’unico gover-no centroasiatico ad averimbocca il sentiero dellarepressione. Anche ilKirgyzistan ha dato un giro divite alle libertà religiose e ilTagikistan ci sta pensandoseriamente. Neanche ilTurkemnistan e l’Uzbekistandanno per scontate le libertàche l’America considerasacre. Felix Coley di «Forum18», un gruppo con base adOslo che controlla il livello dilibertà religiose nella regione,parla di “trend” contro il biso-gno di trascendenza organiz-zata. E si comincia rumoreg-giare riguardo la presidenzakazaka dell’Osce nel 2010. IlKazakistan è uno Stato a pre-valenza musulmana che malsopporta organizzazioni reli-giose al di fuori del propriocontrollo, specialmente perconfessioni non autoctone. Èil caso delle chiese protestan-ti, che registrano ritardi conti-nui nel processo di riconosci-mento. Lo scorso anno lasvolta, con una dichiarazioneufficiale da parte del ministrodella Giustizia: «abbracciareun’altra fede è da considerareun tradimento nei confrontidella propria tradizione reli-giosa e della Patria». Unavera scomunica ufficiale. Enel calderone sono finitianche i Testimoni di Geova egli Hare Krishna. Occorretenere conto che molti sonoconvinti che le libertà religio-se siano l’apripista per tutte lealtre, come il canarino cheveniva portato in miniera. Ilprimo a morire quando arri-vava il gas venefico.
dell’Alleanza» e non basteràtriplicare l’esercito afgano pervincere. Gli Usa dovrannoraddoppiare gli sforzi, chevorrà dire mettere mani al por-tafogli per una cifra adeguata.Serviranno nuove tasse.Soprattutto servirà «tempo,denaro e sangue». Per anni gliamericano hanno distinto frala «guerra buona», quellaafgana, giustificata dalla primareazione al 11 settembre 2001e quella «cattiva», il conflittoiracheno. Almeno così è statoper tutta una generazione didemocratici e liberal che ama-vano pensarla in questamaniera. Per loro affrontare ildiscorso di un ritiro in Iraq erameno difficile, perché lo colle-gavano ad uno sforzo maggio-re da dedicare a Kabul. Nonera dunque una fuga, solo unospostamento di bandierine.Non basterà però spostarequalche brigata. Il primo e piùdifficile impegno della presi-denza di Barack Obama si pre-senta come un incubo. Per vin-cere la «guerra buona» serviràla più sofisticata tecnica dicounterinsurgency – di cui èesperto David Petraeus - enor-mi risorse e una politica esteradi rara qualità. Bastererebbepensare alla complessità delproblema Pakistan per render-sene conto. Ora i ragazzini,con le loro pistole ad acqua,giocano davanti alle scuole,ma sempre più spesso le cari-cano con acido da batteria, persfigurare le compagne di scuo-la, che hanno la sola colpa divoler studiare. Questa è unabattaglia contro l’ignoranzache si pretendeva di vinceresubito, ma così non è stato.Non basteranno i Predator -
MICHAEL CROWLEYObama vs Osama The New RepublicDecember 2008
Interessante articolo di quellache un tempo era consideratal’unica rivista - creatura diMartin Peretz - letta su AirForce One, almeno ai tempi diBill Clinton. Dà il tono delclima con cui i nuovi demo-cratici si avvicinano allaPennsylavania Avenue, senzamiti e un pragmatismo dettatodai tempi. Molto duri e diffici-li. In America si stava ancoravotando quando John Nagl, uncolonnello dell’Esercito inpensione decise di fare unviaggio in elicottero sui cielidell’Afghanistan. Avendospeso ben tre anni di servizioin Iraq, nel poco accogliente«Triangolo sunnita», avevabene in mente cosa volessedire una situazione difficile.Comunque aveva contribuitoa scrivere il manuale di coun-terinsurgency del corpo deiMarines e dell’Esercito. Ora èuno studioso del progetto NewAmerican security, comeesperto militare. Sorvolandoquelle montagne aspre, quellevalli con gole profonde, sistava rendendo conto del pro-blema Afghanistan. «Nonbasterà raddoppiare le forze
L A R I V I S T A D E L L E R I V I S T E a cura di Pierre Chiartano

Risk
110
secondo questa visione, nonsarebbe né una dittatura eneanche uno Stato fascista.Sarebbe soltanto un neosul-tanato col monopolio dellaviolenza e la gestione assolu-ta dell’esercizio della religio-ne, che vede Israele come il“cattivo” consigliere dellapolitica di Washington neiconfronti di Teheran.
aerei senza pilota – che nellanotte sorvolano il Waziristana caccia di taliban e militantidi al Qaedae, con tecnologicaprecisione. Non basterannoneanche i loro missili mave-rick per vincere la «guerrabuona». Forse un Paese paci-ficato renderà il mondo piùsicuro, ma non vi è certezzaneanche di questo. Se le risor-se degli Usa sono limitate, acausa della crisi, – affermaNagl – Obama dovrà mobili-tare l’intera nazione e vararenuove tasse, ben sapendo chenon si è certi di cosa vogliadire vincere in Afghanistan.A dimostrazione che di«buono» in quegli altopianic’è rimasto ben poco.
garantiti. Rispetto alla manodi ferro usata verso i dissi-denti nei primi anni dellaRivoluzione – dove veniva-no eliminati senza troppicomplimenti – qualcosa ècambiato. In meglio. Le cri-tiche al leader supremo nonsono infrequenti e spessosono state sottoscritte lettereaperte di critica alla sua con-dotta da personaggi come igiornalisti Ahmad Zeyda-badi, Issa Saharkhiz e il teo-logo Ahmad Qabel. Il lin-guaggio semplice quantoretorico di Ahmadinejad hafacilitato anche gli opposito-ri nell’utilizzare la stessachiarezza nella critica. Tajzadeh ex viceministrodegli Interni, Sayyid Mo-hammad Sadr vice ministrodegli Esteri con Khatami emolti altri rappresentantidella corrente riformista ,cancellata dalle ultime tor-nate elettorali da alcunicolpi di mano normativi,reagiscono ancora al regimedi Ahmadinejad. Anchealcuni membri del suogoverno hanno avuto deipicchi di gradimento pubbli-co non appena lasciati –spesso costretti a farlo – gliincarichi ufficiali. È il casodel negoziatore sulla issuenucleare. Max Weber civiene incontro per spiegarela natura del potere inPersia: non è autoritarismotradizionale, esercitato conla mediazione della virtù delleader, ma esercizio «sulta-niale del potere», attraversol’arbitrio personale. CosìGanji descrive il governo diKhamenei. L’Iran di oggi,
nessuno prima. Nonostante ifallimenti, assai numerosi,in politica come in econo-mia e le promesse mancate,soprattutto per la lotta allacorruzione. Per Khatami, ilriformista, il potere diKhamnei è tanto da averridotto la figura del presi-dente a un semplice «facto-tum» della politica iraniana.Controlla, di fatto, l’esecuti-vo, il legislativo e il poteregiudiziario e, se non bastas-se, nomina il comandantedelle Guardie della Rivo-luzione. Sopravvalutare lafigura di Ahmadinejad portaa due generi di errori. Il pri-mo è la sovrastima del per-sonaggio che ne amplificaun potere che non detiene néesercita. Il secondo è che iproblemi che attraversa ilPaese non dipendono tuttidal suo governo e non scom-pariranno una volta lasciatoil potere. Le quattro presi-denze dell’Iran, dalla rivolu-zione khomeinista, sonostate dello stesso Khameni(1981-89), di Rafanjiani(1989-97), di Khatami(1997-05) e da ultimo diAhmadinejad. Leggendo frale righe dare un giudizioimparziale è compito assaicomplesso, ma l’autoreammette che se da un latol’ultimo periodo ha signifi-cato un peggioramento dellecondizioni del Paese, peraltri versi si sono avuti alcu-ni lievi miglioramenti. Nelmodello politico unicamera-le (Majlis) i concetti didemocrazia, come si inten-dono in Occidente, sonoaleatori e solo formalmente
L A R I V I S T A D E L L E R I V I S T E
MARK MAZOWER Paved intentions:Civilization andImperialismWorld Affairs Fall 2008
Storia ragionata del termineciviltà, del suo utilizzo e delquadro storico che ne hafatto sviluppare potere politi-co e immagine comunicati-va. Cominciando dalla«fine» potremmo citare ilR2P di Kofi Annan, ovvero il«Responsability to protect»che ha aperto le porte all’in-terventismo umanitario. Unanuova categoria che non èaltro che il cavallo di Troiaper smontare, senza tanticomplimenti e qualche buo-na ragione, il concetto disovranità nazionale. Anche ilpatto tra George W. Bush eTony Blair, meglio conosciu-to come «Alleanza fra civil-
BDI AKBAR GANJI The Latter-Day Sultan Foreign Affairs November/December 2008
Chi comanda veramente inIran? Se lo chiedono intanti, ma per molti comeper l’autore dell’articolo,giornalista e dissidente, larisposta è Khamenei, ilcapo supremo. Il presidentedella Repubblica islamicaAhmadinejad conta soloperché è appoggiato dalleader supremo, come mai

riviste
111
tà» a seguito della leader-ship morale richiesta dopol’11 settembre, potrebbe farparte del finale della storia.Ma parliamo dell’inizio,dove tra 1815 e la Secondaguerra mondiale, un siste-ma internazionale di Statiprese forma, sotto l’egidadella primazia europea.Civiltà dell’Europa, in quelcaso, che presto avrebbesubito una deriva atlantica.Comunque, a metà del-l’Ottocento, il termineemerse prepotentementenel lessico inglese e france-se e connotava il modo incui l’umanità era uscitadal-la barbarie e quindi eradiventata una società civi-lizzata. L’integrità dellapersona e la proprietà pri-vata ne erano il cardine, lacifra distintiva. Un percor-so avviato dopo la sconfittadi Napoleone Bonaparte,che accentuò i toni sullacooperazione piuttosto chesulla conquista. FrancoisGuzot nel suo History ofCivilization in ModernEurope, la definisce comeun percorso verso il compi-mento dell’idea di umani-tà, sottolineando un concet-to futuribile: «l’espansionedella mente» nel sensorazionale del termine e delmassimo sviluppo dei dirit-ti individuali. Guzot ritieneche la civiltà europea siasuperiore ad altre, comequella indiana o dell’anticoEgitto, perché è riuscita acombinare sapientementeun comunità della culturacon gli sviluppi politiciimprontati alla «diversità».
L A R I V I S T A D E L L E R I V I S T E
L’insediamento europeo dellaciviltà ha portato come conse-guenza una sua esportazioneoltremare. È stato costruitoun diritto internazionale chepotesse agevolare questaespansione, ma che, comun-que, potesse preservarel’equilibrio fra gli Statisovrani. John Stuart Millinfatti applicava i principi dilibertà in seno a questo terri-torio precostituito da regole eciviltà. Nel 1845 un luminare deldiritto internazionale ameri-cano, molto influente, HenryWheaton, stabilì una distin-zione precisa che stabiliva unconfine fra «diritto interna-zionale cristiano» e una sortadi raccolta di leggi in uso nelmondo musulmano. Neltempo e con passaggi di filo-sofia del diritto successivi,questa visione incise sul rap-porto fra Europa e imperoOttomano. Subito dopo laguerra di Crimea, che sancì,per la prima volta, la perdita-da parte della Sublime porta- di un territorio per secolirimasto nell’alveo della cul-tura islamica. Di lì in poi lo ius publicumeuropeo si impose metabo-lizzando lentamente ma ine-sorabilmente il mondomusulmano. Con la primaguerra mondiale entrò sullascena Washington, il wilso-nismo e un nuovo protagoni-smo. Ora i fallimenti dell’O-nu nel proteggere le popola-zioni da governi dispotici – ealcuni problemi legati al ter-rorismo - pongono una sfidaal concetto di sovranitànazionale.
cui Mosca avrebbe tenuto testa.Secondo l’autore dell’articoloquesti eventi testimonierebbero ildrammatico cambiamento avve-nuto nel balance of power inter-nazionale, a scapito diWashington naturalmente. Unaderiva a danno del potere assolu-to esercitato dall’Occidente sulmondo, entrato in crisi già a metàdel secolo scorso, ma che avreb-be avuto il suo compimentoall’alba del nuovo. Dopo pochianni dalla caduta del muro sta-remmo assistendo alla caduta delvallo del liberalismo. L’autoremette in guardia comunque dalvalore di qualsiasi profezia. CitaJean-Francois Revel, all’indo-mani dell’ascesa di MikhailGorbachev, giudicato mentoredella vittoria del comunismosull’Ovest. Poi seguito daFukuyama e la sua visionesull’Ultimo uomo, e soprattuttola Fine della Storia sintesi dellavittoria finale del liberalismo.Vittoria che avrebbe avuto ilsigillo, nel passaggio al XXIsecolo, dal trionfo della primaguerra del Golfo del 1990-’91.Quindici anni dopo starebbeemergendo – secondo Gresh –un secondo modello di consen-sus, seguendo impostazione sto-rica del «post-americanismo».Secondo le linee del Libro bian-co della difesa francese del 2008,l’economia e l’approccio strate-gico dell’Occidente (Usa piùEuropa) non potranno più esserequelli del 1994. Il mondo è cam-biato. Gli Usa rimarranno lapotenza prevalente per lunghianni ancora e non solo dal puntodi vista militare. Nel frattempo aPechino, New Delhi, Brasilia eMosca starebbe crescendo unadiversa geometria di potere.
ALAIN GRESHUnderstanding the BeijingConsensusLe Monde Diplomatique December 2008
La chiamano «la fine dell’arro-ganza» - parafrasando il titolo delDer Spiegel del 30 settembrescorso - e sarebbe certificata dauna lunga serie di segnali sullascena internazionale. L’antia-mericanismo sembra vivere ilsuo momento di gloria – a quan-to scrive l’autore dell’articolo-stando al lungo elenco di causeche potrebbero essere messe incalce al certificato di morte delWashington consensus. Il primoelemento è costituito dalla crisifinanziaria, letta come il falli-mento del modello capitalistico.A questo si aggiunge internet:dieci anni fa gli Usa produceva-no il 50 per cento del traffico webmondiale oggi solo il 25 percento. Per non dire del fallimen-to del Doha round sul commer-cio internazionale, dopo innume-revoli tentativi di rianimare lapolitica del Wto, arenatasi difronte al «no» di Cina e India,che non volevano sacrificare ipropri agricoltori sull’altare dellibero mercato. Anche l’affaireGeorgia viene letto come unasconfitta della proiezione dipotenza americana nel Caucaso,

112
E F I R M EL del numero
MARIO ARPINO: generale, già Capo di Stato maggiore della Difesa
PIETRO BATACCHI: caporedattore di Panorama Difesa
FABRIZIO BRAGHINI: analista strategico
MAURO CANALI: storico, ordinario di Storia dei Partiti e Movimenti Politici all’Università di Urbino
FABRIZIO EDOMARCHI: analista dei Balcani
EGIZIA GATTAMORTA: ricercatrice del CeMiSs per l’Africa e il Mediterraneo
GIOVANNI GASPARINI: ricercatore presso l’Istituto Affari Internazionali
RICCARDO GEFTER WONDRICH: ricercatore del CeMiSs per l’America Latina
OSCAR GIANNINO: direttore di Libero Mercato
VIRGILIO ILARI: docente di Storia delle Istituzioni Militari all’Università Cattolica di Milano
LUDOVICO INCISA DI CAMERANA: ambasciatore, già sottosegretario agli Affari Esteri
BENIAMINO IRDI: ricercatore
GENNARO MALGIERI: deputato Pdl, giornalista e scrittore
AHMAD MAJIDYAR: analista per l’Afghanistan all’American Enterprise Institute
ANDREA MARGELLETTI: presidente Ce.S.I. - Centro Studi Internazionali
DAVID J. SMITH: senior fellow al Potomac Institute for Policy Studies di Washington e direttore del Georgian Security Analysis Center di Tbilisi
EMANUELE OTTOLENGHI: direttore del Transatlantic Institute di Bruxelles
WALTER RUSSELL MEAD: Henry A. Kissinger Senior Fellow per la Politica estera al Council on Foreign Relations. Autore di molte pubblicazioni
STEFANO SILVESTRI: presidente dell’Istituto Affari Internazionali (Iai)
ANDREA TANI: analista militare, scrittore