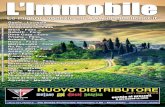Relazione Fano
description
Transcript of Relazione Fano

1
Sui disturbi del linguaggio nell’autismo.
Luciana Brandi (Laboratorio DiLCo, Università di Firenze)
(Fano- giugno 2008)
Relazione
Partendo dalla classificazione del disturbo del linguaggio nell’autismo proposta in Brandi 2005, viene
presentata l’analisi psicolinguistica delle caratteristiche salienti dei tipi individuati, in comparazione ai
processi che guidano in generale l’acquisizione del linguaggio, nel tentativo di mostrare come nell’anomalia
autistica si ritrovino modalità di processing – se pur ‘in eccesso’ - che sono proprie anche dello sviluppo
regolare. Da questa considerazione, discende una precisa filosofia, un preciso metodo, di intervento
psicolinguistico sul disturbo in oggetto, di cui verranno presentate le linee guida.
DLSA - soggetti con Disturbo del Linguaggio Severo:
In questi casi, quando il bambino esce dal periodo di mutismo, (4/4.5 anni), comincia a produrre sequenze
ritmiche di suoni proto-linguistici, nel senso che ‘assomigliano’ a vocali o consonanti della lingua nativa ma
non sono propriamente riconoscibili come tali, e pur tuttavia la prosodia dell’intera sequenza è simile a quella
di una vera e propria frase. Intonazione e accento, l’attribuzione di prominenze accentuali alternate, ritmo e
prosodia, sono tutti elementi che segnalano la successione di eventi espressivi nel tempo. Infatti, non si
tratta di produzioni vocali casuali o stereotipe, ma piuttosto di atti che discendono da una intenzione
comunicativa. Il comportamento associato all’atto di parola - lo sguardo rivolto all’interlocutore e all’oggetto
coinvolto, l’espressione della faccia, il movimento - fa capire che bambino vuole trasmettere un significato, e
lo fa nell’unico modo che ha a disposizione: la produzione di forme di vocalizzazione dotate di una struttura
metrico-ritmica, quello che abbiamo definito, seguendo Trevarthen 1999, come la musicalità del linguaggio
(Brandi 2003). I suoni realizzati dentro tale involucro musicale non corrispondono tuttavia a delle unità
linguistiche, perciò il senso voluto dal bambino può essere solo intuito, e con grande difficoltà e ambiguità da
parte dell’interlocutore, con la conseguenza di una consistente incapacità comunicativa.
Anche sulla base dell’esperienza accumulata nel corso delle osservazioni e dei trattamenti portati avanti con
l’equipe dell’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’A.O. di Careggi, abbiamo formulato l’ipotesi che la
musicalità, combinata alla capacità di attenzione condivisa, possa essere considerata il segnale
dell’emergere di capacità di tipo linguistico nel bambino autistico e renda perciò attuabile la (ri)abilitazione. Si
tratterebbe di un vero e proprio indicatore precoce per l’accesso al linguaggio nel bambino autistico con
disturbo severo, e perciò, se saputo valutare, può consentire l’avvio di un trattamento mirato. Infatti, è
proprio dal mantenimento-sollecitazione di questa capacità che può successivamente svilupparsi, dietro
opportuno intervento (ri)abilitativo, un tipo di produzione propriamente linguistica, fatta prima di sequenze
sillabiche più o meno simili a quelle del linguaggio adulto, poi delle prime parole, anche se la progressione
può essere assai lenta e presentare persistenti caratteristiche di disturbo fonologico. Quando invece la
musicalità è scambiata per suoni casuali e privi di valore nella direzione dell’apprendibilità del linguaggio,
quando ne viene sottovalutato il ruolo di anticipatore della scansione metrico-sillabica degli enunciati,

2
lasciata a se stessa progressivamente deperisce, perché la progressione verso il linguaggio – in questi casi -
può avvenire su esclusiva base spontanea. Le ragioni sono di ordine prettamente neurofunzionale.
Infatti cercando una spiegazione delle caratteristiche del disturbo linguistico su base neurobiologica,
abbiamo ipotizzato, facendo tesoro degli studi di Boddaert et al 2004, che vi sia in questi soggetti una
attivazione ridotta delle aree del linguaggio, compreso l’area di Wernicke, e un’attività diffusa esterna al lobo
temporale (cingolo bilaterale, parietale posteriore, cervelletto). Le conseguenze sono che l’ascolto di suoni
complessi induce un’attivazione corticale e una rete funzionale anomale. L’autismo appare perciò associato
con la disfunzione di specifiche regioni temporali specializzate nella percezione e nella integrazione di suoni
complessi, investendo anche l’interfaccia tra la percezione della parola e le rappresentazioni di memoria a
lungo termine. Perciò, in questi casi di disturbo severo del linguaggio l’ostacolo allo sviluppo deriva dalla
combinazione di due fattori cruciali: la difficoltà di individuare le unità in cui l’onda sonora (input fonologico)
potrebbe essere segmentata, la permanente iper-esposizione alla variazione contestuale. L’effetto è che
ciascun input fonologico viene processato come alterato, e segnato da un eccesso di prominenza delle
variazioni contestuali che lo fanno percepire ogni volta come ‘nuovo’ a causa delle disfunzioni nelle
rappresentazioni a lungo termine. Segue che l’emergere di categorie fonologiche (l’invarianza) trova
continui ostacoli in quanto viene a mancare quella accumulazione statistica di dati da cui emerge la
categorizzazione fonologica.
Per quanto riguarda i processi che guidano l’acquisizione della lingua nativa – in generale, dunque anche in
assenza di disturbi - riteniamo che la struttura fonologica scaturisca dall'esperienza cumulativa che consente
il formarsi di categorizzazioni come forma di computo sulle regolarità statistiche presenti nel segnale del
parlato sulla base dell'accumulazione statistica piuttosto che di un codice predeterminato: la segmentazione
è introdotta col trasdurre i suoni variabili in modelli di gesti articolatori (unità motoria e informativa insieme),
su una base iniziale ritmico-prosodica (Cutler 1996; Gerken 1996; De Boysson-Bardies 1996).La prosodia
diviene, ancora in una fase pre-lessicale, la chiave per accedere all’identificazione dei confini dei costituenti
sintagmatici, e dell’ordine delle parole, la lingua emerge ontogeneticamente dal processo di imitazione di un
segnale acustico quasi continuo mediante un meccanismo organizzato somatotopicamente e
neuroanatomicamente segmentato (Studdert-Kennedy 2000; Rizzolatti, Buccino 2005). L’unità linguistica
iniziale è la parola olistica: anche se è prodotta come una sequenza di gesti discreti, tuttavia tali gesti ancora
non sono rappresentati come elementi fonetici indipendenti che possono essere usati liberamente in altri e
differenti contesti: “come una conseguenza automatica di ordinare e ammucchiare parole simili
foneticamente, emergono i gesti indipendenti, e modelli ricorrenti di gesti co-occorrenti sono gradualmente
integrati nei segmenti” (Studdert-Kennedy 2000: 280).
Riguardo alla relazione tra aspetti uditivi e aspetti motori del linguaggio, la ricerca sui neuroni specchio
(per la cui relazione eventuale con la formulazione di ipotesi per trattare l’autismo si veda anche Brandi e
Bigagli 2004), ha anch’essa messo in evidenza la necessità teorica di distanziarsi da una concezione della
mente umana come totalmente disincarnata, e più in particolare per i neuroni specchio audio-visivi dell’area
premotoria F5 ha dimostrato che “non fa alcuna differenza se una data azione è udita, osservata oppure
eseguita” (Gallese 2003: 33). In altre parole, il trasferimento trans-modale dell’informazione sembra essere
una capacità forse innata del nostro sistema cognitivo, ed i neonati mostrano di essere in grado di operare
un’integrazione trans-modale dell’informazione sensoriale: Meltzoff 2002 mostra in particolare come i
neonati siano in grado di imitare movimenti della faccia e della bocca, quindi di tradurre in comando motorio,

3
necessario per attivare il comportamento imitativo, lo stimolo visivo percepito, e dunque l’informazione visiva
relativa al comportamento osservato.
Se dunque vi è una capacità innata di stabilire relazioni di equivalenza tra modalità sensoriali differenti,
allora diventa percorribile l’idea, congrua con i dati neuroscientifici citati sopra, che l’informazione uditiva
possa tradursi in informazione motoria (e viceversa) per quanto riguarda l’accesso del linguaggio alla mente
umana. Pertanto, se il linguaggio parlato scaturisce dal legame tra sensoriale e motorio che fa diventare
l’informazione uditiva informazione articolatoria, le variazioni contestuali delle combinazioni dei suoni
possono davvero costituire ciò che è necessario e sufficiente per l’acquisizione del linguaggio, senza
bisogno di dover supporre l’esistenza di un codice preordinato che governa il processo.
I dati linguistici evidenziati soprattutto da alcuni casi di disturbo del linguaggio ci portano a supporre che
all’inizio il processo di acquisizione sia fortemente legato alle variazioni contestuali fondate sul trasferimento
transmodale degli stimoli, e che solo successivamente, come effetto di accumulo dell’esperienza e dei
processi di auto-organizzazione cerebrale, ‘emergano’ le invarianze fonologiche quali quelle propriamente
descritte e teorizzate nei sistemi fonologici anche di impostazione sensoriale (Harris 2004).
La stabilizzazione selettiva degli elementi compatibili con l’ambiente linguistico a partire da un repertorio
iniziale più ampio indica che il corso di acquisizione del linguaggio si configura come una perdita di capacità
percettive.
Quello che allora fa ‘diverso’ il processo nel bambino autistico con DSLA è precisamente la difficoltà ad
‘ammucchiare parole simili foneticamente’, di conseguenza, la variabilità con cui si offre il linguaggio alla
percezione uditiva diviene l’eccesso rispetto al quale è estremamente arduo far emergere l’invarianza. A
nostro avviso, la rete associativa tra aspetti sensoriali e aspetti motori del linguaggio è fortemente
condizionata dal vincolo posto da un eccesso di ‘sensibilità’ alle variabilità contestuali in ragione del fatto
che, come Boddaert et al. 2004 ci indica, è probabilmente alterata la funzionalità della regione temporale.
Inoltre, sia i dati in De Fossé et al. 2004 sull’asimmetria inversa inerente i lobi frontali, sia quelli in Herbert et
al. 2005 sull’asimmetria corticale a destra correlata all’aumento di volume, ripropongono come centrale il
ruolo della corteccia associativa per quanto riguarda il processing di stimoli rapidi e complessi, inducendo
una progressiva divergenza dalla norma per quanto riguarda le funzioni che richiedono un’attività
associativa. L’asimmetria inversa, in particolare, potrebbe essere il risultato non solo di un improprio
feedback percettivo ma soprattutto del più forte e permanente legame con gli elementi contestualmente
varianti che rende lenta e difficoltosa la formazione di categorie.
Perciò anche con un opportuno e ‘precoce’ intervento (ri)abilitativo, lo sviluppo del linguaggio resta lento e
caratterizzato dalla persistenza di disturbi fonologici, la capacità comunicativa risulta fortemente ridotta.
Dicendo che l’autismo appare associato a tali disfunzioni in area temporale, intendiamo che si debba con
tutta probabilità ipotizzare una relazione consistente con le caratteristiche neurologiche proprie della
sindrome, oltre lo specifico linguistico, nel senso che settorialmente, ad es., le anomalie nell’organizzazione
delle minicolonne e nella formazione del neuropilo potrebbero essere coinvolte nel ‘caos’ percettivo acustico
di cui parlavamo sopra, determinato dalla ridondanza di percezioni sonore distorte che impediscono la
stabilizzazione del rapporto suono-significato; inoltre, più in generale, il danno in area temporale potrebbe
essere anch’esso una ripercussione di processi dismaturativi dell’area frontale che coinvolgono “anche la
selezione e il modellamento delle sinapsi che collegano questa regione a vaste aree del cervello” a partire

4
dall’dea che si possa identificare nella “corteccia prefrontale e nelle sue larghe e potenti connessioni con
tutte le parti del cervello, quel sistema neurologico preciso” alla base della sindrome (Lambiase 2004:
70,71).
Secondo l’ottica psicolinguistica che ci è propria, ci poniamo due interrogativi, di fatto interconnessi: per
quale ragione attribuire tanto valore alla musicalità nella prospettiva dell’accesso al linguaggio per il bambino
autistico; quali aspetti individuare come paradigmatici per lo sviluppo dell’apprendimento del linguaggio.
In primo luogo, possiamo riconoscere nella musicalità una modalità di processare il segnale acustico di tipo
linguistico che si ritrova tuttavia anche nello sviluppo non disturbato del linguaggio. In altri termini, sotto il
filtro di un’anomala perseveranza è tuttavia presente nel bambino autistico una modalità di processazione
dell’evento sonoro che non è fondamentalmente diversa da quella che, in altra età e per un arco temporale
assai più breve, caratterizza anche lo sviluppo linguistico regolare. Iniziamo allora col considerare questa
metà della storia.
Tra i 4 e i 5 mesi l’infante si dà ai cosiddetti “giochi vocali”, modulando le sue produzioni sonore e
manipolando l’involucro musicale del discorso, quello che chiamiamo intonazione: ritmo, tempo, accento; a 5
mesi gioca sulle sue produzioni vocali per comunicare emozioni e comincia ad imitare le vocalizzazioni
dell’ambiente circostante.
Dai 4 ai 7 mesi il bambino produce pseudo-sillabe poi vere e proprie sillabe ; la lallazione canonica si
instaura intorno ai 7 mesi con una combinazione CV che sembra abbastanza universale; ma molto presto
l’intonazione, la fonazione, l’organizzazione ritmica caratteristica della lingua dei genitori vengono
incorporate nelle produzioni sonore; è ora che le vocali prodotte dai bambini cominciano ad assomigliare a
quelle degli adulti.
Fino a 6 mesi i neonati percepiscono contrasti linguistici estesi, mentre dopo i 6 mesi il loro spazio acustico
si riorganizza e si semplifica per adattarsi alla lingua cui sono esposti. Si rilevano, così, differenze individuali
interessanti: attacchi duri e sillabe accentuate nei bambini arabi, modulazioni più dolci in francese, numerose
variazioni di altezza in cantonese (De Boysson-Bardies 1996).
Sin dalla nascita il cervello del neonato è luogo di una intensa attività spontanea: sono le pre-
rappresentazioni che il bambino proietta sul mondo intorno a lui, dapprima peculiarmente attraverso azioni
motorie, poi mentalmente. Queste pre-rappresentazioni possono essere stabilizzate o meno in funzione del
segnale ricevuto dal mondo esterno, producono un gran numero di forme transitorie, che attivano in modo
combinatorio strutture innate (es. le modalità sensoriali, le zone motorie) e distribuzioni neuronali
epigenetiche risultanti dall’esperienza (Changeux 2003).
Se guardiamo nello specifico al linguaggio, possiamo cercare di capire cosa accade nell’interazione con
l’onda sonora che, foneticamente, è fatta di consonanti e di vocali, forgiate all’interno di enunciazioni in cui la
voce dell’adulto è il tramite per dare senso a sé e al mondo, ove il divenire del linguaggio, nelle sue
primissime fasi, intreccia in modo indissolubile significato ed emozioni all’interno di quelle prime forme di
scambio comunicativo che sono segnate dalla ricerca di empatia.
Secondo Nespor, Peña e Mehler 2003 vi è una distinzione di ruolo tra consonanti e vocali , nel senso che le
prime sono connesse alla distinzione lessicale, mentre le seconde permettono l’identificazione del ritmo e
della struttura sintattica. Le vocali in particolare sono gli elementi portatori sia di intonazione (grammaticale
ed emotiva) sia di accento; perciò veicolano la struttura ritmica dell’enunciato e contribuiscono

5
all’interpretazione linguistica più per gli aspetti di alternanza di quantità che per quelli qualitativi in termini dei
tratti distintivi. A livello più basso il ritmo è definito sulla base della percentuale di vocali che occupano l’onda
sonora del parlato, mentre ai livelli più alti è determinato dai modi con cui si alternano costituenti più o meno
prominenti. Il flusso ritmico del parlato è quanto consente all’apprendente di individuare la forma del
repertorio sillabico della sua lingua e da esso la lunghezza media delle parole più comuni. La prosodia
dunque diviene, ancora in una fase pre-lessicale dell’apprendimento linguistico, la chiave per accedere
all’identificazione dei confini dei costituenti sintagmatici, e dell’ordine delle parole.
Da un lato, dunque, la musicalità incarna la similarità con lo sviluppo regolare del linguaggio e trova in
questo il fondamento della sua rilevanza per far sì che anche nei casi più gravi di autismo si possa tentare
una (ri)abilitazione in quanto essa è segno primitivo dell’apprendibilità del linguaggio. Dall’altro lato, però, la
musicalità diventa simultaneamente elemento di dissimilarità, perché il suo perseverare oltre il tempo
previsto è nello stesso tempo segno (causa ed effetto) di processi dismaturativi che impediscono al
bambino autistico di procedere spontaneamente verso l’acquisizione di capacità linguistiche. L’altra metà
della stessa storia: come conquistare allora il linguaggio, soprattutto, come far sì che avvenga quella
stabilizzazione selettiva degli elementi compatibili con l’ambiente linguistico, a partire da un repertorio
iniziale più ampio e ridondante, che fondano il corso di acquisizione del linguaggio sulla ‘perdita’ di capacità
percettive: riuscire a passare dalla grande variabilità iniziale all’invarianza del sistema di categorie
fonologiche da costruire.
L’idea centrale era di ovviare alla difficoltà enorme di discriminazione fonologica su base uditiva usando
come forma chiave di processing il trasferimento trans-modale dell’informazione e dunque impostando
attività che favorissero appunto l’integrazione dell’informazione sensoriale da una modalità all’altra, a partire
dalla naturale prominenza data dai bambini autistici all’informazione visiva. Il percorso compiuto in un caso
trattato (Brandi et al., 2007 in stampa) si è basato su alcune scelte operative che scaturivano dall’intreccio
tra le ipotesi psicolinguistiche e l’osservazione delle disposizioni del bambino. Quando è apparso che egli
mostrava una grande curiosità verso il movimento della propria bocca mentre ri-produceva ad es. la melodia
di una canzone che stava ascoltando, e che guardava la bocca della madre quando gli parlava, abbiamo
avviato pratiche di ripetizione di sillabe che egli faceva soprattutto con la madre: la visione del gesto
articolatorio poteva divenire l’elemento di stabilizzazione percettiva dell’informazione acustica.
Successivamente, quando il bambino ha mostrato interesse, entrando in prima elementare, verso la ‘lettura’,
abbiamo usato anche tale decodifica visiva dello stimolo come strategia per stabilizzare la percezione
dell’input acustico, partendo dall’ipotesi che anche un dato visivo indiretto come la lettura potesse porsi a
ulteriore integrazione del dato visivo diretto dato dal gesto articolatorio del parlante. Il percorso realizzato dal
bambino sembra aver dato conferma all’ipotesi: egli ha sviluppato un interesse elevato per la parola scritta
che ha rappresentato un riferimento stabile per elaborare lo stimolo verbale, dando luogo sia alla produzione
orale di parole sia alla loro scrittura al computer sotto dettatura. La produzione di fatto è passata da un
iniziale dominanza delle consonanti sulla vocale che era presente nella maggior parte dei casi solo nella
forma neutralizzata di schwa , ad una successiva acquisizione delle distinzioni consonantiche e vocaliche
con relativa permanenza di ‘errori’ fonologici. Contemporaneamente, è stato possibile fare delle parole via
via riconosciute nella loro veste acustico-grafemica le etichette per nominare e così conoscere il mondo
intorno: tale scoperta, e la capacità di dare senso al percetto, ha prodotto nel bambino all’inizio quasi una

6
frenesia di conoscenza e contemporaneamente l’avvio di una produzione autonoma spontanea di parole, e
non più solo su ripetizione.
Senza entrare in questa sede nel dettaglio analitico delle eventuali caratteristiche distintive della musicalità
nel bambino autistico rispetto a quella presente nello sviluppo regolare del linguaggio, vogliamo tuttavia
porre una questione: è stato possibile il lungo periodo di addestramento al linguaggio parlato perché il
bambino non solo collaborava ma addirittura mostrava di provare piacere in quello che stava facendo.
Erano, questi, aspetti che ci stupivano perché per un arco di tempo nemmeno troppo breve si trattava di un
lavoro in cui sembrava essere ancora escluso ogni accesso al significato: era un esercizio sul
riconoscimento sillabico e lessicale su via acustica tramite la facilitazione visiva; si pensi alla lettura che
sicuramente avveniva in una modalità che potemmo definire, con ristretta analogia, iperlessia. Certamente il
bambino percepiva la presenza costante di una sollecitazione ambientale estremamente gratificante,
giacché i suoi comportamenti suscitavano tanto nella famiglia quanto nelle altre figure che erano intorno a lui
molto frequentemente contentezza e soddisfazione. Ma non poteva bastare, doveva esserci un motivo più
intrinseco al materiale che stavamo trattando.
Abbiamo accennato più volte agli stadi iniziali dello sviluppo del linguaggio nei termini della struttura metrico-
sillabica del parlato quale forma che emerge dalla musicalità, la quale trova nel metro, nel ritmo e nella
pulsazione i propri elementi distintivi. Se la pulsazione stabilisce l’unità di tempo e gode di proprietà quali
l’isocronia e la costanza (tra le altre), il ritmo è definito dal contrasto e dalla combinazione di accenti, sonorità
e durate. Il comportamento linguistico esibito dal bambino seguito- vale a dire la combinazione dei suoni su
una piccola scala temporale in ri-produzione della musicalità del ‘fraseggio’ adulto - scaturiva da una
percezione che poggiava sul contrasto di intensità quale tratto saliente, sui silenzi, sugli intervalli, le durate, e
portava a pensare che, comunque, la selezione dei tratti da considerare pertinenti doveva sussistere sulla
base della proiezione del senso. Già in Brandi 2003 era stato sottolineato come la sequenza dei contrasti di
intensità sia la guida percettiva per l’attribuzione di significato, ma le questione vera è se si tratta di un
significato esclusivamente emotivo che poco ha a che fare con la formazione del significato linguistico,
oppure se ci troviamo di fronte ad un precursore per la formazione della relazione suono-significato.
Sul livello emotivo, è ‘musicalmente’ evidente che variazioni di metro, di durata, di sonorità, ecc., sono alla
base di espressioni quali felicità, tristezza, rabbia, paura, ecc.. Sul livello semantico-linguistico, adattando ai
nostri scopi alcuni suggerimenti da Tomasello 2003, possiamo pensare che, in generale, per imparare le
parole il bambino deve diventare capace di segmentare l’onda del parlato in unità identificabili, e di
concettualizzare aspetti differenti del proprio mondo esperienziale, fatto di quei ‘giochi sociali’ su cui poggia
l’interazione comunicativa tra le persone.Tale concettualizzazione è un livello di rappresentazione intermedio
tra la percezione ed il linguaggio e si basa sulla capacità di connettere un segmento di parlato con un
segmento della situazione comunicativa; quindi all’inizio si tratta di imparare la significanza comunicativa di
un termine linguistico, e da ciò può poi svilupparsi la capacità di identificare il significato più strettamente
linguistico delle parole. Quando la percezione pragmatica globale del senso riceve conferma dalle reazioni
socio-affettive degli interlocutori, il bambino procede verso dimensioni sempre più ristrette e selezionate del
rapporto tra suono e significato.
Su questa base, possiamo allora trarre alcune provvisorie conclusioni. In primo luogo, nella relazione che il
processo descritto come musicalità intrattiene con la costruzione delle relazioni suono-significato, la
dicotomia tra livello emotivo e livello linguistico è solo apparente perché si tratterebbe di una dimensione -

7
quella delle concettualizzazioni iniziali - contraddistinta da un ‘meticciato’ consistente tra i due livelli. In
secondo luogo, il valore di semanticità in tal modo attribuito alla musicalità porta a ritenere assai plausibile
l’idea di Lambiase (comunicazione personale 2006) che nell’area di Wernicke venga già iniziato una qual
sorta di processamento semantico che poi continuerebbe nell’area 39 e nell’area 19 e oltre, dunque l’ipotesi
di un sostanziale “allargamento” dell’area semantica .
Nel caso del bambino autistico su cui stiamo riferendo, possiamo allora ipotizzare che il ‘rumore’
consonantico induceva a intuire la presenza di una parola, la musicalità (quale organizzazione delle altezze
e concatenazione delle durate) offriva la struttura proposizionale: insieme venivano correlate alla situazione
pragmatica consentendo le prime forme di concettualizzazione per la relazione suono significato. Ma, poiché
tale concettualizzazione si basa anche sul riconoscimento dell’intenzione comunicativa nel contesto di
attenzione condivisa ecco l’altro problema per il bambino, effetto a cascata della dinamica funzionale
cerebrale che gli pertiene. Infatti, se l’acquisizione delle parole e del loro significato si basa su processi che
includono l’abilità a inferire le intenzioni comunicative degli interlocutori quando utilizzano delle parole,
intenzione di riferirsi a degli oggetti o a delle situazioni, di trasmettere un significato, delle informazioni, ecco
di nuovo che il lavoro dell’area temporale , oltre a dover fare i conti con le difficoltà di segmentazione
dell’onda sonora dovute ad una funzionalità anomala, deve misurarsi anche con la relazione con l’area
frontale per quanto attiene alla capacità di inferire sugli stati informazionali della mente propria e altrui,
entrando quindi in quel circuito di effetti a cascata già accennato sopra .
In conclusione, nella musicalità intravediamo il processo che consente di sviluppare un rapporto
contestualizzato coerente tra suono e significato; dalla percezione pragmatica globale del senso, convalidata
dalle reazioni socio-affettive degli interlocutori, il bambino progressivamente costruisce dimensioni sempre
più ristrette e selezionate di tale rapporto, passando dal gioco vocale al gioco cognitivo al gioco linguistico:
una trama di relazioni che progressivamente costruiscono una semantica referenziale sulla base originaria di
una semantica affettiva e cognitiva, dove sono le selezioni socialmente condivise a determinare la
stabilizzazione delle configurazioni neuronali associate all’esperienza linguistica in corso. Ecco perché
riteniamo così importante riconoscere i segni della musicalità nel bambino autistico,e ancor più non
disperderne la potenzialità evolutiva.
LEA - soggetti con Linguaggio Ecolalico,
Alcuni bambini autistici, uscendo dal periodo di chiusura, mostrano di progredire verso il linguaggio
passando attraverso la riproduzione ecolalica, anche differita, di enunciati ascoltati, usati prima come vere e
proprie formule inanalizzate. Successivamente tali enunciati possono essere destrutturati nelle unità
sintagmatiche componenti che quindi vengono variamente ricomposte, dando così origine ad un tipo di
eloquio che presenta le caratteristiche del linguaggio creativo.
All’interno di questo gruppo, occorre distinguere non tanto in ragione della fluenza che, con differenze
relative di fatto non significative, viene comunque raggiunta, talvolta anche con capacità grammaticali
notevoli, quanto piuttosto sulla relazione tra aspetti linguistici e aspetti comunicativi. Precisamente, si
individuano due sottotipi principali.
1)ECA - soggetti con Ecolalia Comunicativa

8
Si tratta di bambini che all’inizio producono enunciati fortemente vincolati a ciò che potremmo chiamare
“l’inventario” di quanto è stato da loro assimilato per riproduzione analogica dell’input linguistico ricevuto, e
dunque enunciati che appartengono ad una sorta di idioletto del soggetto che li ha formati sulla base di una
corrispondenza tra significato globale e uso pragmatico di quei medesimi enunciati. Si ricordi, a titolo
esemplificativo, l’esempio di A. (9 anni di età) che chiede alla madre di aprire la portiera dell’auto
parcheggiata in giardino usando la formula “blu, voglio blu” che egli usa di solito quando vuole che la madre
gli apra la scatola dei biscotti. Per A. in questo periodo, dunque, “blu” significa aprire. Di conseguenza, il
significato che tali enunciati all’inizio posseggono non è di tipo composizionale, vale a dire determinato in
base al contributo semantico delle singole unità componenti, quanto piuttosto di tipo contestuale, in quanto
è fissato dal ‘senso’ della scena in cui tali frasi sono state fruite. Ne consegue una iniziale diffusa ‘infelicità’
(nel senso di Austin) degli atti linguistici compiuti. Successivamente, tuttavia, la capacità linguistica e quella
comunicativa divengono sempre più congrue, in ragione dell’emergere di un’abilità linguistica di tipo
creativo. La capacità di scomporre le formule d’origine nelle unità linguistiche formate dai gruppi di parole
sintagmaticamente componenti, e di ricomporre i segmenti così ottenuti in strutture variate,
progressivamente rende il soggetto capace di dare all’enunciato la forma sempre più perfettamente
corrispondente al significato voluto e all’intenzione comunicativa che lo determina. L’effetto è che nella
conquistata fluenza permangono soltanto episodi sporadici di inadeguatezza comunicativa degli enunciati
prodotti, quello che nella letteratura viene spesso indicato come la ‘stranezza’ dell’autistico fluente.
2)ENCA - soggetti con Ecolalia Non Comunicativa
All’interno di questo gruppo troviamo un’altra tipologia di comportamento linguistico, che è contraddistinta
da una fluenza talvolta perfino maggiore del pari età del tipo ECA, ma che però manifesta caratteristiche
diverse sia linguistiche che pragmatiche. Nello specifico, si tratta di fatto di soliloquio ecolalico, nel senso
che è sufficiente un elemento lessicale presente nell’enunciato dell’interlocutore per far sì che scatti nel
bambino autistico un’associazione immediata che ‘uncina’ a quella parola tutto un enunciato il quale, però,
non ha niente a che vedere, né semanticamente né pragmaticamente, con quanto è o cerca di essere
oggetto di scambio comunicativo. Ad esempio, basta che la terapista faccia una domanda ad P. (9 anni di
età) usando una frase in cui è presente la parola “cappello”, che subito scatta da parte di P. la produzione
della battuta di un noto cartone animato, ma priva di qualunque intento o di citazione voluta o di scherzo o
ironia: è una pura e semplice associazione.
(1)
T: e te c’hai un cappello in testa?
P: togliti quel cappello dalla testa Braccio di Ferro! Puu! No!
togliti quel cappello dalla testa Braccio di Ferro! Puu! No!
T: Braccio? senti non ho capito, Braccio di Ferro?
P: togliti quel cappello dalla testa Braccio di Ferro! Puu! No!
Che si tratti di un soliloquio lo testimonia il fatto che il testo prodotto è completamente disconnesso,
semanticamente e pragmaticamente, dalla situazione comunicativa, pertanto non avviene uno scambio
conversazionale tra parlante autistico ed il suo interlocutore, restano due forme di enunciazione connesse
solo da quel singolo punto di incontro lessicale che ha fatto scattare l’associazione verbale; inoltre si tratta
di enunciati che possono godere di una certa estensione, costituiti da frasi aventi relativa proprietà

9
grammaticale, ed anche lessici altamente specifici. Si veda il seguente enunciato prodotto a seguito della
presenza nel testo della terapista della parola “trasmissione”, ed in ripetizione di una probabile trasmissione
sulla preistoria vista da P.
(2)
P. ok! comincia! raupiteco scende giù dall’albero diventa australopiteco e poi australopiteco si è evoluto
homo abilis, poi la ricevoluzione di abilis è la trasformazione che è diventato homo erectus, poi la
ricevoluzione di homo erectus è diventato homo sapiens, poi homo sapiens era homo sapiens sapiens.
homo sapiens.. sapiens scrive tut.. facevano tanti disegni nuovi che parlavano degli animali o dei disegnini
tanti preistorici, poi vedevano tutti i disegni nel nella trus..scruttura, scru ttu ra va
Dunque l’ecolalia, - uno dei comportamenti linguistici più caratterizzati nel disturbo autistico - può presentarsi
sia dotata di caratteristiche funzionali comunicative quanto priva di esse, principalmente a seconda dei casi
clinici, ma anche in uno stesso soggetto in rapporto a differenti condizioni. La questione diventa capire quali
sono le caratteristiche di tale fenomeno, quali fattori funzionali siano alla base della capacità o incapacità
comunicativa ad essa connessa, e se e come da esso possano scaturire forme di linguaggio cosiddetto
creativo, cioè quel linguaggio governato da regole sulla cui base dagli elementi base vengono a prodursi
costituenti sempre più vasti in rapporto al sistema grammaticale coinvolto.
Per quanto riguarda la possibile base neurofunzionale sottostante ai due tipi individuati, ci rifacciamo ad un
recente studio Catani et al.2005, dove si propone di analizzare, mediante le nuove tecniche di imaging, in
modo più dettagliato il fascicolo arcuato L’analisi è stata fatta su 11 adulti destrimani e col sistema della
trattografia MRI (imaging di risonanza magnetica); da essa sono emersi tre tipi di connessioni: 1) un lungo
segmento che connette il lobo frontale con quello temporale, corrispondente al fascicolo arcuato classico; 2)
un segmento posteriore laterale che connette il lobo temporale con il lobo parietale; 3) un segmento
anteriore laterale che connette il lobo frontale con il lobo parietale. In altri termini, nell’area perisilviana
venivano ad essere identificati due percorsi di connessione tra frontale e temporale, uno diretto, costituito dal
lungo segmento mediano già anticipato da Wernicke, ed uno indiretto, costituito da due segmenti: uno
posteriore che collega il temporale col parietale, ed uno anteriore che collega il parietale col frontale. Si tratta
dunque di una connettività assai più complessa di quanto si potesse prevedere, in merito alla quale Catani et
al. 2005 propongono precise ipotesi funzionali, ragionando sui vari tipi di afasia attestati in relazione alle
differenti lesioni che interessano la regione: il percorso diretto sembra essere collegato alle funzioni
strettamente fonologiche quali la ripetizione automatica, il percorso indiretto, invece, alle funzioni
semantiche. Ovviamente questo non significa che tali funzioni sono da localizzarsi esclusivamente in questa
area, significa piuttosto, e in modo per noi ancor più interessante, che le due funzioni sono anatomicamente
dissociabili. Inoltre l’estensione delle connessioni fuori dei limiti classici delle aree di Broca e Wernicke
rispettivamente, porta a ritenere la corteccia parietale inferiore un’area linguistica primaria separata con
connessioni fitte alle classiche aree per il linguaggio. Si tratta delle aree 39 e 40 di Brodmann, regione di cui
Geshwind fin dal 1965 aveva sottolineato l’importanza per il linguaggio, di conseguenza gli autori nominano
questa regione, confermata adesso da prove di neuroimaging, territorio di Geshwind.
Pur nella circoscrivibilità della ricerca, dato che non include l’analisi di altre connessioni, ad es. quella
talamica, rilevanti per le funzioni linguistiche, tuttavia alcuni suggerimenti puntano direttamente a chiarire
alcuni aspetti del linguaggio ecolalico nell’autismo qui considerati.

10
Per quanto riguarda i soggetti ENCA, il tracciato diretto assicura la ripetizione fonologica corretta, mentre le
connessioni anomale sul territorio di Geshwind, correlate al processing semantico, disconnettono la
fonologia dal significato e sottostanno al soliloquio semanticamente deprivato. L’eloquio possiede una decisa
fluenza nella ripetizione fonologica, tuttavia presenta tratti di variazione molto interessanti. Sul piano della
forma morfo-fonologica, troviamo neologismi che fanno sospettare la dominanza della dimensione ecolalia di
impianto fonologico, in quanto spesso la combinazione di frasi è solo la giustapposizione di sequenze
foniche completamente irrelate dal punto di vista semantico. Esistono tuttavia ‘isole’ di coerenza, nel senso
che alcune parti del testo sono sufficientemente controllate anche sul livello semantico. Emerge dunque una
palese, intermittente, dissociazione tra forma fonologica e realizzazione semantica dello stesso enunciato
prodotto; la ripetizione è fluente ma la comprensione è tuttavia estremamente ridotta, e limitata al significato
originario di frammenti del percepito.
Per quanto riguarda il caso dei soggetti ECA, possiamo semplicemente supporre che il territorio di Geshwind
insieme alle connessioni associative dirette costituiscano la base neurobiologica della produzione ecolalica.
Da un lato, la probabile assenza di anomalie nella rete per la percezione dei suoni complessi (Boddaert et
al. 2004), rende conto del fatto che il linguaggio si presenta con caratteristiche normali dal punto di vista
della forma sia fonologica che grammaticale. Dall’altro lato, la perseverazione intesa come mancata abilità a
organizzare nuove forme di risposta in relazione al mutare degli stimoli ambientali può essere ricollegata al
noto interessamento dei lobi frontali, in particolare delle aree frontali orbito-mesiali, nel quadro autistico per
quanto riguarda vari sintomi fra i quali l’anomalia della pragmatica del linguaggio.
Questi casi tuttavia evidenziano il ruolo della ripetizione analogica di forme e strutture linguistiche
nell’acquisizione.
Abbiamo già sottolineato come nei casi di ecolalia comunicativa, attraverso l’uso differito di un linguaggio
formulaico di natura olistica, nel gioco verbale di attribuire e riconoscere un significato non
composizionalmente ma globalmente rispetto alla situazione pragmatica, il bambino autistico via via
accumula sufficiente esperienza per progredire verso la capacità di segmentazione e ricomposizione: gli
iniziali enunciati globali, riprodotti letteralmente sulla base di legami pragmatici fra la vecchia e la nuova
situazione, progressivamente vengono scomposti nei pezzi componenti, sempre più ristretti, fino alle
variazioni morfologiche, e i segmenti così ottenuti vengono ricomposti in strutture variate, dando così luogo
alla comparsa di un linguaggio di tipo creativo. É come se ci trovassimo di fronte ad una iper-funzione
perseverante aplicata ad una processo che comunque pertiene allo sviluppo regolare del linguaggio. Sulla
base del felice incontro fra le ricerche linguistiche condotte da decenni sulla fonologia articolatoria con i dati
emergenti dalla ricerca sui neuroni specchio, possiamo elaborare una ipotesi congrua a quanto stiamo
trattando in merito all’ecolalia. Il parlato organizzato fonologicamente presuppone l’abilità di imitare
localmente, la quale dipende da un meccanismo che fa percepire il sé e l’altro da sé isomorfici. Il
trasferimento trasmodale degli stimoli trova conferma nei neuroni specchio audiovisivi (Rizzolatti; Kohler et
al. 2002) che codificano l’azione indipendentemente se essa sia eseguita, udita o vista.
Abbiamo già visto sopra, trattandoi il caso DSLA, le dinamiche reletive al fatto che l’unità iniziale dell’agire
fonetico nel bambino sia la parola olistica: un semplice algoritmo ne compie l’analisi automatica in elementi
più piccoli che quindi vengono riusati grazie alla organizzazione combinatoria. Col tempo la variabilità
dell’input viene disambiguata dal contesto e dagli indici che forniscono etichettature semantiche e
situazionali e così categorizzata. E’ un meccanismo formalmente similare tanto per lo sviluppo fonologico

11
che lessicale. In tale ottica, diviene rilevante il rapporto fra la capacità di imitazione e l’uso di riproduzione
ecolalica, in quanto tale forma di enunciazione realizzerebbe concretamente le proprietà di globalità e di
sensibilità al contesto che, secondo il nostro approccio, caratterizzano gli inizi del linguaggio nel
bambino/nella bambina. L’acquisizione delle parole e del loro significato (Bloom 2000, Tomasello 2003) si
basa su processi che includono l’abilità a inferire le intenzioni comunicative delle persone del contesto
quando utilizzano delle parole: intenzione di riferirsi a degli oggetti o a delle situazioni, di trasmettere un
significato, delle informazioni. Quando la percezione pragmatica globale del senso riceve conferma dalle
reazioni socio-affettive degli interlocutori, il bambino procede verso dimensioni sempre più ristrette e
selezionate del rapporto tra suono e significato.
Su questo terreno di comunicazione intersoggettiva, il bambino prima è spinto all’uso di enunciati
memorizzati sulla base di analogie contestuali e non perché li analizzi ancora nella loro struttura interna.
Dall’accumulo si questa esperienza il bambino diviene capace di analizzare gli enunciati nelle loro parti e di
estrarre porzioni sempre più ristrette - sintagmi, parole, morfemi - che poi può rimontare a suo piacimento.
Per tale via vengono a formarsi le categorie linguistiche astratte ed il linguaggio di tipo creativo.
Di fatto l’apprendimento iniziale del linguaggio, in generale, avverrebbe anche sulla base di comportamenti
ecolalici. Si constata infatti che il fenomeno ecolalico non era esclusivo della patologia del linguaggio. Fin dai
lavori di Peters 1977, ulteriormente sviluppati in Peters 1983, l’ecolalia aveva fatto la sua comparsa nella
descrizione dell’apprendimento del linguaggio in condizioni normali, in quanto si rilevava come nelle prime
produzioni linguistiche dell’apprendente accanto al linguaggio governato da regole compariva una forma di
parlato per formule, le quali altro non erano che enunciati olistici che venivano ripetuti così come erano stati
percepiti, quindi presentavano una complessità ed una correttezza grammaticale di gran lunga superiore a
quella propria del parallelo linguaggio governato da regole. Senza entrare troppo nel merito delle spiegazioni
funzionali di tipo socio-comunicativo date, già in Brandi 1996: 40 avevo sottolineato che Ann Peters
distingue uno stile analitico e uno stile gestaltico nello sviluppo della lingua materna. Lo stile analitico è usato
per assolvere a funzioni referenziali, per la costruzione di concetti lessicali, ecc.; lo stile gestaltico è il
tentativo di usare interi enunciati in una situazione socialmente appropriata, dunque in contesti
conversazionali. Peters sostiene che può esiste una variazione individuale fra i bambini riguardo alla
predominanza dello stile, ma può accadere anche che uno stesso bambino usi o l’uno o l’altro stile a
seconda delle situazioni, in particolare lo stile gestaltico per le funzioni sociali e lo stile analitico per le
funzioni referenziali, specificamente la nominazioni. Risalta tuttavia la sproporzione, in complessità
strutturale e adeguatezza, evidenziata fra i due tipi di parlato, quello per formule e quello di tipo creativo;
essa è tale da richiedere di essere approfondita e se possibile spiegata . Soprattutto chiede di essere
investigato il ruolo di una forma di parlato che non si basa sul processo composizionale previsto, entro ogni
modello di grammatica, come il fattore necessario e sufficiente per l’acquisizione del linguaggio, poiché si
tratta del processo che porta alla costruzione degli enunciati tramite l’espansione di strutture a partire dai
costituenti minimi grazie all’applicazione delle regole sintattiche proprie della grammatica nativa. Infatti la
natura olistica del linguaggio formulaico mette quest’ultimo fuori dalla portata di qualunque applicazione della
grammatica in quanto nel funzionamento ne viola il procedere per via analitica e nella percezione
dell’apprendente asserisce l’assenza di attribuzione di una struttura interna.
Anche Fabbro 2004 richiama il ruolo dell’ecolalia sia nell’apprendimento della lingua nativa che della lingua
seconda; la questione è ripresa da Aglioti e Fabbro (2006, p. 36-37) che la riconoscono tra i meccanismi

12
base dell’apprendimento del linguaggio articolato, evidenziando inoltre il legame tra la progressiva
scomparsa di comportamenti linguistici ecolalici e la sufficiente maturazione dei lobi frontali deputati alla loro
inibizione, collocata intorno ai 36 mesi. In sostanza prende corpo l’idea che almeno per una parte dei
processi di acquisizione del linguaggio l’apprendente è spinto all’uso di enunciati memorizzati sulla base di
analogie contestuali e non perché li analizzi nella loro struttura interna.
Tutto ciò porta a pensare che nei casi di ECA si tratta in sostanza di lavorare strategicamente ad
incrementare e potenziare una modalità di processing che tuttavia già il bambino possiede in modo latente,
vale dire operare verso progressive destrutturazioni e ristrutturazioni variate delle formule in uso, cogliendo
progressivamente il focus di attenzione distribuzionale che può essere latente se pur in modo opacizzato.
Riferimenti bibliografici
Aglioti S.M., Fabbro F. 2006 Neuropsicologia del linguaggio, Bologna, il Mulino. Bloom, P. 2000 How children learn the meanings of words, Cambridge, Mass., The MIT Press. Boddaert N., Chabane N., Belin P., Bourgeois M., Royer V. Barthelemy C., Mouren-Simeoni M-C., Philippe A., Brunelle F., Samson Y., Zilbovicious M. 2004 “Peception of complex sounds in autism: abnormal auditory cortical processing in children”, American Journal of Psychiatry, 161: 2117-2120. Brandi, L. 2003 “Tra musica e linguaggio: alle origini della parola”, Quaderni del Dipartimento di Linguistica, 13, pp.31-53 Brandi L., Bigagli A. 2004 “Neuroni specchio, linguaggio e autismo”, Quaderni del Dipartimento di Linguistica, 14: 153-162. Brandi, L. (2005). Linguaggio e comunicazione. Dis/giunzioni artistiche. Quaderni del Dipartimento di Linguistica, 15, 169-192. Brandi, L., Bigagli, A., Mantovan, M. Salvatori, C.& Simonetti C. (2007 in stampa). Disturbi del linguaggio nell’autismo: tipi clinico-linguistici,.Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Changeux, J.P. (2003). L’uomo di verità. Milano: Feltrinelli. Catani, M., Jones D., ffychte D.H. 2005 “Perisylvian language networks of the human brain”, Annals of Neurology, 57: 8-
16. Cutler A. (1996), Prosody and the word boundary problem, in J.L. Morgan, K. Demuth (eds.) Signal to syntax, Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Assoc. Pub.. De Fossé L., Hodge S.M., Makris N., Kennedy D.N., Caviness Jr. V.S., McGrath L., Steele S., Ziegler D., Herbert M.R., Frazier J.A., Tager-Flusberg H., Harris G.J. 2004 “Language-association cortex asymmetry in autism and specific language impairment”, Annals of Neurology, 56: 757-766. Fabbro, F. 2004 Neuropedagogia delle lingue, Roma, Astrolabio. Gallese, V. 2003 “Neuroscienza delle relazioni sociali”, in Ferretti F. (a cura di), La mente degli altri, Roma, Editori
Riuniti: 13-44. Gerken, L.A. 1996 Phonological and distributional information in syntax acquisition, in Morgan J.L., Demuth K. (eds.) Signal to syntax, Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Assoc. Pub.: 411-425. Harris, J. 1994 English sound structure, Oxford, Blackwell.
Herbert M.R., Ziegler D.A., Deutsch C.K., O’Brien L.M., Kennedy D.N., Filipek P.A., Bakardjiev A.I., Hodgson J., Takeoka M., Makris N., Caviness jr. V.S. 2005, “Brain asymmetries in autism and developmental language disorder: a nested whole-brain analysis”, Brain, 128 (1): 213-226. Lambiase, M. 2004 Autismo e lobi frontali, Gussago (BS), Vannini Editore. Nespor,M., Peña, M. & Mehler, J. (2003). On the different roles of vowels and consonants in speech processing and language acquisiztion. Lingue e linguaggio, II, “, 203-230. Peters A.M. 1977 Language learning strategies: does the whole equal the sum of the parts?, Language, 53: 560-573. Peters A.M. 1983 Units of language acquisition, Cambridge, Cambridge University Press. Rizzolatti G, Buccino G. 2005 “The mirror neuron system and its role in imitation and language”, in Dehaene , Duhamel, Hauser, Rizzolatti (a cura di), From monkey brain to human brain. , Cambridge, Mass, The MIT Press, pp. 213-233. Kohler E., Keysers C., Umiltà A.M., Fogassi L., Gallese V., Rizzolatti G., 2002 “Hearing sounds, understanding actions: Action representation in mirror neurons”, Science, vol. 297: 846-848. Studdert-Kennedy, M. 2000 “Imitation and th emergence of segments”, Phonetica, 57: 275-283. Tomasello, M. 2003 Constructing a language, Cambridge, Harvard University Press. Trevarthen, C. 1999 “Musicality ant the intrinsic motive pulse: evidence from human psychobiology and infant communication”, Musicae scientiae, special Issue “Rythms, musical narrative, and the origins of human communication”, Liege, European Society for the Cognitive Sciences of music: 157-213..