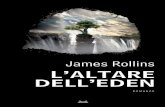Rassegna stampa 12 luglio 2017 - patriarcatovenezia.it · All’origine del disagio sociale, idee e...
Transcript of Rassegna stampa 12 luglio 2017 - patriarcatovenezia.it · All’origine del disagio sociale, idee e...
RASSEGNA STAMPA di mercoledì 12 luglio 2017
SOMMARIO
“Con il motuproprio Maiorem hac dilectionem sull’offerta della vita - scrive l’arcivescovo Marcello Bartolucci sull’Osservatore Romano di oggi -, Papa Francesco ha
aperto la via alla beatificazione di quei fedeli che, spinti dalla carità, hanno offerto eroicamente la propria vita per il prossimo accettando liberamente e volontariamente una morte certa e prematura con l’intento di seguire Gesù: «Egli ha dato la sua vita
per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Giovanni 3, 16). Come si sa, ormai da secoli le norme della Chiesa cattolica prevedono che si possa
procedere alla beatificazione di un servo di Dio percorrendo una di queste tre vie. 1) La via del martirio che è la suprema imitazione di Cristo e la testimonianza più alta della carità. Il concetto classico di martirio comprende: a) l’accettazione volontaria
della morte violenta per amore di Cristo, da parte della vittima; b) l’odium del persecutore per la fede, o per un’altra virtù cristiana; c) la mitezza e il perdono della
vittima che imita l’esempio di Gesù, il quale sulla croce invocò la misericordia del Padre per i suoi uccisori. 2) La via delle virtù eroiche, esercitate «speditamente,
prontamente, piacevolmente e sopra il comune modo di agire, per un fine soprannaturale» (Benedetto XIV) e per un congruo periodo di tempo, ossia fino a farle
diventare un modo abituale di essere e di agire conforme al Vangelo. Si tratta delle virtù teologali (fede, speranza, carità), cardinali (prudenza, giustizia, fortezza,
temperanza) e “annesse” (povertà, obbedienza, castità, umiltà). 3) C’è, poi, una terza via, meno conosciuta e meno battuta, che, però, conduce allo stesso risultato
delle altre due. È la via dei cosiddetti casus excepti, così chiamati dal Codice di diritto canonico del 1917 (cfr. cann. 2125-2135). Il loro riconoscimento porta alla conferma
di un culto antico, cioè successivo al pontificato di Alessandro III († 1181) e antecedente al 1534, così come stabilì Urbano VIII (1623-1644), il grande legislatore delle cause dei santi. La conferma del culto antico è chiamata anche “beatificazione equipollente”. Queste tre vie sono tuttora aperte e percorribili, ma non sembra che siano sufficienti per interpretare tutti i casi possibili di santità canonizzabile. Infatti, ultimamente, la Congregazione delle cause dei santi si è posta la domanda «se non
siano meritevoli di beatificazione quei servi di Dio che, ispirati dall’esempio di Cristo, abbiano liberamente e volutamente offerto e immolato la propria vita per i fratelli in
un supremo atto di carità, che sia stato direttamente causa di morte, mettendo così in pratica la parola del Signore: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Giovanni 15, 13)» (Positio peculiaris, p. 3). Si tratta di introdurre
una quarta via, che potremmo chiamare dell’offerta della vita. Pur avendo alcuni elementi che la fanno assomigliare sia alla via del martirio che a quella delle virtù
eroiche, è una via nuova che intende valorizzare una eroica testimonianza cristiana, finora senza una procedura specifica, proprio perché non rientra del tutto nella
fattispecie del martirio e neppure in quella delle virtù eroiche. La via dell’offerta della vita, infatti, assomiglia parzialmente a quella del martirio perché c’è l’eroico
dono di sé, fino alla morte inclusa, ma se ne differenzia perché non c’è un persecutore che vorrebbe imporre la scelta contro Cristo. Similmente, la via
dell’offerta della vita assomiglia a quella delle virtù eroiche perché c’è un atto eroico di carità (dono di sé), ispirato dall’esempio di Cristo, ma se ne differenzia perché non è l’espressione di un prolungato esercizio delle virtù e, in particolare, di una carità eroica. Si richiede, comunque, un esercizio ordinario di vita cristiana, che renda
possibile e comprensibile la decisione libera e volontaria di donare la propria vita in un atto supremo di amore cristiano, che superi il naturale istinto di conservazione,
imitando Cristo, che si è offerto al Padre per il mondo, sulla croce. È chiaro, pertanto, che tutte le vie alla santità canonizzata debbono avere un denominatore comune
nella carità, che è “vincolo della perfezione”, “pienezza della legge” e “anima della santità”. Anche l’offerta della vita, quindi, non può prescindere dalla perfezione della
carità, che in questo caso, però, non è il risultato di una prolungata, pronta e gioiosa ripetizione di atti virtuosi, ma è un unico atto eroico che per la sua radicalità,
irrevocabilità e persistenza usque ad mortem esprime pienamente l’opzione cristiana. I teologi, poi, insegnano che, in forza della “connessione” tra le virtù, dove c’è un atto eroico di carità non può mancare un corrispondente atto di fede, speranza, prudenza, fortezza e così via. Va pure detto che il fattore tempo, ossia la durata
dell’offerta ha una sua rilevanza. Infatti, se l’atto eroico dell’offerta si protrae negli anni, potrebbe alla fine rientrare nella fattispecie delle virtù eroiche, che diventano
tali non solo perché sono l’espressione di comportamenti straordinariamente perfetti, ma anche perché protratti per un tempo notevole, che la giurisprudenza canonica
indica in una decina di anni di pratica nei casi ordinari. Per delimitare questo aspetto il motuproprio parla molto opportunamente di “morte a breve termine”, il che non vuol dire immediata ma neppure così lontana da trasformare l’atto eroico in virtù eroica. Nel qual caso muterebbe la fattispecie. Qualora si verifichi la compresenza
della offerta eroica della vita con l’esercizio eroico delle virtù cristiane, è ovvio, che l’iter giuridico preferirà la fattispecie delle virtù eroiche, che esprimono più
compiutamente la personalità del servo di Dio, la santità e la sinfonia delle sue ricchezze spirituali. Se fosse possibile tracciare una graduatoria dei percorsi giuridici per l’accertamento della santità canonizzabile, potremmo concludere che al primo posto sta il martirio, al secondo le virtù eroiche, al terzo l’atto eroico dell’offerta
della vita fino alla morte inclusa. Per concludere il ragionamento possiamo tranquillamente asserire che chi sigilla la sua vita con un atto eroico di carità, può essere considerato perfetto discepolo di Cristo e, come tale, meritevole di essere
proposto quale modello di vita cristiana, qualora Dio stesso ne garantisca l’autenticità e l’esemplarità mediante la fama di santità, la prova dei miracoli e il giudizio
favorevole della suprema autorità della Chiesa. L’offerta della vita usque ad mortem, finora non costituiva una fattispecie a sé stante, ma, se c’era, veniva incorporata,
solo come dettaglio, nella fattispecie delle virtù eroiche, oppure in quella del martirio. È ormai chiaro che questa incorporazione non rendeva giustizia a una vera e, per molti aspetti, toccante espressione di santità (…) Con questo provvedimento la dottrina sulla santità cristiana canonizzabile e la procedura tradizionale della Chiesa per la beatificazione dei servi di Dio non soltanto non sono state alterate, ma si sono
arricchite di nuovi orizzonti e opportunità per l’edificazione del popolo di Dio, che nei suoi santi vede il volto di Cristo, la presenza di Dio nella storia e l’esemplare
attuazione del Vangelo” (a.p.)
3 – VITA DELLA CHIESA L’OSSERVATORE ROMANO Pag 7 La quarta via di Marcello Bartolucci Una nuova fattispecie nell’iter processuale delle canonizzazioni Pag 7 Maiorem hac dilectionem Motuproprio sull’offerta della vita nelle cause dei santi AVVENIRE Pag 2 Nuovo modo di capire la santità di sempre di Stefania Falasca Il motu proprio di Papa Francesco Pag 5 “L’offerta della vita”, via nuova verso gli altari di Gianni Cardinale, Riccardo Maccioni e Filippo Rizzi La decisione del Papa con un motu proprio. Dai miracoli alla morte “in odium fidei”: ecco come si diventa beati. Apeciti: una luce su eroismi spesso vissuti nel nascondimento Pag 16 Il capo scout: sono gay. La comunità si interroga di Luciano Moia L’arcivescovo di Gorizia invita al discernimento: “Diritto al rispetto, ma ricerca della verità”
IL GIORNALE Il Papa voleva fare cardinale un laico di Stefano Filippi e Serena Sartini Il monaco filosofo che rifiutò anche la politica IL FOGLIO Pag 2 Fate politica, ma fatela bene. Il Papa chiama i giovani, che rispondono di Matteo Matzuzzi Lab.ora-Servitori del bene comune. Contro l’apatia dei Millennial 5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO AVVENIRE Pag 3 Debito pubblico e miseria, una spirale che va spezzata di Francesco Gesualdi All’origine del disagio sociale, idee e provocazioni LA NUOVA Pag 1 Strategia per crescita e lavoro di Giulio Buciuni e Giancarlo Corò Pag 6 Sono le donne che guidano la ripresa I dati di Confcooperative: le imprese in rosa crescono più della media, boom delle coop femminili Pag 6 In Italia ci sono 307mila famiglie milionarie L’1,2% del totale detiene il 20,9% della ricchezza 7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA CORRIERE DEL VENETO Pag 3 Venezia e Mestre separate, via libera al referendum: “Voteremo il 22 ottobre” di Marco Bonet e Andrea Zucco Ingorgo elettorale in Regione Pag 5 Le mura veneziane (ma non di Venezia) diventano patrimonio dell’umanità di Paolo Coltro Da Palmanova a Peschiera, da Bergamo a Zara: “Spot da due milioni di dollari” Pag 11 San Marco su prenotazione dal 2018. E tassa di sbarco in alcune isole di Gloria Bertasi La giunta approva le linee per la gestione dei flussi. Ipotesi di limitazioni per fasce orarie (10-18) dell’area marciana. Bus e auto turistiche contingentati LA NUOVA Pagg 2 – 3 Passa il referendum in consiglio regionale di Alberto Vitucci e Nicola Brillo Separazione Venezia – Mestre. Ora Zaia deciderà la data, probabile il 22 ottobre Pag 18 Comunità ebraica, Gnignati confermato Presidente per altri quattro anni IL GAZZETTINO DI VENEZIA Pag V Brugnaro: pronto a far campagna per il no di Roberta Brunetti Lettera polemica di Bellati: “Quel patto scritto tradito dopo aver incassato i voti della Lega” 8 – VENETO / NORDEST CORRIERE DEL VENETO
Pag 1 Carrozzoni duri a morire di Marco Bonet La nuova partecipata … ed inoltre oggi segnaliamo… CORRIERE DELLA SERA Pag 1 Gli eterni interessi nazionali di Angelo Panebianco Europa e illusioni Pag 13 Lombardia e Veneto, i referendum gemelli che non si somigliano di Dario Di Vico Sull’autonomia a Venezia serve il quorum, a Milano no Pag 28 Non si giudica il passato da prigionieri del presente di Ernesto Galli della Loggia LA STAMPA Se la mafia teme la scuola di Alessandro D’Avenia AVVENIRE Pag 1 Nel nome dei figli di Andrea Sciarretta Il papà di Noemi per il piccolo Charlie Pag 3 Quei sette zeri che incendiano l’Italia di Antonio Maria Mira Boschi in fiamme: non-prevenzione e altri nodi Pag 21 La demagogia si vince tornando al bene comune di Stefano Vecchia Parla l’intellettuale indiano Pankaj Mishra L’OSSERVATORE ROMANO Pag 4 Per un’intelligenza artificiale che sia sociale di Solène Tadié A colloquio con Luciano Floridi Pag 5 Un’idea sbagliata di islam di Paolo Branca Nei circa mille oratori della diocesi di Milano un quarto dei giovani sono musulmani IL FOGLIO Pag 1 “L’islam prenderà l’Europa con le nascite” di Giulio Meotti L’arcivescovo di Strasburgo Luc Ravel evoca il “grand remplacement” IL GAZZETTINO Pag 1 Tre ragioni per rinunciare allo ius soli di Carlo Nordio LA NUOVA Pag 8 La violenza inconsulta vista da chi è vulnerabile di Costanza Jesurum
Torna al sommario 3 – VITA DELLA CHIESA L’OSSERVATORE ROMANO Pag 7 La quarta via di Marcello Bartolucci Una nuova fattispecie nell’iter processuale delle canonizzazioni Con il motuproprio Maiorem hac dilectionem sull’offerta della vita, Papa Francesco ha aperto la via alla beatificazione di quei fedeli che, spinti dalla carità, hanno offerto eroicamente la propria vita per il prossimo accettando liberamente e volontariamente
una morte certa e prematura con l’intento di seguire Gesù: «Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Giovanni 3, 16). Come si sa, ormai da secoli le norme della Chiesa cattolica prevedono che si possa procedere alla beatificazione di un servo di Dio percorrendo una di queste tre vie. 1) La via del martirio che è la suprema imitazione di Cristo e la testimonianza più alta della carità. Il concetto classico di martirio comprende: a) l’accettazione volontaria della morte violenta per amore di Cristo, da parte della vittima; b) l’odium del persecutore per la fede, o per un’altra virtù cristiana; c) la mitezza e il perdono della vittima che imita l’esempio di Gesù, il quale sulla croce invocò la misericordia del Padre per i suoi uccisori. 2) La via delle virtù eroiche, esercitate «speditamente, prontamente, piacevolmente e sopra il comune modo di agire, per un fine soprannaturale» (Benedetto XIV) e per un congruo periodo di tempo, ossia fino a farle diventare un modo abituale di essere e di agire conforme al Vangelo. Si tratta delle virtù teologali (fede, speranza, carità), cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) e “annesse” (povertà, obbedienza, castità, umiltà). 3) C’è, poi, una terza via, meno conosciuta e meno battuta, che, però, conduce allo stesso risultato delle altre due. È la via dei cosiddetti casus excepti, così chiamati dal Codice di diritto canonico del 1917 (cfr. cann. 2125-2135). Il loro riconoscimento porta alla conferma di un culto antico, cioè successivo al pontificato di Alessandro III († 1181) e antecedente al 1534, così come stabilì Urbano VIII (1623-1644), il grande legislatore delle cause dei santi. La conferma del culto antico è chiamata anche “beatificazione equipollente”. Queste tre vie sono tuttora aperte e percorribili, ma non sembra che siano sufficienti per interpretare tutti i casi possibili di santità canonizzabile. Infatti, ultimamente, la Congregazione delle cause dei santi si è posta la domanda «se non siano meritevoli di beatificazione quei servi di Dio che, ispirati dall’esempio di Cristo, abbiano liberamente e volutamente offerto e immolato la propria vita per i fratelli in un supremo atto di carità, che sia stato direttamente causa di morte, mettendo così in pratica la parola del Signore: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Giovanni 15, 13)» (Positio peculiaris, p. 3). Si tratta di introdurre una quarta via, che potremmo chiamare dell’offerta della vita. Pur avendo alcuni elementi che la fanno assomigliare sia alla via del martirio che a quella delle virtù eroiche, è una via nuova che intende valorizzare una eroica testimonianza cristiana, finora senza una procedura specifica, proprio perché non rientra del tutto nella fattispecie del martirio e neppure in quella delle virtù eroiche. La via dell’offerta della vita, infatti, assomiglia parzialmente a quella del martirio perché c’è l’eroico dono di sé, fino alla morte inclusa, ma se ne differenzia perché non c’è un persecutore che vorrebbe imporre la scelta contro Cristo. Similmente, la via dell’offerta della vita assomiglia a quella delle virtù eroiche perché c’è un atto eroico di carità (dono di sé), ispirato dall’esempio di Cristo, ma se ne differenzia perché non è l’espressione di un prolungato esercizio delle virtù e, in particolare, di una carità eroica. Si richiede, comunque, un esercizio ordinario di vita cristiana, che renda possibile e comprensibile la decisione libera e volontaria di donare la propria vita in un atto supremo di amore cristiano, che superi il naturale istinto di conservazione, imitando Cristo, che si è offerto al Padre per il mondo, sulla croce. È chiaro, pertanto, che tutte le vie alla santità canonizzata debbono avere un denominatore comune nella carità, che è “vincolo della perfezione”, “pienezza della legge” e “anima della santità”. Anche l’offerta della vita, quindi, non può prescindere dalla perfezione della carità, che in questo caso, però, non è il risultato di una prolungata, pronta e gioiosa ripetizione di atti virtuosi, ma è un unico atto eroico che per la sua radicalità, irrevocabilità e persistenza usque ad mortem esprime pienamente l’opzione cristiana. I teologi, poi, insegnano che, in forza della “connessione” tra le virtù, dove c’è un atto eroico di carità non può mancare un corrispondente atto di fede, speranza, prudenza, fortezza e così via. Va pure detto che il fattore tempo, ossia la durata dell’offerta ha una sua rilevanza. Infatti, se l’atto eroico dell’offerta si protrae negli anni, potrebbe alla fine rientrare nella fattispecie delle virtù eroiche, che diventano tali non solo perché sono l’espressione di comportamenti straordinariamente perfetti, ma anche perché protratti per un tempo notevole, che la giurisprudenza canonica indica in una decina di anni di pratica nei casi ordinari. Per delimitare questo aspetto il motuproprio parla molto opportunamente di “morte a breve termine”, il che non vuol
dire immediata ma neppure così lontana da trasformare l’atto eroico in virtù eroica. Nel qual caso muterebbe la fattispecie. Qualora si verifichi la compresenza della offerta eroica della vita con l’esercizio eroico delle virtù cristiane, è ovvio, che l’iter giuridico preferirà la fattispecie delle virtù eroiche, che esprimono più compiutamente la personalità del servo di Dio, la santità e la sinfonia delle sue ricchezze spirituali. Se fosse possibile tracciare una graduatoria dei percorsi giuridici per l’accertamento della santità canonizzabile, potremmo concludere che al primo posto sta il martirio, al secondo le virtù eroiche, al terzo l’atto eroico dell’offerta della vita fino alla morte inclusa. Per concludere il ragionamento possiamo tranquillamente asserire che chi sigilla la sua vita con un atto eroico di carità, può essere considerato perfetto discepolo di Cristo e, come tale, meritevole di essere proposto quale modello di vita cristiana, qualora Dio stesso ne garantisca l’autenticità e l’esemplarità mediante la fama di santità, la prova dei miracoli e il giudizio favorevole della suprema autorità della Chiesa. L’offerta della vita usque ad mortem, finora non costituiva una fattispecie a sé stante, ma, se c’era, veniva incorporata, solo come dettaglio, nella fattispecie delle virtù eroiche, oppure in quella del martirio. È ormai chiaro che questa incorporazione non rendeva giustizia a una vera e, per molti aspetti, toccante espressione di santità. Già Benedetto XIV, il magister, non escludeva dagli onori degli altari quelli che avevano dato la vita in un estremo atto di carità, come ad esempio, l’assistenza degli appestati che, scatenando il contagio, diventava causa certa di morte. Tutta questa problematica cominciò a diventare oggetto di esplicita riflessione della Congregazione delle cause dei santi, a partire dal congresso ordinario del 24 gennaio 2014. Il prefetto, cardinale Angelo Amato, portò la questione all’attenzione del Santo Padre Francesco nell’udienza del 7 febbraio successivo. Il Papa «approvò e incoraggiò» lo studio di questa nuova fattispecie, per cui il dicastero allestì una Positio peculiaris, con i contributi complementari di cinque studiosi delle cause dei santi: un biblista, un docente di teologia dogmatica, uno specialista in teologia spirituale, un giurista e uno storico. Il 2 giugno 2016 la Congregazione tenne sull’argomento un congresso peculiare composto da 15 esperti (10 consultori e 5 postulatori), diversi da quelli della Positio peculiaris. Presiedette la riunione il vescovo Enrico dal Covolo, soprattutto nella sua qualità di postulatore. La discussione si svolse sulla traccia di cinque quesiti, comunicati fin dalla convocazione del congresso e così formulati: «1. L’offerta della vita, seguita dalla morte, può essere giudicata come espressione di suprema ed eroica imitazione di Cristo? 2. Quali caratteristiche psicologiche e teologiche dovrebbe avere l’offerta della vita per essere un eroico atto di carità? 3. L’offerta della vita deve maturare nel contesto di una consolidata vita cristiana, oppure può essere una decisione improvvisa, senza cioè una preparazione remota? 4. È opportuno che l’offerta della vita sia una fattispecie distinta da quella del martirio e delle virtù eroiche? 5. La procedura giuridica per l’eventuale beatificazione per viam vitae oblationis, oltre l’inchiesta diocesana super vita, virtutibus, oblatione vitae, fama sanctitatis... deve comprendere anche la prova di un miracolo?» (Relatio et vota congressus peculiaris, p. 8). A ogni domanda fu risposto per iscritto dai quindici consultori e postulatori che poi si confrontarono in una riunione collegiale (congresso). Come è noto, le conclusioni dei congressi peculiari della Congregazione delle cause dei santi sono sempre importanti, perché esprimono il motivato parere di studiosi e di esperti che hanno esaminato a fondo la materia. Tuttavia, il loro voto non è deliberativo e vincolante. Nel nostro caso, l’ampio e sereno approfondimento del congresso portò a queste conclusioni: a) l’offerta della vita, seguita dalla morte, può essere giudicata come espressione di suprema ed eroica imitazione di Cristo, come emerge dal Nuovo Testamento, dalla tradizione dei martiri e dei confessori della fede, dal magistero dei Papi, dal concilio Vaticano II e dalla riflessione teologica, soprattutto a proposito della carità; b) l’offerta della vita, nella stragrande maggioranza dei casi, matura in un contesto di pratica delle virtù cristiane; c) circa il quesito se l’offerta della vita debba essere una fattispecie distinta da quella del martirio e della virtù eroiche, la maggioranza dei voti sostenne l’idea di configurare una fattispecie distinta, mentre una minoranza non lo ritenne opportuno; d) circa la procedura giuridica per l’eventuale beatificazione per viam vitae oblationis, oltre l’inchiesta diocesana super vita, virtutibus, oblatione vitae, fama sanctitatis, la maggioranza dei consultori e dei postulatori ritenne necessario, per la beatificazione, un miracolo formalmente approvato. Con questi pareri, il 27 settembre 2016, si andò alla sessione plenaria dei cardinali e vescovi, membri della
Congregazione delle cause dei santi. Anche in questa sede, i vari aspetti della questione furono messi a fuoco con profondità di dottrina e ampiezza di considerazioni pastorali. In conclusione i cardinali e i vescovi diedero voto favorevole a una nuova via per la beatificazione di chi ha offerto la vita con esplicite e riconosciute motivazioni cristiane. Fu pure evidenziata la necessità di un miracolo, formalmente approvato, quale conferma divina del giudizio umano sull’offerta della vita. Queste conclusioni furono sottoposte dalla Congregazione delle cause dei santi al Santo Padre Francesco con lettera del 28 novembre 2016 (Prot. Num. VAR 7454/14). Il 17 gennaio di quest’anno la Segreteria di Stato informava il cardinale Amato che Sua Santità «in data 10 gennaio corrente ha benevolmente approvato la proposta di procedere alla beatificazione di quei Servi di Dio la cui libera e volontaria offerta della vita sia divenuta causa della loro morte». Veniva pure richiesto alla Congregazione di «redigere il testo del pronunciamento pontificio» per presentarlo alla definitiva approvazione del Santo Padre. Il testo del citato pronunciamento pontificio è ora il motuproprio Maiorem hac dilectionem, firmato da Papa Francesco. Questo documento pontificio molto opportunamente all’art. 2 precisa: «L’offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio, deve rispondere ai seguenti criteri: a. offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione propter caritatem di una morte certa e a breve termine; b. nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura; c. esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell’offerta della vita e, poi, fino alla morte; d. esistenza della fama sanctitatis et signorum, almeno dopo la morte; e. necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione». L’art. 3 del motuproprio aggiunge come regolarsi nell’indagine canonica sull’offerta della vita e nella preparazione del relativo dossier (positio) da sottoporre ai consultori teologi e ai cardinali: «La celebrazione dell’inchiesta diocesana o eparchiale e la relativa positio sono regolate dalla Costituzione apostolica Divinus perfectionis magister del 25 gennaio 1983 [...] e dalla Normae servandae [...] del 7 febbraio dello stesso anno». Questa nuova normativa sull’offerta della vita dovrà raccordarsi, logicamente, anche con l’Istruzione Sanctorum mater del 17 maggio 2007, la quale intende agevolare la corretta applicazione della legislazione del 1983. Infine, il motuproprio ha deciso che il dubium, ossia l’oggetto dell’accertamento delle cause sull’offerta della vita, fosse così formulato: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur (“se risultano provate l’offerta della vita fino alla morte a motivo della carità nonché le virtù cristiane esercitate almeno in grado ordinario, nel caso e per le finalità di cui si tratta”). Il Santo Padre ha anche disposto che questo suo atto legislativo fosse promulgato mediante «L’Osservatore Romano» e che entrasse in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Con questo provvedimento la dottrina sulla santità cristiana canonizzabile e la procedura tradizionale della Chiesa per la beatificazione dei servi di Dio non soltanto non sono state alterate, ma si sono arricchite di nuovi orizzonti e opportunità per l’edificazione del popolo di Dio, che nei suoi santi vede il volto di Cristo, la presenza di Dio nella storia e l’esemplare attuazione del Vangelo. Pag 7 Maiorem hac dilectionem Motuproprio sull’offerta della vita nelle cause dei santi Pubblichiamo di seguito il testo in latino e in italiano della lettera apostolica in forma di motuproprio «Maiorem hac dilectionem» con la quale Papa Francesco ha introdotto una nuova fattispecie nell’iter di beatificazione e canonizzazione. LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE DE OBLATIONE VITAE «Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis» (Io 15, 13). Singulari existimatione et honore digni sunt illi christifideles, qui Iesu Christi vestigia ac placita proxime sequentes, vitam suam pro aliis voluntarie ac libere praebuerunt et hoc in proposito usque ad mortem perseveraverunt.
Omnibus compertum habetur heroicam vitae oblationem, caritate monitam ac fultam, Christi veram, plenam ac praestantissimam imitationem exprimere, quapropter ea digna est illa admiratione, quae fidelium communitas reservare illis solet, qui voluntarie vitam immolaverunt sanguinis martyrio occumbentes vel heroico in gradu christianas virtutes exercuerunt. Faventi consilio a Congregatione de Causis Sanctorum edito, quae Plenaria in Sessione diei 27 mensis Septembris anno 2016 diligenter perscrutata est an huiusmodi christifideles beatificationis sint digni, has quae sequuntur statuimus normas servandas: ARTICULUS I Vitae oblatio nova facti species est itineris ad beatificationem et canonizationem, quae a specie super martyrio et super heroicitatem virtutum differt. ARTICULUS II Vitae oblatio, ut sit apta atque efficax ad Servi Dei beatificationem haec requirit: a) libera ac voluntaria sui vitae oblatio et heroica propter caritatem certae ac tempore proximae mortis acceptio; b) nexus inter vitae oblationem et praematuram mortem; c) exercitium, saltem ordinario gradu, christianarum virtutum ante vitae oblationem et, deinceps, usque ad mortem; d) exsistentia famae sanctitatis et signorum saltem post mortem; e) necessitas miraculi, beatificationis intuitu, quod post Servi Dei mortem et per eiusdem intercessionem eveniat. ARTICULUS III Dioecesanae vel Eparchialis Inquisitionis celebratio una cum pertinenti Positione ad normam Apostolicae Constitutionis Divinus perfectionis Magister diei 25 mensis Ianuarii anno 1983 in Actis Apostolicae Sedis, volumine 75 (1983), 349-355 editae, et secundum Normas Servandas in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum diei 7 mensis Februarii eiusdem anni promulgatas in Actis Apostolicae Sedis, volumine 75 (1983), 396-403 editas, praeter sequentia, temperata est. ARTICULUS IV Positio super oblatione vitae ad dubium respondeat “An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur”. ARTICULUS V In articulis subscriptae Apostolicae Constitutionis haec sequentia innoventur: Ad art. 1: «Episcopis dioecesanis vel Hierarchis ceterisque in iure aequiparatis, intra fines suae iurisdictionis, sive ex officio, sive ad instantiam singulorum fidelium vel legitimorum coetuum eorumque procuratorum, ius competit inquirendi circa vitam, virtutes, vitae oblationem vel martyrium ac famam sanctitatis vel vitae oblationis vel martyrii, asserta miracula, necnon, si casus ferat, antiquum cultum Servi Dei, cuius canonizatio petitur». Ad art. 2, 5: «Inquisitio de assertis miraculis ab inquisitione de virtutibus vel de vitae oblatione vel de martyrio separatim fiat». Ad art. 7, 1: «Una cum externis cooperatoribus causis sibi commissis studere atque Positiones super virtutibus vel super vitae oblatione vel super martyrio parare». Ad art. 13, 2: «Si Congressus iudicaverit causam instructam fuisse ad legis normas, statuet cuinam ex Relatoribus committenda sit; Relator vero una cum cooperatore externo Positionem super virtutibus vel super vitae oblatione vel super martyrio conficiet iuxta regulas artis criticae in hagiographia servandas». ARTICULUS VI In articulis supradictarum Normarum servandarum in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum haec innoventur: Ad art. 7: «Causa potest esse recentior aut antiqua; recentior dicitur, si martyrium vel virtutes vel vitae oblatio Servi Dei per orales depositiones testium de visu probari possunt; antiqua vero, cum probationes de martyrio vel de virtutibus vel de vitae oblatione dumtaxat ex fontibus scriptis erui possunt».
Ad art. 10, 1°: «In causis tam recentioribus quam antiquis, biographiam alicuius historici momenti de Servo Dei, si extat, vel, ea deficiente, accuratam relationem chronologice digestam de vita et gestis ipsius Servi Dei, de eius virtutibus vel vitae oblatione vel martyrio, de sanctitatis et signorum fama, non omissis iis quae ipsi causae contraria vel minus favorabilia videntur». Ad art. 10, 3°: «In causis recentioribus tantum, elenchum personarum quae ad eruendam veritatem circa virtutes vel vitae oblationem vel martyrium Servi Dei, necnon circa sanctitatis vel signorum famam conferre possunt vel adversari». Ad art. 15, a: «Relatione accepta, Episcopus omnia usque ad illud tempus acquisita promotori iustitiae vel alii viro perito tradat, ut interrogatoria conficiat quae apta sint ad verum indagandum et inveniendum de Servi Dei vita, virtutibus vel vitae oblatione vel martyrio, fama sanctitatis vel vitae oblationis vel martyrii». Ad art. 15, b: «In causis antiquis vero interrogatoria dumtaxat famam sanctitatis vel vitae oblationis vel martyrii adhuc vigentem necnon, si casus ferat, cultum recentioribus temporibus Servo Dei praestitum respiciant». Ad art. 19: «Ad probandum martyrium vel virtutum exercitium vel vitae oblationem et signorum famam Servi Dei qui pertinuerit ad aliquod Institutum vitae consecratae, notabilis pars testium inductorum debent esse extranei, nisi, ob peculiarem Servi Dei vitam, id impossibile evadat». Ad art. 32: «Inquisitio super miraculis separatim instruenda est ab inquisitione super virtutibus vel vitae oblatione vel martyrio et fiat iuxta normas quae sequuntur». Ad art. 36: «De Servis Dei, quorum sanctitas vitae adhuc legitimo examini subiecta est, quaelibet sollemnia vel panegyricae orationes in ecclesiis prohibentur. Sed etiam extra ecclesiam abstinendum est ab iis actis quibus fideles induci possint ad falso putandum inquisitionem ab Episcopo factam de Servi Dei vita et virtutibus vel vitae oblatione vel martyrio certitudinem secum ferre futurae eiusdem Servi Dei canonizationis» Haec omnia, quae his Apostolicis Litteris motu proprio statuimus, mandamus ut rite funditusque serventur, contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis minime obstantibus et publici iuris fiant per editionem super actis diurnis scilicet “L’Osservatore Romano” et ab hoc ipso die vigere incipiant et deinceps in Actis Apostolicae Sedis referri mandamus. Datum apud Sanctum Petrum, die XI mensis Iulii, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri quinto. LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO “MAIOREM HAC DILECTIONEM” SULL’OFFERTA DELLA VITA «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15, 13). Sono degni di speciale considerazione ed onore quei cristiani che, seguendo più da vicino le orme e gli insegnamenti del Signore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la vita per gli altri ed hanno perseverato fino alla morte in questo proposito. È certo che l’eroica offerta della vita, suggerita e sostenuta dalla carità, esprime una vera, piena ed esemplare imitazione di Cristo e, pertanto, è meritevole di quella ammirazione che la comunità dei fedeli è solita riservare a coloro che volontariamente hanno accettato il martirio di sangue o hanno esercitato in grado eroico le virtù cristiane. Con il conforto del parere favorevole espresso dalla Congregazione delle Cause dei Santi, che nella Sessione Plenaria del 27 settembre 2016 ha attentamente studiato se questi cristiani meritino la beatificazione, stabilisco che siano osservate le norme seguenti: ART. 1 L’offerta della vita è una nuova fattispecie dell’iter di beatificazione e canonizzazione, distinta dalle fattispecie sul martirio e sull’eroicità delle virtù.
ART. 2 L’offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio, deve rispondere ai seguenti criteri: a) offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione propter caritatem di una morte certa e a breve termine; b) nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura; c) esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell’offerta della vita e, poi, fino alla morte; d) esistenza della fama di santità e di segni, almeno dopo la morte; e) necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione. ART. 3 La celebrazione dell’Inchiesta diocesana o eparchiale e la relativa Positio sono regolate dalla Costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 1983, in Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 349-355), e dalle Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum del 7 febbraio dello stesso anno, in Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 396-403), salvo quanto segue. ART. 4 La Positio sull’offerta della vita deve rispondere al dubium: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur. ART. 5 Gli articoli seguenti della citata Costituzione Apostolica sono così modificati: Art. 1: “Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nell’ambito della loro giurisdizione, sia d’ufficio, sia ad istanza dei singoli fedeli o di legittime associazioni e dei loro rappresentanti, compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù, l’offerta della vita o il martirio e la fama di santità, di offerta della vita o di martirio, sui presunti miracoli, ed eventualmente, sul culto antico del Servo di Dio, di cui si chiede la canonizzazione”. Art. 2, 5: “L’Inchiesta sui presunti miracoli si faccia separatamente da quella sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio”. Art. 7, 1: “studiare le cause loro affidate con i collaboratori esterni e preparare le Positiones sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio”. Art. 13, 2: “Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta, aiutato da un collaboratore esterno, farà la Positio sulle virtù, sull’offerta della vita o sul martirio, secondo le regole della critica agiografica”. ART. 6 Gli articoli seguenti delle citate Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopi facendis in Causis Sanctorum sono così modificati: Art. 7: “La causa può essere recente o antica; è detta recente, se il martirio, le virtù o l’offerta della vita del Servo di Dio possono essere provati attraverso le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le prove relative al martirio o le virtù possono essere desunte soltanto da fonti scritte”. Art. 10, 1°: “nelle cause sia recenti che antiche, una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un’accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del Servo di Dio, sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio, sulla fama di santità e di miracoli, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa”. Art. 10, 3°: “solo nelle cause recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a esplorare la verità sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio del Servo di Dio, come pure sulla fama di santità e di miracoli, oppure impugnarla”.
Art. 15, a: “Ricevuta la relazione, il Vescovo consegni al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa preparare gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù, l’offerta della vita o il martirio, la fama di santità, di offerta della vita o di martirio del Servo di Dio”. Art. 15, b: “Nelle cause antiche gli interrogatori riguardino soltanto la fama di santità, di offerta della vita o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti”. Art. 19: “A provare il martirio, l’esercizio delle virtù o l’offerta della vita e la fama dei miracoli di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, i testimoni presentati devono essere, in parte notevole, estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della particolare vita del Servo di Dio”. Art. 32: “L’inchiesta sui miracoli dev’essere istruita separatamente dall’inchiesta sulle virtù o sull’offerta della vita o sul martirio e si svolga secondo le norme che seguono”. Art. 36: “Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame. Ma anche fuori della chiesa bisogna astenersi da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l’inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù, sul martirio o sull’offerta della vita del Servo di Dio, comporti la certezza della futura canonizzazione dello stesso Servo di Dio”. Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione e che, successivamente, sia inserito in Acta Apostolicae Sedis. Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 luglio, quinto del Nostro Pontificato. Francesco AVVENIRE Pag 2 Nuovo modo di capire la santità di sempre di Stefania Falasca Il motu proprio di Papa Francesco «Ora esistono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità; ma la più grande di esse è la carità». Così san Paolo a conclusione del suo celebre Inno contenuto nella Prima lettera ai Corinzi sulla virtù infusa dell’amore e dirimente del cristiano. È stato perciò da sempre chiaro come a imitatio Christi – che per amore si è offerto al Padre sulla croce per il mondo – anche le vie alla santità canonizzata devono avere un denominatore comune nella carità, che è supremo vincolo della perfezione, pienezza della legge e anima stessa della santità. E ora proprio la possibilità del riconoscimento specifico di atti di carità eroica compiuti con l’offerta estrema della propria vita apre un nuovo iter giuridicamente percorribile nelle cause di canonizzazione. Con il motu proprio Maiorem hac dilectionem sull’offerta della vita, papa Francesco ha infatti inteso aprire la via alla beatificazione e canonizzazione proprio di quei fedeli che, spinti dalla carità, hanno eroicamente fatto dono della propria vita per gli altri: in un supremo atto radicale di carità hanno accettato con libertà e volontariamente il destino di una morte certa, prossima e prematura sulle orme di Cristo, che ha dato la sua vita per noi. Una quarta via dell’offerta della vita, dunque, una nuova fattispecie che si aggiunge e si distingue così dalle procedure canoniche per giungere alla canonizzazione finora note, percorribili e praticate: quelle sul martirio, sull’eroicità delle virtù e sulla conferma di un culto antico chiamato «canonizzazione equipollente». È un segno dei tempi anche questa via? Fatto è che a fare la differenza nell’esame di riconoscimento è proprio l’immolazione della vita per i fratelli in un atto supremo di carità che sia direttamente causa di morte, mettendo così in pratica la parola di Cristo: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
vita per propri amici». È una via che certamente intende valorizzare ed elevare a esempio un’eroica testimonianza cristiana, finora rimasta senza una procedura specifica proprio perché, sebbene possa essere similare per certi versi alle altre, non rientra del tutto nella fattispecie del martirio (per questo infatti si deve dimostrare l’odium fidei da parte del persecutore che provoca la morte) come neppure in quella delle virtù eroiche dei confessori, dove si deve dimostrare l’espressione di un prolungato esercizio di tutte le virtù teologali e cardinali in grado eroico, anche se l’atto di carità vincolato alla causa della morte per l’offerta della vita non può essere separato dal vissuto delle virtù cristiane. Con questo provvedimento che, come osserva monsignor Marcello Bartolucci, segretario della Congregazione delle cause dei santi, è frutto di un lungo tempo di riflessione, di esperienza del dicastero e di osservazione dell’attuale vissuto cristiano, «la dottrina sulla santità canonizzabile e la procedura tradizionale non soltanto non sono state alterate, ma si sono arricchite di nuovi orizzonti e opportunità per l’edificazione del popolo di Dio, che cerca nei suoi santi l’esemplare attuazione del Vangelo». Testimonianze così ci sono, e sono degne, per il bene che alimentano di fede e di speranza, di essere prese in considerazione e proposte come modelli oggi. Se per le sei suore Poverelle che nel 1995 morirono in Congo a causa dell’epidemia di ebola, capitolando una dietro l’altra nel giro di un mese, non fosse già stato inoltrato il processo sulle virtù forse oggi sarebbe stata adottata questa procedura ad hoc. Perché nel loro caso si è trattato proprio di consapevole dono totale di sé per i fratelli, nella libera accettazione propter caritatem di una morte certa e a breve termine. Una scelta determinata a vivere tra i più poveri. Una storia di amore e di morte, di sofferenza e di fede, nella vicenda buia di un virus misterioso e terribile che scatena ciclicamente epidemie mortali in Africa. Sei donne bergamasche e bresciane che, nonostante l’infuriare dell’epidemia, si rifiutarono di tornare in Italia e rimasero a curare i malati. Avrebbero potuto riparare finché fosse passato il rischio di contagio e invece, consapevoli di mettere a repentaglio la loro vita, continuarono a stare accanto ai sofferenti. Senza aver mai pensato di abbandonare la trincea della carità. Fino all’ultimo respiro. Pag 5 “L’offerta della vita”, via nuova verso gli altari di Gianni Cardinale, Riccardo Maccioni e Filippo Rizzi La decisione del Papa con un motu proprio. Dai miracoli alla morte “in odium fidei”: ecco come si diventa beati. Apeciti: una luce su eroismi spesso vissuti nel nascondimento Roma. Papa Francesco apre la via alla beatificazione di quei fedeli che, spinti dalla carità, hanno offerto eroicamente la propria vita per il prossimo accettando liberamente e volontariamente una morte certa e prematura con l’intento di seguire Gesù. Lo fa con la pubblicazione, avvenuta ieri, del Motu proprio Maiorem hac dilectionem, che inizia proprio con le parole di Gesù prese dal Vangelo di Giovanni: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici». In un articolo che viene pubblicato sull’Osservatore Romano il segretario della Congregazione delle cause dei santi, l’arcivescovo Marcello Bartolucci, spiega che con questa decisione il Pontefice stabilisce una nuova via percorribile per procedere alla beatificazione di un servo di Dio. Via che si aggiunge a quelle finora prestabilite, e cioè quelle del martirio, quella delle virtù eroiche e quella della cosiddetta 'beatificazione equipollente'. Per Bartolucci questa via «dell’offerta della vita » pur avendo alcuni elementi che la fanno assomigliare sia alla via del martirio che a quella delle virtù eroiche, «è una via nuova che intende valorizzare una eroica testimonianza cristiana, finora senza una procedura specifica, proprio perché non rientra del tutto nella fattispecie del martirio e neppure in quella delle virtù eroiche». In concreto il Motu proprio precisa che «l’offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio», deve rispondere ai cinque criteri. E cioè: «offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione propter caritatemdi una morte certa e a breve termine; nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura; esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell’offerta della vita e, poi, fino alla morte; esistenza della fama sanctitatis et signorum, almeno dopo la morte; necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione». Il documento papale inoltre aggiunge come regolarsi nell’indagine canonica sull’offerta della vita e nella preparazione del relativo dossier
(positio) da sottoporre ai consultori teologi e ai cardinali. Come riferito da Bartolucci il Motu proprio è stato emanato dal Papa dopo un approfondito studio della questione partita nel gennaio 2014 e passata al vaglio, nel giugno 2016 di un Congresso peculiare del dicastero delle cause dei santi presieduto «soprattutto nella sua qualità di postulatore» dal vescovo salesiano Enrico dal Covolo, rettore della Lateranense. Nel settembre 2016 la sessione plenaria dei porporati e vescovi membri della Congrega- zione presieduta dal cardinale Angelo Amato poi «diedero voto favorevole ad una nuova via per la beatificazione di chi ha offerto la vita con esplicite e riconosciute motivazioni cristiane », evidenziando «la necessità di un miracolo, formalmente approvato, quale conferma divina del giudizio umano sull’offerta della vita». Intervistato dalla Radiovaticana, monsignor dal Covolo precisa che il «messaggio centrale » del Motu Proprio è questo: «l’offerta della vita diventa una nuova, cioè una terza fattispecie – finora inedita – dell’iter di beatificazione e canonizzazione e si distingue dalle altre due fattispecie tradizionali, che sono il martirio e l’eroicità delle virtù». Il presule osserva poi che dei cinque criteri indicati dal Papa il primo e il secondo «sembrano i più rilevanti». Infatti «deve trattarsi di un’offerta libera e volontaria della vita e di eroica accettazione propter caritatem - bisogna sottolineare questo - per la carità, per l’amore di Dio e del prossimo, di una morte certa e a breve termine e deve esserci un nesso - questo è il secondo criterio - tra l’offerta della vita e la morte prematura ». Monsignor dal Covolo osserva poi che la scelta del Motu proprio «è dovuta al fatto che alcune volte ci si è trovati in difficoltà durante lo svolgimento del processo canonico, cioè magari si è partiti con il processo sul martirio e poi si è dovuti passare al processo sull’eroicità delle virtù, che sono molto diverse tra di loro, perché in realtà non si capiva bene se si trattasse di una fattispecie o dell’altra, cioè se dell’eroicità della vita e delle virtù o del martirio ». È il caso, ad esempio, del servo di Dio, Salvo D’Acquisto o di San Massimiliano Kolbe «che fu beatificato per l’eroicità della vita e delle virtù e fu poi canonizzato per martirio». «Questo Motu proprio Maiorem hac dilectionem di papa Francesco consentirà di offrire un ulteriore strada “mediana” per portare agli onori degli altari tanti sacerdoti ma anche gente comune che con i loro “semplici” gesti come dice il Vangelo di Giovanni hanno dato “ la vita per i propri amici”». È il primo commento che arriva – dopo aver esaminato attentamente la nuova Lettera apostolica di papa Bergoglio – da monsignor Ennio Apeciti, sacerdote ambrosiano, classe 1950, rettore del Seminario lombardo a Roma ma soprattutto consultore della Congregazione delle cause dei santi. «Da anni si discuteva proprio di questi testimoni di santità all’interno del Dicastero Vaticano – argomenta lo studioso – attorno soprattutto ai tanti atti di carità, di sacrificio e di donazione al prossimo, consumati spesso nel nascondimento. Questi modelli di vita apostolica sono stati definiti quasi in gergo dei “martiri della carità” per il loro farsi prossimo e spendersi per la vita degli altri». Casi e ed esempi che riportano concretamente ai numerosi dossier esaminati anche in sede di postulazione proprio da Apeciti nella sua veste di responsabile dell’ufficio delle cause dei santi della arcidiocesi di Milano. «Mi viene in mente a questo proposito la vicenda da me direttamente seguita come quella di padre Alfredo Cremonesi, oggi servo di Dio, vissuto tra il 1902 e il 1953 che non ha voluto abbandonare il suo villaggio della Birmania e il “piccolo gregge” a lui affidato. Ha voluto morire con loro e si è opposto alle persecuzioni del regime militare con il solo obiettivo di evitare la morte inutile di tante persone. Ma non fu vittima di una precisa volontà di odio per il suo credo religioso. Non vi fu evidente anche se presente “odium fidei”. Questo sacerdote fu massacrato perché il suo villaggio fu accusato di aver ospitato dei ribelli. Ed egli rimase sino alla fine con la sua gente. Il Motu proprio di Francesco sembra proprio venire incontro a questi casi specifici e così mostrare le virtù di santità di questi grandi apostoli della carità». Una vicenda quella di padre Cremonesi – a giudizio di monsignor Apeciti – del tutto simile ai coraggiosi gesti di altruismo compiuti durante la Resistenza dal sacerdote della Bassa Reggiana don Pasquino Borghi (1903 -1944). «Si tratta del classico caso di un buon sacerdote che conosce il rischio di morire per aver dato aiuto e riparo a tanti antifascisti – spiega Apeciti – e infatti viene barbaramente fucilato dalle milizie fasciste. Il suo atto rappresenta il gesto di una morte consapevole compiuta per salvare altre persone ». E – nel solco di questi modelli di carità e di «offerta libera e volontaria della propria vita» – in contesti spesso di «morte certa e a breve termine» come indica proprio il motu proprio Maiorem hac dilectionem – monsignor Apeciti elenca
gli esempi del beato don Pino Puglisi o ancora della laica missionaria Annalena Tonelli barbaramente uccisa in Somalia nel 2003. «Ella si è esposta al rischio della morte – è la riflessione – e ha offerto la sua azione di apostolato verso gli ultimi senza pensare che fossero cristiani o musulmani». Una morte a breve termine dove spesso «manca il periodo minimo di 10 anni per la pratica in modo eroico delle virtù, come si dice tecnicamente» ma un dono di sé fatto e compiuto convintamente per una causa superiore e per la salvezza concreta di tante anime. «Mi viene in mente il sacrificio eroico fatto dal venerabile il carmelitano padre Benigno Calvi che sa di morire ad appena 28 anni, a causa di una terribile malattia, – osserva Apeciti – spira convinto che il suo sacrificio servirà a salvare il suo Ordine in Lombardia». Un altro esempio di questa «strada mediana» aperta dal motu proprio di Francesco «un vero nuovo itinerario» lo definisce Apeciti viene dalla testimonianza del servo di Dio Sabatino Iefuniello il fattorino e fidato collaboratore di fratel Ettore. l’apostolo dei senzatetto milanesi. «Sabatino non si sottrae mai alle richieste del camilliano fratel Ettore riesce miracolosamente a guarire dopo la prova di una dura polmonite. Infragilito dalla malattia anziché aspettare la normale convalescenza ritorna tra i poveri di fratel Ettore per compiere un ennesimo soccorso. Quella sua azione di carità gli è fatale. Ma come ci indica la Lettera apostolica di Bergoglio egli ha voluto consapevolmente dare la vita per i propri amici ». IL MARTIRIO - E la vittima perdona chi la uccide L’offerta della vita come nuova «fattispecie» nell'iter processuale per la beatificazione e il successivo riconoscimento della santità va ad aggiungersi alle altre vie più tradizionali previste dalla Chiesa da secoli. Innanzitutto il martirio, che, come sottolinea l’Osservatore Romano, è la suprema imitazione di Cristo e la testimonianza più alta della carità. Il concetto classico di martirio comprende: l’accettazione volontaria della morte violenta per amore di Cristo; l’odium del persecutore per la fede o per un’altra virtù cristiana; la mitezza e il perdono della vittima che imita l’esempio di Gesù sulla croce. VIRTÙ EROICHE - Il Vangelo diventa un modo di essere Una via, per così dire più consueta, è quella delle virtù eroiche che, scrive Benedetto XIV, vanno esercitate «speditamente, prontamente, piacevolmente e sopra il comune modo di agire, per un fine soprannaturale». Non 'una tantum' dunque ma per un periodo sufficiente a farle diventare – scrive l’Osservatore Romano – un modo abituale di essere e di agire conforme al Vangelo. Si tratta delle virtù teologali (fede, speranza, carità), cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) e 'annesse' (povertà, obbedienza, castità, umiltà). Se viene riconosciuta l’eroicità delle virtù, il servo di Dio è dichiarato venerabile. Per la beatificazione è necessario il riconoscimento di un miracolo per sua intercessione. «CASUS EXCEPTI» - Il riconoscimento di un culto antico Un’altra via, meno conosciuta è quella dei cosiddetti casus excepti, espressione del Codice di diritto canonico del 1917 (cfr. cann. 2125-2135). Come ricorda l’Osservatore Romano il riconoscimento porta alla conferma di un culto antico, cioè successivo al pontificato di Alessandro III († 1181) e antecedente al 1534, così come stabilì Urbano VIII (1623-1644), il grande legislatore delle cause dei santi. La conferma del culto antico è chiamata anche 'beatificazione equipollente'. Detto in altro modo, la beatificazione ed eventualmente la canonizzazione equipollente è una procedura con cui il Papa approva per decreto un culto esistente da tempo di un servo di Dio non ancora beatificato o canonizzato. L’OFFERTA DELLA VITA - Carità e il dono eroico di sé Come detto il Motu proprio pubblicato ieri introduce una nuova fattispecie dell’iter di beatificazione e canonizzazione. Perché sia valida ed efficace occorrono alcuni requisiti: offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione propter caritatem di una morte certa e a breve termine; un nesso tra l’offerta della vita e la morte prematura; l’esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell’offerta della vita e, poi, fino alla morte; esistenza della fama di santità e di segni, almeno dopo la morte; il miracolo per la beatificazione, dopo la morte del servo di Dio e per sua intercessione.
Pag 16 Il capo scout: sono gay. La comunità si interroga di Luciano Moia L’arcivescovo di Gorizia invita al discernimento: “Diritto al rispetto, ma ricerca della verità” Un capo scout “celebra” un’unione civile con il compagno. Il parroco ne sollecita le dimissioni alla luce delle sue responsabilità educative. Il viceparroco frena. La comunità si divide. Il clima è pesante. Ma, dopo una ventina di giorni, l’intervento dell’arcivescovo spiazza tutti. Rifiuta il ruolo del giudice, non assolve e non condanna. Ma invita la comunità a riflettere insieme per capire se, anche da un avvenimento così divisivo, si possono cogliere aspetti di grazia. Un intervento all’insegna della moderazione quello deciso dall’arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli, che nei giorni scorsi ha presentato al consiglio presbiterale e a quello pastorale un’ampia riflessione sul caso Staranzano, il piccolo Comune alle spalle di Monfalcone, teatro di una vicenda che – ne parliamo nel box qui sotto – che un tempo si sarebbe definita pruriginosa. Prendendo spunto dagli Atti degli Apostoli, e in particolare dalla descrizione del Concilio di Gerusalemme ( At15) – in cui ci si trovò a decidere come organizzare la convivenza tra i cristiani provenienti dal giudaismo e quelli convertiti dal paganesimo – Redaelli propone di seguire la stessa indicazione. Ascoltare lo Spirito, senza pretendere di trovare ricette preconfezionate nelle Scritture o nella tradizione canonica. Il passaggio si trova in un testo di Carlo Maria Martini ( Cristiani coraggiosi. Laici testimoni nel tempo di oggi, Milano 2017) che Redaelli definisce «un grande maestro del discernimento». Dall’arcivescovo di Milano scomparso nel 2012, Redaelli fu ordinato sacerdote e poi nominato avvocato generale della Curia ambrosiana. Ora il riferimento a Martini serve per introdurre ciò che può sembrare strano e forse, ad alcuni, anche inopportuno. E cioè «di fronte a ciò che ha creato contrasti e scalpore» si può osare chiedersi quali siano gli aspetti di grazia presenti? Redaelli ricorda il passaggio di Paolo nella Lettera ai Romani («Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio». Ma non certo per concludere che tutto – e in particolare le scelte compiute dai protagonisti della vicenda – può essere definiti “bene” in maniera semplicistica. Ma per ripercorrere la vicenda con la lampada di quel discernimento che, a parte Martini, è indicato come prassi virtuosa anche da papa Francesco in Amoris laetitia. L’Esortazione postsinodale sulla famiglia è richiamata esplicitamente per ricordare, sintetizza Redaelli, che «chi si aspetta o pretende sempre e comunque princìpi chiari, astratti e immodificabili... non può che restare deluso». Criterio di umiltà e di realismo tanto più valido quando non ci si confronta non princìpi astratti, ma con l’intimità dei sentimenti delle persone. Proprio l’opportunità del confronto è il primo degli aspetti di grazia indicato dal vescovo di Gorizia. Come grazia «è la progressiva maturazione della convinzione che il discernimento stia diventando sempre più la cifra fondamentale dell’agire pastorale». Ma anche «l’attenzione rispettosa, partecipe e talvolta sofferta ai cammini personali di ciascuno ». Su questo aspetto Redaelli ricorda il diritto al rispetto e alla dignità personale, che vuol dire atteggiamento non giudicante. Grazia allora – e qui arriviamo a uno dei punti più delicati, ma anche più coraggiosi della lettera – vuol dire anche «individuare la volontà di Dio per la propria vita nella concretezza della situazione in cui si trova». È il grande principio del “massimo bene possibile” qui ed ora – richiamato più volte in Amoris laetitia – che si oppone alla logica farisaica del “minimo indispensabile”. E, se è vero che non bisogna mai rinunciare a proporre l’ideale evangelico «sapendo ben distinguere le diverse situazioni di partenza » è altrettanto vero – annota ancora il vescovo di Gorizia – «non indulgere a facili giudizi e non sostituirsi alla responsabilità di ciascuno». Sarebbe facile concludere che il discernimento è quasi un mezzo per rendere accettabile ogni scelta e azzerare ogni istanza etica. Invece è proprio vero il contrario. Tanto che Redaelli, proseguendo nel suo elenco degli aspetti di grazia, spiega che anche per quanto riguarda l’amore, «i diversi modi di sentire diffusi oggi, pur avendo aspetti di verità, sono spesso riduttivi ». E quindi non bisogna temere di definire “riduttivo” il luogo comune secondo cui «ciò che conta è che due persone si amino, a prescindere da chi sono, dagli impegni che hanno assunto, dalla responsabilità verso altri e anche dalla qualità del loro amore». Come “riduttivo” è concepire la libertà «come il fare quello che l’individuo ritiene a prescindere non solo dal confronto con ciò che è giusto e ciò che non lo è, ma anche dalla relazione con le persone e dalla responsabilità verso di esse e verso la comunità». E chi ha un ruolo educativo che richiede particolare responsabilità deve
sviluppare una consapevolezza che va a sua volta inquadrata nelle categorie della grazia. Ma come tradurre queste riflessioni in scelte concrete? Il vescovo è consapevole che sia la realtà, sia il lavoro di discernimento e di approfondimento teologico e pastorale della Chiesa «è in continuo sviluppo » perché deve confrontarsi con tematiche inedite che prima non esistevano o finivano sotto silenzio. Da qui la necessità di accostarsi a tematiche (come appunto l’amore omosessuale) con umiltà, tanto più «quando si è di fronte a questioni nuove e complesse» sulle quali la riflessione ecclesiale non è del tutto matura e i pareri sono diversi. Lo stesso criterio che deve adottare l’Agesci – conclude Carlo Roberto Maria Redaelli – che ha la necessità di «proporre oggi determinati valori con un approccio diverso rispetto al passato». Vale in particolare per il tema degli affetti e per altri temi «che fino a poco tempo fa non erano neppure quasi ipotizzabili». La scelta insomma non tocca al vescovo con un intervento autoritario dall’alto, ma alle stesse realtà ecclesiali operanti in ambito educativo che, lungo questo percorso di discernimento sicuramente non facile, devono «giungere ad alcune indicazioni condivise e sagge». Quando all’inizio di giugno, Marco Di Just, uno dei capi scout del locale gruppo Agesci, ha deciso di fare outing con il compagno Luca Bortolotto, consigliere comunale, “celebrando” un’unione civile in municipio, nessuno nella piccola comunità di Staranzano – settemila abitanti in provincia di Gorizia – si è stupito troppo. Gli orientamenti del capo scout non erano un mistero, anche se l’uscita allo scoperto ha obbligato il parroco, don Francesco Maria Fragiacomo, a criticare la scelta sul bollettino parrocchiale: «Come cittadino ognuno può fare quello che gli consente la legge dello Stato. Come cristiano, però, devo tener conto di quale sia la volontà di Dio sulle scelte della mia vita. Come educatore cristiano, in più, devo tener conto della missione e delle linee educative della Chiesa e della mia associazione cattolica». Da qui la richiesta a Di Just di fare, «per coerenza» un passo indietro. Richiesta che non è stata condivisa né dal viceparroco don Eugenio Biasol, guida spirituale degli scout, presente alla cerimonia come amico dei due giovani, sia dall’Agesci Friuli Venezia Giulia che un post su Facebook ha ribadito la propria fiducia nei capi scout del Gruppo di Staranzano. L’esigenza del rispetto per tutte le persone, «indipendentemente dall’orientamento sessuale» (Al 250), si ritrova in più punti dell’Esortazione postsinodale. «Si deve integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia 'immeritata, incondizionata e gratuita'. Nessuno può essere condannato per sempre. Non mi riferiscono solo ai divorziati che vivono in nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino» (Al 297). E, a proposito dell’accoglienza per le persone omosessuali, in modo più esplicito al punto 250: «Si tratta di assicurare un doveroso accompagnamento, affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella propria vita». Nel paragrafo successivo si dice anche che «non esiste alcun fondamento» (Al 251) per equiparare matrimonio e unioni gay. IL GIORNALE Il Papa voleva fare cardinale un laico di Stefano Filippi e Serena Sartini Il monaco filosofo che rifiutò anche la politica Nell'ultimo concistoro celebrato da papa Francesco alla fine di giugno, un'infornata di cardinali particolarmente striminzita (appena cinque), doveva esserci un porporato in più. Un italiano, un personaggio di spicco, un uomo di Chiesa noto in tutto il mondo e che è, naturalmente, molto stimato da Jorge Mario Bergoglio. Ma che non è un vescovo responsabile di una diocesi e nemmeno un alto papavero della Curia vaticana. Non è nemmeno prete. È un laico, sia pure consacrato, un monaco che non può confessare né dire messa: il fondatore della Comunità di Bose, Enzo Bianchi. Un nome dirompente perché da sempre iscritto all'ala progressista della Chiesa italiana, contestatore di certi aspetti della cattolicità, per alcuni non del tutto ortodosso, saggista di fama, editorialista di giornali come La Stampa e Repubblica, oltre che di Osservatore Romano e Avvenire. Ma l'aspetto più clamoroso di questa nomina sarebbe stato il fatto che Bianchi non è
prete, né vuole esserlo: l'ordinazione sacerdotale gli era stata sollecitata due volte, come egli stesso ha raccontato in un'intervista concessa alla Stampa quando compì 70 anni, nel 2013. Glielo chiesero, in tempi diversi, due vescovi, il cardinal Michele Pellegrino (arcivescovo di Torino dal 1965 al 1977) e il vescovo di Biella, la diocesi dove ha sede la Comunità di Bose, che è una piccola frazione del comune di Magnano, nel Canavese. Bianchi rifiutò entrambe le volte. L'indiscrezione che il Papa pensava di dare la porpora a Bianchi non è nuova, ma questa volta trova conferma in ambienti vicini alla Segreteria di Stato vaticana, dove invece non viene accreditata una seconda mancata nomina cardinalizia di cui pure si mormora nei Sacri palazzi. Anch'essa di un laico, senza precedenti, esplosiva: quella di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio ed ex ministro del governo tecnico di Mario Monti. Con la creazione di Bianchi a cardinale, papa Francesco avrebbe voluto segnare una svolta epocale nella storia della Chiesa degli ultimi secoli: avrebbe riaperto ai laici le porte del collegio più esclusivo al mondo, quello che elegge il Pontefice. I cardinali laici, porporati che al momento della designazione sono privi degli ordini maggiori (cioè diacono, prete o vescovo), non sono una novità assoluta nei duemila anni di vita della Chiesa. È stata una prassi applicata per secoli. Si trattava di chierici che avevano ricevuto la tonsura o un ordine minore (accolito o suddiacono), il che non impediva loro di sposarsi o di continuare nel matrimonio già celebrato. Ma dal Settecento è progressivamente venuta meno finché, nel 1858, il beato Pio IX ha creato l'ultimo cardinale laico. Era un avvocato della Rota romana, si chiamava Teodoro Mertel, figlio di un panettiere bavarese e ministro dello Stato pontificio. Papa Mastai Ferretti gli impose la berretta nel concistoro del 15 marzo 1858 e due mesi dopo, il 16 maggio, lo ordinò diacono ma non prete. Mertel partecipò pure al conclave che elesse Leone XIII. Dopo di lui, nessuno. Pare che Paolo VI avesse pensato di creare cardinale Jacques Maritain, filosofo francese che fu tra i suoi principali consiglieri. La cosa non ebbe seguito anche perché dai tempi di Pio IX erano intervenute novità di rilievo nel codice di diritto canonico proprio a riguardo nelle nomine cardinalizie. La riforma del 1917, sotto Benedetto XV, dispose che solo chi era prete o vescovo potesse ottenere la porpora e successivamente, nel 1983, Giovanni Paolo II fece aggiungere che chi non era vescovo dovesse ricevere questa ordinazione prima del concistoro. Di fatto, Wojtyla e Ratzinger hanno creato alcuni cardinali senza ordinarli vescovi, ma si trattava di teologi ultraottantenni senza il diritto di entrare in conclave. In base a queste regole Bianchi, che ha 74 anni, avrebbe dovuto ricevere sia l'ordinazione presbiterale sia quella episcopale. Cosa che egli rifiutò con una certa alterigia, visto che disse di voler restare «un semplice cristiano, laico come lo sono i monaci», e per fare qualche esempio non citò umili fraticelli nascosti in qualche convento sconosciuto, ma san Pacomio, san Benedetto e san Francesco d'Assisi. Farlo ora cardinale avrebbe costretto l'ex priore di Bose a ricredersi o a mettere in difficoltà lo stesso Bergoglio. E questa è stata l'argomentazione con cui il Papa è stato convinto a desistere dal proposito. Più d'uno nel dicastero che collabora più da vicino con il Pontefice, a quanto sembra, era perplesso sull'opportunità della nomina, forse anche il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. L'abilità della diplomazia vaticana ha tolto tutti dall'imbarazzo. Uomo di dialogo tra le chiese cristiane, grande teologo e biblista, giornalista, saggista, uomo ricco del soffio dello Spirito Santo. E poi lauree honoris causa, riconoscimenti internazionali, cittadinanze onorarie. Padre Enzo Bianchi è monaco laico (ovvero non sacerdote) fondatore della comunità monastica di Bose, in provincia di Biella. Nasce a Castel Boglione, in provincia di Asti, 74 anni fa. Fin dalla gioventù è attirato dagli studi biblici e già durante l'Università fonda i primi gruppi biblici composti da giovani di diverse confessioni cristiane. Dopo la laurea in Economia all'Università di Torino, matura il desiderio di una vita monastica. Si ritira in una cascina, a Bose, dove poi, nel 1965, fonda la Comunità interconfessionale, nata sulla scia del Concilio Vaticano II e sull'onda dei movimenti e delle nuove comunità religiose. Fino al 1967 rimane da solo. Poi i primi fratelli, cattolici e protestanti. Oggi la Comunità, composta da una novantina di monaci, viene visitata ogni anno da 20mila persone. Il voto del celibato, la preghiera, il lavoro e l'evangelizzazione sono i pilastri che sostengono la nuova comunità, riconosciuta poi dal diritto canonico come Associazione pubblica di fedeli. Si dedica alla predicazione, non solo a Bose ma anche nelle comunità locali, cattoliche, protestanti e ortodosse. Cattolico impegnato in politica, avrebbe avuto un futuro nella Democrazia cristiana. «Mi avrebbero
candidato alle elezioni politiche del 1968 - raccontava in una recente intervista - ma nel frattempo ero andato a Rouen a vivere tra i baraccati lungo la Senna insieme all'Abbé Pierre. È stata un' esperienza che mi ha cambiato. Ho lasciato tutto e sono salito a Bose, a vivere da solo in una cascina abbandonata». Per due volte gli viene chiesto se vuole essere ordinato presbitero, ma lui rifiuta. «Voglio restare un semplice cristiano, laico come lo sono i monaci», è il suo motto. La sua opera di evangelizzazione e di trasmissione del Vangelo passa anche dai mezzi di comunicazione. Scrive per Avvenire, La Stampa, Famiglia Cristiana, Repubblica. Il suo messaggio arriva anche Oltralpe. Collabora infatti per i francesi La Croix e La Vie. Molto apprezzato e stimato da Papa Benedetto XVI, partecipa in qualità di esperto agli ultimi due sinodi dei vescovi indetti dal pontefice tedesco. Nel 2008 quello sulla Parola di Dio e nel 2012 sulla Evangelizzazione. Papa Francesco lo nomina, nel 2014, consultore del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Dal gennaio di quest'anno non è più priore della comunità di Bose. «Nella storia di ogni nuova comunità monastica - scrive padre Enzo Bianchi nella lettera in cui annuncia le dimissioni - il passaggio di guida dal fondatore alla generazione seguente è un segno positivo di crescita e di maturità. Dopo cinquant'anni di priorato è giusto che questo compito venga preso da altri. La trasmissione dell'eredità tra generazioni è uno dei grandi problemi della nostra società», aveva detto lasciando l'incarico ma rimanendo sempre punto di riferimento indiscusso della realtà nel biellese. IL FOGLIO Pag 2 Fate politica, ma fatela bene. Il Papa chiama i giovani, che rispondono di Matteo Matzuzzi Lab.ora-Servitori del bene comune. Contro l’apatia dei Millennial Roma. Uno dei più grandi errori di lettura del corrente pontificato è di aver affibbiato a Papa Francesco un generico ma totale distacco dalla politica. Ha giocato un ruolo non indifferente il suo primo discorso ai vescovi italiani riuniti per la professione di fede in San Pietro, con quel "è compito vostro" un po' travisato. Quasi che i suoi silenzi dinanzi a marce, sit-in, eventi laici ma afferenti al campo religioso fossero un segno evidente di disinteresse. Poi succede che a Firenze, nel novembre del 2015, davanti alla chiesa italiana riunita per il suo quinto Convegno ecclesiale, Francesco tiene uno dei discorsi più politici da quando sta a Santa Marta, chiude la stagione inaugurata nel 1985 a Loreto e si rivolge - dopo aver definito alcune questioni non di poco conto con la corposa platea episcopale lì riunita - ai giovani. "Il modo migliore per dialogare è quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti". Da qui, la necessità di "immergersi nell'ampio dialogo sociale e politico" per "vivere i problemi come sfide e non come ostacoli". Insomma, la chiamata a darsi da fare, a rimboccarsi le maniche per vincere quella "apatia" - parole di Bergoglio - che oggi è così à la page. Tempo da perdere non ce n'è, osservata Francesco, anche perché "oggi non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento d'epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli". Ed è allora che si gettano le basi del progetto Lab.ora-mille giovani. Servitori del bene comune, promosso dall'associazione Laudato Sì. Il fine che si ripromette è di scavare nella società italiana, pescando il meglio della gioventù e lanciandola nel complicato e caotico agone nostrano. Impresa improba? Forse, soprattutto in quest' epoca dove lo scollamento tra giovani e politica, tra giovani e bene comune, ha assunto proporzioni enormi, con le cosiddette nuove generazioni che sovente disertano i seggi e di fare politica attiva hanno sempre meno voglia . Ma intanto ci si prova. Con incontri di quattro giorni dove si parla e si ascolta e in un clima di fraternità si lavora su grandi aree tematiche, con l'obiettivo unico di formare, valorizzando i carismi e il talento di mille giovani dai 23 ai 35 anni, credenti sì ma non solo cattolici. Formarli nelle diocesi e poi presentarli alle imprese locali, quindi - se meritevoli - far giocare loro un ruolo in politica. Tutto meno che un casting per giovani promesse, insomma, e anche per rimarcare questo concetto si è preferito prima avviare il progetto e poi presentarlo con i dovuti crismi dell'ufficialità. Più una scuola itinerante (si sono tenuti due incontri, in totale ve ne saranno dieci e il prossimo è in programma tra pochi giorni a Caltagirone, in Sicilia) che gira in lungo e largo l'Italia, con
testimoni a rappresentare un'idea di bene comune. La Cei ne è parte, vi sono vescovi coinvolti, da mons. Giampaolo Crepaldi di Trieste a mons. Michele Pennisi di Monreale, a mons. Mario Toso di Faenza. E poi economisti, giuristi, giornalisti, esponenti di comunità e movimenti. Una rete articolata che parte dal Vangelo e dalla dottrina sociale della chiesa - il punto di partenza cristiano, ça va sans dire, è chiaro e scontato - e che mette a disposizione il suo patrimonio di idee, ideali e buone prassi, stando in mezzo ai giovani. Con un monito finale, una sorta di faro datato 1984. Stavolta è Giovanni Paolo II a parlare, ricordando che "i capi non si improvvisano, soprattutto in epoca di crisi. Trascurare il compito di preparare nei tempi lunghi e con severità di impegno gli uomini che dovranno risolverla, significa abbandonare alla deriva il corso delle vicende storiche". Torna al sommario 5 – FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ, ECONOMIA E LAVORO AVVENIRE Pag 3 Debito pubblico e miseria, una spirale che va spezzata di Francesco Gesualdi All’origine del disagio sociale, idee e provocazioni Ormai anche in Italia la miseria è diventata un fatto palpabile che non può essere risolto senza occuparsi di debito pubblico. Di per sé il debito non è sempre rovinoso. In tempi di sottoccupazione può essere un’ottima scelta se è finalizzato al bene comune ed è finanziato attraverso i canali della sovranità monetaria. In tal caso la somma mancante è coperta con moneta di nuova emissione, che oltre ad avere effetti stimolanti su produzione, consumi e occupazione, ha il vantaggio di non dover essere restituita. Diverso è il debito contratto per l’arricchimento di pochi tramite il ricorso a prestiti privati. In tal caso rappresenta un salasso perché alla restituzione del capitale vanno aggiunti gli interessi, senza che la comunità abbia goduto di alcun beneficio. Purtroppo da più di trent’anni, già prima di entrare nell’euro, lo Stato italiano si è ridotto alla condizione di una qualsiasi famiglia, che dipende dalle banche per ogni spesa eccedente le entrate. Il suo debito nei confronti dei privati oggi ha raggiunto 2.270 miliardi di euro e ci procura una spesa per interessi che ruota attorno al 10% delle entrate fiscali. Nel 2016 è stata pari a 68 miliardi di euro, nel 2012 addirittura 87 miliardi per un semplice capriccio della speculazione. Soldi di tutti, che invece di andare a finanziare scuole, trasporti pubblici, sanità, ricerca, tutela dell’ambiente, vanno a ingrassare gli azionisti di grandi strutture finanziarie. In effetti solo il 5,4% del debito pubblico italiano è detenuto dalle famiglie. Tutto il resto è nelle mani di banche, assicurazioni, fondi d’investimento, i cosiddetti 'investitori istituzionali', sia italiani che esteri. Più precisamente quelli italiani detengono il 63,1% del nostro debito, quelli esteri il 31,5%. Si può senz’altro affermare che il debito verso i privati è un meccanismo di redistribuzione alla rovescia: prende a tutti per dare ai più ricchi perché solo i facoltosi hanno un sovrappiù da prestare allo Stato. E i risultati si vedono: l’Italia è sempre più disuguale. Da un punto di vista patrimoniale, ossia della ricchezza accumulata sotto forma di case, terreni, titoli, le famiglie più ricche, pari al 10% del totale, detengono il 46% dell’intera ricchezza privata, quelle più povere, pari al 50% del totale, posseggono il 9,4%. I segnali di un’Italia sempre più disuguale si ritrovano anche nella distribuzione del reddito. Ogni individuo del 10% più ricco ha un introito annuale medio di 77.189 euro, mentre quelli del 10% più povero si fermano a 6.521 euro. Un divario di quasi 12 a 1. Situazione peggiore degli anni Ottanta del Novecento quando il rapporto era 8 a 1. Il sottoprodotto dell’ingiustizia è la miseria che il debito aggrava tramite l’austerità, scelta classica di uno Stato asservito alla finanza. Assunto come priorità il pagamento degli interessi, lo stato cerca di raggranellare il dovuto aumentando le entrate e riducendo le spese. Ma se conduce l’operazione tassando poveri e ceto medio, invece che ricchi e benestanti, e tagliando servizi essenziali, invece che sprechi e privilegi, per molte famiglie le conseguenze sono drammatiche. Le statistiche confermano che 7 milioni di persone, 11,6% della popolazione italiana, vivono ormai ridotti in stato di grave deprivazione materiale. E se allarghiamo la visuale a chi vive nelle ristrettezze, scopriamo che le persone a rischio povertà, o esclusione sociale, sono 17 milioni e mezzo, quasi un terzo della popolazione
italiana. Lungo questa strada, l’intero sistema entra in una spirale di crisi che trascina tutti verso il fondo. Se aumentano le persone in difficoltà, i consumi si contraggono, le imprese non ricevono ordini, i licenziamenti si moltiplicano. Più nessuno investe in attività produttive, l’unico settore in espansione è la finanza. Negli ultimi 10 anni in Italia la domanda complessiva si è ridotta ai minimi storici facendo salire la disoccupazione alle stelle. Nel 2016 i disoccupati erano 3 milioni pari all’11,7% della forza lavoro. Ma il dato si riferisce solo a chi cerca attivamente lavoro. Se si includesse nel conteggio anche coloro che un lavoro salariato lo vorrebbero, ma non lo cercano perché scoraggiati, il numero dei disoccupati salirebbe a 5,5 milioni, il 21,6% della forza lavoro.7 Purtroppo anche la pubblica amministrazione contribuisce al problema: fra il 2013 e il 2016 ha perso 84mila unità. Da oltre trent’anni, ogni governo dichiara di porsi come priorità l’abbattimento del debito, ma se ne va lasciandosi dietro un debito sempre più alto. E non perché viviamo al di sopra delle nostre possibilità, come qualcuno vorrebbe farci credere, ma perché non ce la facciamo a tenere il passo con gli interessi. L’esame dei bilanci pubblici dimostra che siamo dei risparmiatori, non degli scialacquatori. Ad esempio nel 2016 abbiamo risparmiato 25 miliardi di euro: a tanto ammonta la differenza fra ciò che abbiamo versato allo Stato sotto forma di tasse e ciò che abbiamo ricevuto indietro sotto forma di servizi, investimenti, previdenza sociale. Ciò nonostante nel 2016 il debito pubblico è cresciuto di altri 40 miliardi perché il risparmio accumulato non è stato sufficiente a coprire tutta la spesa per interessi. Questa storia si ripete dal 1992 e ciò spiega perché da allora il nostro debito è passato da 850 a 2.270 miliardi di euro, nonostante 768 miliardi di risparmi. È semplicemente successo che su una somma complessiva di 2.038 miliardi di interessi, 1.270 sono stati pagati a debito. Il debito che si autoalimenta attraverso gli interessi è una delle forme più odiose di strangolamento: è usura. Ma gli strumenti per sottrarci a questo meccanismo perverso ci sono: vanno dal congelamento degli interessi, al ripudio del debito illegittimo; dall’imposizione di un prestito forzoso a carico dei cittadini più agiati, ad una tassazione progressiva del reddito e del patrimonio; dall’introduzione di una moneta complementare nazionale, alla riforma della Banca centrale europea; dal controllo della fuga di capitali alla regolamentazione della speculazione sui titoli del debito pubblico. Il problema non sono gli strumenti, ma la volontà di perseguire politiche non gradite ai ricchi e ai poteri della finanza. L’unica forza capace di imporre un’altra gestione del debito, rispettosa dei diritti sociali, è la pressione popolare. Ma i cittadini si attivano solo se si rendono conto dei danni che subiscono. Di qui il ruolo centrale dell’informazione che tutti dovrebbero assumere, a maggior ragione le realtà che lottano contro l’esclusione sociale. Che aspettano associazioni, sindacati, movimenti, parrocchie, ad unire le forze per organizzare una grande campagna di informazione pubblica sui nessi esistenti fra debito pubblico e disagio sociale? Il silenzio su questo tema non è più tollerabile. In Italia ci sono 307mila famiglie milionarie, pari all’1,2% del totale, che possiedono il 20,9% della ricchezza finanziaria. È quanto emerge dal rapporto «Global Wealth 2017: Transforming the Client Experience» di The Boston Consulting Group (Bcg), in cui si calcola anche che nel 2021 le famiglie milionarie saranno 433mila, l’1,6% del totale e con uno stock pari al 23,9%. A livello globale il numero di famiglie milionarie è cresciuto in un anno del 7%, arrivando a quota 18 milioni circa. Si tratta dell’1% delle famiglie, che detengono il 45% della ricchezza. Bcg rileva come la ricchezza finanziaria privata continui a correre in tutto il mondo, grazie alla corsa di Wall Street e degli altri principali mercati. Mentre la ricchezza finanziaria globale è cresciuta del 5,3% e, in Europa, del 3,2%, l’Italia ha registrato una leggera battuta d’arresto, anche se nei prossimi 5 anni è previsto che la ricchezza riprenderà a crescere. LA NUOVA Pag 1 Strategia per crescita e lavoro di Giulio Buciuni e Giancarlo Corò La recente protesta contro il Ceta, l'accordo di libero scambio tra Canada e Unione Europea, ripropone un tema cruciale per il Made in Italy, ossia il controverso legame tra tutela delle produzioni e protezionismo commerciale. Se tutelare la tipicità dei prodotti può servire a conservare competenze distintive, d'altro canto le limitazioni commerciali riducono la libertà di scelta dei consumatori, proteggendo le posizioni di rendita che si
formano nei mercati chiusi. Il confine tra tutela dei consumatori e protezione dei produttori è dunque labile, anche se le capacità di mobilitazione sono molto diverse. Da un lato molti consumatori con poche informazioni e nessuna associazione che ne tuteli gli interessi. Dall'altro pochi produttori politicamente ben organizzati, il cui obiettivo è limitare l'offerta per mantenere alti i prezzi di vendita e ridurre i rischi dell'innovazione. Il protezionismo non penalizza solo i consumatori, ma anche la competitività di lungo periodo del sistema produttivo. Le stesse produzioni tipiche italiane hanno molto da guadagnare dall'estensione dei mercati, anche se questo richiede investimenti in promozione, organizzazione delle reti di vendita e crescita della produttività. Sentiamo spesso ripetere che il Made in Italy è, in quanto tale, sinonimo di qualità ed esclusività, di produzioni create da un sapere artigianale radicato in luoghi specifici. D'accordo, ma dobbiamo tuttavia essere consapevoli che questo non basta per assicurare tassi di crescita accettabili a un paese moderno, che ha invece bisogno di imprese industriali e un'organizzazione internazionale della produzione per rispondere alla domanda di una classe media globale in espansione. Fra un decennio più della metà dei consumi mondiali verranno da Cina, India e Indonesia. Se vogliamo perciò creare in Italia opportunità di lavoro qualificato non possiamo limitarci a produzioni di nicchia per le ristrette élite occidentali. Dobbiamo invece moltiplicare il valore del Made in Italy attraverso nuove versioni di beni e servizi industriali in grado di occupare spazi di mercato più ampi e remunerativi. Se non lo facciamo noi, lo faranno altri - come sta avvenendo con Nespresso o Pizza Hut in due prodotti tipici dell'italianità - con buona pace di agricoltori, botteghe artigiane e la retorica sul Made in Italy. Esistono per fortuna anche in Italia industrie dove le strategie di versioning dei prodotti sono già attive. Nel settore moda, ad esempio, i grandi marchi - da Armani a Dolce&Gabbana a Tod's - affiancano alle linee da sfilata versioni destinate a fasce di consumo più ampie grazie anche a processi produttivi internazionali. Nell'agroalimentare è interessante il caso del formaggio Gran Moravia di Brazzale, prodotto nel territorio della Repubblica Ceca ma frutto di un qualificato lavoro di ricerca, marketing e gestione logistica sviluppato nella storica sede dell'Alto Vicentino. Pensiamo anche al settore del legno-arredo, dove medie aziende come Fantoni e Friulintagli hanno saputo coniugare qualità manifatturiera a economie di scala, diventando parte fondamentale della filiera Ikea. Sono queste formule efficaci di un Made in Italy che non si accontenta di contemplare la propria esclusività, ma che la differenzia e la perfeziona sfruttando le opportunità offerte dall'economia globale. Pag 6 Sono le donne che guidano la ripresa I dati di Confcooperative: le imprese in rosa crescono più della media, boom delle coop femminili Roma. Sono sempre più numerose le imprese sociali in Italia che vedono aumentare anno dopo anno il volume delle loro attività e l'occupazione. Ma, a fronte di un dinamismo che si consolida, 7 cooperative sociali su 10 nel 2016 non hanno raggiunto gli obiettivi di innovazione prefissati. Soprattutto per mancanza di risorse (84, 3%), dicono. Un gap a cui le nuove modalità di capitalizzazione previste dalla riforma del Terzo settore potrebbero porre rimedio, se non fosse che il 64, 5% degli enti ancora non le conosce o le conosce poco. A misurare lo stato di salute delle aziende del Terzo settore è l'indagine «Strumenti per lo sviluppo delle imprese sociali» che Isnet (associazione in rete con 1.221 organizzazioni) ha svolto con Banca Etica, nell'ambito dell'Osservatorio sull'Impresa sociale. E il risultato - è convinto il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Luigi Bobba - è «incoraggiante», nonostante il processo di innovazione sia segnato ancora da «chiaro-scuri». «La riforma del Terzo settore - ha affermato durante un incontro alla Camera - può offrire strumenti, un ecosistema favorevole per il rafforzamento e la nascita di imprese sociali innovative» e per «far sì che numero sempre più elevato di imprese abbia un Dna innovativo». «L'apporto di capitale sociale con elementi di vantaggio fiscale - ha spiegato il sottosegretario - assieme alla defiscalizzazione per chi intende reinvestire gli utili, vuole spingere verso l'innovazione sociale». «Il cammino di questa riforma, che necessita di altri decreti attuativi - ha sottolineato il presidente del Cnv, Edoardo Patriarca - è ancora lungo, ma il cantiere è aperto. È una sfida che riguarda le reti sul territorio e il Parlamento». I dati dell'Isnet rilevano come per il terzo anno consecutivo anche nel 2016 siano aumentate (+8,4%) le
cooperative sociali con un'attività in crescita, passando dal 33,6% del 2015 al 42% del 2016; il 41,5% del campione (400 cooperative sociali) prevede di chiudere in crescita anche il 2017, il 39% stima un aumento dell'occupazione (+11,4% sul 2016). Ma il 70% ammette di non avere raggiunto gli obiettivi di innovazione e il 64,5% non conosce o conosce poco i nuovi strumenti di capitalizzazione (social bond, capitali di rischio), con un 8% contrario per timore di perdere la governance. Al momento solo il 5% delle cooperative ha pensato a una soluzione per produrre la propria analisi di impatto sociale, così come previsto dalla riforma. Ma il sottosegretario chiarisce: «Abbiamo già una bozza di linee guida a riguardo. La legge prevede che non tutte le imprese sociali debbano fare necessariamente un bilancio sociale e applicare le linee, ma vogliamo che diventi una cultura diffusa». Roma L'energia delle imprese in rosa guida l'uscita dalla crisi. Le aziende al femminile crescono più della media del sistema imprenditoriale, soprattutto nelle aree metropolitane del Sud - Reggio Calabria, Catania e Palermo sono le regine - in ambiti fino a qualche anno fa presidio esclusivo, o quasi, di imprese al maschile e trovano nella cooperazione il loro habitat economico preferito. È quanto emerge da "Donne al lavoro, la scelta di fare l'impresa", il focus Censis-Confcooperative. Su un totale di 6 milioni e 74mila imprese registrate, il 21,8% (1,32 milioni) è guidato da donne. Fra il 2014 e il 2016 l'incremento delle imprese femminili è stato dell'1,5%, il triplo rispetto alla crescita del sistema imprenditoriale che non è andato oltre lo 0,5%. Tra il 2014 e il 2016 a fare la differenza sono i dati relativi a settori tipicamente maschili, nell'area dell'energia e nelle costruzioni infatti, la crescita è stata del 2,6%, settore quest'ultimo dove i dati complessivi mostrano una diminuzione delle imprese del 2,1%. Le imprese rosa nascono soprattutto nelle regioni centrali (+2%), al Sud (+1,8%), mentre il Nord Ovest e il Nord Est presentano incrementi più contenuti (1% circa). Le regioni a più alto tasso di crescita sono il Lazio e la Calabria (entrambe con un +3,1%), mentre, all'opposto, Piemonte, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Marche segnano una dinamica negativa. In termini di stock, la quota più elevata di imprese femminili è attribuibile al Mezzogiorno, dove hanno sede 476mila aziende, pari al 23,7% del totale. Se si prendono in considerazioni le 14 città metropolitane, al primo posto nel 2016 si colloca Reggio Calabria con il 24,2%, seguita da Catania con il 23,6% e da Palermo con il 23,4%. Roma e Milano sono sotto il valore nazionale, ma presentano gli stock più elevati: Roma è prossima alle 100mila unità, mentre Milano supera le 60mila imprese. In totale circa 464mila imprese al femminile si concentrano nelle aree metropolitane, poco più di 1/3 dei numeri nazionali. Rilevante è il numero di imprese guidate da donne straniere, in particolare nel tessile-abbigliamento con il 27,2% sul totale delle aziende "rosa" attive nel settore. Più considerevole è invece il contributo alla crescita del numero delle imprese che proviene dalle cooperative femminili che crescono del 4,1% in due anni (superando la soglia delle 30mila unità nel 2016) e portano al 21,1% la quota delle cooperative femminili sul totale delle cooperative. Circa il 40% dell'incremento osservato è riconducibile al contributo delle coop guidate da donne. Le 39.500 cooperative aderenti all'Alleanza fatturano 150 miliardi di euro e occupano un milione e 150mila addetti, pari al 90% dell'occupazione cooperativa in Italia. Di queste 1 su 3 è a guida femminile, le donne coprono una quota pari al 58% sul totale dell'occupazione, mentre la governance è donna per il 26%. «Questo perché le cooperative - dice Maurizio Gardini presidente di Confcooperative - sono le imprese che coniugano meglio di altre vita e lavoro. Bisogna puntare sulla conciliazione per accrescere la presenza delle donne nelle imprese e nel mondo del lavoro». Pag 6 In Italia ci sono 307mila famiglie milionarie L’1,2% del totale detiene il 20,9% della ricchezza Roma. L'Italia conta 307mila famiglie milionarie, pari all'1,2% del totale, che possiedono il 20,9% della ricchezza finanziaria italiana. È quanto emerge dal rapporto «Global Wealth 2017: Transforming the Client Experience» di The Boston Consulting Group (Bcg), in cui si calcola anche che nel 2021 le famiglie milionarie saranno 433mila, l'1,6% del totale e con uno stock pari al 23, 9%.A livello globale il numero di famiglie milionarie è cresciuto in un anno del 7%, arrivando a quota 18 milioni circa. Si tratta dell'1% delle
famiglie, che detengono il 45% della ricchezza. Bcg rileva come la ricchezza finanziaria privata continui a correre in tutto il mondo: «La corsa di Wall Street e degli altri principali mercati finanziari ha portato il valore totale di azioni, obbligazioni e depositi bancari alla cifra di 166.500 miliardi di dollari. Rispetto al 2015 si tratta di un incremento del 5,3%, superiore al +4,4% registrato l'anno precedente. Nel 2021 si dovrebbe toccare la quota di 223.100 miliardi di dollari, con una crescita media annua del 6%, derivante in parti uguali dalla creazione di nuova ricchezza e dalla valorizzazione degli asset esistenti».«Mentre la ricchezza finanziaria globale è cresciuta del 5,3% e in Europa del 3, 2%, l'Italia ha registrato una leggera battuta d'arresto riconducibile principalmente a riduzione di valore (cosiddetto effetto mercato) delle partecipazioni azionarie dirette e degli investimenti obbligazionari che avevano come controparte istituzioni finanziarie - dichiara Edoardo Palmisani, Principal di Bcg -. Le dinamiche della ricchezza finanziaria sono sempre legate infatti a due fattori: la nuova ricchezza generata e la performance del portafoglio. Il nostro report, per quest'anno, evidenzia come la creazione di nuova ricchezza sia rimasta pressoché costante, mentre sono stati gli investimenti diretti azionari ed obbligazionari a generare una performance negativa, seppur parzialmente controbilanciati da fondi comuni e gestioni patrimoniali».«Se guardiamo ai prossimi 5 anni - prosegue Palmisani - ci aspettiamo che la nostra ricchezza riprenda a crescere, superando i 5 trilioni di dollari. Oggi ci attestiamo sui 4,5 trilioni, a trainare saranno nuovamente i segmenti che hanno più di un milione di ricchezza e che cresceranno a tassi del 5/6%». Torna al sommario 7 - CITTÀ, AMMINISTRAZIONE E POLITICA CORRIERE DEL VENETO Pag 3 Venezia e Mestre separate, via libera al referendum: “Voteremo il 22 ottobre” di Marco Bonet e Andrea Zucco Ingorgo elettorale in Regione Venezia. Veneziani e mestrini voteranno per dirsi addio e lo faranno, con ogni probabilità, nello stesso giorno in cui i veneti voteranno per allontanarsi un po’ di più da Roma, il 22 ottobre. Con 33 «sì», un solo «no» e il Partito Democratico fuori dall’aula insieme a Mdp, il consiglio regionale ha infatti approvato ieri l’ultimo passaggio ultra tecnico, buro-demografico, necessario per allestire il quinto referendum per la divisione della «capitale del Veneto» (i quattro tentativi precedenti sono andati a vuoto: tre vittorie del No, un quorum mancato). Nello specifico, si tratta dell’atto che individua la popolazione che sarà chiamata alle urne: come proposto dalla giunta dopo accurate indicazioni degli uffici, a votare saranno soltanto gli abitanti del Comune di Venezia (261 mila persone) e non tutti quelli della fu Provincia, ora Città metropolitana (846 mila persone). A questo punto, licenziata la delibera tecnica e già manifestato col giudizio di meritevolezza del 14 febbraio scorso il pieno appoggio politico all’iniziativa, per dar corpo al sogno dei separatisti manca solo un ultimo step, scontato: il decreto di indizione del referendum firmato dal presidente della Regione Luca Zaia. In quale data? Il capogruppo della Lega Nicola Finco ieri in aula è stato esplicito: «Siamo favorevoli all’accorpamento con il referendum per l’autonomia, in un election day il 22 ottobre. In questo modo possiamo risparmiare 900 mila euro». Sottinteso: e metterci al riparo da eventuali reprimende della Corte dei conti. A proposito di election day: giusto ieri, a Belluno, si è tenuta una riunione congiunta della Conferenza enti locali e della Commissione statuto della Provincia, che com’è noto ha a sua volta annunciato un referendum per vedersi riconosciuta dalla Regione più autonomia. Anche in questo caso si sta lavorando all’accorpamento il 22 ottobre (una giornata di vero e proprio «ingorgo elettorale») che pure comporterebbe per la Provincia Dolomitica una spesa di 300 mila euro in rimborsi ai Comuni. Non un’uscita di poco conto, di questi tempi, sicché la decisione finale verrà rimessa all’assemblea dei sindaci in agenda per martedì. Tornando al referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, com’era prevedibile molte sono state le polemiche ieri in consiglio, corollario della battaglia giudiziaria avviata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che ha già impugnato al Tar il giudizio di
meritevolezza ed ha annunciato di voler fare altrettanto anche con la delibera di ieri. Con Brugnaro (sindaco di centrodestra anche se lui si dichiara «oltre la destra e la sinistra») si sono schierati Pd e Mdp, che come il primo cittadino contestano la legittimità dell’iter regionale basato sulla legge 25 e sull’articolo 133 della Costituzione, in conflitto con la legge Delrio - norma di rango costituzionale - che ha incluso Venezia tra le Città metropolitane fissando un percorso per la separazione assai diverso da quello previsto per gli altri Comuni. «Non tener conto del ricorso del Comune né dei pareri della presidenza del Consiglio dei ministri e del nostro Ufficio legislativo, oltre a illudere i cittadini rischia di avere ripercussioni economiche e configurare il danno erariale» avvertono i dem Francesca Zottis, Bruno Pigozzo e Stefano Fracasso. «Non comprendiamo il motivo di questa ostinazione, perché la Regione non voglia almeno attendere l’esito del ricorso». I dem, e con loro Marino Zorzato di Area Popolare, l’hanno in realtà capito benissimo: «Qui si vuole mettere l’istituzione regionale nel mezzo di una bega tutta politica tra la Lega e Brugnaro - ha detto Zorzato rivolgendosi ai dirimpettai della maggioranza - siccome non avete i numeri per sfiduciarlo in consiglio comunale, venite a regolare qui la vostra faida». È chiaro, infatti, che in caso di vittoria del Sì Brugnaro dovrebbe abbandonare Ca’ Farsetti, per una questione politica (il referendum è stato molto personalizzato) ma soprattutto tecnica: l’indomani lui sarebbe il sindaco di Venezia oppure di Mestre? Aspetto delicato, se si considera che Venezia è anche Città metropolitana, non a caso sottolineato con forza da Piero Ruzzante di Mdp. Il Carroccio, va da sé, con Alberto Semenzato e Gabriele Michieletto ha smentito qualunque intenzione che non sia quella di dare a mestrini e veneziani l’occasione di esprimersi, «dando seguito ad una proposta che giace qui dalla scorsa legislatura, quando non c’eravamo né noi, né Brugnaro». Con la Lega si è schierato il Movimento Cinque Stelle («È una questione di democrazia») e sentitamente ringraziano i promotori del referendum: «E’ solo l’inizio di una grande avventura che ridarà a Mestre e Venezia la dignità perduta». E già si indica il prossimo obiettivo, «lo statuto speciale per Venezia». Venezia libera, in Veneto libero, insomma. «E liberi pure noi» si buttano nella mischia i bellunesi. Avanti il prossimo. Pag 5 Le mura veneziane (ma non di Venezia) diventano patrimonio dell’umanità di Paolo Coltro Da Palmanova a Peschiera, da Bergamo a Zara: “Spot da due milioni di dollari” Sventolìo di bandiere italiane, croate e montenegrine per il riconoscimento come patrimonio Unesco dell’umanità delle «opere di difesa veneziane fra 16° e 17° secolo: Stato da terra e Stato da mar occidentale». Ma non sventola la bandiera con il leone di San Marco, Venezia è esclusa con le sue fortificazioni in laguna, come quelle nell’Egeo, a Candia, in Anatolia, sul mar Nero… ovunque ci fossero da difendere commerci e baili. Non sono i misteri della diplomazia o della burocrazia, ma quelli di un’analisi storico-filologica ferrea e nel contempo difficilmente comprensibile alle frotte di turisti affascinati dalla storia. Ma tant’è: nel patrimonio Unesco entrano le mura veneziane di Bergamo, le fortificazioni di Peschiera sul Garda, l’incomparabile città-fortezza di Palmanova, nonché le architetture militari di Zara (Zadar) e Sebenico (Sibenik) in Croazia e Cattaro (Kotor) in Montenegro. Una strada lunga, dall’idea al riconoscimento, se si pensa che si cominciò a vagheggiarla a Bergamo già nel 1988, ventinove anni fa. Per costruire i bastioni bergamaschi, sforando tempi e costi, la Serenissima impiegò ventisette anni. Ed erano pietre e mattoni, mica carte. Bergamo, la capofila del progetto, ha avuto il gran merito di crederci e di convincere: il progetto viene ufficializzato nel 2007, nel 2014 l’inserimento assieme a Croazia e Montenegro nella «Tentative List», due anni dopo l’Italia decide che questa sarà la sua unica candidatura non ambientale per quell’anno, consegnando all’Unesco un dossier di mille pagine. A maggio 2017 il responso di Icomos (International Council of Monuments and Sites), braccio operativo della consulenza Unesco. Icomos raffina, elimina, lima, sottilizza, cambia il titolo del sito transnazionale che il 9 luglio passa alla grande nell’assise decisiva dell’Unesco a Cracovia. Il fatto è, in verità, che i veneziani si sono inventati per primi un tipo di fortificazione all’avanguardia per quegli anni iniziali del ‘500 in cui le artiglierie erano sempre più efficienti e nel contempo mutava la sua visione/posizione commerciale nel mondo. L’America è lontana, si ragionava in Maggior Consiglio, meglio potenziare le reti commerciali mediterranee ed
europee e i confini dello Stato da terra. Detto, deciso e quasi fatto: Venezia ci impiega novant’anni per Venezia per mettersi in sicurezza, militare e commerciale: i due aspetti non erano mai disgiunti. E allora vediamole, queste fortezze che dopo progettisti, architetti, schiere di operai e soldati, residenti adesso attendono nuove ondate di turisti attratte dal timbro fresco fresco di gioielli dell’umanità. L’Unesco sostiene che il riconoscimento equivale, nell’immediato, a una campagna pubblicitaria da due milioni di dollari. Se ne renderanno conto i 5500 abitanti di Palmanova? Lì dove è tutto tranquillo dal 1848, i tempi dell’ultimo assedio austriaco quando la città si ribellò agli Asburgo assieme a Venezia, tranquillo e vuoto e bellissimo, nel paradigma di una geometria che unisce utopia a razionalità. Palma (il Nova verrà aggiunto da Napoleone assieme alla terza cerchia di mura) nacque dal nulla il 7 ottobre 1593, nel giorno dell’anniversario della battaglia di Lepanto (1571) e di Santa Giustina protettrice. Dei diversi progetti di città poligonale, prima undici, poi dieci, infine nove lati, il Senato veneziano scelse l’ennagono, cosicché Palma splende come una stella a nove punte. Sentinella ai confini dell’Impero, ma soprattutto baluardo contro i Turchi che facevano sempre paura. E da lì partirono anche i soldati che combatterono gli Uscocchi, pirati slavi scatenati arroccati a Segna, che tra il 1592 e il 1609 si erano impadroniti di 250-300 navi veneziane, il 10 per cento dei navigli in mare. Gente che non faceva sconti: nel 1613 catturarono la galera del sopracomito Cristoforo Venier, uccisero tutto l’equipaggio, decapitarono Venier divorandogli il cuore dopo averlo strappato dal petto. Brutalità che non arriva nell’eleganza del perimetro di bastioni, della piazza esagonale centrale contornata d’acqua, delle diciotto strade radiali. Palmanova rimane una città ideale realizzata e visibile, anche se non si riuscì mai a popolarla, oltre ai soldati, con i ventimila abitanti previsti. Appunto, un sogno per pochi. A Peschiera i bastioni si riflettono sull’acqua, praticamente da sempre: fin dalle origini è stata una cittadella militare e nella sua forma attuale la vediamo come la fecero i veneziani dal 1549 in poi. Uno scoglio a monito del Ducato di Milano, dove vivere non era semplice: «tale e tanta è la penuria di vivere sopra la fortezza di Peschiera e così puochi sono gli negotii...», recita una supplica del 1589. Ma oggi, accanto ai militari che restano, c’è colore, fascino, suggestione. Bergamo alta è in Lombardia, ma una delle associazioni alfiere del progetto si è battezzata «Terre di Venezia». La Serenissima agli inizi del ‘500 la difendeva con le unghie e con i denti, ci furono scontri frequenti, ma Bergamo era anche il simbolo dei confini dello Stato da terra. Per cui, dal 1561 mura imponenti a difesa della città alta, con un significato politico preciso. Ma anche un’utilità non solo militare: funzionavano da barriera doganale. Si è conservata praticamente intatta, con i suoi sei chilometri di sviluppo, una strada coperta esterna, 14 baluardi, due piattaforme, due polveriere, 100 aperture per bocche da fuoco, e quattro porte. Un’opera immensa: doveva costare 100 mila ducati e ne costò quasi un milione e mezzo, quindici volte tanto. Ci lavorarono per anni e anni più di 4000 muratori, lapicidi, guastatori, falegnami, tecnici, spazzando via più di 250 case del tessuto romano-medievale della città. Però a Bergamo alta non entrò più nessuno. Pag 11 San Marco su prenotazione dal 2018. E tassa di sbarco in alcune isole di Gloria Bertasi La giunta approva le linee per la gestione dei flussi. Ipotesi di limitazioni per fasce orarie (10-18) dell’area marciana. Bus e auto turistiche contingentati Venezia. Una «card» per accedere su prenotazione a San Marco, ai suoi musei, ai suoi negozi, alla basilica del patrono e, perché no, ai caffè blasonati del salotto buono di Venezia. Ma non solo, nel prossimo futuro, potrebbe essere introdotto un ticket per sbarcare sulle isole di Murano, Burano Sant’Erasmo, Pellestrina e Torcello, come già succede in località turistiche quali Capri e Pantelleria. A «istruire» i turisti sulle regole di comportamento cittadine (niente tuffi o biciclette ma nemmeno pic-nic e vestiti da spiaggia) di sicuro arriverà un hashtag con cui «spammare» la rete di informazioni utili, e spiegate con un metodo al passo con i tempi, nella visita a Venezia. La «road map», ossia il piano di lavoro richiesto dall’Unesco a Comune e Stato, inizia a prendere forma e ieri il sindaco Luigi Brugnaro e i suoi assessori ne hanno discusso per quasi tre ore durante la seduta di giunta. I dettagli del documento, che delinea le politiche di gestione dei flussi turistici in città, non sono ancora pubblici ma qualcosa di quelle 150 pagine è già trapelato. Come annunciato nelle linee guida approvate ormai due mesi fa a Ca’
Farsetti, l’amministrazione ha studiato tutte le proposte avanzate da associazioni, categorie e singoli cittadini in commissione consiliare Turismo lo scorso autunno e ne ha tenuto conto nel formulare soluzioni che migliorino la qualità della vita quotidiana in città e che rispondano alle necessità di tutela e salvaguardia richieste dall’organizzazione internazionale. Il capitolo sicuramente più interessante della «road map» fucsia riguarda l’area marciana considerata, proprio per introdurre il booking, un unico sito monumentale com’è Pompei. Nell’atto di indirizzo sul turismo, la giunta ventilava l’ipotesi di un confronto con tutti i soggetti che operano a San Marco per capire come ridurre il peso del turismo nella piazza più fotografata del mondo. Ora, quel confronto pare essersi avviato e spuntano alcune idee di lavoro. L’area marciana è delimitata dai ponti della Paglia e della Zecca, ci si può accedere dal lato del museo Correr, dalla Torre dell’Orologio, da calle della Canonica e da lato di calle Larga San Marco. Per regolare gli ingressi va trovato dunque il modo di presidiare una decina di entrate. Come, dalle indiscrezioni di palazzo, non sarebbe ancora stato deciso. Potrebbero essere tornelli oppure steward o vigili. Quello che conta però è che nel 2018, e per tutto l’anno, dovrebbe essere testata sul campo la possibilità di regolare i flussi in piazza. Tre le ipotesi allo studio. La zona potrebbe essere chiusa a chi non ha prenotato nei giorni con più arrivi a Venezia, ossia nei week end dal venerdì alla domenica o nei mesi «caldi» di luglio e agosto. Oppure, altra idea, potrebbero essere introdotte fasce orarie giornaliere. Ad esempio, tra le 10 e le 18, le ore cioè più gettonate dai turisti San Marco sarebbe accessibile solo con la prenotazione. Residenti, studenti, lavoratori sarebbero esclusi. Per ora, è prematuro fare congetture su ciò che sarà davvero introdotto tra qualche mese ma quello che è certo è che nel 2018 le novità dovrebbero essere molte. Prenotazione obbligatoria, ticket di sbarco nelle isole della laguna ma anche nuove linee di Actv per decongestionare i vaporetti del Canal Grande. Si tratta di interventi attesi da molti anni a San Giobbe e a San Basilio dove, ancora nel Piano urbano del Traffico di dieci anni fa, sono previsti terminal a beneficio di chi arriva dalla terraferma ma soprattutto dei turisti. A San Giobbe c’è il nuovo ponte intitolato a Valeria Solesin che faciliterebbe l’arrivo ai vaporetti. Il documento della giunta introduce, infine, la possibilità di fermare pullman e auto turistiche quando la città e i parcheggi sono pieni. LA NUOVA Pagg 2 – 3 Passa il referendum in consiglio regionale di Alberto Vitucci e Nicola Brillo Separazione Venezia – Mestre. Ora Zaia deciderà la data, probabile il 22 ottobre Colpo di scena. Il veto di Brunetta e i dubbi degli alleati non sono bastati. Ieri il consiglio regionale ha approvato l'ultimo atto che apre la porta all'indizione del referendum per la separazione amministrativa di Venezia e Mestre. Un solo contrario, Pietro Dalla Libera (civica Moretti), i tre consiglieri del Pd Zottis, Pigozzo e Fracasso sono usciti dall'aula, come già avevano fatto in febbraio al momento di votare la "meritevolezza" del quesito. A favore tutti gli altri, compresi gli assessori di Forza Italia Donazzan e Giorgetti.Esultano i separatisti. «Ha vinto la democrazia, contro chi vuol solo mantenere la poltrona», commenta a caldo Stefano Chiaromanni, «le provocazioni di Renato Brunetta, che domani inaugura una sede di Forza Italia proprio sotto la sede del Movimento in via Bembo non hanno sortito alcun effetto». «Adesso si decida la data e si cominci il dibattito nel merito», auspica Alberto Mantovan, «basta ricorsi al Tar e polemiche strumentali». «Ce l'abbiamo fatta nonostante Brugnaro e Brunetta abbiano tentato in tutti i modi di ostacolare il voto», dice Marco Sitran, «adesso si deve votare il 22, data storica che cambierà la storia sulla via del federalismo». Lunga la lista dei ringraziamenti. «Zaia, Forcolin, Finozzi. Ma anche Michieletto, la Lista Tosi, il Movimento Cinque stelle, Fratelli d'Italia.Gian Angelo Bellati, già candidato sindaco delle civiche e della Lega, spalanca un gran sorriso: «Grande esempio di democrazia. E di bella politica. Di chi mantiene i patti firmati con i cittadini. Non tutti lo fanno, e nemmeno il sindaco Brugnaro che si era impegnato con noi a fare il referendum».I tre consiglieri del Pd spiegano così la loro uscita dall'aula: «Non siamo contrari al referendum ma a questo modo di procedere della giunta regionale che non tiene conto del ricorso del Comune, né dei pareri degli uffici legali. Si rischia il danno erariale».Strada spianata dunque verso il referendum? Non è automatico. Prima della firma sul decreto di indizione del referendum
- che il governatore Zaia dovrebbe annunciare nei prossimi giorni - il governo potrebbe intervenire, sollevando il "conflitto di attribuzione". L'argomento impugnato da Brugnaro con il suo ricorso al Tar. In sostanza: può la legge Delrio, che ha istituito le Città metropolitane, essere superiore all'articolo 133 della Costituzione che assegna alle Regioni il potere di modificare i confini dei comuni? Un tema non solo legale, ma soprattutto politico. «Non vorremmo votare un referendum che poi viene dichiarato illegittimo», dice il consigliere comunale pd Nicola Pellicani.Molte crepe si vedono sulla muraglia di certezze che aveva portato in questi anni il Pd e il centrosinistra a sostenere le ragioni dell'unione. In tanti, anche nelle file della sinistra, si dichiarano ora possibilisti. La Lega ne ha fatto una priorità della sua campagna elettorale, a sinistra qualcuno lo vede come uno strumento per "mandare casa" il sindaco Brugnaro che altrimenti governerà cinque anni e forse anche di più. Favorevoli alla consultazione anche i Cinquestelle e Fratelli d'Italia. Ma resta il blocco del centro, con estensioni a sinistra e a destra.Come finirà? Gli autonomisti si preparano alla battaglia d'estate. Ma la certezza sulla data del voto ancora non c'è. È possibile che per accontentare tutti la Regione possa indire il referendum, senza però abbinarlo all'altro referendum sull'autonomia del Veneto. «Ma in questo caso andremo alla Corte dei Conti, si spreca quasi un milione di euro dei cittadini», dicono a una sola voce i comitati.Gli unionisti annunciano altre carte vincenti. Il sindaco Luigi Brugnaro, che in caso di separazione dovrebbe dimettersi, ha presentato un ricorso al Tar come Comune e come Città metropolitana - l'ex Provincia che presiede di diritto, anche se non votato dai cittadini, come sindaco del comune capoluogo - in cui definisce "illegittimo" il referendum dopo l'entrata in vigore della legge sulla Città metropolitana. L'esatto contrario, secondo le memorie depositate al Tar dagli autonomisti: «Con la separazione la Città metropolitana si rafforza», dicono, «si risparmiano 120 milioni delle Municipalità». La guerra è ancora lunga. Ma la battaglia di ieri l'hanno vinta senza dubbio i separatisti. Venezia. Alleati con idee opposte. Almeno sulla separazione di Venezia e Mestre. Forza Italia e Lega litigano sull'autonomia. Punto irrinunciabile per il Carroccio, che però il partito di Berlusconi non vede con grande entusiasmo. L'ultimo scontro sulla separazione è costato una frattura dentro la Lega. L'espulsione dell'assessora al Commercio della giunta Brugnaro Francesca Da Villa, rea di non aver votato contro il ricorso al Tar per far dichiarare "illegittimo" il referendum, come aveva deciso il suo partito. Polemiche tra il Carroccio e il sindaco Brugnaro, che governa con l'appoggio del centrodestra. Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia e commissario veneziano del partito, ex ministro ed ex candidato sindaco perdente per due volte, è tra coloro che si sono messi di traverso. Onorevole Brunetta, Lei ha chiamato il governatore Zaia per dirgli di rinviare il voto sul referendum? «No comment». Lei è favorevole al referendum per la separazione?«Ho detto che sono favorevole al referendum sull'autonomia del Veneto promosso da Zaia. E al regionalismo a geometria variabile. Quello è sacrosanto». E Venezia-Mestre? «Trovo che l'ennesimo referendum su questa materia, mi pare sia il quinto, sia del tutto inutile. Dunque mi pare che non sia legittimo abbinare quel referendum a quello sull'autonomia del Veneto il 22 ottobre».Sarebbe il quinto, lei dice. Ma forse i tempi sono cambiati.«Mi pare stucchevole votare per la quinta volta su uno stesso tema. Superato tra l'altro dopo l'introduzione della Città metropolitana. Ma visto che i referendum sono atti di democrazia e di libertà, lo facciano. Per ragioni di correttezza istituzionale non si deve però votare nella stessa giornata dell'altro».La motivazione è che così si risparmiano 900 mila euro.«Che discorsi, se il referendum non si fa non spendiamo niente».Gli autonomisti sostengono che i poteri forti in queste occasioni si alleano. E il referendum non lo faranno fare. «Ma quali poteri forti... In Regione c'è un partito che governa con il 60%, può fare quello che vuole».Ma voi alleati avete tirato il freno.«Beh, chiaro che se tra poco dovremo andare al governo e governare insieme l'Italia bisogna ragionare. Io con Zaia vado d'accordo. Ho parlato l'altro giorno anche con Salvini. Credo che su questa vicenda si dovrà trovare un punto di incontro».Cioè buttare a mare il referendum? «Farlo in una data diversa». E se il vostro alleato Zaia dovesse farlo lo stesso?«Beh, vediamo prima come va a finire». Insomma, Brunetta, Lei ha fatto pressioni sul governatore leghista per far rinviare il voto di ieri? «Su questo preferisco non rispondere. Grazie».
Venezia. La Lega tira dritta in consiglio regionale: anticipa il punto all'ordine del giorno e lo approva. Con i voti della maggioranza compatta (Forza Italia compresa) passa la proposta di deliberazione amministrativa numero 45, volta a individuare la popolazione interessata al referendum di suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e di Mestre. Si tratta di un passaggio tecnico, per eliminare dal voto gli abitanti della Città metropolitana.«Lo avevamo promesso nel programma elettorale del 2015 per le amministrative insieme al sindaco Brugnaro e l'abbiamo mantenuto», commenta il capogruppo in consiglio regionale della Lega Nord, Nicola Finco. «Se poi il sindaco di Venezia ha cambiato idea nel corso di questi anni, questo è un problema suo». Sul fatto di aver anticipato il voto di una settimana, il capogruppo leghista risponde: «Nessuna ripicca personale nei confronti del sindaco, è solo una questione politica: la settimana prossima la vogliamo dedicare alla votazione del bilancio, non volevamo portare la discussione troppo avanti». «Una cosa è certa», conclude Finco, «non ci lasciamo certo comandare da Renato Brunetta».Ora la parola passa al governatore Luca Zaia, che dovrà indire il referendum cittadino. E la data sarà il 22 ottobre prossimo, in concomitanza con quello regionale («in questo modo risparmieremo un milione di euro»). «Con la decisione sulla perimetrazione dei confini dell'elezione abbiamo chiuso un percorso: solo i cittadini di Mestre e Venezia parteciperanno al voto, sono ovviamente esclusi quelli della Città metropolitana», spiega il vicepresidente della Regione, Gianluca Forcolin. «Io non mi esprimo sul voto, ma sono felice di dare la possibilità ai cittadini di Mestre e Venezia di farlo».A preoccupare il sindaco di Venezia, secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali, è che l'eventuale vittoria del Sì lo porterebbe al decadimento dalla carica di sindaco della città di Venezia e anche della Città metropolitana. «Siamo da sempre contrari al referendum», spiega l'assessore regionale Elena Donazzan, presente in aula, «ma questo è un passaggio tecnico, ora ci batteremo perché vinca il no alla separazione».L'opposizione di centrosinistra in consiglio regionale si è astenuta: «Non siamo contrari al referendum, ma a questo modo di procedere da parte della giunta", spiegano i consiglieri del Pd Francesca Zottis, Bruno Pigozzo e il capogruppo Stefano Fracasso. «Non tener conto del ricorso del Comune di Venezia né dei pareri della presidenza del consiglio dei ministri e del nostro ufficio legislativo, oltre a illudere i cittadini rischia di avere ripercussioni economiche e si potrebbe configurare il danno erariale», proseguono. «Non comprendiamo il motivo di questa ostinazione, perché la Regione non voglia almeno attendere l'esito del ricorso. O meglio, forse si capisce dalla discussione in Consiglio, sembra che questa scelta sia più una rivendicazione della Lega per colpire Brugnaro, anziché una decisione politica consapevole».«La posizione del Movimento 5 Stelle», dichiara la consigliera regionale Erika Baldin, «è di consentire ai cittadini di esprimersi sulle questioni che li riguardano e sul proprio futuro. È una questione di democrazia alla quale non vanno sovrapposte questioni politiche: i partiti politici dovrebbero rimanere fuori da questa polemica che non fa il bene dei cittadini». Pag 18 Comunità ebraica, Gnignati confermato Presidente per altri quattro anni Paolo Gnignati riconfermato alla guida della Comunità Ebraica di Venezia per altri quattro anni. Gnignati, avvocato civilista, è stato infatti nuovamente nominato presidente della Comunità, ruolo che ha ricoperto nel passato quadriennio. La nomina è avvenuta all'unanimità - salva la sua astensione - nel corso della prima riunione di Consiglio dopo le elezioni del 25 giugno scorso. In occasione della consultazione elettorale Gnignati aveva ottenuto il numero più alto di consensi. Ad affiancarlo in Giunta Giuseppe Gesuà sive Salvadori, confermato nella veste di vicepresidente, e Gaia Ravà come terzo membro dell'esecutivo. A completare il Consiglio Dan Levi, Enrico Levis, Sandra Levis e Paolo Navarro Dina.Senso di responsabilità, coesione e cooperazione i concetti chiave espressi dal nuovo Consiglio che guiderà la Comunità per i prossimi quattro anni. L'impegno per il futuro - si legge in una nota della Comunità - è di promuovere uno spirito di concreta e fattiva collaborazione con la cittadinanza tutta, in vista delle sfide che la Comunità insieme alla Città di Venezia sarà chiamata a sostenere nei prossimi anni. La Comunità Ebraica di Venezia è una delle ventuno comunità ebraiche italiane riunite nell'Unione delle comunità ebraiche italiane e coordina le attività
culturali-religiose degli ebrei delle province di Venezia, Treviso e Belluno .Viene definita una comunità di medie dimensioni e conta ufficialmente 540-600 appartenenti, soprattutto tra Venezia-centro storico (poco più di 400 persone) e la cintura. IL GAZZETTINO DI VENEZIA Pag V Brugnaro: pronto a far campagna per il no di Roberta Brunetti Lettera polemica di Bellati: “Quel patto scritto tradito dopo aver incassato i voti della Lega” Un altro via libera dalla Regione al referendum per la separazione di Venezia e Mestre. E il sindaco Luigi Brugnaro mette in guardia da quello che giudica un «disastro», conferma la decisione di impugnare la consultazione ritenuta illegittima, ma annuncia che se sarà costretto, farà campagna elettorale entrando nel merito della questione. «Stiamo già facendo i conteggi di quanto costerebbe la separazione alla città. I danni sarebbero enormi!». Ieri il Consiglio regionale ha confermato la scelta della Giunta di far votare solo i cittadini del Comune di Venezia, e non dell'intera Città metropolitana. Un ulteriore passaggio verso un referendum che si avvicina, ma che Ca' Farsetti ha già annunciato che impugnerà davanti al Tar, non appena sarà indetto. «Lo hanno deciso il Consiglio comunale e la Città metropolitana - ricorda Brugnaro - Non voglio fare l'errore di personalizzare il referendum. È una strada che porta al disastro economico, oltre che sociale, della città. Ora siamo a un bivio. C'è chi pensa che abbia un senso. E chi ritiene che sia un disastro. Ma, ripeto, non voglio personalizzare. Sono posizioni trasversali». Il sindaco non vuole replicare nemmeno all'ex alleato Gian Angelo Bellati che torna a rinfacciargli il patto elettorale tradito sul referendum. «Lui parla di tradimento? - sbotta Brugnaro - È la persona che doveva fare il vicesindaco per tutelare quell'accordo, che voleva fare il direttore generale per soldi, che alla fine si è dimesso anche da consigliere comunale dove avrebbe potuto difendere la sua posizione. Una persona che forse, in questa vicenda, ha interessi concreti da difendere». Il sindaco si dice pronto ad affrontare una dura campagna elettorale per il no, se il ricorso al Tar non bloccherà la consultazione, o se addirittura arriverà tardi. «Sarebbe un ulteriore danno per la città. I danni saranno davvero enormi - ribadisce Brugnaro - Siamo facendo i conteggi. Sarà un disastro sia per la terraferma che per il centro storico. Un primo effetto sarà la chiusura del Casinò. Sarà una follia. I bilanci sono incastrati. Si andrà a un blocco dell'attività amministrativa per anni, tra ricorsi e controricorsi. Entreremo nel merito di tutto questo. Se sarà costretto, farò campagna elettorale e chiederò a tutte le forze politiche di esprimersi». Nel 2015 la Lega Nord e il candidato Brugnaro stipulano e sottoscrivono un accordo dal quale si evince chiaramente la volontà di far celebrare ai cittadini del comune di Venezia il famoso referendum per suddivisione del territorio in due comuni, uno d'acqua (Venezia) e uno comprendente la terraferma. Esiste un'esigenza, è stata fatta una raccolta firma da parte dei comitati, sono stati fatti i passaggi necessari come da legge vigente, e cosa succede??? Succede che in barba agli accordi sottoscritti, il sindaco Brugnaro (che ha incassato anche i voti dei Comitati e della Lega Nord) si defila, non ne vuol più sapere, addirittura incarica i suoi uffici di fare ricorso contro la celebrazione del referendum. Una volta la parola era fondamentale, valeva più di un accordo scritto... Mai un uomo si sarebbe sottratto dal mantener fede alla parola data. Oggi invece per qualcuno, (e dispiace che questo qualcuno sia un sindaco che ha preso un impegno), per qualcuno, dicevo, la parola data non vale nulla, e parimenti non vale nulla un autografo, una firma, un sigillo ad un accordo elettorale. Quanto poco vale la parola di qualcuno, e quanto poco vale la sua firma! Potrei capire un suo schierarsi per il si o per il no (anche se un sindaco dovrebbe astenersi dal farlo, ma voler impedire che i propri concittadini si esprimano è un atto contro la democrazia e contro gli accordi sottoscritti, atteggiamento che poco si addice a chi riveste il ruolo di sindaco. Pensavamo di avere a che fare con un signore di parola, ci sbagliavamo. Poveri cittadini del Comune di Venezia, non si finisce mai, ahime', di imparare. (Gian Angelo Bellati - segretario Unioncamere ed ex candidato sindaco) Torna al sommario
8 – VENETO / NORDEST CORRIERE DEL VENETO Pag 1 Carrozzoni duri a morire di Marco Bonet La nuova partecipata È nato «Veneto Welfare» e davvero se ne sentiva il bisogno. Chi altri, se non la Regione per il tramite di un nuovo ente (il ventesimo stando agli elenchi ufficiali; poi ci sono altre tredici società), avrebbe infatti potuto occuparsi della «promozione, l’informazione e l’assistenza sulla previdenza complementare», «curare i rapporti con gli enti accreditati», «offrire servizi e assistenza in materia», «realizzare progetti di tutela sociale» ed effettuare gli immancabili «studi e ricerche»? Ci voleva «Veneto Welfare» si sono detti Lega e Forza Italia, anche se i soldi sono quelli che sono: 40 mila euro. Basteranno, forse, per uno studio o una ricerca. Di sicuro non per pagare il futuro direttore nominato in deroga e senza bando, che si vorrebbe con stipendio pari a quello di un dirigente regionale (il minimo è 80 mila euro), figuriamoci un revisore dei conti, il personale e i consulenti, ammessi sì ma «solo in caso di progetti particolari». Proprio sui denari fanno leva d’altronde i consiglieri della Lega, sussurrando d’aver solo tenuto fede «ad un impegno di maggioranza preso con Antonio Guadagnini (il consigliere indipendentista che ha firmato il progetto di legge, ndr.)». Nessuno sembra crederci davvero a questo ente che dovrebbe perfino dare - non meglio precisati - «contributi» ai disoccupati veneti: «È solo una questione di equilibri interni». L’obiettivo, rivelato senza troppi imbarazzi, è quello di soffocare l’idea nella culla della prima legge di bilancio utile, forse già in autunno. «Semplicemente, Veneto Welfare non verrà finanziata e addio». Guadagnini se la sarà segnata, certo a questo punto ne esce meglio l’assessore al Lavoro Elena Donazzan, che dopo aver votato sì ha perlomeno tentato una difesa d’ufficio: «È un cambio di paradigma, una rivoluzione. Una legge manifesto che è la declinazione del principio di sussidiarietà». Passi. Ma davvero il Veneto ha bisogno di «leggi manifesto»? Davvero c’era bisogno di un nuovo carrozzone, per quanto parcheggiato, per cancellare il quale come minimo si dovrà tornare in aula un’altra mezza giornata e approvare una legge uguale e contraria? Con tutto quel che ci sarebbe da votare (seriamente, con convinzione) per il bene del Veneto? Con tutto quel che ci sarebbe da fare proprio sul fronte della razionalizzazione degli enti e delle partecipate? Il piano risale al 2010 ma volendosi limitare a questa legislatura va registrato perlomeno un annuncio all’anno: prima il governatore Luca Zaia (7 aprile 2015), poi il segretario della Programmazione Ilaria Bramezza (12 settembre 2016), quindi il vicepresidente con delega al Bilancio Gianluca Forcolin (22 marzo 2017). Parola d’ordine: tagliare. Obiettivo indicato: risparmiare. Ma tra il tagliare e il risparmiare ci sono di mezzo il codice civile, la burocrazia, Dio non voglia altri soci, dipendenti, fornitori, crediti e debiti di ogni tipo. Non basta uno schiocco di dita, neppure se le dita sono quelle del governatore. Lo sanno bene a Veneto Promozione, la società nata nel 2011 (non cent’anni fa) per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese. La si vorrebbe chiudere da più di un anno ma, complici i dissidi interni dell’altro socio (le Camere di commercio), non ci si riesce. Nel mezzo, ci sono 20 dipendenti. Il Centro di protezione civile di Longarone è in liquidazione coatta: il commissario ha fatto sapere che i soldi in cassa (669 mila euro) non basteranno a pagare i creditori (768 mila euro), tra cui ci sono tre dipendenti senza stipendio da settembre e perfino gli scout, in paziente attesa di 20 mila euro. Veneto Nanotech, su cui sono stati investiti circa 40 milioni in 12 anni, è in concordato preventivo: sono stati ceduti i laboratori mentre i dipendenti, una cinquantina, via via se ne sono andati. Dopo la chiusura di Veneto Agricoltura, ancora in liquidazione a causa di alcune pendenze, è stata aperta l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, che fa esattamente le stesse cose (ci sono voluti tre diversi atti notarili per trasferire tutto da una scatola all’altra), anche se certo con un presidente in meno (è rimasto solo il direttore). Finalmente è stata chiusa la Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale, nata nel 2006, operativa fino al 2010, liquidata nel 2013. L’Istituto per le Ville Venete è commissariato. Le Ater sono commissariate. Gli Enti per il diritto allo studio universitario (Esu) sono commissariati. Il Parco del Delta del Po è commissariato, come quello dei Colli Euganei e quello della Lessinia. Il tutto in attesa delle più volte
annunciate «riforme complessive», mai approdate in aula. Non risulta si sia mai completata la fusione tra Edilizia Canalgrande e Immobiliare Marco Polo, le «real estate» della Regione. Non ha avuto seguito, per ora, l’incorporazione di Veneto Strade in Cav studiata dall’assessore alle Infrastrutture Elisa De Berti. La newco autostradale con Autovie e Anas è impantanata (va detto, non per colpa della Regione Veneto che è socio largamente minoritario). Anche Veneto Sviluppo sta cambiando pelle ma per ora è stata ufficializzata solo l’acquisizione di Friulia Sgr. Ebbene, in questo quadro già di per sé ingarbugliato, davvero si sentiva il bisogno di buttare nel mucchio pure l’indispensabile «Veneto Welfare»? Torna al sommario … ed inoltre oggi segnaliamo… CORRIERE DELLA SERA Pag 1 Gli eterni interessi nazionali di Angelo Panebianco Europa e illusioni Chi lo avrebbe mai detto? Macron, presidente della Francia, vuole fare, sulla questione dei migranti, l’interesse della Francia anziché dell’Italia. Era lecito, quando Macron venne eletto, rallegrarsi per la sconfitta di Le Pen. Ma molti commenti che abbiamo letto in Italia sul presidente «europeo», erano fuori misura, rivelavano l’infantilismo politico dei loro autori. Gli «europeisti macroniani», però, non sono i soli afflitti da tale malattia. I loro avversari, i «sovranisti», non sono da meno. Mentre i primi ignorano l’importanza degli interessi nazionali, i secondi ne offrono un’immagine caricaturale, pensano che le nazioni siano le stesse dell’Ottocento, mondi a tenuta quasi stagna, ove basta chiudersi dentro e buttare via la chiave per vivere prosperi e felici (per inciso, non era vero neppure nell’Ottocento). Il cosmopolitismo, che ignora la forza degli interessi nazionali, e il sovranismo, che li finge diversi da ciò che sono, sono due diverse versione dell’incapacità di pensare con realismo il mondo in cui viviamo. Spiegare la forza degli orientamenti cosmopoliti in Italia è facile. La presenza del papato, una unificazione nazionale recente, la sconfitta nella Seconda guerra mondiale (a cui ci condusse il nazionalismo muscolare dell’età fascista), il perpetuarsi di divisioni (fra Stato e Chiesa, fra Nord e Sud) che non hanno mai permesso a molti italiani di sviluppare un senso di appartenenza collettiva, sono all’origine della sindrome cosmopolita, di quelli che si credono «cittadini del mondo» anziché italiani. Per costoro non solo gli interessi nazionali non esistono o, se esistono, basterebbe la buona volontà per neutralizzarli, ma è anche illegittimo evocarli, è segno di grettezza morale, forse una manifestazione di cripto-fascismo. Incapaci di capire che un mondo diviso in una pluralità di Stati e nazionalità implica necessariamente la presenza di altrettanti interessi, a volte fra loro compatibili e a volte no, i cosmopoliti sono anche inconsapevoli di come funzioni una democrazia. La democrazia è quel regime in cui se la maggioranza degli elettori vuole intensamente una cosa, Macron o chi per lui, non gliela può negare. Questa inconsapevolezza fa dei cosmopoliti una «élite senza popolo». I sovranisti sono afflitti dalla sindrome opposta. Credono di sapere cosa sia l’interesse nazionale. Lo credono sinonimo di autarchia: niente euro, niente Europa, niente migranti, niente più interdipendenza. Nella variante lepenista, questo orientamento si sposa al tradizionale nazionalismo francese. In Italia, ove il nazionalismo è debole, il sovranismo è solo desiderio di sicurezza, l’illusione di acquisirla chiudendo le frontiere, anche quelle economiche. Se i cosmopoliti pensano che la democrazia sia un fastidioso inciampo che impedisce al cosmopolitismo di trionfare, per i sovranisti, all’opposto, la democrazia è un totem: ciò che vuole la maggioranza deve essere attuato senza passare attraverso filtri e mediazioni. Per i sovranisti il «popolo» ha sempre ragione. Non è compito delle élite distinguere, a fronte degli elettori, che cosa sia ragionevole e possibile e cosa sia invece irragionevole e impossibile. Le élite, ammesso che possano ancora essere definite tali, sono soltanto i portavoce dei desiderata delle maggioranze. I cosmopoliti sono una élite senza popolo, i sovranisti sono popolo senza élite. Ma, qualcuno potrebbe replicare, una cosa è il cosmopolitismo, un’altra l’europeismo, anche quello dei macro-entusiasti. Non è cosi: l’europeismo acritico, che nega l’esistenza di interessi nazionali in competizione in
Europa, è solo una variante del cosmopolitismo. È una ricostruzione falsa della storia dell’Europa quella che la divide in due periodi: la fase di successo (dai trattati di Roma in poi) in cui l’interesse europeo prevaleva sugli interessi nazionali e la fase attuale, della crisi, quella in cui comandano i «gretti» interessi nazionali. Bugie. Gli interessi nazionali hanno sempre dominato l’Europa. La differenza è che un tempo i diversi interessi si sostenevano (quasi sempre) a vicenda e oggi sono molto spesso in conflitto. Il cosmopolitismo (anche nella variante dell’europeismo acritico) e il sovranismo sono orientamenti ideologici che impediscono di valutare realisticamente il mondo in cui viviamo. Il primo non capisce che se si nega l’importanza degli interessi nazionali si finisce per favorire l’interesse di altri a scapito di quello del proprio Paese. Il secondo non capisce che difendere l’interesse nazionale oggi è possibile solo rifiutando la tentazione autarchica, sfruttando le opportunità che offre, ma anche i vincoli che impone, un mondo interdipendente. In Europa si tratta di cercare punti di equilibrio fra la tutela dell’interesse nazionale e gli interessi altrui. Cosmopoliti/europeisti acritici e sovranisti, con la loro presenza, indeboliscono la nostra posizione contrattuale in Europa. Quando sui tavoli europei bisognerà discutere dei futuri assetti - e anche valutare proposte che, come quella di Renzi, puntano a strappare vantaggi per l’Italia - bisognerà sollecitare da coloro che prendono la parola più realismo e sobrietà. Pag 13 Lombardia e Veneto, i referendum gemelli che non si somigliano di Dario Di Vico Sull’autonomia a Venezia serve il quorum, a Milano no Si vota per l’autonomia in entrambe le Regioni il prossimo 22 ottobre e sia in Lombardia che in Veneto l’iniziativa è stata presa in stretto collegamento dai due governatori leghisti, Roberto Maroni e Luca Zaia. Ma pochi sanno che saranno diversi sia i quesiti ai quali dovranno rispondere i rispettivi elettorati sia il sistema di validazione del voto in rapporto all’affluenza. In Lombardia non è previsto il quorum che invece è indicato dalla legge regionale veneta (articoli 20 e 26) che regola i referendum consultivi. Il quesito che troveranno nelle urne i veneti è estremamente circoscritto («Vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?») ed è in sostanza ciò che resta della precedente formulazione indipendentista azzoppata suc-cessivamente dal giudizio della Corte costituzionale. Per evitare ulteriori problemi con la Consulta la giunta Zaia si è tenuta al minimo e ha scelto di non condire il quesito con ulteriori giri di parole. I leghisti nordestini però si erano in qualche modo legati le mani perché la loro stessa legge approvata a suo tempo dal consiglio regionale prevede esplicitamente il quorum del 50%+1 voto degli aventi diritto per dichiarare la validità del referendum, che resta in ogni caso consultivo e basta. I leghisti lombardi, invece, non avendo un precedente contenzioso con la Consulta si sono sbizzarriti e il quesito rivolto agli elettori è lungo cinque righe e si rivolge all’elettore nell’urna usando il «voi» al posto del più confidenziale «tu» veneto: «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?». È evidente dalla lettura del testo la volontà di rassicurare i lombardi, per tradizione assai meno autonomi-sti dei veneti, con riferimenti espliciti all’unità nazionale e persino alla Costituzione. Questo voto non è l’anticamera della secessione sussurra Maroni agli elettori, state tranquilli. Ha aggiunto nel testo però l’espressione «relative risorse» che fa balenare un altro contenzioso: quello sul cosiddetto residuo fiscale, la differenza tra l’ammontare delle tasse che i lombardi pagano a Roma e ciò che torna al territorio sotto varia forma. Ma il referendum non riguarda quest’argomento. L’altra parola-chiave è «specialità», un termine che si usa nel lessico politico per indicare le Regioni a statuto speciale che non comprendono però la Lombardia. Resta il dubbio, dunque, su quale sia la specialità della Lombardia a meno che gli estensori del quesito non volessero indicare una generica «eccellenza». Saremmo solo al patriottismo lessicale. Messo però da parte il dibattito filologico c’è una notizia di sole 48 ore fa che mette in una luce del tutto particolare le rivendicazioni di autonomia. In Veneto è stata creata una nuova società
partecipata della Regione: si chiama Veneto Welfare e dovrà occuparsi della promozione e dell’informazione sui temi della previdenza complementare. In parole povere, un ente inutile. Pag 28 Non si giudica il passato da prigionieri del presente di Ernesto Galli della Loggia Come è già accaduto per altri esponenti della Chiesa cattolica, anche dal passato del neodesignato capo della Congregazione della Dottrina della Fede, Luis Francisco Ladaria Ferrer, pare che possano emergere fatti gravi. Molti anni fa, quando era vescovo, egli avrebbe (il condizionale è assolutamente d’obbligo) «coperto» alcuni sacerdoti accusati di pedofilia. Un caso non nuovo, dicevo, che qui mi interessa solo come un esempio del modo in cui nella nostra società, che pure sta così velocemente cancellando il passato, questo stesso passato sembra prendersi una rivincita affermando la propria esistenza e facendo irruzione nel presente. Ma è una rivincita solo apparente. Infatti anche in questo caso il presente si dimostra di gran lunga più forte e capace di affermare il suo pieno dominio sul tempo. Lo fa innanzi tutto in un modo quanto mai penetrante: cioè con l’applicare disinvoltamente anche alle epoche e alle circostanze più lontane, quando viene per qualunque ragione a contatto con esse, i propri criteri di giudizio, la propria morale - criteri e morale naturalmente attuali, tutti improntati alla sensibilità di oggi. Perlopiù, insomma, il predominio assoluto del presente, il «presentismo», prende la forma specifica di un’indiscriminata at-tualizzazione etica. La quale però, a ben vedere, non è che uno dei tanti aspetti di un fenomeno più generale: e cioè l’ostracismo ormai decretato dalla nostra cultura nei confronti della storia (a proposito del quale si può leggere un interessante libro di Francesco Germinario, appena uscito: Un mondo senza storia?, Asterios). Ostracismo verso la storia che nasce da due fratture avvenute negli ultimi decenni: da un lato le novità del progresso scientifico-tecnico responsabili di averci cambiato la vita, e dall’altro la fine delle grandi narrazioni ideologiche otto-novecentesche la quale sta cambiando il nostro modo di pensare. Tutto ormai è presente: e così giudichiamo il passato con il nostro metro attuale. Negando quindi implicitamente che come mille altre cose anche il giudizio morale - specie quello collettivo, quello riferibile alla società nel suo complesso - risenta inevitabilmente dei tempi. Che anch’esso sia frutto della storia e possa mutare con essa. Viceversa, messi di fronte a grandi fenomeni storici i più vari come la schiavitù, la guerra, l’entusiasmo religioso, lo spirito di conquista, il colonialismo, la differenza sociale e giuridica tra i sessi, siamo indotti a emettere su due piedi facili giudizi di condanna. Nel generale addio alla storia che si sta consumando in tutto l’Occidente, il passato diviene così il più ovvio e facile (tanto non si urta la sensibilità, e dunque la reazione, di nessuno) ambito di applicazione del «politicamente corretto». Con l’accluso obbligo di fare ammenda e di chiedere perdono per chi di quei fenomeni può essere più o meno sensatamente e più o memo direttamente ritenuto oggi responsabile. Ho parlato di «politicamente corretto» perché del passato, di quanto ogni volta è allora davvero accaduto - cioè del contesto effettivo in cui le cose si svolsero, e pertanto delle logiche, dei valori e delle mentalità allora operanti, dei vincoli e dei condizionamenti allora presenti - sembra che non si possa, e soprattutto non sia lecito, darsi alcun pensiero. Ciò che importa, invece, sembra essere solo affermare un principio generale circa ciò che è bene e ciò che è male. Naturalmente, secondo il punto di vista delle maggioranze politico-culturali che dominano il discorso pubblico in Occidente: punto di vista che, intendiamoci, può essere giusto e accettabilissimo - chi mai per esempio approverebbe oggi la schiavitù o la subordinazione della moglie al marito? - ma che, trasposto nel passato, acquista un carattere di assolutezza che fa capire poco o nulla, comporta una rigidità prescrittiva che rischia di non rendere giustizia alle persone. So bene che se si applica quanto vengo dicendo a certi argomenti il discorso si fa pericoloso, rischiando di apparire in qualche modo giustificatorio: ma può essere questo un buon motivo, mi domando, per rinunciare a porre a tutti noi un problema di verità e di equità? Chi come chi scrive ha una certa età ricorda bene un tempo e una società in cui comportamenti che oggi non esitiamo a qualificare come pedofilia (perché senz’altro lo sono), e che quindi suscitano la nostra sacrosanta indignazione con relativa richiesta di sanzioni adeguate, non producevano invece la stessa riprovazione e lo stesso allarme che producono oggi. Ad esempio, è
molto probabile che oggi le notti romane di Pier Paolo Pasolini non sarebbero circondate dalla sostanziale noncuranza di quarant’anni fa. Sicché se egli fosse vivo è possibile che retrospettivamente più d’uno troverebbe in proposito qualcosa o molto da ridire. Così come oggi troveremmo certamente molto da ridire sul passato del responsabile dell’ex Sant’Uffizio se le voci che lo riguardano venissero confermate; e in ogni caso giustamente esigiamo che in questo come in tutti gli altri casi analoghi sia fatta fino in fondo la necessaria chiarezza e quindi la necessaria giustizia. Il che non può impedirci però di continuare ad agitare nel nostro animo il pensiero della fragilità di ogni facile giudizio davanti alla dura macina del tempo, e di condividere sempre anche noi laici l’antico ammaestramento alla pietà. LA STAMPA Se la mafia teme la scuola di Alessandro D’Avenia 15 settembre 1993. Il giorno in cui lo hanno ucciso, don Pino Puglisi era andato a bussare alle porte del Comune per chiedere l’ennesimo permesso per utilizzare i locali sotterranei dei palazzoni di via Hazon per qualcosa che assomigliasse a una scuola: nel quartiere di Brancaccio mancava la scuola media. E in quei locali la mafia controllava spaccio, prostituzione minorile e combattimenti di cani. Padre Puglisi sapeva che senza una scuola la vita dei ragazzini delle elementari se la sarebbe presa la strada, unica scuola, i cui maestri erano i picciotti dell’esercito mafioso dei Graviano. Don Pino sapeva che, solo grazie alla cultura, a quei bambini poteva essere prospettata una vita diversa. Per questo costituì il centro Padre Nostro proprio come scuola alternativa, luogo in cui potevano giocare e studiare. La scuola non si sarebbe mai fatta (è stata aperta solo nel 2000) perché i politici del quartiere erano conniventi con i boss locali e le richieste venivano colpevolmente ignorate. Proprio per questo don Pino fu ucciso: «Si portava i picciriddi cu iddu» («Si portava i bambini con lui»). Questa la motivazione addotta dal suo sicario, Salvatore Grigoli, detto il Cacciatore. Don Pino sapeva bene che la rivoluzione comincia dai piccoli e dal loro incontro con la bellezza, di cui la scuola è custode. Per questo era, per i mafiosi, pericoloso quanto Falcone e Borsellino, e per questo, come loro, doveva morire. 19 luglio 1992. Il giorno in cui lo hanno ucciso, Paolo Borsellino, pur essendo domenica, si era alzato presto per scrivere una lettera di scuse a una professoressa che lo aveva invitato a parlare ai suoi ragazzi, ma per una serie di disguidi quella lettera era stata ignorata e la professoressa si era indispettita. Borsellino quella mattina scriveva così: «Il 4 maggio 1980 uccisero il Capitano Basile ed il Comm. Chinnici volle che mi occupassi io dell’istruzione del procedimento. Nel mio stesso ufficio frattanto era approdato il mio amico di infanzia Giovanni Falcone e sin d’allora capii che il mio lavoro doveva essere un altro. Avevo scelto di rimanere in Sicilia. I nostri problemi erano quelli dei quali avevo preso ad occuparmi quasi casualmente, ma se amavo questa terra di essi dovevo esclusivamente occuparmi. Da quel giorno mi occupo quasi esclusivamente di criminalità mafiosa. E sono ottimista perché vedo che verso di essa i giovani, siciliani e no, hanno oggi una attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai quarant’anni. Quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta». A questi fatti di cronaca aggiungiamo, il 9 luglio 2017, lo sfregio alla statua di Giovanni Falcone, nella omonima scuola media dello Zen di Palermo: è uno di quei gesti con cui la semantica mafiosa ribadisce controllo del territorio e veicola un messaggio mirato a chi deve capire, in una scuola che svolge un lavoro simile a quello fatto da Puglisi e auspicato da Borsellino nella sua lettera. C’è quindi un filo che lega Falcone, Borsellino, Puglisi, e i ragazzi, e quindi la scuola. Loro sapevano bene che il più grande nemico della cultura mafiosa è la perdita di consenso (il controllo del territorio è tutto), soprattutto tra giovani e bambini. Il gesto avvenuto allo Zen, a 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio e a 24 dall’assassinio di don Puglisi, conferma che la vita di questi uomini è ancora viva e che la scuola ne è memoria viva, cioè feconda. Anche per questo ho cercato di raccontare quegli anni, dal punto di vista di un ragazzo, in uno dei miei romanzi, intitolandolo Ciò che inferno non è, pensando proprio al fatto che questi uomini sapevano bene che i giovani sono, in mezzo all’inferno, ciò che non è inferno, ma solo se trovano maestri disposti ad ampliare le loro vite mettendo in gioco la propria. Così fanno gli insegnanti dello Zen, che diventano quindi pericolosi in territori la cui logica è il
potere, il controllo, la violenza, o altri insegnanti in tutt’altri contesti in cui a dominare sono più ordinariamente ignoranza, nichilismo, individualismo, consumismo, solitudine... La statua di Falcone decapitata è la conferma che la direzione è giusta, quella testa continua a ribadire le parole che lui stesso aveva pronunciato in un’intervista, con l’ottimismo di un realista: «La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni». Non bastano i tweet dettati dall’indignazione di rito, prontamente inviati da tutte le cariche principali dello Stato, e spero che quella scuola, con i suoi insegnanti e studenti, non venga presto dimenticata. AVVENIRE Pag 1 Nel nome dei figli di Andrea Sciarretta Il papà di Noemi per il piccolo Charlie Caro direttore, leggo tante cose sul caso del piccolo Charlie Gard da persone che vivono al di fuori della malattia, senza sperimentarla, senza sapere davvero che cos’è la malattia grave di un proprio figlio. La cosa più semplice che avviene in questi giorni è giudicare la vita degli altri. Lo fanno i medici, lo fa la gente, lo fanno i giudici a cui ci si rivolge e ai quali la legge in Inghilterra e altrove dà questo potere. Io dico, invece, che la strada è un’altra. Sono il padre di Noemi, la piccola di Guardiagrele (Chieti) affetta da Sma1, grave malattia neurodegenerativa, di cui ha scritto anche “Avvenire”. Noemi ha da poco compiuto cinque anni, passati a lottare – insieme a noi genitori, al fratello e ai tantissimi che le vogliono bene – contro questo male. La piccola è molto conosciuta per aver incontrato papa Francesco e anche per le mie battaglie di padre: sono presidente dell’associazione Progetto Noemi Onlus (progettonoemi.com), che si batte per ottenere cure e assistenza ai pazienti, ma anche alle famiglie chiamate ad assistere 24 ore al giorno i propri cari non autosufficienti. Noemi è così diventata simbolo di tanti bambini, di tante persone e di tante famiglie che chiedono sostegno e considerazione rispetto al dramma che vivono quotidianamente. La vicenda di nostra figlia si intreccia con quella di Charlie Gard. Ci rivediamo molto in questo dramma: anche noi abbiamo vissuto momenti terribili, avevamo davanti il buio e la mancanza di speranza. A Noemi, quando è nata, diedero infatti tre mesi appena di vita, ma decidemmo di permetterle di andare avanti fino a quando sarebbe stato possibile, anche se “attaccata a macchinari”. E oggi in casa di macchinari ne abbiamo dieci, con poca assistenza e supporto. I medici ci dissero: “Non ha speranza”. Ma, nonostante tutto, alcuni di loro ci hanno accompagnato e seguito nella nostra scelta. Quando nostra figlia aveva tre mesi nessun medico avrebbe immaginato che Noemi, oggi, sarebbe stata in grado di dipingere dei quadri stupendi, con la poca forza muscolare che ha. Beh, a distanza di anni quegli stessi medici ci chiedono uno dei suoi quadri, che per noi hanno un valore inestimabile. Il mio messaggio di padre è insomma chiaro: nessuno si erga a giudice, nessuno si permetta di strumentalizzare e ideologizzare vicende così intime e delicate. I genitori devono essere libere di decidere in dialogo e alleanza coi medici. E chi fa le leggi deve rispettare e rendere possibile questa condizione di libertà e di collaborazione. Perché se c’è una speranza, vale la pena di percorrerla fino in fondo. È semplice giudicare stando al di fuori del problema. Potremmo invertire per un giorno le posizioni, e vi assicuro che anche la persona più saggia e razionale si sentirebbe messa in discussione se è suo figlio o sua figlia a rischiare la morte. Ciò che bisogna fare è accompagnare e sorreggere la famiglia, analizzando tutte le possibilità e alimentando una ragionevole speranza, ma ricordandosi anche che i miracoli sono sempre possibili, come il sorriso di Noemi dimostra. Chi non la conosce, immagina Noemi come una bambina che soffre enormemente, “attaccata ai macchinari”, e rimane esterrefatto quando di fronte si ritrova una bimba che sorride! Questo è il mistero della vita, che nessun uomo al mondo ha il potere, il diritto di giudicare. In questi cinque anni di vita di Noemi, la ricerca ha fornito il primo farmaco per la Sma1, non una cura che guarisce ma un farmaco che aumenta di molto la qualità di vita. Nessun medico, cinque anni fa, lo avrebbe immaginato. La ricetta secondo la nostra concreta esperienza non è staccare la spina, ma poter fare esprimere la ricerca, i medici, i genitori. Ricordiamoci tutti che la medicina, la scienza, è fatta da uomini che
hanno deciso di studiare e agire con la speranza di migliorare la qualità di vita del paziente anche inguaribile. Ci sono migliaia di famiglie che lottano ogni giorno per il diritto alla vita, e in verità di queste si parla poco. Famiglie logorate dalla mancanza di assistenza e di contributi e dagli ostacoli burocratici che rendono difficile persino garantire il respiro del proprio caro disabile gravissimo. È questo che non dovrebbe mai accadere, se il “diritto alla vita” esiste davvero… Pag 3 Quei sette zeri che incendiano l’Italia di Antonio Maria Mira Boschi in fiamme: non-prevenzione e altri nodi Ci sono sette zeri e una recente legge, pensata male e applicata peggio, dietro l’emergenza incendi che sta devastando il Paese, soprattutto (ma non solo) al Sud, come non accadeva almeno da tredici anni. Fatti che facilitano l’opera criminale degli incendiari. Gli zeri si riferiscono ai mezzi aerei messi in campo da sette regioni: Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo si può leggere in una tabella, aggiornata a ieri, sul sito del Dipartimento nazionale della Protezione civile. La legge è il decreto legislativo n.177 del 2016 che ha eliminato il Corpo forestale dello Stato, non solo i 'poliziotti dei boschi' ma soprattutto i maggiori esperti di incendi boschivi. Due fatti nuovi che cadono in un anno particolarmente caldo e secco, con precipitazioni invernali molto scarse e alte temperature estive. Uno degli effetti dei mutamenti climatici, purtroppo ampiamente annunciati dagli scienziati. Insomma, tutto questo non è una sorpresa. Lo aveva detto con cruda chiarezza il capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, in un incontro con le Regioni il 18 maggio. Dunque per tempo, ma già con preciso allarme: «Invito tutti a non abbassare la guardia, a tenere alta l’attenzione sul rischio incendi boschivi e chiedo a tutte le Regioni che ancora non lo hanno fatto di dotarsi di una propria flotta (aerea)». E poi aveva sottolineato: «Questo è un anno particolare per il quadro normativo nuovo e complesso» (la norma che abbiamo ricordato) che impone «una profonda riorganizzazione a tutti i livelli dell’utilizzo delle risorse, delle procedure e della filiera delle responsabilità». Che invece è andata a rilento. Pochi uomini della Forestale sono transitati nei Vigili del fuoco, gli elicotteri passati ai Carabinieri sono poco utilizzati (negli scorsi anni operavano in convenzione con alcune Regioni), ma soprattutto si corre il rischio di (dis)perdere conoscenze, competenze, professionalità. Una situazione che già due mesi fa era da allarme rosso. Infatti, tra febbraio e aprile le Regioni avevano chiesto l’intervento della flotta area antincendio nazionale ben 111 volte contro 72 del 2016 e 55 del 2015. E dal 15 giugno a oggi sono stati 430, dato mai visto da dieci anni. Una situazione da superlavoro, malgrado la flotta sia quest’anno aumentata, e sia ormai la più numerosa d’Europa. Ma questo non basta, se tutti non fanno il loro. Soprattutto in un anno così secco e caldo, soprattutto mentre è ancora in corso una delle più grandi emergenze della storia italiana, quella del terremoto dell’Italia centrale che impegna uomini, mezzi, risorse. Ma il terremoto non sai quando arriva, mentre per gli incendi la previsione è possibile. Gli incendiari sanno bene quando e dove appiccare, ma lo possono sapere anche gli uomini che li contrastano. Ed è quindi colpevole non mettere in campo tutto ciò che è necessario. Lo aveva ricordato anche il premier Paolo Gentiloni nelle annuali 'Raccomandazioni' inviate ai presidenti delle Regioni il 13 giugno. «Si auspica che le SS.LL. abbiano provveduto a organizzare i propri sistemi regionali antincendio boschivo, in termini di risorse umane e di mezzi terrestri e aerei, nell’ottica della maggior efficienza possibile al fine di garantire adeguati livelli di risposta». Ma, aveva aggiunto il presidente del Consiglio, «è inoltre rilevante che anche i dispositivi di prevenzione, di controllo e di monitoraggio continuo del territorio siano ben pianificati e realizzati perché consentono da una parte di ridurre gli inneschi degli incendi e dall’altra permettono alle squadre di spegnimento da terra di effettuare interventi quanto più tempestivi possibili». Parole da condividere completamente. Gli aerei servono, ma quando intervengono ormai il danno è fatto. Serve operare prima, come per tutte le emergenze, come per il dissesto idrogeologico che, purtroppo, dopo la distruzione operata dalle fiamme sarà ancor più grave. Stato, Regioni, Comuni, volontariato, nessuno escluso. È la sussidiarietà dell’emergenza e della prevenzione. Serve la cura dei nostri boschi, soprattutto di quelli nuovi che stanno rioccupando il terreno agricolo abbandonato. Serve riprendere con forza la lotta agli scarichi illegali dei rifiuti e ai roghi tossici, passata purtroppo in secondo ordine e ne vediamo le
drammatiche conseguenze nel Parco nazionale del Vesuvio dove bruciano discariche e aree boschive. Serve sempre più una seria e concreta politica ambientale, sostenuta da quella cultura del rispetto del Creato cui ci richiama ripetutamente papa Francesco. Le fiamme di questa torrida estate ce lo ricordano. Ma lo si sapeva da tempo. Colpevole è stato farsi trovare impreparati. Pag 21 La demagogia si vince tornando al bene comune di Stefano Vecchia Parla l’intellettuale indiano Pankaj Mishra L’ascesa di poteri transnazionali come Is/Daesh o un incremento delle tendenze nazionaliste e isolazioniste alla Trump, alla Le Pen e persino Brexit come espressioni di «una guerra civile globale» in corso. Ovvero del contrasto tra la mancanza di responsabilità delle democrazie liberali e l’adesione di realtà discriminate a ideali di «dominazione culturale, populismo e brutalità vendicativa». Aprono al dibattito le tesi di Age of Anger: A History of the Present (Il tempo della rabbia. Una storia del presente, Allen Lane, 2017; è prevista la pubblicazione in italiano di Mondadori) del saggista e romanziere indiano Pankaj Mishra. Polemico e documentato, il libro sembra avere come obiettivo critico La fine della storia e l’ultimo uomo di Francis Fukuyama a 25 anni dalla prima stampa (1992). Se per il politologo americano le due forze motrici della storia, «la logica della scienza moderna» e «la lotta per il riconoscimento», portano al collasso di ogni totalitarismo, l’autore indiano presenta una visione negativa della storia della modernizzazione secondo la narrativa occidentale, di cui i totalitarismi europei sarebbero stati una manifestazione aberrante. Coerente con il principio che quasi tutto nella storia contemporanea indica che gli Stati fondati su una democrazia orientata al mercato vanno verso il fallimento, il 48enne Mishra individua e descrive in sostanza la sfida lanciata dai “perdenti” a un ordine globale dominato da valori occidentali. Una condizione ricca di incognite ma anche di potenzialità, con un ruolo innovativo per filosofia e religione in quanto espressioni di istanze condivise, profonde e inestinguibili. Aperta anche a un ruolo più compiuto e universale di guide morali come papa Francesco.“Avvenire” ne ha discusso con Mishra, partendo dalla domanda sul pensiero critico verso l’Occidente. In un tempo in cui localismo, tribalismo e militanza religiosa sono visti soprattutto come vestigia di un passato oscurantista, nel suo libro lei suggerisce che si tratta invece di espressioni di una opposizione alle regole occidentali che peraltro molti in Asia e Africa sembrano accogliere. Su che cosa basa la sua interpretazione? «Penso che la nozione di individualismo tanto sponsorizzata negli ultimi decenni – vedi Margareth Thatcher che era arrivata a affermare che “non esiste qualcosa definibile come società” – abbia portato a una enfatizzazione dell’intraprendenza individuale all’interno di un mercato in cui competere, relegando la collettività e anche gli Stati in secondo piano. Quello a cui assistiamo oggi, in realtà, è il suo fallimento. Non solo perché nei fatti molti dipendono da strutture sovraindividuali, ma anche perché esistono ancora società che continuano a enfatizzare il benessere collettivo rispetto a quello individuale». Dove, soprattutto? «In tutte quelle realtà in cui lo sviluppo individualista viene contrastato perché sono sottolineate le tradizioni comuni. Non sorprende se però anche l’Occidente si ritrova in prima linea. In effetti anche in realtà come la Gran Bretagna, centrali nella concezione individualista, stiamo ora assistendo a manifestazioni di tribalismo (ad esempio, Brexit) e al ritorno di interessi collettivi. Ovviamente – prosegue Pankaj Mishra – come in ogni tempo di crisi si aprono prospettive e anche opportunità per agitatori e movimenti reazionari. Vedi Trump, che vince puntando sulle paure e sulle umiliazioni degli americani. Questa tendenza, è però anche un’opportunità per rivedere ideali in cui abbiamo riposto troppa fede, per individuare opportunità intellettuali e politiche, per chiudere con egoismo e mancanza di solidarietà. Se non sarà così, a vincere saranno i demagoghi che sono molto veloci nel passare dalla teoria all’azione». Negli ultimi anni si è molto discusso di un nuovo assetto internazionale, multipolare. Con un ruolo crescente di Cina, India e altre potenze emergenti. Possono avere un ruolo positivo?
«Ogni volta che è emerso un nuovo potere geopolitico, ha incentivato nuovi conflitti. Basti pensare alla esperienza di Germania, Italia, Giappone nel XX secolo. In un mondo che continua ad aspirare alle stesse cose, a porsi le stesse priorità, l’emergere di nuovi protagonisti tende a seguire gli stessi percorsi del passato. Io non credo che le nazioni emergenti dell’Asia offrano nuove basi morali per un mondo più unito e più giusto. Le loro proposte avranno sempre un taglio egemonico e, pur davanti all’eventuale miglioramento degli stili di vita, la possibilità di conflitti sarà sempre presente. In India stiamo vedendo come l’incremento delle possibilità e delle aspettative politiche acceleri la distruzione della democrazia, anziché consolidarla». Nella sua visione esiste un ruolo per le istituzioni sovrannazionali? «L’Onu e altre organizzazioni sono dominate dai Paesi più potenti e quindi è illusorio pensare che possano essere una forza positiva. Sono esse stesse parte del problema o almeno sono inefficienti nell’affrontarlo. Occorre trovare nuove fonti di pensiero e riscoprire le istituzioni filosofiche e religiose. Dobbiamo espandere la nostra immaginazione e guardare a luoghi inaspettati, a altre istituzioni – il Papa, per esempio, o il Dalai Lama – perché hanno moralità e ruolo storico». L’OSSERVATORE ROMANO Pag 4 Per un’intelligenza artificiale che sia sociale di Solène Tadié A colloquio con Luciano Floridi «La tecnologia a nostra disposizione ci dà una leggera spinta verso il mondo migliore. Siamo davanti a un bivio in cui c’è una strada leggermente più facile da prendere. Ma è possibile che si prenda l’altra, ossia quella sbagliata». Così Luciano Floridi, docente di filosofia ed etica dell’informazione all’università di Oxford, riassume la questione delle sfide etiche che le rapide innovazioni dell’intelligenza artificiale pongono al nostro mondo. Su questo tema il filosofo è intervenuto il 6 luglio al convegno del Cortile dei gentili tenutosi all’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, alla presenza del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la cultura. In quest’intervista concessa all’Osservatore Romano a margine dell’incontro, Floridi si sofferma sui grandi benefici che l’uomo potrà trarre da tali progressi tecnici, a patto di non cedere alla tentazione di credersi solo nell’universo. Il Cortile dei gentili ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale (IA) con entusiasmo ma anche con grandi riserve. Nella sua relazione il cardinale Ravasi ha parlato del passaggio dall’“homo faber” all’“homo creator” che, insieme alla possibilità di superare i limiti biologici, fa nascere anche il rischio che l’uomo si creda così potente da sostituire Dio. Da laico esperto in intelligenza artificiale condivide queste preoccupazioni? Dalla mia prospettiva laica, che non è alternativa ma è complementare rispetto a quella del cardinale Ravasi, ritengo che queste preoccupazioni siano del tutto giustificate. Sono anche moderatamente - questa è una parola importante - ottimista sulla possibilità di risolverle, ma ci vuole tanta buona volontà. Innanzitutto dobbiamo preoccuparci di questa nuova forma di agenti autonomi, in grado di apprendere da soli. In secondo luogo dobbiamo chiederci di chi sia la responsabilità di quello che sta succedendo. La risposta è semplice: è tutta nostra; è umana e resterà umana. L’ultima domanda è: saremo in grado di risolvere questi problemi? Penso di sì, però ci vuole l’impegno e l’intelligenza che abbiamo messo oggi in quest’incontro: la mia paura riguarda non tanto le difficoltà in sé, quanto il fatto che se ne sottovaluti l’importanza, che non si investa intellettualmente in questa direzione e quindi che qualche disastro si possa produrre. Solo dopo che ciò sarà avvenuto, si cercherà di correre ai ripari dicendo che avremmo dovuto pensarci prima. È già successo tante volte nella storia della vita umana: è successo con l’ambientalismo, col nucleare, con la schiavitù e i campi di concentramento. Abbiamo fatto degli errori orrendi, mostruosi, ma non serve arrivare a un completo e totale disastro per poi ripensarci. Questa volta ci stiamo ripensando in tempo. Solo così si potrà prendere la direzione giusta. Molti filosofi cristiani vedono nell’emergenza della modernità rinascimentale anche l’espressione di una crisi dell’uomo e del suo rapporto con il creato: l’uomo è divenuto il centro dell’universo, arrivando a voler dominare la natura. Si può evitare che l’IA esasperi tale dinamica, divenendo invece un’opportunità per ripensare il nostro rapporto con la “casa comune” e con il creato?
Direi che siamo un po’ ambigui. Entrambe le alternative sono possibili. Forse la tecnologia a nostra disposizione ci dà una leggera spinta verso il mondo migliore. Siamo davanti a un bivio in cui c’è una strada leggermente più facile da prendere. Ma è possibilissimo che si prenda l’altra, ossia quella sbagliata. C’è una tecnologia che ci invoglia oggi a essere più altruisti, ma questo non vuol dire che lo saremo; che ci invoglia a essere più attenti alla natura, ma non vuol dire che lo saremo. Il punto che lei solleva mi sembra molto importante, quello della modernità dal Rinascimento in poi in un mondo che diventa sempre più secolarizzato. Nella mia prospettiva, è come se ci fossero due ingredienti, invece di uno soltanto. In un mondo completamente ateo, avviene una cosa bruttissima: l’umanità non è in grado di essere riconoscente a nessuno. È come se ci fosse una bellissima festa in cui tutto è perfetto, ma ci sono soltanto io. C’è poco da divertirsi. Nei momenti di gioia, non possiamo essere grati a nessuno. Manca l’ultima forma di alterità, che è quella di Dio. E questo l’ateo non lo capisce, non lo coglie completamente. Al contempo se ci sono soltanto io, mi posso davvero mettere al centro dell’universo? Da un lato si può dire «che bello ci siamo soltanto noi, allora dominiamo la natura, questo pianeta è un limone, lo spremiamo, ne creeremo un altro!». Quante volte sentiamo dire che si deve civilizzare e trasformare Marte perché questo pianeta sta per finire: ma così ci spostiamo e ne andiamo a consumare un altro. Sono cose catastrofiche. Lo stesso ragionamento è quello che ci dice che la vita non è tanto bella se siamo da soli in mezzo all’universo. Nell’assenza dell’altro c’è questo doppio problema: la mancanza di riconoscenza e l’intento costante di mettersi al centro. Ma noi al centro non siamo! Se ci poniamo invece in un contesto di fede, allora c’è un grande Altro, un’alterità totale che non è aliena ma che è legata a noi, e che ci permette anche di metterci in periferia. In questo modo possiamo essere partecipi della festa invece di comportarci come un teenager che pensa che la festa sia sempre la sua. Questi due vantaggi - e lo dico da laico, dunque dall’esterno - li trovo assolutamente cruciali per pensare il futuro. Mettendoci in periferia e provando riconoscenza nei confronti di qualcosa che ci è stato dato e che non è nostro è come se avessimo due strumenti fondamentali che ci insegnano come risolvere le presenti sfide. Due strumenti di cui avremo bisogno per non ricadere nei vecchi errori. In un recente articolo pubblicato su «Il Sole 24 Ore», lei scrive che l’IA sta passando da fantascienza a forza sociale. Ma come è possibile metterla oggi al servizio concreto della persona? In molto contesti fantascientifici abbiamo piccoli robot che fanno le cose al posto nostro, meglio di noi. Oggi, ad esempio, le lastre sono lette meglio dall’IA che da un radiologo; l’operazione della cataratta viene eseguita da un robot e non invece dalla mano tremolante di qualcuno che magari, quel giorno, è un po’ stanco; esattamente come l’aereo viene pilotato e atterra meglio con un sistema artificiale piuttosto che da un pilota. Abbiamo robot su Marte che autonomamente raccolgono e mandano informazioni a noi qui sulla terra. Sono cose che da ragazzi negli anni Settanta vedevamo nei film di fantascienza in bianco e nero: eppure queste cose che sembravano allora assolutamente futuristiche oggi fanno parte del nostro quotidiano. Le aree interessate da questi benefici sono tre. La prima è la realizzazione di cose che non dovremmo fare noi, ma che dovrebbero invece fare i robot e l’intelligenza artificiale. Abbiamo trovato un modo per non lavare più i piatti, domani faremo tagliare i giardini, non c’è bisogno che lo facciamo noi. La seconda è il crollo dei costi di tante cose, come ad esempio i viaggi aerei divenuti molto più economici grazie alla digitalizzazione. In terzo luogo, direi che ci rimane ora da pensare l’impensabile, e cioè cose che noi fino a qui non abbiamo mai pensato di fare: sappiamo che le grandi possibilità tecnologiche ci permetteranno di fare cose magiche che non abbiamo ancora inventato. In questo contesto, tuttavia, è fondamentale riconoscere che cosa significa essere arrivati a una meccanizzazione dell’azione privata dall’intelligenza. Molti pensano che l’attuale contesto sia un matrimonio tra intelligenza e azione: in realtà invece si tratta del divorzio tra l’azione e l’intelligenza. Oggi il mio telefonino gioca meglio a scacchi di chiunque, eppure l’intelligenza non gli serve. Abbiamo creato una frattura tra queste due cose e la preoccupazione è grande. A conclusione del suo intervento, ha detto che la società dovrà farsi carico dei costi immediati dell’IA. Cosa intende? Si pone in una prospettiva schumpeteriana di “distruzione creativa”?
Esattamente. Lei ha colto quello che intendevo tra le righe. Quando c’è una trasformazione socioeconomica così profonda e veloce, è quasi impossibile per la generazione attuale adattarsi allo stesso passo. Molti resteranno indietro. Dobbiamo assicurarci che chi resta indietro non sia la classe sociale che paga il costo di uno sviluppo meraviglioso. Chi verrà dopo di noi nella migliore ipotesi usufruirà di questo straordinaria invenzione umana, ed è bellissimo. Ma non è giusto che chi oggi si trova spiazzato in termini di perdita di ruolo, lavoro e reddito debba pagarne tutte le conseguenze. La civiltà ne trarrà beneficio e quindi è giusto che tutta la società si faccia anche carico dei costi che questo beneficio comporterà. Quali categorie saranno coinvolte per prime? Molti dei lavori che sono strutturati in termini di interfaccia. Si pensi a chi fino all’altro ieri faceva le fotocopie, a chi lavora in segreteria o chi controlla i biglietti all’aeroporto: sono tutti lavori che in realtà servono a mettere noi in connessione con la macchina o la macchina in connessione con noi. Sono lavori d’interfaccia, quindi sono destinati a sparire. È meglio che troviamo una soluzione. Pag 5 Un’idea sbagliata di islam di Paolo Branca Nei circa mille oratori della diocesi di Milano un quarto dei giovani sono musulmani Per la sua ostinata attenzione verso gli ultimi e i lontani Papa Francesco è ritenuto da alcuni un “buonista”, ma si tratta di una percezione superficiale e affrettata che non sa cogliere la radicalità evangelica del suo messaggio. Egli infatti con coraggio e determinazione non si stanca di richiamare le coscienze a cogliere e a riparare il carattere pretestuoso di molte opposizioni e conflittualità che invece ci trovano consenzienti e complici, tanto siamo allarmati da una rappresentazione parziale della realtà nella quale prevalgono in modo impressionante pericoli, timori e negatività. Come sanno bene i sociologi, è sufficiente che una cosa sia creduta vera perché essa produca effetti reali. Motivi concreti di preoccupazione non mancano di certo, ma altra cosa è diffondere in maniera sistematica l’impressione che il nostro rapporto coi musulmani, tanto quelli presenti sul nostro territorio quanto coloro che vivono nei paesi d’origine, siano ormai ridotti a una sorta di resa dei conti finale fra due contendenti che sarebbero addivenuti al cruciale dilemma mors tua, vita mea. Un sistema mediatico inadeguato paventa il pericolo di un’invasione e di un’islamizzazione imminente delle nostre terre. Ma guardiamo ai dati reali: 1,5 milioni di musulmani su circa 56 milioni di italiani. La prospettiva di un rapido mutamento che ci costringerebbe a rinunciare ad alcolici e carni suine e obbligherebbe le nostre donne a indossare un velo, più che poco plausibile, si mostra inconsistente. Sulla lunghissima distanza, uno sbilanciamento demografico verso comunità religiose più prolifiche non può essere escluso, ma attualmente mi pare più un alibi per trincerarsi sulla difensiva o, peggio, sulla passività che non gestisce nulla con un progetto ben definito e sostenuto, per arrendersi a subire più che a gestire ciò che sarebbe diritto-dovere di stati moderni e istituzioni democratiche almeno tentare di affrontare seriamente. Promuovere e premiare le pratiche migliori è l’essenza di una società aperta e matura. Per la caccia alle streghe di turno le dittature sono molto più efficaci, e inquietanti segnali in tal senso non mancano di certo. Che i musulmani abbiano preso il posto dei “cattivi” come nemico epocale diventa ormai un’evidenza, fatta salva l’emblematica eccezione per i peggio rappresentativi fra essi che per diverse ragioni vengono graziati (vedi recenti provvedimenti di Trump che non includono alcuna petromonarchia del Golfo) o demonizzati (vedi i soliti noti corteggiati dai media pur rappresentando una minoranza autoreferenziale che vive tra noi come un corpo estraneo o una società parallela) all’interno della medesima logica perversa. L’esito è inevitabilmente quello di concedere a pochi fanatici la rappresentanza legittima e ufficiale di 1,6 miliardi di musulmani che vivono oggi sulla Terra, in uno svariatissimo caleidoscopio di situazioni delle quali le più promettenti vengono condannate alla non esistenza e le peggiori sovraesposte con maniacale e autolesionista programmaticità. Eppure i fattori positivi davvero non mancano: i dati ufficiali della Diocesi di Milano confermano che nei suoi circa mille oratori il 25 per cento degli utenti sono giovani islamici, affidati con fiducia dalle loro famiglie a un ambiente religiosamente orientato piuttosto che lasciati per strada o indirizzati altrove. Circa il 15 per cento dei musulmani nelle scuole pubbliche non chiede l’esonero dall’ora di religione, desiderando restare coi
compagni di classe in un modulo formativo che non solo è privo di “pericoli” di proselitismo, ma li vede talvolta come protagonisti, in quanto maggiormente interessati alle tematiche trattate rispetto ai compagni di classe locali. Nelle associazioni femminili e fra le nuove generazioni nate e cresciute in Italia gli esempi di mutua stima, rispetto e collaborazione non si contano, benché poco valgano agli occhi miopi dei media e alle timide o inesistenti prassi delle amministrazioni. Persino su punti cruciali del cosiddetto scontro di civiltà si registrano da tempo riflessioni e comportamenti che meriterebbero di essere valorizzati nel comune interesse. Sempre più spesso giovani musulmani italiani (anche se privi di cittadinanza per la nota inerzia burocratica) confessano di sentirsi più liberi di praticare il loro stesso culto qui che nei paesi d’origine delle loro famiglie. Non digiunare in pubblico durante il Ramadan è infatti là un reato punito dalle forze dell’ordine; qui resta un peccato da risolversi eventualmente fra il singolo e Dio, fuori da ogni controllo “statale”. Che i seguaci di una tradizione religiosa nobile e plurisecolare, basata su principii etici non distanti dai nostri e imparentati strettamente con la comune radice ebraica, restino “figli di un dio minore” asfissiati da inchieste e sondaggi sul burkini, la carne di maiale e il consumo di alcolici, è indice non tanto della loro presunta arroganza, quanto della nostra inconsistenza. Le pur lodevoli e consistenti iniziative di solidarietà verso irregolari e profughi rischiano di celare sotto il velo dell’emergenza una ben diversa realtà ormai matura e radicata che attende solo di essere debitamente portata alla luce. Il ruolo dei credenti, in questo senso, dovrebbe essere cruciale. La spiritualità e l’etica di masse di giovani rischiano di restare appannaggio dei pochi e ideologicamente orientati gruppi organizzati. Nessuno sembra volersene prender carico per non turbare i benpensanti autoctoni. Persino nelle situazioni di maggior emarginazione, esposte al pericolo della devianza e della criminalità, poco o nulla viene seriamente dibattuto né tantomeno messo in pratica. Dare un tetto e un pasto ai diseredati è sublime opera di misericordia... ma come si può ignorare che molti di loro conducono un’esistenza ai limiti? Troppi sans-papiers vivono tra noi per anni, ammassati in poche stanze affittate in nero e lavorano per italiani senza scrupoli che li smistano sulle strade a vender fiori, ombrelli, accendini... senza che nessuno si chieda quali conseguenze alla lunga comporti ospitare “braccia” da lavoro a basso costo e senza oneri sociali, purché la loro umanità negata venga minimamente presa in considerazione. Le rappresentanze consolari e diplomatiche dei loro paesi d’origine sono persino più assenti e indifferenti riguardo al loro destino di quelle locali. Ne incontro molti quasi quotidianamente per le strade e col pretesto della lingua mi faccio raccontare le loro storie. Non parlo per sentito dire, ma per diretta e dolorosa esperienza. Persino quando mi son messo d’impegno per far qualcosa almeno per i carcerati mi sono trovato, per anni, davanti a un muro di gomma. Chi già lavora nelle prigioni non gradisce nuovi “intrusi”. E così la mia casa e il mio studio traboccano di libri di letteratura araba da me selezionati e catalogati che volentieri regalerei alle istituzioni penitenziarie, ma ho perso ormai ogni speranza di riuscirvi. “Qualcuno da odiare”, specie in periodi di crisi, è la riproposizione della perenne guerra fra poveri che garantisce e perpetua i privilegi dei pochi agiati. Che dire poi dei poveri cristiani arabi, circa diecimila copti solo a Milano, sbeffeggiati da chiunque in quanto estranei che vengono a toglierci qualcosa? Ne conosco che vivono qui da decenni, son già cittadini italiani e i cui figli sono spesso i primi della classe... Ma si sentono rifiutati, messi nel mucchio dei non desiderabili senza alcuna considerazione verso la loro situazione sociale né verso la loro identità religiosa. IL FOGLIO Pag 1 “L’islam prenderà l’Europa con le nascite” di Giulio Meotti L’arcivescovo di Strasburgo Luc Ravel evoca il “grand remplacement” Roma. Non sono mancati i grandi prelati, vescovi e cardinali, che hanno denunciato il "sorpasso" dell'islam in Europa. Come il cardinale Raymond Leo Burke: "Ho sentito diverse volte degli islamici che spiegavano: 'Quello che non siamo riusciti a fare con le armi in passato lo stiamo facendo oggi con la natalità'". Come Piero Gheddo, decano dei missionari italiani: "L'islam ha demograficamente in mano il futuro dell'Europa". Come il cardinale Christoph Schön born, l'arcivescovo di Vienna che ha parlato della possibile "conquista islamica dell'Europa". Come l'ex capo della chiesa cattolica nella Repubblica
Ceca, il da poco defunto Miloslav Vlk: "I musulmani in Europa hanno molti più figli delle famiglie cristiane". Adesso però una simile denuncia non viene da un esponente dell'ala più conservatrice del clero, ma da un alto rappresentante della solitamente timida chiesa francese, l'arcivescovo di Strasburgo Luc Ravel, per giunta nominato da Papa Francesco lo scorso febbraio. In una intervista al quotidiano Dernières Nouvelles d'Alsace e che ha fatto il giro dei media mainstream francesi, l'arcivescovo prima ha parlato dei numeri dell' aborto: "L'aborto non è solo concesso ma incoraggiato. E si tratta di un incoraggiamento che non posso accettare, non per una questione di fede, ma perché amo la Francia". Dice che si dovrebbe "lasciar fluire generosamente la vita, questo è il segno più sicuro della forza di una nazione e una civiltà". Poi Ravel si è lasciato scappare quella frase: "I fedeli musulmani sono ben consapevoli del fatto che la loro fertilità è tale che oggi lo chiamano... 'Grand Remplacement', lo dicono in maniera molto pacata e positiva che un giorno tutto questo sarà loro". E' la prima volta che un grande prelato cattolico, come l'arcivescovo di Strasburgo Luc Ravel, usa l'espressione coniata dallo scrittore e pamphlettista Renaud Camus, "Grand Remplacement", la sostituzione del popolo francese da parte dell'islam e che gli è costata ben due condanne da parte dei tribunali francesi per "incitamento all'odio". E proprio due settimane fa una feroce polemica era scoppiata al programma radio "Répliques", su France Culture, quando il filosofo Alain Finkielkraut aveva osato invitare proprio Camus a parlare di "Grand Remplacement". "Renaud Camus non ha più voce in capitolo anche se tutti parlano di lui, dandogli la parola ho voluto mettere fine all'anomalia di questa assenza onnipresente", ha cercato di difendersi Finkielkraut. A violare il tabù anche Michèle Tribalat, direttrice dell' Istituto nazionale degli Studi demografici che ha appena pubblicato un libro intitolato "Assimilation: la fin du modèle français", dove traccia un parallelismo quasi apocalittico tra l'esplosione dei flussi migratori e il fallimento dell'integrazione. L'arcivescovo di Strasburgo, Luc Ravel, non è nuovo a provocare il dibattito in Francia. Nel 2015 scrisse un saggio per spiegare che i cristiani d'Europa erano presi fra due fuochi, "la bomba terrorista, il profeta vendicativo" da un lato, e dall'altra parte "i terroristi del pensiero, gli adoratori della Repubblica". Così che "non saremo tenuti in ostaggio dagli islamisti, ma non vogliamo essere tenuti in ostaggio dai benpensanti". Adesso Ravel ha senz'altro rotto due tabù con la sua ultima intervista. Oggi in Francia, a più di quarant'anni dalla legge che ha preso il nome della compianta Simone Veil, un quarto delle nascite finiscono ancora in un aborto. Un francese su quattro. A fronte di 800 mila nascite ogni anno ci sono circa 220 mila interruzioni di gravidanza. Otto milioni di aborti, circa, dal 1975. Ravel ha poi sollevato il tema, sulfureo e controverso, del "sorpasso" dell'islam e della sua crescita demografica. Ogni inizio anno, l'Insee pubblica le cifre per lo stato civile relativo ai nomi assegnati ai bambini nati in Francia dal 1900. Così, a Seine-Saint-Denis il 42,9 per cento sono nomi musulmani, nella Val-de Marne il 26,3, il 23,5 nel Rodano, il 20 nel Bouches-du-Rhône, il 19 nell'Hérault e il 17,1 a Parigi. Nessuno sa quanti siano i musulmani di Francia (è proibito raccogliere le statistiche su base etnico -religiosa). Ma in due decenni, la popolazione musulmana francese si suppone sia aumentata del 25 per cento secondo le stime più basse, del 50 per cento per le stime mediane, del 100 per cento se si confrontano le cifre Ined e del governo dal 1997 al 2014, passando da tre a sei milioni. E' due, tre, sei volte la crescita media della popolazione francese. Forse per questo l'espressione "Grand Remplacement" spaventa tanto. IL GAZZETTINO Pag 1 Tre ragioni per rinunciare allo ius soli di Carlo Nordio L’ostinazione con la quale il governo e il partito di maggioranza insistono sulla legge dello jus soli ha delle ragioni che, direbbe Pascal, la Ragione non conosce. Al contrario, razionalità e buon senso dovrebbero ispirarne una riflessione, se non proprio una rinuncia. E questo per tre motivi: uno strategico, l’altro tattico, e il terzo riassuntivo di entrambi. Il primo motivo, strategico, è evidente. Nel momento in cui il ministro dell’interno sia affanna a predicare all’Europa, all’Italia e al mondo che non possiamo sostenere questo flusso massiccio, ininterrotto e infinito di migranti, naufraghi e richiedenti asilo, l’allargamento dei criteri di concessione della cittadinanza suonerebbe come un invito a ingressi ulteriori. Non importa che questo sia vero: ma è certo che così
il provvedimento verrebbe percepito. I trafficanti e gli scafisti ci considererebbero, come spesso è avvenuto nella Storia, un Paese irresoluto ed incerto, capace solo di fare la faccia feroce, che accelera e frena senza avere una direzione sicura. Un disastro nel disastro. Il secondo motivo, tattico, è altrettanto chiaro : non potrebbe esserci un momento peggiore. Al di là infatti del merito della legge, il buon senso basterebbe a farci capire che essa oggi non costituisce né una priorità né una necessità urgente che giustifichi un ennesimo ricorso alla fiducia. Governo e parlamento hanno davanti colossali problemi elettorali, finanziari e internazionali, aggravati da una litigiosità interna che minaccia di risolversi in una crisi irreversibile. Impantanarsi in una legge che, secondo gli ultimi sondaggi, è ripudiata da due terzi degli italiani, confligge con l'opportunità politica, che, come si sa, è una delle linee guida di un esecutivo assennato. Il terzo motivo, che riassume entrambi, è forse il più importante. I cittadini hanno capito benissimo l'infernale pasticcio in cui il nostro Paese si è cacciato, accettando di integrare, o meglio di stravolgere l'accordo di Dublino con una clausola che ci impone di accogliere nei nostri porti tutti i migranti, anche quelli raccolti da navi straniere in acque internazionali. La paternità di questa bella pensata è oggi disconosciuta da tutti, e in fondo ci interessa poco ricostruirla a fini polemici. Ma i nostri lettori ricorderanno che da tempo insistiamo su questa singolarità giuridica, che contrasta con il diritto internazionale, con la legge del mare, e, ancora una volta, con il buon senso. Ma ormai la frittata è fatta, e il ministro Minniti, va detto suo onore, sta sudando sangue per cercare di rimediare. Orbene, di fronte agli indugi di un'Europa riluttante e al netto rifiuto anche dei paesi presunti amici - Francia,Germania e Spagna di aprire i loro porti, l'allargamento della cittadinanza italiana a centinaia di migliaia di immigrati suonerebbe come contraddittoria e quasi paradossale. Immaginiamo il commento beffardo di Merkel e compagnia: Volete anche farne dei cittadini? Teneteveli. Detto questo, c'è da chiedersi il perché di tanta inavveduta improvvisazione da parte governativa. Una risposta non c'è, se non nello stato di confusione in cui versa il suo azionista di maggioranza. La riprova si trae dall'infelicissima recente iniziativa di punire chi esibisce e commercia l'effigie di Mussolini. Sarà bene ricordare al ministro della giustizia che il nostro codice penale, in base al quale verrebbero comminate e irrogate le condanne, è datato 1930, ed è firmato proprio dal Duce. Che faremo? Puniremo anche i magistrati che ne citeranno e ne applicheranno gli articoli? LA NUOVA Pag 8 La violenza inconsulta vista da chi è vulnerabile di Costanza Jesurum Si sta parlando molto in questi giorni di Maurizio De Giulio, elettricista di Nichelino, provincia di Torino, che in macchina con compagna e figlia, ha travolto una motocicletta, sembrerebbe come ritorsione a seguito di una lite sulla strada. Come conseguenza, il conducente Matteo Penna, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre la fidanzata Elisa Ferrero ha perso la vita.Si rimane sbigottiti, di fronte a una notizia del genere, anche se poi emergono alcune informazioni che iscrivono il comportamento di De Giulio in una storia personale in cui a un certo punto emergono azioni violente e inconsulte. Per esempio, si era già reso protagonista di un incidente analogo anche se con esiti fortunatamente diversi, nell'ottobre del 2015, quando aveva improvvisamente tagliato la strada a un altro conducente con il proprio furgone, procurandogli lesioni al collo, e un altro episodio sempre su strada, che avrebbe coinvolto diverse automobili risalente al 2010. Colpisce però l'opinione pubblica, il comportamento tenuto dalla compagna di De Giulio, Milena, che ha dichiarato di essersi distratta per guardare il telefonino, proprio nella fase cruciale dell'episodio, ma anche che lui aveva frenato e che insomma non doveva essere considerato responsabile dell'omicidio. In sostanza lo ha difeso, e la sua pagina facebook è stata presa di mira da commenti molto aggressivi e indignati. È interessante constatare come in un paese diffusamente omertoso, con una consistente difficoltà a portare a termine indagini per i più svariati reati, con una tendenza diffusa a ignorare un senso civile e dello Stato, dove non di rado gli stessi rappresentanti istituzionali hanno un'idea blanda del concetto di crimine (recente il caso del sindaco di Pimonte, Michele Palummo, che ha definito «una bambinata» uno stupro di branco ai danni di una minore), si cerchi nelle persone correlate a ogni incriminato di omicidio, una zelante dichiarazione di verginità. Una ferma condanna morale e una presa
di distanza dall'accusato, come se le compagne, o - ricordiamo il caso di Foffo - i padri delle vittime fossero la garanzia di una verginità collettiva, la prova di una innocenza necessaria, una catarsi per interposta persona. In realtà ci sono molti motivi per cui ciò non accade, e forse anzi nel caso della compagna di De Giulio sono anche di più. Da una parte infatti ci sono da fare considerazioni di ordine sociale ed economico. Milena è di origine extracomunitaria, di professione colf: da diversi punti di vista, che piaccia o meno ammetterlo, è una persona in una posizione di vulnerabilità che può ritenere opportuno non prendere posizioni forti, che potrebbe non avere le idee chiare su come andrà con il suo compagno, e che potrebbe scegliere di non scagliarsi contro di lui, non avendo magari una consistente rete di appoggio in un Paese che non è il suo. Più genericamente però quando emergono questi fatti di cronaca, è come se la persona che si rivela capace di reato, mostrasse una parte di se nascosta, oppure dissimulata, la mettesse nel centro della scena, e mettesse da parte invece altri modi di fare e di essere in relazione che risultavano più piacevoli, erano considerati socialmente accettabili e in un certo modo, davano qualcosa anche alla personalità di chi ci aveva a che fare. Per le compagne, e i padri e le madri degli imputati di processi mediaticamente noti, può essere davvero difficile condannare un comportamento criminale, perché questo vorrebbe dire, dover dire di riconoscerlo come tale, e anche forse capire dove quel comportamento criminale c'è sempre stato, e implicitamente ammettere psicologicamente che una parte di loro, con quella caratteristica che ha trasformato quella persona in un assassino, aveva a che fare, aveva una relazione. Magari questo timore è anche privo di senso, però di fatto si tratta di un passaggio difficile, che può cogliere impreparati. Torna al sommario