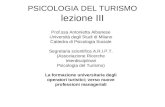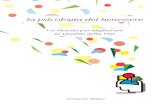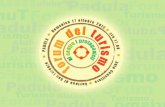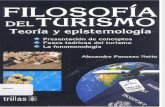Psicologia Del Turismo
-
Upload
matteogiordani -
Category
Documents
-
view
31 -
download
0
description
Transcript of Psicologia Del Turismo
Turista colui che si trasferisce temporaneamente, per almeno 24 ore e per non pi di un anno, per motivi quali: tempo libero, affari, famiglia, meeting. (onu 1963). Il turista un viaggiatore che si sposta dalla propria residenza (almeno 50 miglia) per affari, per piacere, per motivi personali al di fuori del pendolarismo lavorativo (ntrrc, usa). Un turista un viaggiatore volontario, temporaneo che viaggia con l'aspettativa del piacere derivato dalla novit e dal cambiamento che sperimenta in un viaggio circolare relativamente lungo e non ricorrente.
Dal viaggiatore al turista. Concezione antica del viaggio: viaggio come sofferenza e punizione, come prova: mezzo per dimostrare ci che uno veramente. Concezione moderna: manifestazione di libert, fuga dalla necessit. un piacere, un mezzo che permette di accedere a qualcosa di nuovo, originale, inatteso.
Confronto: atteggiamento pi frequente: ancorare al mondo delle cose familiari ci che si percepisce per la prima volta.
Dal viaggiatore al turista:perdita dell'arte del viaggio. MacCannel: turista un pellegrino di un mondo laico. Le attrazioni sono il tradizionale centro del pellegrino. Homo turisticus figlio della civilt moderna in cui il mutamento visto come valore. La societ moderna crea valori permeabili. La societ del tempo libero e del turismo la societ del consumo.
Vacanza come prodotto di consumo: disponibilit economica influisce soprattutto sulla durata, sulla scelta della localit e sul periodo ma non sulla sua effettuazione, vacanza un prodotto che assolve la funzione di valorizzare l'espressivit personale e di comunicare l'appartenenza ad un'lite o status o stile di vita. Oggi vi una forte propensione al consumo contro gli scenari orientati alla semplicit. Non vengono abbandonati alcuni beni ma il comportamento pi comune quello di posticipare l'acquisto. Il consumo attento e selettivo. Si crea una nuova tipologia di turista: il turista consumatore quindi pi selettivo. Atteggiamento tipico del turista: evitare gli altri turisti.
Prodotto turistico deve possedere fattori come attrattiva, strutture turistiche e accessibilit.
L'analisi del prodotto turistico: secondo due prospettive: orizzontale (prospettiva turistica) e verticale (prospettiva del produttore). Si tratta di due prospettive divergenti. Alla base vi la difficolt di capire come si genera la soddisfazione o l'insoddisfazione della domanda per potere indirizzare la progettazione o riprogettazione turistica. Non un problema di miopia ma di restrizione del campo visivo: il produttore osserva il fenomeno turisti con con occhiali diversi da quelli del turista.
Punto critico: conciliare la qualit dell'esperienza turistica con i vincoli ambientali, naturali. Realizzando un concetto di marketing sociale.
Importante la riformulazione del prodotto
utilizzo di risorse interne o esterne controllabili e compatibili con quelle interne per acquistare servizi nuovi
individuazione di opportunit e accesso a risorse esterne non controllate
arricchimento del prodotto mediante accordi con altre aziende.
Comunicazione pubblicitaria: scopo di far si che i potenziali consumatori rispondano in modo pi favorevole a ci che l'azienda offre. L'azienda d informazioni ai consumatori cercando di modificare i loro desideri e fornendo dei motivi per preferire gli specifici prodotti dell'azienda. Messaggio pubblicitario:
coinvolge (attrae attenzione, suscita interesse)
comprensione ( decodifica veloce)
convinzione (accentua i benefici)
comportamento ( comportamento d'qacquisto)
il prodotto turistico deve: attrarre nelle destinazioni e nelle aree di transito, deve garantire servizi, deve fornire una chiara immagine delle destinazioni e delle informazioni.
Politica di marca: l'insieme delle decisioni relative alla caratterizzazione del prodotto e alle scelte di comunicazioni, distribuzione e prezzo che si riferiscono ad un prodotto dotato di nome, marchio e logo. L'immagine esterna si rapporta al target prefissato e svolge tre funzioni:
contribuisce a creare aspettative (l'immagine dipende cmq dalle aspettative e dalle esperienze del turista)
una immagine positiva favorisce l'efficacia della comunicazione pubblicitaria, promozionale, comunicazione interpersonale (passa parola) e quindi la costruzione delle aspettative da parte del potenziale turista
un'immagine definita in modo chiaro e positiva tende a rafforzare la qualit del rapporto con il turista
marketing si occupa della funziona tecnica dello scegliere a chi vendere, cosa e come. Programa le azioni conseguenti perseguendo la realizzazione del profitto tramite la soddisfazione dei bisogni del consumatore.
Le 4 P di Kotler: prodotto, prezzo, posizionamento, promozione
poi aggiunte: potere e pubbliche relazioni.
Leva competitiva
qualit del prezzo: componente prioritaria dell'immagine del prezzo
posizionamento strategico dell'impresa: segmentazione del mercato, politiche di prezzo, concetto di servizio integrato
azione di supporto
promuove uno stile manageriale partecipativo
sviluppa la comunicazione interna
orienta le risorse al problem solving
sviluppa attivit di addestramento reciproco
domanda: insieme di movimenti e servizi richiesti dai consumatori e si segmenta in base alle esigenze individuali: stimolata e spontanea.
offerta: l'insieme dei servizi e delle prestazioni materiali fornite dai soggetti attivi e passivi per soddisfare i bisogni dei fruitori che trovano sempre pi specializzazione.
Il servizio: non ha un tempo di vita ma un tempo di erogazione. La presenza del fattore umano rende il servizio fortemente influenzabile.
La qualit di un servizio la misura di quanto il servizio reso corrisponde alle aspettative del cliente, fornire un servizio di qualit significa adeguarsi alle aspettative del cliente.
Qualit: hard: contenuto tangibile del servizio (orari); soft: contenuto emotivo del servizio (cordialit). La qualit di un servizio determinata da fattori: cultura del servizio, risorse umane, risorse tecnico economiche, organizzazione, capacit di risposta, affidabilit, comunicazione, credibilit, sicurezza, capire e conoscere il cliente, cortesia, competenza.
Aspetti critici per la qualit: aspetti organizzativi e gestionali.
ricorso alla tradizione
sottovalutare il contributo dei collaboratori dello sviluppo della qualit del lavoro e della professione.
Elevato individualismo
squilibrio della cultura professionale su quella aziendale
valutazione del cliente sulla qualit del servizio
passaparola
esigenze personali
esperienza passata
comunicazioni esterne
questi fattori portano alla percezione del servizio atteso che viene confrontato con la percezione sul servizio: dimensione della qualit del servizio.
Modello delle 5 Q: qualit paragonata (concorrenza), qualit percepita e qualit attesa (cliente), qualit erogata e qualit progettata (organizzazione).
L'insoddisfazione. Perch si perde un cliente: cambia abitudini, trova prezzo troppo alto, deluso dalla qualit e dal servizio.
La soddisfazione del cliente (customer satisfaction) una valutazione post acquisto del prodotto. La soddisfazione uno stato psicologico derivante dalla risposta emotiva che l'esito della comparazione comporta.
Teoria del livello di adattamento: la soddisfazione che deriva dal prodotto influenzata dall'esperienza avuta in passato con prodotti simili, dal contesto di percezione e dalle caratteristiche del percettore: risultato un livello di adattamento col quale si raffronta la performance percepita.
Teoria dell'assimilazione contrasto: si verifica un effetto diverso a seconda che la perfomance percepita differisca poco (la differenza ignorata e non si verifica insoddisfazione) o molto (la discrepanza tra aspettative e percezione tende ad amplificare il contrasto tra le due producendo un forte effetto sulla soddisfazione:postivo o negativo) da quella attesa.
Teoria del livello di comparazione : per ciascun attributo prodotto il consumatore paragona la performance ad un livello di riferimento che funzione di 3 elementi: esperienza passata, esperienza di altri consumatori, informazioni sul prodotto.
Relazione tra qualit del servizio e soddisfazione del cliente
le variabili che influenzano l'una non sono necessariamente le stesse che influenzano l'altro. Aumentare qualit senza che il consumatore avverta il miglioramento non equivale ad un aumento della soddisfazione. necessario distinguere tra qualit percepita e oggettiva.
Risorse umane. Fattore prioritario di successo del servizio. La gestione delle risorse umane deve essere focalizzata tanto sulle dimensioni tecniche quanto su quelle comportamentali: ci condiziona le strategie di selezione, le possibilit di formazione. La teoria del marketing sostiene che le relazioni di successo sono costruite su scambi soddisfacenti da cui traggono valore sia i clienti che i fornitori.
ciclo del fallimento: servizio di bassa qualit, turne over alto, pessimo servizio, personale tratta il cliente come viene trattato dal manager. Obbiettivo: ricerca della produttivit. Soluzione: semplificare le procedure e assumere personale a basso costo. Si punta su regole non su servizio.
Ciclo della mediocrit: tipico di grandi aziende burocratizzate. Gli standard di erogazione del servizio sono definiti da regole rigide orientate alla serializzazione e all'efficienza produttiva. Il personale si aspetta di passare tutta la vita lavorativa in quella organizzazione. La formazione focalizzata sull'apprendimento di regole e aspetti tecnici non su capacit relazionali. Aumento del salario dipende dall'anzianit e la performance definita dall'assenza di errori piuttosto che da alta produttivit o eccellenza di servizio.
Cliente insoddisfatto mostra nei confronti del personale ostilit e questo si protegge con l'indifferenza seguendo meramente le regole o rispondendo con altra ostilit.
Ciclo del successo: compiti ampi, formazione e delega delle responsabilit permettono al front line di controllare la qualit. Uso di strategie di marketing, snellimento della struttura burocratica: personale pi dinamico orientato al servizio.
Ruolo del cliente: partecipa al servizio prosumer: producer e consumer. Pu essere partecipativo in vari modi: fornendo dati diagnostici per realizzare un servizio, svolgendo una parte del lavoro e sostituendo i dipendenti (self service, biglietterie automatiche), pu essere coinvolto nel controllo qualit, pu influenzare direttamente l'ethos (norme di vita), la motivazione, la produttivit. L'interazione azienda-cliente ha la natura di un processo sociale che richiede norme e regole interiorizzate dal personale capaci di guidare il comportamento di ogni giorno.
Momento della verit l'incontro tra il cliente e chi eroga il servizio. Quello che accade non pu pi essere direttamente influenzato dall'azienda. Sono l'abilit, la motivazione e gli strumenti impiegati da chi fornisce il servizio e le aspettative e comportamento del cliente che creano il processo di erogazione del servizio.
Modalit di erogazione del servizio: l'azienda pu far leva sulla partecipazione per esplorare nuove possibilit di segmentazione del mercato con variabili psicologiche (disponibilit a partecipare alla realizzazione) oppure di comportamento (attivit dei partecipanti) e per riprogettare la propria offerta a seguito di cambiamenti nel ruolo del cliente. Il grado di coinvolegimento del cliente nella realizzazione dipende da una serie di fattori: durata dell'erogazione del prodotto, frequenza.
Riprogettazione del ruolo del cliente: analisi dei potenziali punti di contatto con l'organizzazione, studio delle relazioni tra questi punti e le singole operazioni che compongono il prodotto.
Immagine dell'azienda: il turista nel suo agire di consumo acquista realmete l'immagine della vacanza e della localit ma soprattutto dell'organizzazione. L'immagine una componente della soddisfazione del cliente, una fonte degli standard di prestazione.
L'immagine aziendale: marchio: valore aggiunto al prodotto stesso costituito dalla somma degli stimoli memorizzati inzonsciamente ed evocati dalla sua percezione.
Emozioni tipiche del post turismo: irritazione, noia, delusione, rabbia
Turismo nel 2000: non pi evasione dal lavoro, lusso, massificazione, stereotipo cultuale ma realizzazione, necessit, individualit.
Turismo come norma sociale una regola collettiva alla quale occorre sottomettersi: un modello di consumo. Ha funzione integrativa e normativa.
Turismo come festa: entrambe ricorrono periodicamente, hanno funzione rigenerative e danno possibilit di accedere a piaceri altrimenti negati. La festa una celebrazione, un momento di meditazione, di crescita morale, elevazione spirituale. trasgressione, eccesso.
Turismo come festa ragionevole.
Vacanza non pi come evento sporadico occasionale ma preventivata tra le spese. una risposta ad esigenze frustrate, un fattore di integrazione sociale, un simbolo di status ed vissuta come necessit
Nell'esperienza turistica la persona modifica i propri modelli di comunicazione. La scelta di divenire turista diviene un atto comunicativo che permette di trasmettere agli altri una particolare immagine di s.
Funzioni della vacanza:
compensazione
ricreazione
funzione simbolica
turismo non un need ma un want, un desiderio, un mezzo per differenziarsi, un bisogno culturale. Viaggio come libert e avventura: da vacanza come riposo dallo stress quotidiano a periodo attivo in cui conoscere e sperimentare situazioni e luoghi nuovi con altre persone.
Motivazione turistica:
fuga evasione
vagabondare
regredire
ricerca s
socializzazione
cultura- conoscenza
prestigio sociale
cambiamento- inversione
tipologie di viaggio:
ricreativo: ricerca ed esperienza ludica
diversivo: fuga da noia e routine
esperenziale: esperienza nuova, autentica
sperimentale: ricerca di s
esistenziale: adesione ad un centro spirituale
tipologie di turista:
vacationer: abitudinario
sightseer: cacciatore di immagini
drifter: ricerca dell'avventura
la fotografia:turista va verso le immagini, non verso le cose. Luogo visitato diventa un non luogo, una serie di istantenee. Turista andr alla ricerca delle cose da vedere pre definizione.
La presenza fisica, nel mondo, di artefatti e infrastrutture (naturali e culturali) non sufficiente a giustificare l'esistenza del turismo. il bisogno forte e radicato che spinge l'individuo al viaggio, psicologicamente definito come un evento essenzialmente socio-psicologico.
Societ industriale: lavoro come misurazione rigida del tempo. Turismo: concentrazione spaziale e temporale della domanda: stagionalit. Tempo libero: centrato su riposo- famiglia, casa. Viaggi a medio-lungo raggio. Societ post industriale:lavoro: organizzazione pi elastica del tempo. Turismo: minore concentrazione spaziale e temporale della domanda. Tempo libero: loisir urbani.
Turismo fattori di crescita: incremento produttivo e redditi, industrializzazione, urbanizzazione, mobilit, progresso nella tecnologia dei trasporti, nuovo atteggiamento verso tempo libero e turismo
Ambito di indagine sociologia sono i valori, gli atteggiamenti e i comportamenti delle collettivit umane dal piccolo gruppo (microsociologia) allo stato nazionale (macrosociologia). focus anche il tempo libero e sul rapporto con le attivit routinarie della vita.
Fine settimana: fase di riposo e di costruzione per un efficiente ritorno al lavoro crea trauma del fine settimana. Tempo libero: pausa dalla solitudine del lavoro come condizione unica di socialit, identit di ruolo. Turismo pu essere studiato solo in relazione al suo opposto: la vita quotidiana.
significato della vacanza dato da obbiettivi con alti livelli di motivazioni
desiderio di relax e riposo (fuga, evasione, staccare dallo stress)
benessere Isvago, divertimento)
arricchimento ( culturale, sociale, conoscenza di s e degli altri)
periodo per ricarcarsi
Modello di Fishbein e Ajzen
teoria dell'azione ragionata spiega come gli atteggiamenti possono guidare il comportamento attraverso una ponderata valutazione delle interazioni: il comportamento determinato dall'intenzione di eseguirlo: una volta espressa con attenzione, l'intenzione il pi importante elemento predittivo del comportamento.. ma spesso conoscere la sola intenzione non basta per prevedere una azione. I fattori che rendono pi probabile che un'intenzione si trasformi in azione:
atteggiamento verso il comportamento (valutazione personale, piacere)
norme soggettive: credenze su come gli altri giudicano quel comportamento: una pressione sociale percepita a eseguire o meno quel comportamento (per non deludere, dovere).
Il modello. Sfera personale formata da valori, interessi, motivazioni (auto realizzazione, autostima, motivazioni sociali) aspettative determinata dalla sfera sociale ovvero dal gruppo di appartenenza, di riferimento. Questo comporta per l'individuo l'attivazione di una funzione adattiva e integrativa. Secondo questo modello la presa di decisione sar determinata dalle aspettative che appartengono al vissuto personale (quindi a tutti i fattori che appartengono alla sfera sociale e personale) le quali determineranno anche il livello di soddisfazione riguardo la vacanza. ()
Impatto sociale e culturale nel turismo: fenomeno turismo contribuisce a modificare sistemi di valori, condotta morale, comportamento individuale, stile relazione familiari, l'organizzazione comunitaria nella localit di destinazione.
Relazione turista- residente: carattere strumentale, raramente marcata da colorazioni affettive, spesso caratterizzata da un certo grado di distanza sociale e di stereotipizzazione.
Interazione caratterizzata da 4 aspetti:
transitoria
limitata da legami spaziali e temporali
manca di spontaneit
non si svolge su un piano di uguaglianza
la cultura ospitante pu dar vita a meccanismi di auto protezione: desiderio di chiudersi, isolarsi dall'invadenza del turismo. L'impatto del turismo dipende dall'interazione tra la natura del cambiamento e la capacit, abilit, forza della cultura ospitante di assorbimento.
Modelli di analisi dell'impatto turistico: DOXEY: indice di irritazione (livello di euforia, indifferenza o apatia, irritazione, antagoismo, livello finale).BUTLER: 6 stadi di evoluzione che ricalcano il ciclo di vita di un prodotto: esplorazione, coinvolgimento, sviluppo, consolidamento, stagnazione, declino. Individua inoltre due dimensioni bipolari: favorevole/sfavorevole, attivo/passivo.AP: teoria dello scambio sociale: l'interazione considerata un processo in cui degli attori sociali si scambiano reciprocamente delle risorse.
L'atteggiamento dei residenti verso lo sviluppo turistico: durata della residenza, dipendenza economica dal turismo, distanza dalla propria abitazione dal centro turistico, coinvolgimento del residente nelle decisioni che riguardano il turismo, luogo di nascita, livello di informazione e contatto con i turisti, caratteristiche demografiche, tasso di crescita della comunit.
Gentifricazione: processo di rigenerazione di un quartiere urbano associato all'arrivo di gruppi sociali ad alto reddito, processo che tende ad allontanare i gruppi a reddito pi basso che lo abitavano precedentemente e che generalmente implica un sostanziale recupero e miglioramento delle condizioni degli edifici. Quartieri di solito accessibili dal centro e caratterizzati dalla presenza di costruzioni datate e di un certo valore di studio.
Il caso di Cervia: la costruzione dell'immagine
importanza dell'immagine della destinazione relativamente all'agire turistico. Si tratta di una rappresentazione multidimensionale nella mente dell'individuo dotata di specifiche propriet. Il significato di un luogo, la sua immagine per l'individuo, non si relaziona in modo deterministico alle caratteristiche fisiche e sociali dell'ambiente: la percezione di una localit tender ad esprimersi come risposta soggettiva altamente personalizzata. Una volta formata questa condizioner piuttosto stabilmente il comportamento del turista influenzando il modo in cui le informazioni sulla destinazione verranno trattate ed elaborate.
Scopi della ricerca:1 definire l'ampiezza e la profondit delle rappresentazioni mentali effettivamente possedute da un particolare campione di turisti relativamente ad una destinazione selezionata2 valutare l'impatto dei principali fattori personali ed esperenziali3 produrre un set di attributi sufficientemente rappresentativo del dominio indagato in vista di uno studio pi rigoroso sul contesto specifico.
Base teorica: teoria dell'immagine secondo il modello di Baloglu e McCleary.
Metodo: tecnica del questionario e focus group. Il questionario comprende due sezioni: la prima indaga i principali aspetti strutturali (variabili sociodemografiche) come et, genere, luogo di residenza e livello di istruzione. La seconda include alcune variabili valutative quali il grado di familiarit della destinazione misurato attraverso scala likert a 10 punti e le dimensioni pi salienti dell'immagine turistica sono individuate da domande: quali tra le tre parole descrivono meglio Cervia come localit di vacanza o destinazione balneare.
Al metodo del focus group andava il compito di sondare gli aspetti sottesi dagli obbiettivi della ricerca. Per garantire attendibilit e validit dei test stato utilizzato il registratore durante i colloqui di gruppo, la trascrizione sbobbinata e un controllo sull'analisi dei contenuti.
Inoltre il test-preliminare aveva lo scopo di garantire efficacia nel cogliere l'informazione.
Il campione: soggetti con almeno un'esperienza di viaggio verso la destinazione nell'anno precedente rispetto l'indagine. Questo gruppo si suddivideva in tre sottogruppi: uno di prova (nella fase di pre ricerca)... gruppo 1(area appeninica) gruppo 2 ( )
sul piano dei contenuti possibile individuare i principali punti di forza e di debolezza percepiti: specifici aspetti legati alla vita notturna, all'intrattenimento, alle opportunit ricreative e sportive, ristorazione. La percezione di idoneit sia verso la famiglia che verso i giovani cos come un pubblico elitario suggerisce un profilo distintivo e un vantaggio competitivo. Si percepisce dai confronti ricorrenti forniti spontaneamente rispetto le destinazioni limitrofe.
Emergono carenze nella rete viaria, prezzi generalmente alti e accessibilit problematiche alle strutture. Attributi di natura astratta si riferiscono all'ospitalit ricevuta ovvero alla mancanza di spontaneit percepita da parte del personale. Giudizi positivi si riferiscono alla mancanza di atti criminosi ma non alla sicurezza stradale.
Sul versante delle impressioni generali cervia risultava categorizzata come destinazione balneare caratterizzata dal verde.
Questa ricerca tentativo di cogliere in modo naturali elementi coinvolti nella strutturazione dell'immagine mentale di una destinazione turistica relativamente ad un contesto ambinetale e socio culturale molto specifico. Un limite della disegno di ricerca stato l'individuazione dei diversi fattori motivazionali rilevanti che sarebbe necessario indagare tramite esperienze pregresse e caratteristiche sociodemografiche e soprattutto indagare gli input legati alle operazioni di marketing.
Quest'indagine sulle componenti dell'immagine pu rilevarsi preziosa nella pianificazione delle strategie promozionali. L'organizzazione turistica dovrebbe considerare i propi punti di forza e le proprie debolezze rispetto quelli della conocorrenza e selezionare la posizione attraverso la quale possbile trarre un forte vantaggio competitivo.
Fase pre ricerca suggerite tre identit distinte: pinnarella e tagliata (famiglie con figli in et infantile e con adolescienti); cervia struttura per nuclei familiari in et adulta; milano marittima status symbol anche dal punto di vista del buon gusto o dello stile di vita. Questo permetter di identificare il target per i servizi pi indicati.