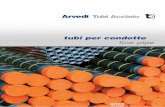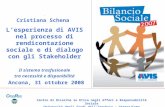Mostra a cura di: Antonio Bruno e Cristiana ViscardiEsperienze condotte nell’ambito della Scuola...
Transcript of Mostra a cura di: Antonio Bruno e Cristiana ViscardiEsperienze condotte nell’ambito della Scuola...

1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO IIFacoltà di Architettura
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura
Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana
Mostra a cura di: Antonio Bruno e Cristiana Viscardi
LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA Procedure, metodi e strumenti operativi per la stesura dei Piani di Manutenzione
(Legge quadro sui Lavori Pubblici L. 109/94 e s.m.i.)
Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Presentazione
La Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia Urbana, istituita con D.R. 21 novembre 1996 - G.U. 5 dicembre 1996, ed attivata dall'a.a. 1997/98 presso il Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell'Architettura della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", è la prima del settore in Italia.
La Scuola si inserisce in un clima culturale nel quale la Manutenzione e Gestione Edilizia ed Urbana, rappresentano tematiche di rilevante importanza. La cura costante, necessaria per gestire il patrimonio edilizio esistente e per garantire l'adeguata utilizzazione delle risorse naturali ed artificiali presenti sul territorio nel rispetto dei loro caratteri peculiari, richiede metodi e strumenti per riportare all'iniziale efficienza le prestazioni offerte e per introdurre, in una prospettiva di sviluppo, nuove prestazioni.
L’obiettivo formativo è quello di fornire competenze specifiche nei seguenti settori:• conservazione del capitale manufatto - edilizio ed urbano - e del capitale naturale;• controllo della gestione del manufatto e del capitale naturale;• manutenzione dell’ambiente costruito e naturale;• individuazione delle strategie più efficaci per l’intervento di recupero;• controllo del processo piano/progetto/attuazione/gestione.
Pertanto, l’esperienza formativa risponde alla domanda di nuove competenze e figure professionali in grado di utilizzare metodi e strumenti per garantire gli obiettivi di qualità nelle fasi relative alla programmazione, progettazione realizzazione dell’intervento sul patrimonio esistente e nella fase di gestione.
La Scuola, il cui corso di studi ha durata 2 anni con 800 ore di insegnamenti, rilascia il titolo di specialista in "Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana".
Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli

2
Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di NapoliPresentazione
Articolazione didattica
L'ordinamento comprende 6 aree disciplinari alle quali sono dedicate le 800 ore complessive di didattica:Area 1: Discipline tecnologicheArea 2: Discipline estimativeArea 3: Discipline fisico-tecnica e impiantisticheArea 4: Progettazione architettonica e urbanisticaArea 5: Teoria e tecnica per il restauroArea 6: Discipline giuridiche e del management
Direttore Prof. Arch. Gabriella Caterina
Collegio docenti
I docenti titolari degli insegnamenti attivati sono provenienti delle Facoltà di Architettura, Ingegneria e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".Docenti:Prof. V. Baldini, Prof. V. Betta, Prof. V. Biggiero, Prof. C. Capolupo, Prof. S. Casiello, Prof. G. Caterina, Prof. U. Caturano, Prof. G. D’Alfonso, Prof. A. Dal Piaz, Prof. M. Dentice D’Accadia, Prof. C. Di Biase, Prof. V. Fiore, Prof. F. Forte, Prof. D. Francese, Prof. L. Fusco Girard, Prof. C. Gasparrini, Prof. M. Guarino, Prof. F. La Saponara, Prof. P. Mazzei, Prof. L. Morrica, Prof. D. Pianese, Prof. R. Picone, Prof. M. R. Pinto, Prof. L. Sansone, Prof. M. Scudiero.
La Scuola si è avvalsa, inoltre, della collaborazione di docenti specialisti del settore, provenienti da atenei italiani e stranieri, dalla Pubblica Amministrazione e dal mondo del lavoro.

3
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONEEsperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Strumenti operativi per l’applicazione della Norma UNI 10874. Criteri di stesura del Manuale di Manutenzione (per i tecnici). Caso studio un isolato del Centro
Storico di Vairano Patenora (CE)
RELATORE : Prof. Maria Rita PINTO CORRELATORI: Prof. Gabriella CATERINA Prof. Stella CASIELLO
SPECIALISTI: Arch. Maria Teresa CARFORAArch. Patrizia ZANFAGNA
Sintesi del lavoro di tesi:Stesura e validazione dei contenuti del manuale di manutenzione (per i tecnici)
all’interno di un quadro legislativo e normativo
Obiettivi• Istituire un sistema di raccolta delle ”informazioni di base” e di aggiornare le “informazioni di ritorno” a
seguito degli interventi, che consenta, attraverso l’implementazione e il costante aggiornamento del “sistema informativo”, di conoscere e manutenere correttamente l’immobile e le sue parti ;
• Istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la corretta ed efficiente esecuzione degli interventi.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONEEsperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

4
Metodologia• Intepretazione dei contenuti e criteri forniti dal progetto di NORMA UNI U49030240 e successiva Norma
10874 “Criteri di stesura dei manuali d’uso e di manutenzione” scopo-contenuto -esito informativo;• Traduzione dei contenuti della norma UNI in schede operative (documenti ed istruzioni);• “Test” delle schede al caso studio “Progetto di intervento di recupero di edilizia residenziale sovvenzionata
Borgo Medioevale di Vairano Patenora (Ce) L.457/78;• “Test di validazione della Norma (sono state riportate alcune variazioni dei contenuti consistenti in
specifiche, aggiunte, modifiche con le rispettive motivazioni).
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONEEsperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Strumenti• classificazione del sistema edilizio:
• sistema tecnologico• sistema ambientale
• scheda identificativa bene immobile• lista anagrafica degli elementi• elaborati tecnici
• schede tecniche• schede diagnostiche• schede cliniche• schede normative• istruzioni per le ispezioni• istruzioni per la manutenzione
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONEEsperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

5
ConclusioniGli elementi per lo studio proposto sono stati cercati in un contesto di transizione che
vede la manutenzione passare da un sistema di attività e procedure tecniche ad un sistema con funzioni di servizio che assorbe compiti di conoscenza, previsione, programmazione e controllo in un dinamico quadro legislativo-normativo.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONEEsperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

6
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO: L’ESPERIENZA DELLO I.A.C.P. NAPOLI.
Note per una proposta innovativa delle politiche manutentiveRELATORE : Prof. Gabriella CATERINA CORRELATORE: Prof. Vittorio FIORE
SPECIALISTA: ARCH. Nicola RAGOSTA
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONEEsperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
IL PATRIMONIO TECNICO IMMOBILIARE
DISTRIBUITO SUL TERRITORIO :
LO I.A.C.P. NAPOLI E PROVINCIA
Sintesi della tesi
Dall’analisi della struttura tecnico-organizzativa dello I.AC.P. (Istituto Autonomo Case Popolari) di Napoli, in relazione alla triplice veste di “costruttore”, “gestore” e “manutentore”del patrimonio edilizio-residenziale, si è ipotizzata una riorganizzazione del Servizio Tecnico di Manutenzione nell’ottica di una nuova ed innovativa “politica manutentiva”
Obiettivi
Il presente lavoro di tesi si è posto i seguenti obiettivi:
- Elaborazione di una Nuova Politica Manutentiva;
- Definizione di adeguate Strategie Manutentive;
- Strutturazione di un Piano di Manutenzione Informatizzato;
- Ottimizzazione dei Programmi di Manutenzione.
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI NAPOLI E PROVINCIA
( I. A. C. P. )
LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO
PROFILO STORICO DAL RISANAMENTO AD OGGI
ORGANIGRAMMA I.A.C.P.
GLI ORGANI FUNZIONALI
ATTIVITA’, FINALITA’, PATRIMONIO
RESPONSABILITA’ ORGANI
PROFILO TECNICO IMMOBILIARE DELLO I.A.C.P.
ORGANIGRAMMA
SETTORE MANUTENZIONE
ORGANIGRAMMASTRUTTURA
TECNICA PERIFERICA
SCHEDATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
FUNZIONI, QUALIFICHE E COMPETENZE DEL SETTORE MANUTENZIONE
NORMATIVA E GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
DEGLI INTERVENTI
NORME SISTEMATICHE
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA MANUTENZIONE
LA MANUTENZIONE NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

7
STRUMENTI PER CONOSCERE “LO STATO DI FATTO” DEL SETTORE MANUTENZIONE
ZONA OVEST
CARTINA REGIONALE DELLE LOCALITA’ DOVE SONO PRESENTI COSTRUZIONI DELLO I.A.C.P.SETTORE MANUTENZIONE
IL PATRIMONIO TECNICO DELLO I.A.C.P. NAPOLI E PROVINCIA SUDDIVISO PER ZONE.
ZONA W 1
ZONA W 2
ZONA W 3
ZONA EST
ZONA E 1
ZONA E 2
ZONA E 3
ZONA E 4ZONA W 4
ATTIVITA’ MANUTENTIVA
•I LOCATARI CON SEGNALAZIONE SCRITTA E PROTOCOLLATE, SOLLECITANO I TECNICI DI ZONA AD INTERVENIRE PER IL SOPRALLUOGO DI VERIFICA DEL GUASTO AVVENUTO NELL’UNITA’ IMMOBILIARE.
•INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO AVVENUTO.
•I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VENGONO APPALTATI A IMPRESE ESTERNE.
•I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VENGONO CON LA LEGGE 05/08/1978 N°457.
•NELLA STRUTTURA DELL’UFFICIO NON ESISTE UNA SQUADRA DI OPERAI PER L’ISPEZIONE E L’INTERVENTO.
IL PATRIMONIO TECNICO IMMOBILIARE DISTRIBUITO SUL TERRITORIO: NAPOLI E PROVINCIA
PER LA INDIVIDUAZIONE DELL’INTERO PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE E’ STATA ELABORATA UNA SCHEDA, CON LE SEGUENTI VOCI:
INTERVISTA “A DUE” COME STRUMENTO RIVELATORE
• COSA SIGNIFICA “MANUTENZIONE” PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE ?
• A QUALE LEGGE FA RIFERIMENTO IL SETTORE MANUTENTIVO PRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ?
• DA QUANTE UNITA’ E’ COSTITUITO IL PATRIMONIO DELL’ENTE ?
PER AFFRONTARE I PROBLEMI DI MANUTENZIONE L’ENTE
CONOSCE BENE IL SUO PATRIMONIO TECNICO IMMOBILIARE ?
• UTILIZZA UNA POLITICA MANUTENTIVA PER PREVENIRE IL
DEGRADO DELL UNITA’ IMMOBILIARI ?
• FA RICERCA E SPERIMENTAZIONE QUESTO SETTORE PER
MIGLIORARE IL PROPRIO PATRIMONIO ?
• GLI ADDETTI AL CONTROLLO DEL DEGRADO DI QUESTO
PATRIMONIO FA STUDI SISTEMATICI SUL PROBLEMA DELLA
MANUTENZIONE ?
• QUANDO SONO STATI REALIZZATI I PRIMI EDIFICI DELLO I. A. C. P.?
QUALI SONO LE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE PER LA COSTRUZIONE
DELLE UNITA’ IMMOBILIARI ?
• QUALI SONO LE TECNICHE COSTRUTTIVE ADOPERATE PER LA REALIZZAZIONE DI QUESTO PATRIMONIO ?
• QUALI STRATEGIE MANUTENTIVE METTE A REGIME L’UFFICIO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ?
• NELLE SCELTE PROGETTUALI “EX NOVO” DI EDIFICI IL SETTORE PROGETTI PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL PROBLEMA MANUTENTIVO ?
• NELLA FASE DI IDEAZIONE DI UN EDIFICIO L’ UFFICIO PROGETTI E QUELLO MANUTENTIVO COLLABORANO ?
• IL SETTORE MANUTENTIVO NEL FARE “MANUTENZIONE” E’ SUPPORTATO DA UN SISTEMA INFORMATIVO ?
• PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI VENGONO REDATTI “PIANI DI MANUTENZIONE” ?
• ESISTE UNA BANCA DATI DEI MATERIALI UTILIZZATI PER UNA COMPLETA CONOSCENZA DELL’INTERO PATRIMONIO IMMOBILIARE ?
• I MATERIALI UTILIZZATI NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, UNA VOLTA IN OPERA, VENGONO OSSERVTI” PER UN PERIODO PRESTABILITO, IN MODO DA VERIFICARE IL LORO COMPORTAMENTO NEL TEMPO ?
• VIENE EFFETTUATO “MONITORAGGIO” SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE UNA VOLTA CONCLUSO L’INTERVENTO ?
• ESISTE UN REGOLAMENTO CHE STABILISCE IN MANIERA PRECISA QUALI OPERE DEBBONO ESSERE ESEGUITE DALL’ENTE GESTORE, QUALI DAGLI ASSEGNATARI ?
• ESISTE UN RAPPORTO TRA UTENZA ED ENTE, RIGUARDO AL PROBLEMA DELLA MANUTENZIONE, NEL SENSO DI UNA MAGGIORE RESPONSABILITA’ DELLA UNITA’ LOCATA ?
VANILOCALITA’ CED LEGGE DATA DI COSTRUZIONE TECNICA COSTRUTTIVA ALLOGGI

8
POLITICHE MANUTENTIVE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLO I.A.C.P.
INTERVISTA AL RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONE
DEFINIZIONE PER LO I.A.C.P. DISTRATEGIA IMMOBILIARE:
INSIEME DI OBIETTIVI DI MEDIO E LUNGO PERIODO, VALUTATI SECONDO LE PRIORITA’ DELL’ENTE, ATTRAVERSO PROCEDURE TECNICO – ECONOMICHE, AL FINE DI GARANTIRE IL MANTENIMENTO NEL TEMPO DEL VALORE PATRIMONIALE DI UN IMMOBILE.
I LIVELLO METASTRATEGICOSI RICERCANO LE RAGIONI DELL’INSUCCESSO REGISTRATO DAGLI ORGANI DECISIONALI NEGLI ULTIMI TRENTA ANNI DI VITA DELL’ENTE. .L’ENTE SI DOMANDA :
PERCHE’ CAMBIARE ?QUALI ERRORI SONO STATI COMMESSI NELLE VALUTAZIONI DELLE SCELTE IMMOBILIARI?
II LIVELLO STRATEGICOL’ENTE DEVE PREOCCUPARSI DEL PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE. CIO’COMPORTA SCELTE DI OBIETTIVI DI MEDIO E LUNGO PERIODO, OPPORTUNAMENTE GERARCHIZZATI. L’ENTE SI DOMANDA:
COSA CAMBIARE ?
III LIVELLO TATTICOL’ENTE DEVE FARE LE PROPRIE SCELTE. IN QUESTA FASE. E’ INDISPENSABILE UN’AZIONE INTEGRATA TRA I SETTORI DELL’ENTE (SINERGIE NON RISCONTRATE NELL’ATTUALE ORGANIGRAMMA ). L’ENTE SI DOMANDA:
COME E CON CHI CAMBIARE ?
IV LIVELLO ATTUATIVO - GESTIONALEL’ENTE DEVE STABILIRE I TEMOI DEI VARI INTERVENTI IN BASE AD UN PROGRAMMA E UN PIANO. L’ENTE SI DOMANDA:
QUANDO INTERVENIRE ?
“AZIONE INTEGRATA”
TRA I SETTORI DELL’ENTE
MODIFICA
ORGANIGRAMMA I.A.C.P.
INTERVENTI REALIZZATI CON LA REDAZIONE DI :
UN PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
DEFINIZIONE PER LO I.A.C.P. DI: POLITICA MANUTENTIVA:
PROGRAMMAZIONE DEI DIVERSI CRITERI TECNICI ED ECONOMICI CHE PERMETTONO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO DI UN IMMOBILE.
LA MODIFICA DELLA STRUTTURA DELL’ORGANIGRAMMA E’ FONDAMENTALE IN QUANTO E’ UNA CONSEGUENZA DELLA NUOVA STRATEGIA IMMOBILIARE ADOTTATA DALL’ENTE. LA NUOVA STRATEGIA E LA MODIFICA DELL’ORGANIGRAMMA FANNO SI CHE L’ENTE INIZI AD OPERARE SECONDO UNA “PROGETTAZIONE INTEGRATA” TRA I VARI SETTORI, FONDAMENTALE PER OTTIMIZZARE LE RISORSE ECONOMICHE.
STRATEGIA IMMOBILIARE
POLITICA MANUTENTIVA
VALUTAZIONE DI CRITICITA’ E PRIORITA’PER IL PIANO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
STRATEGIE DI MANUTENZIONEMANUTENZIONE PROGRAMMATA
VALUTAZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTI
PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
PIANO DI QUALITA’
STANDARD DI PRESTAZIONE DELL’ENTE
ELEMENTI PER CONTROLLARE LA QUALITA’ DEL PROCESSO EDILIZIO E MANUTENTIVO
BILANCIO DI PREVISIONE
Gestione e manutenzione
BILANCIO CONSUNTIVO
Gestione e manutenzione
STIMA DEI COSTI NEL
CICLO DI VITA
INDICE DEI DI COSTI MANUTENZIONE
Istruzioni lavori di manutenzione
O rdine dei Lavori
LAVORI DI
MANUTENZIONE

9
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
“Procedure di manutenzione per un controllo dei costi di gestionedel campus universitario di Fisciano (Salerno)”
Il lavoro di tesi è riferito al piano di manutenzione del progetto di un edificio universitario, denominato
“Invariante 12B”, del campus universitario dell’Università degli
Studi di Salerno della sede di Fisciano.
La finalità del lavoro di tesi è stata quella di creare un modello
informatico per la razionalizzazione economica
dell’organizzazione gestionale e manutentiva dell’edilizia
universitaria grazie anche al supporto di un data base.
Lo studio parte dall’analisi di un edificio già realizzato e denominato
invariante 11C.
RELATORI : Prof. Gabriella CATERINA
Prof. Vittorio BETTA
CORRELATORI : Prof. Vittorio FIORE
Prof. Giovanni D’ALFONSO
SPECIALISTI: arch. Roberto BORRIELLO
arch. Carmine TOMEO
Obiettivi:
• Creare un sistema per la razionalizzazione economica dell’organizzazione gestionale e manutentiva dell’edilizia universitaria.
• Garantire l’utilizzo dell’edificio contrastandone il degrado e favorendone il mantenimento delle prestazioni tecniche iniziali in funzione delle esigenze dei fruitori e delle richieste legislative.
• Revisionare e modificare il progetto iniziale.
• Individuare le strategie più efficaci per una diversa politica manutentiva.
L’analisi ha considerato aspetti riferiti:• ai costi di costruzione• ai costi energetici• ai costi relativi alla manutenzione• alla gestione
Istogramma dei costi di manutenzione degli elementi tecnici dell'"Invariante 11C"riferito al periodo di 1 anno
L. -
L. 2.000.000
L. 4.000.000
L. 6.000.000
L. 8.000.000
L. 10.000.000
L. 12.000.000
L. 14.000.000
L. 16.000.000
L. 18.000.000
1
Elementi tecnici
Impo
rto in
£
IMPIANTO IDRICOSANITARIOIMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTOANTINCENDIOIMPIANTO DICONDIZIONAMENTOMURATURE ESTERNE
PARETI INTERNE
INFISSI ESTERNI
INFISSI INTERNI
CONTROSOFFITTI
PAVIMENTAZIONIINTERNE**COPERTURE
IMPIANTOASCENSORE*IMPIANTOILLUMINAZIONE
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

10
Cliccando sull’oggetto (nell’esempio l’elemento fan-coil dell’impianto di condizionamento) si visualizzano le informazioni primarie ad esso collegate nonché i riferimenti alle schede informative per la gestione
della manutenzione.
L’archiviazione dei disegni in formato .dwg e l’assegnazione a layer diversi dei vari sistemi edilizi consente di poter gestire i vari componenti a tutti i livelli di informazione garantendo, successivamente,
la facilità di dialogo con il gestore della manutenzione.
IL TRASFERIMENTO DI DATI E IMMAGINI NEL PROGETTO IN REAL TIME
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Strumenti per la manutenzione programmata• ANAGRAFICA: (contenente i dati anagrafici, di localizzazione, tecnici, funzionali e dimensionali dei componenti,ecc.)• SCHEDATURA DELLE LAVORAZIONI: informazioni sui metodi di lavorazione, mezzi e risorse necessari,
frequenza dei lavori, costi e tempi di esecuzione;• PIANO DI MANUTENZIONE: contenente informazioni sulla frequenza, modalità, operatori,specifica tecnica e costo
dell'intervento di manutenzione, per ogni componente;• PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE: contenente l'allocazione e l’organizzazione delle risorse
tecniche ed economiche e le loro modalità di impiego; • RICHIESTE DI INTERVENTO : contenente le richieste di intervento non programmate, per guasto od obsolescenza;• ORDINI DI LAVORO: contenenti le autorizzazioni amministrative all'intervento e le istruzioni agli operatori;• CONTROLLO DEI LAVORI: contenente informazioni relative agli interventi già effettuati o da effettuare;• GESTIONE MAGAZZINO: gestione magazzino e controllo ricambi (merce in deposito, ordini da effettuare, ecc.);• RAPPORTI DI SPESA: rapporti di spesa contenenti i dettagli appropriati per il controllo dei costi;• ARCHIVIO STORICO: archivio storico contenente gli interventi effettuati in relazione ai piani di manutenzione redatti;• ISPEZIONE E MONITORAGGIO: contenente le condizioni funzionali e di conservazione degli elementi tecnici• INFORMAZIONI DI RITORNO: contenente i dati di ritorno da elaborare per la costruzione di modelli di
comportamento nel tempo dei componenti.
ConclusioniMediante l'utilizzo di tali moduli il sistema deve essere in grado di consentire la continua ritaratura del piano di manutenzione, attraverso le informazioni di ritorno che vengono acquisite dai singoli ordini di lavoro, dai rapporti di esecuzione e dai consuntivi economici.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

11
Il Piano di Manutenzione del lotto 2 di Città della Scienza a Napoli.
RELATORI : Prof. ing. V. Betta, Prof. arch. G.Caterina, Prof. arch. C.Di Biase, Prof. arch. V.Fiore, Prof. arch. L.Fusco Girard
SPECIALISTI : Simonetta COPPOLA, Marcella de ANGELIS, Maria DI PALMA, Ornella RAGANATI
Oggetto della ricerca è il nuovo Museo Vivo di Città della Scienza, realizzato a Coroglio. Il Museo rientrava in un più ampio progetto di risanamento dell’area precedentemente
appartenente alla Federconsorzi e acquistata nel 1993 dalla Fondazione IDIS.Obiettivo del lavoro è stato quello di fornire alla Fondazione IDIS un Piano di Manutenzione
che consentisse, attraverso la programmazione degli interventi manutentivi, di ottimizzare le risorse finanziarie e operative, e di prolungare il ciclo di vita utile del Museo.
Al fine di prevedere e pianificare le attività inerenti la manutenzione, controllare lo stato di funzionamento del sistema, programmare gli interventi ed individuare le risorse, è stato
ipotizzato un processo manutentivo articolato in quattro fasi fondamentali.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
I FASE: LA CONOSCENZAOBIETTIVI:Definire l’ampiezza dell’oggetto fisico sul quale effettuare gli interventi e stabilire la loro dimensione e interferenza.METODOLOGIA:Raccolta e organizzazione di informazioni relative al contesto e all’immobile oggetto di studio mediante la rielaborazione di dati urbanistici, ambientali e gestionali.STRUMENTI:- elaborazione della Scheda Identificativa del Complesso;- elaborazione della Scheda Identificativa del Lotto 2;- elaborazione delle Schede di Scomposizione del Sistema Edilizio e Scomposizione del Sistema Impiantistico;- elaborazione delle Schede Tecniche.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

12
II FASE: LA PIANIFICAZIONEOBIETTIVI: Pianificare la fase operativa del piano di manutenzione. METODOLOGIA:Individuazione delle tipologie degli interventi da attuarsi, delle strategie organizzative, dei mezzi e degli strumenti necessari alla gestione delle attività manutentive, confrontando i dati derivanti dalla fase conoscitiva, dalla manualistica e dalle ispezioni effettuate in situ.STRUMENTI:- elaborazione delle Schede di Istruzioni per la Manutenzione- elaborazione delle Schede di Monitoraggio Diagnostico- elaborazione delle Schede Diagnostiche
- elaborazione delle Schede Banca Dati e Clinica.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
III FASE: LA PROGRAMMAZIONEOBIETTIVI: Razionalizzare e semplificare le attivitàmanutentive facendo interagire gli aspetti di carattere tecnologico-costruttivo con quelli di natura gestionale, al fine di prevedere i costi manutentivi annui ed eventuali picchi di spesa.METODOLOGIA:Indicazioni organizzative e operative, tempi, modalità, risorse, competenze e costi necessari alla realizzazione degli interventi, sulla base delle informazioni raccolte durante la fase di pianificazione e adattate alle specifiche caratteristiche tecniche e di usura dell’edificio oggetto di studio.STRUMENTI:- elaborazione dello Scadenzario- elaborazione del Cronogramma.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

13
IV FASE: LA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA GESTIONALE
OBIETTIVI: Riorganizzazione programmatica dell’attuale settore manutentivo mirata ad un miglioramento operativo attraverso nuove procedure manutentive di tipo preventivo - migliorativo.
ANALISI E RIELABORAZIONE DEI DATI
Valutazioni riassuntive di quanto rilevato in fase di indagine e controllo (informazioni di ritorno) al fine di creare ricircuitazione di dati “dinamici”;Strutturazione di un “corpus informativo” utile alla verifica degli interventi manutentivi con immediato riscontro circa la validità dei sistemi di controllo.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

14
La valutazione della fattibilità finanziaria ed economica delle alternative di destinazione d’uso da attribuire a Palazzo Landulfo, in Rodio
(fraz. di Pisciotta – SA).
RELATORE : Prof. Luigi FUSCO GIRARD SPECIALISTA: Arch. Francesca JOVENE
Sintesi del lavoro di tesiLa problematica è affrontata con un approccio integrato. Le diverse ipotesi, sostanziate in termini di progetto architettonico, funzionale e gestionale compatibilmente con i caratteri connotativi del manufatto e del contesto economico, sociale e culturale di cui è parte integrante, sono state valutate affiancando agli strumenti tradizionali dell’analisi economica e finanziaria, la metodologia multicriterio C.i.e. L’analisi rivela che il presupposto per la fattibilità risiede nel relazionare il sistema degli obiettivi e delle risorse necessarie a perseguirli,ad un contesto che trascende la realtà locale per ricercare cooperazione e collaborazione alla scala territoriale. La capacità di stimolare sinergie risulta la componente delle idee-progetto indispensabile a garantirne la sostenibilità all’interno del funzionamento sistemico di una “rete” che connettendo Rodio alle altre piccole meteore disseminate nel parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, ne supera lo stato di isolamento endemico rendendo ciascuna realtà locale, con la sua specificità, fortemente integrata e interrelata alle altre in un rapporto di reciproco arricchimento. Si tratta di chiarire qual è il ruolo che la comunità rodiana intende assumere nell’ambito della “rete” e da questo punto di vista, il restauro di Palazzo Landulfo, la volontà di “recuperarlo” alla vita economica, sociale e culturale del contesto “ambientale” in cui è ubicato, rappresentano un’occasione imprescindibile.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Obiettivi dello StudioObiettivo di questo studio è offrire un supporto
argomentato alla decisione da prendererelativamente alla destinazione d’uso da attribuire al Palazzo Landulfo, acquistato dal Comune di Pisciotta nell’aprile del 2000 e per il quale sono al vaglio dell’amministrazione due alternative dalla cui analisi prende inizio il processo valutativo oggetto di questa tesi: Casa Albergo per Anziani o Laboratorio Teatro.
Il “confezionamento” delle idee-progetto, recepite dalla comunità senza il supporto di un processo dialogico-comunicativo teso alla costruzione di una visione condivisa, ha generato una faziosa frattura tra i sostenitori dell’uno o dell’altro “possibile futuro” che i gruppi sociali intuitivamente hanno immaginato scaturire dalla realizzazione di ciascuna alternativa.
Scopo di questo studio è innescare un processo di esplicitazione e comunicazione critica dei contenuti implicitamente riconosciuti dalla collettività nelle diverse ipotesi di destinazione d’uso, al fine di ridurre i conflitti, compensare, persuadere, convincere e costruire un clima di consenso sull’idea-progetto “meritevole”.
Oltre al confronto tra le ipotesi “date”, il processo valutativo produrrà nuove alternative per costruire una proposta fattibile sulla base di una razionalità non solo tecnico-formale, ma argomentativa, una visione di lungo termine condivisa da soggetti diversi e capace di proporsi come espressione dell’interesse generale della collettività e del territorio.
Palazzo Landulfo. Prospetto verso la Piazza Vittoria.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

15
Obiettivi del ProgettoLe idee-progetto su palazzo Landulfo perseguono obiettivi che trascendono la valorizzazione della singola emergenza architettonica per rientrare in una strategia di sviluppo integrata fondata su un sistema di obiettivi generalmente condivisi dalla collettività:
Tutela del patrimonio storico e ambientale;
Migliore impiego delle risorse disponibili;
Miglioramento dei livelli occupazionali;
Migliore qualità della vita;
Miglioramento della base economica.
Obiettivi strumentali (necessari al perseguimento dei primi):
Potenziamento dell’accessibilità al sito;
Miglioramento dell’accessibilità nel sito.Obiettivi secondari (conseguibili con il perseguimento dei
primi):
Qualificazione dell’immagine complessiva dell’area;
Stimolo all’investimento privato;
Inserimento in un circuito territoriale.
Ciascuna ipotesi di destinazione d’uso specializza questo elenco di obiettivi e ne implica una diversa gerarchizzazione (da cui scaturisce il conflitto tra i gruppi sociali).
Rodio (frazione di Pisciotta – SA )
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Metodologia di studioA partire dalle idee-progetto iniziali (Casa Albergo
per Anziani e Laboratorio Teatro), lo studio svolge un processo valutativo ciclico che internalizzando i feed-back di ciascuna fase porta a rivedere le ipotesi inizialmente assunte, per costruire alternative in tutto o in parte diverse dalle alternative date ma sostanziate, ad ogni rimando successivo, dalla concretezza della fattibilità.
Scopo dell’implementazione del processo è circoscrivere, per “aggiustamenti” successivi, l’ iniziale “vortice del tutto possibile e del tutto negoziabile”, fino a costruire una “soluzione” da sottoporre al successivo processo decisionale, che potrà tradurla o meno in scelta operativa.
Ad ogni “aggiustamento” successivo corrisponde un implicito processo di negoziazione tra i soggetti coinvolti per e dalla realizzazione del progetto. Il processo aspira a costruire una alternativa “condivisibile” per soggetti diversi che ne compone i diversi obiettivi e li consegue ad un livello giudicato soddisfacente.
La soluzione scaturisce come risultato della ricerca del miglior compromesso tra esigenze (criteri) tra loro non massimizzabili contemporaneamente.
La “complessità” del quadro di riferimento implica la necessità di considerare simultaneamente una molteplicità di criteri eterogenei multidimensionali e talvolta conflittuali, che trascendono quelli di carattere squisitamente economico-finanziario e condizionano l’assunzione dei risultati delle rispettive Analisi.
Esemplificazione del processo valutativo.
A: C.A. B: L.T.
C: C.T. ?
A: Casa Albergo per Anzianie Centro Sociale Polivalente
A1: gest. diretta ComuneA2: gest. ONLUS
B: Laboratorio Teatroe Sportello Intranet
B1: gest. diretta ComuneB2: gest. Comune +FEOGA
C: Casa Teatro e Sportello Intranet
C1: gest. 8 att.anziani e ONLUS C2: gest. 8 attori e ONLUS+ FEOGA
A1 B1A2
BA
B2
C1
C
C2
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

16
Strumenti, Metodi e Criteri di valutazionePer la valutazione delle alternative è stata condotta, in
prima istanza, la verifica della fattibilità finanziaria, attraverso l’analisi della domanda e della sua evoluzione, dell’offerta e della sua evoluzione, l’analisi dei costi iniziali di investimento e di quelli di manutenzione e gestione; l’analisi delle tariffe applicabili e dei finanziamenti ottenibili.
Nelle stesse ipotesi, si è valutata la fattibilità economica assumendo i costi in misura ridotta dall’applicazione dei relativi coefficienti di conversione che tengono conto dei benefici finanziari indiretti rappresentati dal “rientro” di una percentuale dei costi in termini di imposte ( IVA sui materiali,IRPEF, …).
L’analisi finanziaria e quella economica sono stata applicateutilizzando il criterio del VAN (Valore Attuale Netto).
Con l’analisi finanziaria si è calibrata l’ipotesi capace di garantire il massimo valore, cioè la massima differenza ricavi-costi. Ma l’analisi finanziaria sebbene disaggregabile per i singoli operatori, non considera “tutti” i soggetti coinvolti dalla realizzazione né internalizza i valori simbolici-culturali o comunque non monetari.
Al fine di riflettere la complessità del contesto di riferimento della valutazione in termini di molteplicità ed eterogeneità degli impatti e dei soggetti coinvolti, è stato applicato il metodo C.i.e. (Community Impact Evaluation).
La costruzione di quella che si può definire “contabilità sociale” rappresenta il presupposto per garantire equità sociale nella negoziazione insita nel processo di costruzione dell’alternativa “condivisibile”, ossia socialmente fattibile.
C.i.e. :Specializzazione al caso studio della procedura generalizzata per l’applicazione del metodo:
•Conoscenza dello status quo•Descrizione delle alternative, esplicate in termini comparativi•Previsione degli scenari connessi alla realizzazione delle alternative e strutturazione degli scenari in termini di obiettivi perseguibili con la realizzazione delle idee – progetto•Individuazione degli impatti connessi alle variabili di progetto e dei settori della comunità coinvolti dagli impatti•Individuazione della natura degli impatti: DF, IF, DNF, INF •Individuazione degli obiettivi settoriali•Confronto degli obiettivi settoriali con gli impatti delle idee-progetto con espressione del “bilancio” interno ad ogni gruppo•Sintesi delle preferenze settoriali•Rapporto della valutazione
Analisi finanziaria C.A. e C.S.P. A2 (r=4%)
-2000-1000
0100020003000400050006000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
anni
£
Costi totaliRicavi totaliVAN
Analisi economica C.A e C.S.P. A2 (r=4%)
-10000
100020003000400050006000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
anni
Costi totaliRicavi totaliVAN
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Palazzo Landulfo, II livello. Idea-Progetto C ( Casa Teatro)
ConclusioniL’applicazione dell’analisi finanziaria ha portato ad
identificare nell’alternativa della Casa Albergo per Anziani gestita attraverso una ONLUS quella che massimizza il valore monetario diretto.
La C.i.e. ha messo in luce aspetti economici, culturali e sociali che rivelano la maggiore suscettibilità dell’ipotesi B a stimolare interdipendenza e sinergie tra le diverse categorie di attività, a innescare meccanismi di autosostenibilità e a conferire a Rodio una connotazione precisa, un ruolo specifico con cui accedere ad un sistema integrato di sviluppo territoriale riferito al Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.
Sulla base di questi elementi si è elaborata una diversa ipotesi di destinazione d’uso che, basandosi sul progetto architettonico - funzionale dell’alternativa B, se ne discosta per la diversa cocezione gestionale delle attività e della struttura.
L’ipotesi “C”, Casa Teatro, ottimizza i risultati dell’analisi finanziaria del Laboratorio Teatro, ne recepisce la potenzialità “economica”, con l’accentuazione della valenza sociale dell’iniziativa, attraverso la particolare attenzione rivolta alla componente anziana della comunità (che avrebbe propeso per l’attuazione dell’iniziativa A), coinvolta a più livelli dalla partecipazione attiva alle iniziative del Centro.
Frutto del processo valutativo è un’alternativa la cui fattibilità risiede nella razionalità non solo economico-finanziaria ma anche sociale.
Aldilà dell’ alternativa proposta, il vero frutto del processo valutativo è l’ esplicitazione di tutte le implicazioni economiche, finanziarie e sociali connesse alle diverse ipotesi, il che fornisce un supporto “trasparente” alla decisione politica che fornirà la scelta operativa forse prescindendo, ma non ignorando risultati dell’analisi di impatto.
locale cultoCSparrucchiere - trucco attori
camere (2x2p - 1x3p - 1x4p)
servizi igienici camere
soggiorno-lettura
informazioniNU SI
mq. 10.50
mq. 92.00
mq. 20.50
mq. 20.00
mq. 13.00
mq. 9.00
servizio igienico di nucleo mq. 3.00
sala telematica mq. 37.50sportello Intranet mq. 26.00
sala proiezioniST mq. 37.00
cabina luci suonosala prove mq. 40.50
deposito strumenti mq. 6.50
servizi igienici mq. 3.50
mq. 363.00
mq. 25.00
biblioteca mq. 19.00
TOTALE 1° LIVELLOCONNETTIVO mq. 67.00
mq. 430.00
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

17
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONEEsperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
TESI DI SPECIALIZZAZIONE IN MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA URBANA
“Far parlare i muri: aspetto gestionale di un progetto di riutilizzo della biblioteca comunale di Palazzo Pappacoda – Pisciotta (SA)”
SPECIALISTA:Arch. Angela Sanseverino
RELATORE:Prof. Luigi Fusco Girard
Le opzioni prese in considerazione per Palazzo Pappacoda di Pisciotta nascono dall’esigenza di promuovere un modello di sviluppo territoriale compatibile con la tradizione di un’area come quella cilentana. Il progetto di riutilizzo di una struttura architettonica destinata ad una fruizione pubblica poggia le sue basi su un esame degli obiettivi sociali e degli aspetti economici correlati: in questa ottica sono stati analizzati i piani gestionali relativi a due opzioni, di cui si è voluta appurare la convenienza economica. Il lavoro è stato completato da una concreta proposta di utilizzo degli spazi architettonici disponibili.
ObiettiviScopo dello studio è l’analisi economica di un progetto di riutilizzo di una struttura architettonica: in particolare si analizzano gli aspetti gestionali della produzione di un servizio pubblico formulando i business planes relativi a due possibili opzioni di cui si vuole appurare la convenienza economica.Posta alla sommità del colle che ospita il paese, la struttura architettonica del Palazzo Pappacodaè attualmente oggetto di un intervento restaurativo e conservativo grazie a fondi erogati dalla Regione Campania; parte della struttura, precedentemente adibita ad uso abitativo è stata donata all’Amministrazione Comunale con il vincolo di realizzazione di una biblioteca. Per coniugare la spiccata sensibilità civile e culturale del privato cittadino autore della donazione con le esigenze di una popolazione e di un economia in via di sviluppo sono state valutate due possibilità di produzione di servizi pubblici affiancati a quello della biblioteca: in particolare ci si è interessati alla creazione di isole multimediali e di uno spazio per mostre temporanee.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

18
Metodologia Strumenti
1. Analisi della domanda sociale Indagine sul territorio2. Analisi dei potenziali mercati di sbocco Indagine su dati statistici
dell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno
3. Descrizione critica della situazione attuale Indagine sul territoriodi eventuali produttori, già esistenti,di prodotti o beni sostituti
4. Individuazione dei mercati Indagine di mercatodi approvvigionamento
5. Modalità di promozione del bene prodotto Affidamento agli usuali canali pubblicitari
6. Programmazione dell’incremento Misura del servizio erogatodella capacità produttiva Misura del servizio potenziale
7. Esposizione dei prospetti di Analisi del break-even pointanalisi economica e di analisi finanziaria Analisi del VAN (Valore Attuale dell'attività Netto)
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Conclusioni
Isole multimedialiL’aspetto centrale che la “rete delle reti” va assumendo nel quotidiano delle persone consente stime ottimistiche nei riguardi della fruizione del servizio offerto.E’ lecito quindi supporre un incremento della domanda, sia in termini di ore di fruizione da parte dei frequentatori abituali, sia in termini di numero di frequentatori: l’unico limite alla soddisfazione di tale domanda è rappresentato dall’assenza di spazi sufficientemente ampi da mettere a disposizione.
Mostre temporaneeNonostante l’attività espositiva sia un’attività a margine economico negativo, tuttavia l’aspetto promozionale che essa riveste nei confronti della biblioteca e, ad un livello più ampio, di tutto il paese di Pisciotta lasciano intravedere margini di ampliamento del servizio: con ogni probabilità ciò non si concretizzerà nell’aumento del numero di eventi nel periodo, bensì nella realizzazione di mostre di maggiore risonanza che, a fronte di un più elevato valore artistico del materiale presentato, richiamino più ampie affluenze in un numero maggiore di giorni.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE
Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

19
Il percorso verso la sostenibilità locale.Il caso studio di Pisciotta.
Relatore : Prof. Arch. Luigi Fusco GirardSpecialista: Arch. Monica Siani
L’Agenda 21 Locale rappresenta lo strumento con il quale attuare a livello locale obiettivi di sostenibilità.
Lo studio del percorso verso la sostenibilità assume rilevanza attraverso la trattazione delle tappe che hanno segnato l’avvio di processi di sviluppo sostenibile locale.
Il percorso verso la sostenibilità è segnato da numerosi impegni, a livello internazionale, volti a contrastare la crescente disumanizzazione delle nostre città.
Se in particolare ci soffermiamo a pensare alla situazione in Italia diventa allora necessario promuovere processi di pianificazione attenti al patrimonio storico e culturale del nostro paese e che mirino alla salvaguardia del nostro paesaggio così ricco e variegato.
Attraverso l’adozione di Piani d’Azione Ambientali le città possono perseguire uno sviluppo sostenibile che punti all’integrazione delle dimensioni ambientale, sociale ed economica.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Le tappe verso la sostenibilità locale
CONFERENZA DI RIO 1992
AGENDA 21
Scala: globale, nazionale, regionale, locale.
AGENDA 21 LOCALE
1992 Rio de Janeiro: Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo
Agenda 21 è l’agenda di lavoro delle Nazioni Unite per il ventunesimo secolo.
Agenda 21 raccomanda che l’azione politica si svolga in modo integrato su quattro scale: globale, nazionale, regionale e locale.
Agenda 21 Locale è un processo multi-settoriale e partecipativo per realizzare obiettivi dell’agenda 21 a livello locale, attraverso la definizione e attuazione di un Piano Strategico di lungo termine che affronti le problematiche prioritarie di sviluppo sostenibile a livello locale.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

20
1. principi generali e visione locale condivisa
2. problemi e relative cause
3. obiettivi dell’azione ambientale
4. priorita’ d’intervento
5. target
6. programmi tematici
7. piano d’azione
8. attuazione e monitoraggio
9. valutazione e revisione
opzioni attuative
Il processo di Agenda 21 Locale
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
L’Agenda locale 21 si rivela essere uno strumento fondamentale per l’attuazione dello sviluppo sostenibile secondo il principio della sussidiarietà.
Intervenire a livello locale significa agire dal basso verso l’alto secondo quelle che sono nuove forme di autogoverno locale.Nel processo volto a contrastare la crescente disumanizzazione delle nostre città è necessario che avvenga la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
Attraverso Agenda 21 locale ogni città può promuovere in maniera integrata lo sviluppo sostenibile nel campo ambientale, sociale ed economico.
Lo studio della realtà urbana di Pisciotta affronta alcuni aspetti dello Stato dell’Ambiente e vuole rappresentare solo la fase iniziale di un processo che attraverso la partecipazione e la collaborazione di vari soggetti può portare alla definizione di veri e propri piani di azione.
E’ necessario promuovere tali strumenti di governo del territorio affinché attraverso più attente forme di pianificazione possano essere raggiunti risultati che rendano tangibili l’effettivo miglioramento della qualità della vita, nel rispetto del patrimonio naturale e manufatto del nostro paese.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

21
“CENTRO POLIFUNZIONE EX ONMI:definizione della strategia di manutenzione
per una gestione sostenibile”
RELATORE : Prof. Gabriella CATERINA CORRELATORE: Prof. Luigi FUSCO GIRARD
SPECIALISTI: ARCH. Lea ANGINOARCH. Barbara LA ROSSIARCH. Raffaela NARDONE
Sintesi del lavoro di tesi:
L’edificio, “Centro polifunzionale ex ONMI”. oggetto di studio destinato ad ospitare attività di carattere sociale, rientra nel quadro degli interventi del Progetto Urban, piano d’iniziativa comunitaria che coniuga misure di tipo economiche e sociali con interventi urbanistici ma non prevede nessun tipo di sostentamento economico successivo.L’edificio di proprietà del Comune di Napoli è destinato allo svolgimento di pubblici servizi e l’uso diretto, in questo caso da parte di associazioni no profit, non prevede la corresponsione di un canone.Al fine di mantenere le caratteristiche tecnico-strutturali dell’edificio, partendo dalla conoscenza dello stesso, si sono individuate le relazioni tra le attività previste, i fruitori (utenti e operatori) e gli spazi utilizzati; le possibili forme di finanziamento a sostegno delle attività svolte; gli addetti alla manutenzione (uffici-responsabili-operatori) e per analogia con attività similari si sono quantizzati alcuni costi di gestione.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Obiettivi
• Valorizzare la funzione dei Piani d’Iniziativa Comunitaria - Progetto Urban ;• Valorizzare l’utilità di un centro polifunzionale - Edificio ex ONMI- Quartieri Spagnoli Napoli – destinato ad
attività di carattere sociale;• Prolungare il ciclo di vita utile dell’edificio;• Definire una corretta gestione tecnico-economica dell’edificio.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

22
Metodologia
La base della ricerca metodologica-progettuale si fonda sulla conoscenza del sistema architettonico e del sistema ambientale dell’edificio ex ONMI.
Il metodo utilizzato è quello della :• Scomposizione e classificazione del sistema
tecnologico
• Scomposizione e classificazione del sistema ambientale
La classificazione ci ha permesso di individuare la “relazioni” tra l’elemento tecnico e/o componente e l’ambiente in cui è collocato.
Si sono definite inoltre:
• Relazione tra spazio-attività-fruitori• Classificazione elementi di valutazione per la scelta
dello staff di manutenzione• Programmazione degli “interventi” manutentivi.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
StrumentiProgramma degli interventiConoscenza- scheda identificativa - analisi del quartiere- scheda tecnica- analisi del sistema tencologico
scheda tecnica di prodottoscheda anagrafica tecnica
- check-list- analisi del sistema ambientalescheda requisiti tecnici dell’elemento
Pianificazione (Manuale di manutenzione)- Scheda d’ ispezione - Individuazione e descrizione delle istruzioni
necessarie per effettuare la diagnosi fisicoe/o funzionale
- Scheda clinica 1- Indicazione sugli interventi da effettuareRaccolta delle informazioni relative alleispezioni effettuate
- Scheda clinica 2- Rielaborazione delle informazioniProgrammazione (Programma di manutenzione)- Scadenzario- Individuazione delle tipologie d’ispezione e
d’intervento secondo le frequenze prestabilitee indicazione dei costi relativi
- Cronogramma- Articolazione del programma di manutenzione:successione temporale degli interventi ottimizzatiin base alla tipologia, gli operatori, le attrezzaturee la durata degli interventi.
GestioneAmministrativa- scheda amministrativa dei flussi economici- scheda amministrativa personale interno- scheda controllo servizi comuni
Tecnica della costruzione- scheda gestione imprese di manutenzione- scadenzario- cronogramma
La gestione, scomposta in amministrativa e tecnica della costruzione, rimanda al programma degli interventi relazionandoli ai costi manutentivi.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

23
Conclusioni
La gestione del patrimonio immobiliare pubblico è finalizzata non soltanto ad ottenere un utile economico di gestione ma anche al proseguimento di un vantaggio di natura sociale.
La stima del costo globale è risultata piuttosto difficoltosa per la mancanza di dati storici e per l’evoluzione temporale dei costi d’uso in relazione all’utilizzo dell’ edificio. Si sono quindi ipotizzati dei costi e delle forme di sostentamento per analogia con attività similari.
Partendo dai risultati ottenuti da questo studio è possibile estendere la programmazione per il controllo delle attività manutentive in ogni singolo edificio, personalizzandola di volta in volta a seconda delle attività svolte.
Il costo globale di un bene durevole è rappresentato, oltre che dal costo di rinnovamento, da tutte le spese che occorre sostenere per la sua utilizzazione, nel corso della sua vita utile.
Costo del ciclo di vita
Rinnovamentodell’immobile
Spesedi conduzione
Manutenzioneordinaria e/ostraordinaria
Costi energetici Pulizia Costi d’uso
in generaleCosti
di gestione
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

24
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.Casi studio: il Piano di Manutenzione di tre scuole.
RELATORE : Prof. Gabriella CATERINA CORRELATORE: Prof. Maria Rita PINTO
SPECIALISTI: Arch. Sara BIANCHIArch. Roberto MARAIAArch. Paola SIMEONE
Il lavoro consiste, dopo un’attenta analisi del patrimonio in questione, in uno studio dettagliato dei processi di degradamento fisico e di obsolescenza
funzionale di tutti gli edifici scolastici della provincia di Avellino, allo scopo di giungere ad una Manutenzione Programmata degli stessi.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Obiettivo
Elaborazione di linee guida per la Gestione dei 62 edifici scolastici della Provincia di Avellino.
StrumentiPer poter gestire un patrimonio vasto come l’edilizia scolastica della Provincia di Avellino è necessaria innanzitutto una conoscenza approfondita del patrimonio stesso,volta ad accertarne la consistenza le condizioni e la funzionalità. Tale conoscenza è stata raggiunta attraverso un’attenta analisi degli edifici ed ha portato alla redazione di due tipi di schede:
• Schede anagrafiche e• Schede anagrafiche-tecniche
strutturate in modo tale da essere implementabili e da permettere di trattare in maniera omogenea un patrimonio diffuso ed eterogeneo. Senza fare riferimento a modelli precostituiti, sono state inserite in tali schede notizie relative a vari aspetti: tipo ed epoca di costruzione, interventi subiti, localizzazione geografica, dati dimensionali, sistema tecnologico e ambientale.
Prima faseSchema
metodologico
Conservatorio
ANAGRAFICA TECNICA
DESCRIZIONE ANAGRAFICA
INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONEDELLE SCUOLE NELL'AMBITO PROVINCIALE
Disimpegni verticali
ADEGUAMENTI NORMATIVI
SCOMPOSIZIONE SISTEMA TECNOLOGICO
NOTE SULL'EDIFICIO
SCOMPOSIZIONE SISTEMA AMBIENTALE
L.626/94L.13/89
provinciale VV.FF.L.46/90
Certificazione comando
OrizzontamentiStrutture di separazione
Unita' pedagogiche
parascolastiche ed Spazi per attivita'
l'amministrazione
igienico-sanitariSpazi per i servizi
Spazi per la mensafisica e sportiva
integrative
Spazi per
Laboratori ed officine
Spazi per la distribuzione
Spazi per educazione
Rifiniture interne
DATAZIONE DEGLI EDIFICI
POPOLAZIONE SCOLASTICA
ED INTERVENTI SUBITI
DATI DIMENSIONALI
RILIEVO FOTOGRAFICO
CARTOGRAFIA DELLA PROVINCIA
TIPOLOGIA
Fotografie
Involucro esterno
Data di costruzione
Numero piani
Numero alunni
SuperficieVolume
Categorie d'intervento
Aula tipo e Aule spec ialiSpazi collettivi:
Servizi igienicipalestra, auditorium
Scale antincendio
Sede Succursale
CopertureProspetti
Sede Centrale
orizzontali e verticaliSpazi di distribuzione
PianteProspettiSezioni
ELENCO SCUOLE Istituto Magistrale
I.T.CommercialeLiceo Scientifico
I.T.Geometri
I.T.AgrarioIstituto d'ArteI.T.I.S.
I.P.S.I.A.
Liceo Classico
RIFERIMENTI NORMATIVI
in materia di prevenzione, sicurezza e barriere architettonicheVerifica delle conformita' alle normative vigenti
Legislazione in materia di edilizia scolastica
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

25
ObiettivoAttraverso una politica di Manutenzione Programmata, fornire uno strumento che possa garantire il permanere nel tempo degli standards di qualità accettabili e l’adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola e all’innovazione didattica.
StrumentiIn questa fase sono state analizzate le condizioni del degrado fisico e funzionale relativo a tre edifici campione; i dati raccolti convergono in due tipi di schede:
• Schede di monitoraggio diagnosticoSchede diagnostiche
La prima contiene le procedure e le istruzioni da seguire per il monitoraggio dello stato di funzionamento e le informazioni necessarie per effettuare la diagnosi dello stato di degrado fisico e funzionale; la seconda contiene l’elaborazione delle informazioni riguardanti gli elementi e i subsistemi dell’edificio e il loro stato di degrado fisico e funzionale. Queste analisi produrranno le indicazioni per le decisioni di intervento e le relative modalità.
Seconda faseSchema metodologico
Alterazione cromatica
PIANO DI MANUTENZIONE
FASE CLINICA
FASE DIAGNOSTICA
SCADENZARIO
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
AREA ECONOMICA
STRATEGIE DI MANUTENZIONEcondizioneOpportunistica
Componente tecnico
Costo totale interventi
Preventiva programmata
Tipo di interventoCosto operatoriCosto attrezzatureCosto materiali
Predittiva secondoA guasto avvenuto
AREA GESTIONALE
AREA TECNICA
ANALISI DELLE CONDIZIONI DELDEGRADO FISICO PER
CIASCUN SUBSISTEMA(ISPEZIONI)
DEGRADO FUNZIONALE PER ANALISI DELLE CONDIZIONI DEL
CIASCUNA UNITA' AMBIENTALE(ISPEZIONI)
per attività sportive
Descrizione dell'intervento
Componente tecnico
Attrezzature utilizzate
Tempi di interventoInterferenze con l'utenzaRischi per la salute e la
Operatori coinvolti
Materiali impiegati
Frequenza
Tipo di intervento
eseguito
Categoria di intervento
Strategie di interventoComponenti interessati
etc.
Tipo di intervento
adottata
Assenza di aule speciali,
degli interventisicurezza a seguito
strato di laccaturaDisomogeneita' del
Disgregazione strato dirivestimento
Inadeguatezza
SpaccatureMacchie di umiditàFessurazioniDistacchi, etc.
finitura
Mancanza di parti dello
Mancanza di sistemi
Mancanza di isolamento
strutture e/o attrezzature
di oscuramento
termo-acustico
unità ambientali
Assenza e/o inadeguatezza di
dimensionale delle
Insudiciamento da verniceAccumulo di polveriIncrostazioni
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Dai dati emersi nell’Area Diagnostica si evince che i degradi che nelle scuole si verificano più frequentemente riguardano le finiture esterne ed interne e i servizi per cui questi saranno i primi punti su cui intervenire, stabilendo le opportune
• Strategie di Programmazione Manutentiva
dalle quali dovrà dedursi un
• Programma di Manutenzione (Scadenzario)
in cui saranno indicate le scadenze a cui dovranno essere eseguiti i lavori, l’ordine degli interventi ed i relativi costi, che dovranno poi essere messi a confronto con il budget a disposizione dell’Amministrazione Provinciale, tenendo conto che, nella prospettiva prestazionale, l’analisi dei costi dovrà essere sviluppata anche in funzione delle principali esigenze relative al regolare svolgimento delle attività didattiche.
ELEMENTOTECNICO COMPONENTE
DEGRADORISCONTRATO
CAUSA DELDEGRADO
INTERVENTOCORRETTIVO
INTERVENTIPREVENTIVI
FREQUENZAISPEZIONI
SUCCESSIVE
STRATEGIAMANUTENTIVA
Fessurazione edistacchi
Cattiva qualitàdei materiali,agentiatmosferici omeccanici
Analisi delle cause delfenomeno, rappezzamentolocalizzato previarimozione dell’area diintonaco interessata dallelesioni, pulizia etrattamento del supporto esuccessiva ripresacromatica della finitura
Utilizzo dimateriali di buonaqualità,verifica dellecondizioni dellostrato superficialea cicli prefissati(eventualerifacimento)
1-2 anni Manutenzione secondocondizione
Intonaco esternoStrato di intonaco
DisgregazioneCattiva qualitàdei materiali,agentiatmosferici
Analisi delle cause delfenomeno, rappezzamentolocalizzato previarimozione dell’area diintonaco interessata dalladisgregazione, pulizia etrattamento del supporto esuccessiva ripresacromatica della finitura
Verifica periodicadella funzionalitàe della planaritàdella superficiedell’intonaco
1-2 anni Manutenzione secondocondizione
Zoccolatura in pietraRotture e distacchidella zoccolatura
Agenteatmosferico omeccanico
Analisi della cause,rimozione e ripristino deglielementi danneggiati;consolidamento deglielementi parzialmentedistaccati
Verifica dellecondizioni degliancoraggi 1-2 anni
Manutenzionesecondo condizioneRivestimenti esterni
Intonaco etinteggiatura
Mancanza dellazoccolatura
Mancata posain opera
Posa in opera dellazoccolatura
Manutenzione a guastoavvenuto
Fessurazioni e distacchi di intonaco Rotture e distacco della zoccolatura
Esempio di Scheda DiagnosticaIstituto Tecnico Commerciale “E. Fermi”-Vallata
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

26
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONEEsperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Il Piano di Manutenzione e Gestione Edilizia
del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.
Un caso studio: la “Torre A”.
Sintesi del lavoro di tesi
L’eccezionalità del complesso architettonico e la complessità che lo caratterizza sotto il profilo logistico-funzionale conferiscono alla sperimentazione condotta una valenza atipica, non assimilabile né alla scala di edificio né alla scala urbana, bensì a quella delle grandi architetture in cui si traduce la sintesi tra un modello polifunzionale a scala urbana ed un modello architettonico flessibile e dilatato.Il lavoro di tesi è stato pianificato e programmato per raggiungere un duplice obiettivo: strutturare un Sistema Informativo per la gestione delle attività manutentive di un Sistema Edilizio Complesso qual’è il Palazzo di Giustizia di Napoli e redigere un Piano di Manutenzione di una parte di esso, la “Torre A”. La stesura di quest’ultimo ha previsto una specifica analisi del sistema edilizio, allo scopo di individuare l’insieme delle relazioni esistenti “tra le parti edilizie e le componenti impiantistiche”in rapporto alle peculiarità del Sistema Funzionale, su cui fondare appropriate strategiemanutentive e politiche economico-gestionali sostenibili.
RELATORI : Prof. Gabriella CATERINA
Prof. Pietro MAZZEI
CORRELATORI: Prof. Vittorio FIORE
Prof. Dora FRANCESE
SPECIALISTI :
Arch. Antonio BRUNO, Diana MÀDARO
Arch. Cristiana VISCARDI, Ing. Francesco DE ANGELIS
Obiettivi
• Strutturazione di un Sistema Informativoper la conoscenza, la pianificazione e la programmazione, implementabile, flessibile ed adattabile alla quantità e diversità di informazioni acquisite;
• Redazione del Piano di Manutenzione della “Torre A” per il Sistema Architettonico ed il Sistema Impiantistico;
• Programmazione coordinata ed integrata dell’azione manutentiva relativa al Sistema Architettonico ed Impiantistico.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

27
Metodologia e ProcedureL’approccio metodologico-progettuale ha tenuto conto delle indicazioni, in termini di contenuti, dettate dalle norme UNI in materia di manutenzione e dalla vigente normativa in materia LL.PP. (L.109/94 e s.m.i.), e in termini di l’elaborazione, gestione e controllo dei dati delle esigenze di informatizzazione.I criteri e le procedure adottate si riferiscono a strumenti di organizzazione e metodi di lettura del sistema edilizio scientificamente riconosciuti a livello nazionale e d internazionale.L’iter procedurale è stato articolato nelle seguenti fasi:1. Acquisizione dati per la conoscenza del Sistema Architettonico ed Impiantistico della “Torre A”;2. Elaborazione dei dati di ricognizione (ricognitori);3. Scomposizione e classificificazione del Sistema Tecnologico e riarticolazione in sistemi aggregati di elementi tecnici;4. Individuazione degli insiemi manutentivi;5. Elaborazione e redazione delle schedetecnico-anagrafiche, cliniche e di monitoraggio diagnostico degli elementi tecnici manutenibili;6. Articolazione dello scadenzario delle ispezioni e degli interventi;7. Programmazione “ottimizzata” delle ispezioni e degli interventi (cronoprogramma).
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Strumenti
AREA DELLA CONOSCENZA:Anagrafe identificativa:
- Analisi fasi progettuali e realizzative della Torre A;- Analisi dei caratteri generali del sistema edilizio.
Anagrafe tecnica:- Elaborazione dei RICOGNITORI;- Analisi del SISTEMA TECNOLOGICO (PCET);- Analisi del SISTEMA FUNZIONALE (PCA);- Selezione degli Elementi Critici da Manutenere (PAETM);- Schedatura degli Elementi Tecnici da Manutenere.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

28
Strumenti
AREA DELLA PIANIFICAZIONE(Manuale di Manutenzione):
• Individuazione e descrizione delle strategiemanutentive con esplicitazione degli interventi e delle ispezioni da effettuare (schede cliniche);
• Individuazione e descrizione delle istruzioni necessarie per effettuare il monitoraggio e la diagnosi dello stato di degrado fisico e/o funzionale (schede di monitoraggio diagnostico);
• Rielaborazione delle informazioni di ritorno (schede cliniche).
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Strumenti
AREA DELLA PROGRAMMAZIONE (Programma di Manutenzione):
• Individuazione delle tipologie di ispezione e di intervento secondo frequenze prestabilite (scadenzario);
• Articolazione del programma di manutenzione: successione temporale degli interventi ottimizzati in base alla tipologia degli operatori, alle attrezzature richieste e alla durata degli interventi (cronoprogramma).
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

29
CONCLUSIONI
L’elaborazione delle “linee guida per la costruzione di un Sistema Informativo per laManutenzione Edilizia e Urbana”, nel corso del primo anno di studi, ha avuto, come logica e naturale prosecuzione, una applicazione ad un caso “paradigmatico”: il Palazzo di Giustizia di Napoli. I risultati delle attività svolte nel secondo anno di studi e in conclusione con il lavoro di tesi ha consentito il raggiungimento di un duplice obiettivo:
• un nuovo contribuito, in termini metodologici e procedurali, per la strutturazione di Sistemi Informativi per la Gestione e Manutenzione di Sistemi Edilizi Complessi;• un modello di Piano di Manutenzione, a fronte di un quadro normativo e
procedurale in continua evoluzione, per la Gestione e Manutenzione dei Palazzi di Giustizia.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

30
Il Piano di Manutenzione dell’Impianto di Pubblica Illuminazionedel Comune di EBOLI
RELATORE : Prof. Ing. Pietro M A Z Z E I
CORRELATORE: Arch. Laura S C A R C I A
SPECIALISTA: Arch. Vito C A P U T O
S I N T E S I
Classificazione dei componenti ed elementi tecnici secondo la norma UNI 8290 ed UNI 40/1.
Individuazione dei guasti per la redazione della scheda d’intervento e rilevamento degli interventi per circa
sei mesi.
Analisi delle informazioni di ritorno; registrazione al database degli interventi; georeferenzazione dei dati
con il GIS.
Valutazione delle strategie manutentive adottate dal Comune e analisi dei costi degli interventi a guasto.
Redazione del Piano di Adeguamento dell’impianto e Redazione del Piano di Manutenzione.
Analisi dei costi effettuati dall’Ente e dei costi previsti dal Piano di Manutenzione.
Risparmio economico per l’Ente con l’attuazione del Piano di Manutenzione.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Obiettivi
Riduzione dei guasti e dei disservizi sociali;
Funzionalità ed Efficienza dell’impianto;
Creazione del Sistema Informativo;
Gestione dell’impianto con strategia programmata;
Riduzione dei costi con l’attuazione del Piano di Manutenzione;
Gestione delle scorte in magazzino e riutilizzo delle lampade.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

31
Metodologia
• Sopralluoghi con gli operatori manutentori ed interviste ai tecnici responsabili
• L’osservazione, la raccolta e la registrazione degli interventi
• Analisi dei dati e informazioni utili alla stesura del piano di manutenzione
• Redazione della Scheda degli Interventi e delle schede previste dalla norma Uni 10874
• Analisi delle informazioni di ritorno
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Strumenti
• Il Sistema Informativo GIS consente la registrazione degli interventi differenziati secondo il costo;
• Il database individua le linee più soggette a guasto mettendo in relazione i dati numerici con i dati grafici;
• Il Sistema Informativo viene continuamente aggiornato attraverso le informazioni di ritorno;
• Implementazione del Sistema Informativo.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

32
Conclusioni• L’attuazione del Piano di
Manutenzione riduce i costi di gestione di circa € 8.000,00.
• La registrazione e quantificazione annuale degli elementi tecnici e/o componenti sostituiti consente di effettuare:La richiesta di fornitura di nuovo materiale elettrico da parte dell’Ufficio Manutenzione; Una migliore gestione delle scorte in magazzino attraverso la scelta degli elementi e/o componenti sostituiti o da riutilizzare;Il confronto delle spese annualiper la fornitura del materiale elettrico in rapporto a quanto sostituito.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

33
La valutazione ex post della durabilità dei componenti edilizi.Il caso studio del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.
RELATORE : Prof. Gabriella CATERINA CORRELATORE: Prof. Umberto CATURANO
SPECIALISTA: ARCH. Claudio BATTISTA
Sintesi del lavoro di tesi
La tesi approfondisce il problema dell’analisi e della sistemazione delle informazioni di ritorno, provenienti da attività manutentive già eseguite, nella prospettiva di finalizzare tali informazioni ad una realistica previsione delle frequenze e delle scadenze temporali su cui “dimensionare” il piano di manutenzione.Il caso studio, scelto in coerenza con attività di ricerca già sviluppate presso il Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura, avvia a soluzione la determinazione a posteriori della durabilità dei subsistemi tecnologici e dei componenti posti in opera nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Obiettivi
• Progettazione di uno “strumento” per la elaborazione delle informazioni di ritorno delle attività manutentive
• Aggiornamento “progressivo” del piano di manutenzione informatizzato della Torre A
• Elaborazione dei piani di manutenzione degli altri plessi del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, in coerenza con il Sistema informativo per i servizi di gestione e manutenzione
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

34
Metodologia
• Ricognizione della documentazione tecnica (registri delle presenze, degli interventi, delle forniture) relativa all’appalto del Servizio di manutenzione ordinaria delle strutture edili del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli nel periodo contrattuale 4-5-2001/3-5-2002
• Classificazione delle “notizie manutentive” per:– Classe di elementi tecnici interessati dall’intervento– Tipologia (opportunamente codificata) di attività svolta– Descrizione dell’intervento– Localizzazione dell’intervento– Attività giudiziaria insediata nell’unità ambientale luogo
dell’intervento
• Associazione dell’intervento alla “giornata lavorativa” con indicazione:
– Della tipologia e della composizione della squadra di intervento
– Dei mezzi d’opera, del tempo effettivo del loro impiego e del loro costo giornaliero
– Dei prodotti impiegati e del loro costo di approvvigionamento
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Strumenti
• Creazione di un data base in ambiente Microsoft Access per la gestione delle informazioni di manutenzione acquisite
• Importazione del data base in ambiente MapInfo Professional per la localizzazione in pianta delle singole “notizie manutentive” registrate
• Interrogazione delle basi di dati per:– Frequenza degli interventi ascrivibili ad una
medesima classe di attività– Ricorrenza delle tipologie di elementi tecnici
manutenuti– Localizzazione degli interventi ed impatto degli
interventi manutentivi con le attività giudiziarie insediate
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

35
Risultati
• Valutazione della produttività delle ditte appaltatrici del Servizio di manutenzione in base:
– Alla distribuzione dei costi – Alla variabilità giornaliera della composizione
della squadra di intervento
• Individuazione dei componenti “a rischio” per frequenza di interventi manutentivi
• Ottimizzazione della “logistica” della manutenzione in base alla lettura combinata di ricorrenza e localizzazione degli interventi
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

36
C O M U N E D I SESSA AURUNCA
PROVINCIA DI CASERTA
1.1 ISTITUTO SAN LEO 1.2 ISTITUTO CASCANO1.3 ISTITUTO AVEZZANO SORBELLO2.1 ISTITUTO SEMICERCHIO2.2 ISTITUTO CUPA2.3 ISTITUTO CASAMARE2.4 ISTITUTO CORBARA2.5 ISTITUTO FASANI2.5P ISTITUTO FASANI2.6 ISTITUTO PIEDIMONTE2.7 ISTITUTO RONGOLISE3.1 ISTITUTO LAURO3.2 ISTITUTO SAN CASTRESE3.3 ISTITUTO CORIGLIANO3.4 ISTITUTO S.M.VALOGNO3.5P ISTITUTO SAN CARLO3.6 ISTITUTO PONTE3.7P ISTITUTO MAIANO3.8 ISTITUTO SAN MARTINO M.1 ISTITUTO CAIO LUCILIOM.2 ISTITUTO SUCC. CAIO LUCILIO M.3 ISTITUTO DE SANCTISM.4 ISTITUTO SUCC. DE SANCTIS
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONEEsperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Organizzazione del servizio di manutenzione per la gestione del patrimonio edilizio scolastico del Comune di Sessa Aurunca
RELATORE : Prof. Gabriella CATERINA CORRELATORE: Prof. Vittorio FIORE
SPECIALISTI: ARCH. Giovanni BORTOLINARCH. Vincenzo MAGNETTA
Sintesi del lavoroSintesi del lavoroGli Enti Locali gestiscono quasi sempre la manutenzione dei propGli Enti Locali gestiscono quasi sempre la manutenzione dei propri ri patrimoni immobiliari in modo non programmato e privi di un patrimoni immobiliari in modo non programmato e privi di un servizio organizzato, adottando politicheservizio organizzato, adottando politiche manutentivemanutentive basate sul basate sul compromesso di disporre risorse per la manutenzione solo quando compromesso di disporre risorse per la manutenzione solo quando l’esigenzal’esigenza manutentivamanutentiva si è trasformata in urgenza inderogabile, si è trasformata in urgenza inderogabile, compromettendo di conseguenza l’ordinario ciclo di vita utile decompromettendo di conseguenza l’ordinario ciclo di vita utile degli gli immobili.immobili.L’analisi dello stato dell’arte del patrimonio scolastico del CoL’analisi dello stato dell’arte del patrimonio scolastico del Comune di mune di Sessa Aurunca ha riscontrato tutte le problematiche suddette.Sessa Aurunca ha riscontrato tutte le problematiche suddette.Lo studio propone di riorganizzare il servizio di manutenzione Lo studio propone di riorganizzare il servizio di manutenzione in in modo unitario al fine di poter gestire, anche attraverso l’istitmodo unitario al fine di poter gestire, anche attraverso l’istituzione uzione di un sistema informativo, in modo programmato gli interventidi un sistema informativo, in modo programmato gli interventimanutentivimanutentivi..
Obiettivi• Comprendere e governare il rapporto qualità
prestazionale-tempo nel ciclo di vita dei sistemi e componenti edilizi;
• Sviluppare modelli più efficaci per controllare il rapporto tra valore immobiliare e gestione tecnico-economica (costi, investimenti) degli interventi di manutenzione;
• Tradurre conoscenze e modelli in capacità di pianificazione strategica delle attività;
• Costruire una sensibilità in tutti i soggetti coinvolti rispetto ai requisiti di manutenzione;
• Razionalizzare la gestione tecnica ed economica degli interventi necessari a mantenere inalterato nel tempo il livello qualitativo del patrimonio e a stabilire livelli di efficienza e di affidabilità delle opere soggette ai fenomeni di obsolescenza e degrado.
SCUOLA ELEMENTARE PIEDIMONTE
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

37
Metodologia
ANALISI COSTI:Consuntivo gestione e manutenzione anno 2001Monitoraggio interventi di manutenzione anno
2002
ANALISI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Verifica della dotazione organica applicata al servizio di manutenzione e relative
mansioniVerifica di un sistema informativo
Monitoraggio dei plessiRaccolta dati in possesso del servizio
CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO
ORGANIZZAZIONE DEL SUM (Servizio Unitario Manutenzione)
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Procedure e StrumentiProcedure e Strumenti
•• MANUALE DI MANUTENZIONE PER IL MANUALE DI MANUTENZIONE PER IL TECNICOTECNICO
•• PROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONE
•• MANUALE D’USO UTENZA FINALEMANUALE D’USO UTENZA FINALE
•• CONTROLLO DELL’ EFFICIENZA DELLA CONTROLLO DELL’ EFFICIENZA DELLA STRUTTURA STRUTTURA –– SERVIZIO UNITARIO DI SERVIZIO UNITARIO DI MANUTENZIONE (SUM)MANUTENZIONE (SUM)
•• CONTROLLO DEGLI INTERVENTICONTROLLO DEGLI INTERVENTI
2.6.EDIFICIO
ISTITUTO PIEDIMONTE
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
VIA RIVOLIINDIRIZZO
PIEDIMONTELOCALITA’
SESSA AURUNCACOMUNE
CASERTAPROVINCIA
CAMPANIAREGIONE
CARATTERISTICHE EDIFICIO
STRUTTURA
VOLUME
H. MAX
NATURA SUOLO
PIANI FUORI TERRA
PIANI SEMINTERRATI
PIANI INTERRATI
SUPERFICIE COPERTA
SUPERFICIE LOTTO
ANNO DI COSTRUZIONE
C. ARMATO
2950 MC
3.50 M
1
843 MQ
1393 MQ
DATI METEOROLOGICI
S-O
35 %
20 mm
26.5° C
ESTIVA
N-OS-ON-EVENTI DOMINANTI
42 %48 %63 %UMIDITA’
51 mm45 mm60 mmPIOVOSITA’
15.2° C20.1° C11.1° CTEMPERATURA
AUTUNNALEPRIMAVERILEINVERNALESTAGIONE
15INSEGNANTI
2ALTRO PERSONALE
118ALUNNI MAX CONS.
94ALUNNI
PIANTA ORGANICA
PLANIMETRIA UBICATIVA
RILIEVO STATO ATTUALE
PROGETTO INTERVENTO
SCHEDA INTERVENTI
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

38
I RISULTATI ATTESI da una razionale organizzazione del Servizio di Manutenzione
responsabile della gestione del patrimonio edilizio scolastico analizzato, sono essenzialmente i
seguenti:
• Risultati di carattere organizzativo: individuazione di procedure operative più snelle e
funzionali, con l’assegnazione di responsabilità agli attori coinvolti nelle procedure ai vari
livelli;
• Risultati di carattere tecnico: costituzione di un inventario di tutti i beni e impianti che
consentono di valutare le condizioni di efficienza e di funzionalità del patrimonio da
manutenere;
• Risultati di carattere economico: individuazione dei costi superflui e non ottimizzati, con
possibilità del controllo del badget e verifica “in continuo” dei costi globali di intervento.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

39
La Manutenzione degli spazi verdi.Piano di Manutenzione del Parco Virgiliano a Napoli.
RELATORE : Prof. Gabriella CATERINA CORRELATORI: Prof. Marcello FORLANIProf. Nicola PILONEProf. Vittorio FIORE
SPECIALISTA: ARCH. Flavia CASTAGNETO
ABSTRACTQuando oggi si parla di Manutenzione del verde urbano ci si riferisce ad una particolare disciplina dinamica e giovane che sta cercando una sua
autonomia e definizione, nell’ambito della più generale Manutenzione urbana, oggetto di questo convegno internazionale. Allo stato attuale però si
stanno ancora fondando le basi di questo settore della disciplina, mancando ancora terminologia standardizzata, metodologia adeguata, normativa
specifica. Allo stesso tempo l’esigenza di definire strumenti di controllo e gestione del verde è sempre più sentita, ed il verde è visto sempre più
come fattore fondamentale di qualità urbana. Questo lavoro di tesi ha come tema principale l’analisi del rapporto tra verde e costruito e la
proposta di uno strumento operativo per la manutenzione di un parco urbano. Il caso studio esaminato è il PARCO VIRGILIANO di Napoli, oggetto di un recentissimo progetto di recupero ambientale ed edilizio, commissionato, progettato e diretto da uno staff del Dipartimento centro
Storico del Comune di Napoli, coordinato dall’arch. G. Pulli. Il parco Virgiliano, per le sue caratteristiche e la sua indole naturale è a cavallo tra oasi
naturalistica e parco cittadino, situato in una posizione paesaggisticamente straordinaria sullo sperone di roccia del promontorio di Coroglio.
Partendo dalla proposta di un PIANO DI MANUTENZIONE per un caso vivo, l’obiettivo di questo contributo è da un lato cominciare a stimolare
ed intraprendere uno studio più strutturato e sistematico sulla Manutenzione del verde urbano, dall’altro di fornire un modello il più possibile
Flessibile alle esigenze specifiche di evoluzione del parco e trasferibile ad altri parchi urbani. Quando si parla di manutenzione di parchi urbani il
primo fattore da considerare è la COMPLESSITA’ degli elementi presenti, dovuta alla loro eterogeneita’; elementi biotici ed abiotici con cicli di vita
completamente differenti che tuttavia interagiscono continuamente. Un Piano di Manutenzione di un parco urbano deve essere basato sullo studio
delle interazioni tra gli elementi, deve essere ORGANICO, cioè fondarsi sulle relazioni spaziali, fisiologiche, funzionali tra di essi.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
OBIETTIVI
OBIETTIVI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANOValorizzazione del verde urbano:
Mantenimento del valore ecologicoMantenimento del valore storico-testimonialeMantenimento del valore didattico scientificoMantenimento del valore esteticoMantenimento del valore igienico
Valorizzazione del parco Virgiliano:Mantenimento dell’immagine del parcoMantenimento dei valori paesaggistici del sitoProtezione dagli elementi ambientali e vegetali stranei ed aggressiviSicurezza delle essenze vegetali (emergenza climatica e parassitaria)Miglioramento dell’igiene ambientale urbana
OBIETTIVI DELLA TESICreazione di un sistema per la conoscenza del parco Virgiliano FLESSIBILE e TRASFERIBILECreazione di un sistema per la conoscenza del parco Virgiliano adeguato alla ETEROGENITA’ egli elementi soggetti a manutenzioneRedazione di un PIANO DI MANUTENZIONE del parco VirgilianoProposta di interventi MIGLIORATIVI del sistema parco, con eventuali adeguamenti e/o sostituzioni di elementi a rischio, inbase all’analisi degli elementi critici e delle zone a rischio del parco.
Fig.1. Viale del parco verso via t. L. Caro
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

40
PRIMA PARTE: REGISTRAZIONE TECNICA DEGLI ELEMENTI DEL PARCO1. Individuazione della tipologia di dati da acquisire2. Scomposizione del sistema in sottoparti elementari
- Elaborazione della Classificazione generale degli elementi tecnologici di un parco urbano- Elaborazione della Classificazione degli elementi tecnologici del parco Virgiliano
3. Accorpamenti degli elementi del parco in Subsistemi Aggregati di elementi
4. Localizzazione dei Subsistemi Aggregati degli elementi vegetali ed architettonici
5. Redazione di archivi di Schede tecnico-anagrafiche degli elementi- Schede tecniche di Componente vegetale- Schede tecniche di Subsistema aggregato
6. Individuazione delle prestazioni specifiche degli elementi, variabili nel tempo.
SECONDA PARTE: GUASTI ED ISPEZIONI: ANALISI DEI MODI DI GUASTO1. Individuazione degli elementi a rischio di guasto2. Individuazione dei modi e delle cause di guasto – Failure
mode3. Metodi di controllo
METODOLOGIA E STRUMENTI-I
SCHEMA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PARCO VIRGILIANO
FH
G
I
C
B
A
D
E
1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45I
II
III
V
IV
X
XV
XX
XXV
XXX
xxxv
XL
L
SCHEMA DI LOCALIZZAZIONE DEL VERDE
LEGENDA
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
SB8
SCHEMA DI LOCALIZZAZIONE DEI SUBSISTEMI AGGREGATI DEI COMPONENTIVEGETALI
GRIGLIA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PARCO VIRGILIANO
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
METODOLOGIA E STRUMENTI-II
IL SISTEMA PARCO
ELEMENTI BIOTICI (turn over)
ELEMENTI ABIOTICI
UTENTI
Toccolini A., Piano e progetto di area verde, manuale di progettazione, ed. Maggioli, Rimini 2002
LE FUNZIONI DEL VERDE URBANO:
Le aree verdi presenti nel territorio urbanizzato esercitano le seguentifunzioni:
1. INTERCETTAZIONE DELLE POLVERISedimentazione delle particelle, deposito per effetto elettrostatico
2. REGOLAZIONE TERMICARaffrescamento della temperatura ambientale per l’evepotraspirazione delle foglie
3. FISSAZIONE DEI GAS TOSSICIAssorbimento dei gas inquinanti presenti nell’aria
4. PRODUZIONE DI OSSIGENOFotosintesi clorofilliana
5. BARRIERA AL VENTO ED AL RUMOREDeviazione del vento e diminuzione della sua energia cinetica; assorbimento, riflessione e deviazione dell’energia sonora
6. BENESSERE PSICOLOGICO E PERCETTIVO
TERZA PARTE: AREA CLINICA. METODI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI
1. Individuazione delle tipologie di intervento2. Individuazione delle modalità di intervento, materiali, manodopera,
attrezzature3. Redazione di uno scadenzario delle ispezioni e degli interventi manutentivi4. Proposta di interventi migliorativi-ottimizzazione delle opere di
manutenzione
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

41
SPECIFICITA’ E PROPOSTE
SPECIFICITA’ RISCONTRATE NELLA REDAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE:a) La maggior parte degli elementi da manutenere è costituita da ELEMENTI
ORGANICIb) CAPACITA’ DI ADATTAMENTO dei componenti vegetali a condizioni
ambientali poco favorevolia) Mancanza di personale qualificato preposto alla manutenzione degli
elementi vegetali. Manutenzione operata in modo generico.a) Presenza di numerosi elementi con un ciclo di vita breveb) Variabilità elevata del comportamento dell’elemento vegetale in base alla
sua localizzazione all’interno del parco.
PROPOSTE - WORK IN PROGRESS:I. Ricerca di standardizzazione della terminologia specifica per la
manutenzione del verde urbanoII. Sperimentazione su diversi casi di parco urbano: costruzione di banche
dati attendibili per la programmazione della manutenzioneIII. Ricerca di un metodo generale per l’individuazione degli elementi critici di
un parco urbano.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

42
Manutenzione e sicurezza. Il Mantenimento dei livelli di sicurezza fissati per l’emergenza,
mediante interventi programmati e gestione dei dispositivi di protezione attiva e passiva.
Il Palazzo degli Uffici dell’Ateneo Federico II.
SPECIALISTA: Arch. Giuseppe Somma
Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II”TESI DI SPECIALIZZAZIONE IN MANUTENZIONE E
GESTIONE DELL’EDILIZIA URBANA
RELATORE: Prof. Umberto CATURANO
Sintesi del lavoro: esame delle condizioni di esercizio degli impianti antincendio integrati nel sistema edilizio di riferimento; individuazione della strategia manutentiva conveniente.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
Obiettivi
Delineare strumenti attuativi per la manutenzione programmata del Sistema Impiantistico in particolare le unità tecnologiche dell’impianto antincendio.
Superare la prassi manutentiva secondo condizione subordinata alla sorveglianza.
Coordinare l’azione degli attori preposti alla manutenzione ed al controllo delle condizioni di sicurezza (Ufficio Tecnico e Servizio di Prevenzione).
Gestione integrata del buon funzionamento in relazione alla manutenzione programmata degli impianti antincendio.
Sicurezza antincendio.
Progetto
Tutela cittadiniPreservare
Beni
Prevenzione
(norme, provvedimenti tecnici)
Protezione(controllo propagaz. incendio, prolungam.
tempi ignizione,squadre
intervento)
Attiva Passiva
Manutenzione
Classe di resistenza al fuoco
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002

43
Metodologia
Un esame del panorama normativo e legislativo di riferimento ha messo in evidenza:
• la mancanza di procedure normalizzate per alcuni sistemiimpiantistici;
• la necessità di una gestione “integrata” articolata sulle peculiarità dell’oggetto delle azioni manutentive (protezioni attive e passive) nelle condizioni di esercizio.
•
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002
STRUMENTI
L’area conoscitiva-operativa si articola in schede anagrafiche di edificio: tecnico-anagrafiche di impianto con riferimento all’antincendio mediante l’elaborazione di una scheda anagrafica di progetto nella quale si esaminano i carichi di incendio, le destinazioni d’uso, i requisiti normativi;scomposizione del sistema antincendio; schede di monitoraggio diagnostico elaborate sulla scorta di norme UNI, CEI e della normativa nazionale vigente.
Informazioni generali sulle attività a rischio incendio
Autorimessa oltre 9 autoveicoli(Attività 92 ex D.M.I. 16.2.82)
Edificio di altezza >24 m.(Attività 94 ex D.M.I. 16.2.82)
>24 m.
CONCLUSIONI
Nella manutenzione programmata per gli impianti di sicurezza, assume ruolo fondamentale la conoscenza delle condizioni al contorno e dello stato delle parti edilizie che collaborano alla protezione da fuoco.
Necessità di una procedura manutentiva che conservi o incrementi il coefficiente K di riduzione del carico d’incendio.
PROCEDURE, METODI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA STESURA DEI PIANI DI MANUTENZIONE Esperienze condotte nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana di Napoli, 1997/2002