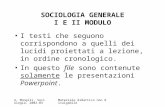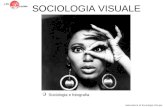Modulo 3 - La Sociologia Ha La Sua Storia
-
Upload
silvia-squaw-neri -
Category
Documents
-
view
4 -
download
1
description
Transcript of Modulo 3 - La Sociologia Ha La Sua Storia

LEZIONE 3 – LA SOCIOLOGIA HA LA SUA STORIA. LA FORMAZIONE DEL
PENSIERO SOCIOLOGICO.
A partire dal 1760 in Gran Bretagna prende vita la RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
e si sviluppano nuove forme di organizzazione della vita SOCIALE E POLITICA.
Ciò richiede però che si sviluppino strumenti di conoscenza ed analisi adeguati
a questi nuovi contesti e a tal fine nascono le SCIENZE SOCIALI. L’uomo già
durante il XVIII secolo comincia ad essere studiato come homo sociologicus e
quindi come soggetto agente al centro di una rete di rapporti sociali. È però
opportuno chiedersi come fa Raymond Aron “quando nasce la sociologia? Quali
autori meritano di essere considerati gli antenati o i fondatori della sociologia?
Quale definizione adottare per quest’ultima? Io ho adottato una definizione che
riconosco vaga ma non ritengo arbitraria. La sociologia è lo studio che pretende
di essere scientifico della realtà sociale in quanto tale, sia al livello elementare
delle relazioni interpersonali, sia a quello macroscopico dei vasti insiemi, classi,
nazioni, civiltà o, per far uso dell’espressione corrente, società globali. Questa
stessa definizione premette di capire perché sia arduo scrivere una storia della
sociologia , sapere dove incominci, e dove finisca. Tanto l’intenzione scientifica
quanto l’oggetto sociale possono essere intesi in più modi. La sociologia esige
nel contempo questa intenzione e questo oggetto, o comincia a esistere l’uno o
l’altro di questi due caratteri? Tutte le società hanno avuto una certa
consapevolezza di se stesse. Più società hanno concepito studi, che
pretendevano d’essere obiettivi, dell’uno o dell’altro aspetto della vita
collettiva. … Nella misura in cui l’intenzione di cogliere la realtà sociale in
quanto tale è costitutiva del pensiero sociologico, Montesquieu merita di
figurare in questo libro come fondatore”1.
CHARLES L. de MONTESQUIEU (1689 – 1755), uno dei più grandi filosofi
dell’Illuminismo, nei suoi studi tenta di individuare le uniformità e le leggi che
governano la società. In quanto sociologo Montesquieu ha cercato di
combinare due idee, nessuna delle quali può essere abbandonata, ma che è
difficile tenere insieme. Da una parte egli sostiene, implicitamente, la pluralità
indefinita delle spiegazioni parziali. Ha mostrato quanto numerosi siano gli
aspetti di una collettività che devono essere spiegati e quanto numerose le
determinanti alle quali si possono ricondurre i diversi aspetti della vita
1 R.Aron, Le tappe del pensiero sociologico, Milano, Mondadori, 1972, p. 21.1

collettiva. Dall’altra ha cercato il modo di superare la pura giustapposizione
delle relazioni parziali, di afferrare qualcosa che costituisca l’unità degli
insiemi storici.
Montesquieu parte dalla diversità e arriva all’unità della specie umana.
Auguste Comte, al contrario, è prima di tutto e soprattutto il sociologo
dell’unità umana e sociale, dell’unità della storia umana.
AUGUSTE COMTE (1798 – 1857) considerato il padre fondatore della
sociologia avverte la necessità di trasportare l’armonia, il metodo e l’ordine
che regnano nel mondo tecnico scientifico, all’interno della FILOSOFIA
SOCIALE. Egli si pone come obiettivo di organizzare una vera e propria
SCIENZA SOCIALE
Comte è convinto che attraverso la SOCIOLOGIA sia possibile individuare le
leggi che hanno presieduto il progresso dell’umanità e sulla base di queste
leggi prevedere e dominare il corso del futuro “savoir puor prévoir et prévoir
pour pouvoir”2. Auguste Comte, come molti dei suoi contemporanei, ritiene
che la società moderna è in crisi, e trova la spiegazione dei disordini sociali
nella contraddizione tra un ordinamento sociale teologico e militare che sta
per scomparire e un ordinamento sociale scientifico e industriale che sta per
nascere. La sociologia diventa lo strumento per recare rimedio alla mancanza
di coerenza, sistematicità e omogeneità fra le diverse scienze. Ma
evidentemente “Comte chiede e pretende troppo dalla sociologia,
trasformandola in una religione laica dell’umanità, altrettanto dogmatica e
intollerante delle religioni rivelate, fino a vedere in essa, nel suo affermarsi ed
estendersi, il segno e la chiave del destino dell’uomo”3.
Per Comte l’individuo non ha una realtà autonoma, ma si realizza in strutture a
lui superiori come la FAMIGLIA, la CHIESA, lo STATO che sono gli elementi
fondamentali di qualsiasi SOCIETA’.
Auguste Comte ha elaborato una teoria di quella che egli chiamava la società
industriale. L’opposizione essenziale, nel suo pensiero è tra le società del
passato, feudali, militari e teologiche, e le società moderne, industriali e
scientifiche, in contrapposizione a quelle militari e teologiche. Ma anziché
porre al centro della sua interpretazione l’antinomia tra le società del passato
2 M. Nocenzi, Vivere l’incertezza sociologia politica e cultura del rischio, Milano, FrancoAngeli, 2002, p. 35.3 F. Ferrarotti, Lineamenti di storia del pensiero sociologico, Roma, Donzelli, 2002, Introduzione p. XIII-XIV.
2

e le società del presente, pone al centro del suo pensiero la contraddizione
inerente alla società moderna che definisce capitalismo.
Il terzo teorizzatore del pensiero sociologico nasce venti anni dopo Comte ed è
KARL MARX (1818 – 1883). Marx, come aveva fatto anche Comte, lavora
osservando la società nella quale si trova a vivere.
Per Marx la storia umana è caratterizzata “dalla lotta di quei gruppi umani che
noi chiamiamo classi sociali, la cui definizione resta, per il momento equivoca,
ma che hanno la duplice caratteristica di comportare da una parte
l’antagonismo tra oppressori e oppressi, e dall’altra di tendere a una
polarizzazione in due blocchi e due soltanto”4. Per questo si può affermare che
il modello marxiano è DICOTOMICO. Ogni società viene descritta attraverso
due classi in opposizione poggiate sul possesso o il “non” possesso della
proprietà, ci sono gli sfruttatori e gli sfruttati, gli oppressori e gli oppressi.
Per Marx la società non può essere compresa partendo dallo Stato, ma deve
essere interpretata facendo riferimento alla sua stessa struttura, considerando
l’articolazione in classi. Marx ha una visione conflittuale della società. Infatti,
per lui i fenomeni determinanti della storia sono caratterizzati dal conflitto,
soprattutto il conflitto di classe.
Ferrarotti nel libro Lineamenti di storia del pensiero sociologico scrive: “Benchè
profondamente divisi quanto al metodo di indagine e al generale orientamento
politico, sia Comte che Marx, come del resto tutti i grands individus che
costituiscono la tradizione classica della sociologia da Proudhon e Spencer fino
a Weber, Pareto e Durkheim, hanno un’immagine della società come realtà
globale e in movimento, sono sociologi che non aspettano dal mercato o dalla
congiuntura politica o dalle mode intellettuali i loro temi di ricerca; seguono un
loro itinerario che può porre al centro del loro interesse i primordi del
capitalismo moderno per far loro prevedere il “proletariato” come forza
organizzativa determinante”5.
Su posizioni notevolmente diverse si trova il contemporaneo britannico di
Marx, HERBERT SPENCER (1820 – 1903). Infatti per lui la società è un
organismo e più ancora una realtà superorganica. La legge dello sviluppo della
società è simile a quella che governa l’organismo animale. Per lui il progresso
4 R.Aron, Le tappe del pensiero sociologico, op.cit, p. 145.5 F. Ferrarotti, Lineamenti di storia del pensiero sociologico, op.cit., Introduzione p. XVI-XVII.
3

della società è MONOLINEARE, senza eccezioni nè drammi, anzi segue il ritmo
dell’evoluzione organica.
L’ultimo periodo del XIX secolo è caratterizzato da un profondo mutamento
nella storia del pensiero, e nella storia civile e politica dell’Europa. Si verifica
una radicale trasformazione nell’affrontare i problemi sia nelle scienze naturali
che in quelle sociali.
La sociologia diventa studio del comportamento dell’uomo che però non viene
considerato più solo come essere RAZIONALE; viene, infatti, meno il PENSIERO
SISTEMICO orientato alla visione ottimistica del futuro. L’uomo viene
considerato prevalentemente come essere IRRAZIONALE.
NIETZSCHE e FREUD sono gli studiosi che meglio di tutti analizzano il
comportamento irrazionale dell’individuo.
FRIEDRICH NIETZSCHE (1844 – 1900) analizza l’individuo come soggetto
agente tentando di scoprire la frammentazione dell’IO che si nasconde dietro
l’apparente unità e razionalità.
SIGMUNT FREUD (1856 – 1936) compie un’analisi più sperimentale rispetto
a Nietzsche e riporta tutto il sociale alla dinamica delle forze interiori che
condizionano l’individuo. Proprio per questo Freud viene considerato come il
fondatore della PSICOANALISI.
Negli ultimissimi anni dell’800 il pensiero sociologico si evolve dal tentativo di
una TEORIA DELLA SOCIETA’ a quello di spiegare l’AZIONE SOCIALE.
ÉMILE DURKHEIM (1858-1917) filosofo dell’università francese da buon
discepolo di Comte è convinto che una società ha bisogno di consenso,
consenso che può nascere solo da credenze assolute, e pone al centro della
sua riflessione l’esigenza del consenso sociale. Nella sua opera La divisione del
lavoro sociale6, che è la sua tesi di dottorato, Durkheim si domanda come un
gruppo di individui può costituire una società? Come gli individui possono
realizzare quella condizione dell’esistenza sociale che è il consenso? A questi
quesiti risponde con la distinzione tra due forme di solidarietà: la solidarietà
meccanica e la solidarietà organica. La solidarietà meccanica è una solidarietà
per somiglianza. La forma di solidarietà opposta, detta organica, è quella nella
quale il consenso, cioè l’unità coerente della collettività, nasce da o si esprime
6É. Durkheim, La divisione del lavoro sociale, Milano, Edizioni di Comunità, 1962.4

con la differenziazione. Gli individui non sono più simili, ma differenti, e, in un
certo senso, proprio perché sono diversi, si realizza il consenso.
Un altro dei padri della sociologia che ha centrato la sua analisi sull’azione
sociale è indubbiamente MAX WEBER (1864 – 1920). Weber definisce la
sociologia come lo studio dell’AGIRE SOCIALE, cioè di quell’agire che si riferisce
come conseguenza dell’agire di altri individui.
Studiando il significato profondo delle azioni dell’uomo in interazione con gli
altri uomini si può capire l’agire sociale e perciò spiegare il suo ITER ed i suoi
EFFETTI. Mongardini nel manuale La conoscenza sociologica scrive:
“L’azione sociale per Weber e’ un agire che e’ riferito all’atteggiamento di altri
individui e orientato nel suo corso in base a questo. Ogni azione è «azione
dotata di senso», ma questo senso viene sempre riferito e orientato sugli altri:
quello che si prevede che gli altri attribuiranno all’azione. Occorre quindi
sempre considerare il senso delle azioni che si instaura tra gli individui quando
questi interagiscono. Weber elabora una famosa tipologia dell’azione sociale.
Le azioni degli individui possono essere:
a) Azioni razionali rispetto allo scopo, nelle quali chi agisce si preoccupa
dell’efficacia degli strumenti rispetto ad uno scopo determinato e voluto;
b) Azioni razionali rispetto al valore, nelle quali l’agire è orientato da un
valore accettato incondizionatamente;
c) Azioni affettive, dovute a stati emotivi;
d) Azioni tradizionali dovute all’influenza del passato e perciò ad
abitudini acquisite”7.
Per GEORG SIMMEL (1858 – 1918), la SOCIOLOGIA è lo studio delle forme e
delle interazioni, vale a dire di quei processi attraverso i quali l’individuo
diviene membro e partecipa della vita associata. La società è perciò il prodotto
delle interazioni tra gli individui. Qualunque relazione sociale presuppone
l’esistenza negli individui di premesse necessarie per consentire la
socializzazione. Tali premesse sono definite da Simmel con il termine di
apriori sociologici. Tali APRIORI sono, citando testualmente l’autore:
“condizioni che sono poste apriori negli elementi stessi … attraverso le quali
essi si connettono realmente alla sintesi “società”.
7 C. Mongardini, La conoscenza sociologica, Genova, ECIG, 2002, p. 587.5

VILFREDO PARETO (1848 – 1923), ci ha fornito invece una complessa
teoria dell’azione sociale. All’inizio dei suoi studi riprende la DICOTOMIA
minoranza governante – maggioranza governata, affrontata già da Simmel ma
ripresa anche da GAETANO MOSCA (1858 – 1941), e l’ha trasformata in
TEORIA DELLE ELITES. Cosa sono le élites? “L’élite è una categoria sociale,
oggettivamente percepibile. Non ci si deve chiedere se l’élite è vera o falsa, e
chi ha il diritto di farne parte. Sono tutte questioni senza senso: l’élite è fatta
da quelli che hanno meritato buoni voti nell’esame della vita, o hanno estratto
numeri fortunati dalla lotteria dell’esistenza sociale”8.
Per Pareto ogni tipo di azione rivela l’abilità degli individui e questa abilità
provoca in tutti i campi, dal gioco alla politica, la selezione dei “migliori”, che
sono poi quelli che vanno a formare l’elite. Da qui viene formulata la teoria
delle élites.
La maggior parte dei sociologi classici ha avuto un’esistenza difficile e
disagiata. Questo fa riflettere sul fatto che forse l’insuccesso personale
garantisca la distanza necessaria per capire il funzionamento degli organismi
collettivi. Oggi la situazione sembra essere anche peggiorata perché “la crisi
investe non più e non tanto il singolo sociologo bensì la sociologia nel suo
complesso sia come disciplina che come insieme di tecniche diagnostiche e di
intervento. Ci si domanda se vi sia una crisi nella sociologia. Ma l’interrogativo
è ovviamente mal posto. La sociologia è nata da una crisi e vive, si nutre di
crisi. … La crisi è reale … Per la sociologia di oggi la sociologia assume la
forma di un dilemma puro e semplice: specializzarsi in senso professionale, e
quindi scadere a mera tecnica operativa, una fra le tante, ridursi a ingegneria
sociale, oppure mantenersi fedele al proprio impulso filosofico originario, alla
propria autonomia, e rischiare quindi di restare indefinitamente prigioniera di
una posizione genericamente filosofeggiante e ambiguamente moralistica …
(La sociologia) È l’ultima, la più recente e quindi la meno collaudata delle
scienze sociali; non può contare su una tradizione solida come gli studi di
diritto, storia, economia. In secondo luogo è stata fondata, almeno
ufficialmente, da un uomo che scambiava la paranoia per igiene mentale e si
proibiva di leggere per lunghi periodi qualsiasi cosa nel timore di venire
intellettualmente inquinato, ossia fuorviato dai suoi progetti intellettuali di
8 R.Aron, Le tappe del pensiero sociologico, op.cit, p. 416.6

maggior impegno. In terzo luogo, è un ibrido persino nel nome, composto da
una parola latina e da una greca, accettato da molti, fra gli altri da Herbert
Spencer, semplicemente perché non si è trovato di meglio. … Eppure, sono
queste disgrazie a decretare, rispetto alle altre scienze, una sorta di primato
della sociologia, a costituirla legittimamente come scienza del presente e del
vivente – scienza, in altri termini, in continua tensione”9.
Se ci vogliamo interrogare sulle ragioni del successo odierno della sociologia,
allora la domanda che va posta è la seguente: a quale bisogno della società
odierna, cioè delle società risponde la sociologia? Si tratta, in realtà, di un
bisogno duplice o addirittura contraddittorio. È un bisogno così forte e così
critico che solo dalla soddisfazione di esso dipende la “tenuta”, la non
disgregazione delle istituzioni. L’ambiguità della sociologia è sostanzialmente
determinata dalla duplicità di questo bisogno sociale, che rimanda alle due
pulsioni fondamentali costitutive degli esseri umani, quella adattiva e quella
contestativa. Queste due pulsioni danno luogo, sia nell’individuo che nella
società ad una condizione di equilibrio instabile e di perenne tensione fra
elementi statici ed elementi dinamici. In questa ottica la crisi della società e la
crisi, ambiguità della sociologia sono correlative, ed è vano, se non dannoso,
illudersi di poterle un giorno superare e vincere per sempre. Perché quel
giorno sarebbe probabilmente anche l’ultimo della vicenda umana.
9 F. Ferrarotti, Lineamenti di storia del pensiero sociologico, op.cit., Introduzione p. XXIII- XXXII.7